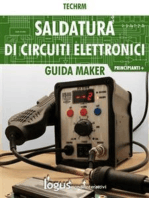Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
GIE 2004 Num 13 Tutto
Caricato da
max_ingCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
GIE 2004 Num 13 Tutto
Caricato da
max_ingCopyright:
Formati disponibili
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
7
8
10 OTTOBRE
POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB MILANO - ISSN 0392-3630 - 3,40
13
ANNO 26
n.
E
ra il 1904 e lelettricit era poco
pi che unintuizione. Intuizioni
erano anche le apparecchiature che
servivano alla sua produzione e al suo
utilizzo. Proprio in quegli anni Federico
Palazzoli iniziava a Brescia la pro-
duzione di componenti per impian-
ti elettrici. Lazienda fondata dal
signor lampadina - come
lo chiamavano i concittadini
bresciani, forse in virt della
genialit delle sue invenzio-
ni - taglia in questi giorni il tra-
guardo dei cento anni e si ri-
conferma una delle realt
leader non solo nel settore
delle prese in-
terbloccate, ma
anche nei si-
stemi Atex per
a t mo s f e r e
esplosive, nei
sistemi per ap-
plicazioni nava-
li e nei prodotti
per quadri. Sia-
mo una bottiglia
ben tappata che
naviga tra le por-
taerei dice Luigi Moretti, attuale pre-
sidente della societ, sottolinean-
do come, essendo una realt medio-
piccola, Palazzoli fa della rapidit e
della flessibilit con cui eroga i ser-
vizi il proprio punto di forza; in so-
stanza, lavorando su quei prodotti che
la grande impresa non in grado di
gestire in modo efficiente proprio a
causa delle dimensioni.
Prova ne sono alcuni importanti
forniture - per esempio il nuovo
polo fieristico di Milano, la por-
taerei Cavour, i box dellautodromo
di Monza o le strutture delle olim-
piadi di Torino - che Palazzoli si
aggiudicata battendo realt di
grande prestigio internazionale,
forse di maggior appeal ma si-
curamente meno flessibili.
Una media tra le grandi
Impianti
Domotica
e dintorni
Tecnologie
La sicurezza
elettrica
del paziente
Organo Direttivo Nazionale di Confartigianato Impianti
I
l successo delloperazione At-
trezzati per vincere, che ha pro-
mosso gli utensili Weidmller Red e
Top Line, andato oltre ogni previ-
sione. Cos Weidmller, sollecitata dal-
le numerose richieste, ha prolunga-
to fino al 31 dicembre il meccani-
smo di vendita abbinata.
E con loperazione Scatta laffare,
dal 1 settembre gli installatori po-
tranno acquistare dal loro rivenditore
di fiducia tre kit di prodotti first
class, con un rapporto qualit/prez-
zo imbattibile. Un mix tanto invi-
tante da accendere linteresse di
tutti, in particolare per i kit Service
e Dati e telefonia. Chi gi utilizza
Weidmller pu cogliere al volo loc-
casione offerta da Service Pro, il kit
della Serie Top Line.
Affidabilit cento per cento
D
a oggi frigoriferi scongelati, antifurti disattivati, sistemi di irri-
gazione bloccati o pc, fax e apparecchi elettrici scollegati saranno
solo un brutto ricordo.
Gli interruttori differenziali montati nel centralino di casa possono
essere soggetti a interventi intempestivi provocati da eventi quali
fulmini, sovraccarichi temporanei o disturbi passeggeri nella rete,
che possono creare disagi all'utente tanto pi gravi quanto pi
lunga la sospensione dell'energia.
Gewiss ha risolto definitivamente questi problemi proponendo Re-
Start, un differenziale che, dopo aver verificato che l'intervento
non sia dovuto a un guasto di tipo permanente o pericoloso, riarma
automaticamente l'interruttore differenziale, ripristinando la tensione
in casa. La versione completa ReStart con Autotest permette inol-
tre di garantire nel tempo le caratteristiche di protezione del diffe-
renziale, svolgendo settimanalmente e in modo automatico, senza
togliere tensione all'impianto, il test consigliato dalle norme.
Schneider Electric acquisisce
Andover Controls
D
opo l'acquisizione del gruppo svedese Tac, una delle principali
realt nel mercato dell'automazione, regolazione e controllo de-
gli edifici, Schneider Electric raggiunge una posizione di vertice nei
sistemi aperti e integrati per building automation grazie all'acquisizione
di Andover Controls. Dai piccoli impianti ai sistemi pi complessi e di-
stribuiti, dal microclima alla gestione e trattamento dei fluidi, loffer-
ta Tac e Andover Controls risponde alle diverse esigenze mediante con-
trollori stand alone o liberamente programmabili, che basano la pro-
pria tecnologia su bus standard e aperti (ModBus, LonWorks e BacNet)
e componenti di campo (sonde, valvole e attuatori).
La nuova filiale
del Triveneto
U
rmet Domus ha inaugurato
la filiale del Triveneto, a Vi-
gonovo, vicino a Venezia. La se-
de disposta allinterno di un mo-
derno edificio, copre una super-
ficie di circa 250 metri quadrati
e vi trova spazio unampia sala
meeting, dove gi da settembre
si svolgono, con cadenza perio-
dica, diversi corsi tecnici dag-
giornamento su tutta la gamma
prodotti Urmet Domus.
Scatta laffare
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
4
7
5
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 3
Sommario
ATTUALIT
A proposito di privacy
Gli adempimenti per la protezione dei dati sono al centro delle preoccupazioni del mondo produttivo
di Roberta Leprotti
NORMATIVA
Gli ausiliari di comando
Scelta e installazione, alla luce delle recenti norme e direttive europee
di Antonio Porro
Direttive europee e marcatura CE
Le regole comunitarie per limmissione sul mercato dei nuovi prodotti
di Mario Giorgio Bartolo
Lilluminazione dei luoghi di lavoro
La nuova norma Uni su Illuminazione di interni con luce artificiale
di Paolo Micelotta
TECNOLOGIE
La sicurezza elettrica del paziente
Il sistema IT e le esigenze di continuit del servizio
di Armando Ferraioli
Dimensionamento del neutro
Quando si scelgono le sezioni dei conduttori occorre considerare il tipo di carico da alimentare
di Angelo Baggini e Gabriele Tacchi
IMPIANTI
Ascoltare al casin e in consiglio comunale
Sistemi audio distribuiti a CaVendramin Calergi e nella sala consiliare del Comune di Pescara
a cura di Alma Taddei
Domotica e dintorni
Unapplicazione di controllo industriale nel residenziale? S, e con ottimi risultati
di Giacomo Orlandi
SOLUZIONI
Senza fili meglio
Allarmi senza black out e senza falsi allarmi
a cura di Alessandra Lucaccini
ON-LINE
Fasce di rispetto: un fattore regionale
Calcolo del campo elettrico e magnetico nei pressi di un elettrodotto
di Daniela Di Cola
RUBRICHE
Panorama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4
Le schede tecniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 104
Novit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1 1 1
Norme & leggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 129
Veicoli da lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 132
Come funziona? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 134
Libri & cataloghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 139
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 140
Le aziende citate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 142
pag. 18
pag. 28
I sensori
Utili informazioni sugli apparecchi
impiegati nellautomazione
pag.48
SPECIALE
VETRINA
pag.93
Nuove tecnologie:
levoluzione della tv
Limpatto della televisione digitale
sul mercato dellinstallazione
pag. 72
pag. 76
pag. 68
pag. 34
pag. 60
pag. 38
pag. 64
pag. 78
Istituto Nazionale
di Qualificazione
delle Imprese
di Installazione dImpianti
Qualificazione imprese appaltatrici pag. 84
Teoria e pratica per i giunti pag. 86
di Andrea Gulinelli
PANORAMA
Panorama
4
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
L
a Bcc opera su un modello di-
verso da quello degli altri isti-
tuti bancari, quello basato soprat-
tutto sull'aiuto reciproco e sul sen-
so di appartenenza, elementi in-
dispensabili per raggiungere obiet-
tivi comuni. Proprio in questo spi-
rito, e per essere maggiormente pre-
senti sul territorio della Valle Ca-
monica, una filiale della Banca di Cre-
dito Cooperativo Camuna stata re-
centemente inaugurata a Mon-
tecchio di Darfo Boario Terme; la
nuova struttura stata progettata
per essere fisicamente diversa dal-
le altre, una sorta di banca aper-
ta dove l'accoglienza e la cortesia
si toccano con mano, dando la giu-
sta importanza alla riservatezza.
Per realizzare questa filiale, la ban-
ca ha scelto come fornitore Mega
Italia, l'azienda specializzata nella
progettazione di agenzie banca-
rie chiavi in mano. La struttura sta-
ta studiata, come tutte le realiz-
zazioni "chiavi in mano" di Mega
Italia, fin nei minimi dettagli; la
progettazione stata concepita
per sviluppare un concetto di ban-
ca differente, che incarnasse la fi-
losofia della Bcc Camuna, espres-
sione del territorio e patrimonio di
chi l vive, studia e lavora. Per que-
sto motivo l'agenzia di Montec-
chio di Darfo stata strutturata
come una banca aperta, persona-
lizzata nei minimi dettagli di finiture
e colori. stata dotata di filodiffu-
sione, di baby parking, di collega-
mento digitale ai canali borsistici con
display lcd nell'area clienti, di ve-
trate scorrevoli con acidature se-
rigrafate motorizzate che consen-
tono di ottenere la giusta riserva-
tezza in occasione di consulenze
commerciali rapide e di postazioni
con casse innovative.
N
el corso di una serata che si
svolta recentemente al Re-
lais San Clemente di Perugia, Phi-
lips Lighting ha premiato Rimep -
azienda del Gruppo Minuti, spe-
cializzata nella vendita allingros-
so di materiale elettrico per lim-
piantistica civile ed industriale e nel-
la vendita al dettaglio di elettronica
di consumo, elettrodomestici, te-
lefonia e pc - per le migliori per-
formance di vendita di prodotti
Philips Lighting ottenute lo scor-
so anno.
Rimep nata nel 1976 come azien-
da specializzata nella vendita al-
lingrosso ed in breve tempo di-
ventata punto di riferimento nel
mercato umbro, grazie allinte-
grazione dellattivit di vendita al
dettaglio. Nel 2001 diventata
socia del consorzio Findea.
Maurizio Minuti, titolare e ammi-
nistratore unico, ha ricevuto il ri-
conoscimento da Aldo Bigatti,
chairman di Philips Lighting, che
ha commentato cos il significato
e limportanza del riconoscimento
consegnato a Rimep: Sono par-
ticolarmente orgoglioso degli ecla-
tanti risultati ottenuti dalla part-
nership Rimep-Philips, che testi-
moniano quanto una relazione e un
impegno di lungo termine fra un
grande marchio e uninsegna lea-
der nel proprio territorio premino
sempre rispetto a scelte di breve
periodo che tal-
volta, nel nostro
settore, altri ope-
ratori fanno.
Con questo rico-
noscimento, Phi-
lips Lighting ha vo-
luto premiare Ri-
mep oltre che per
le ottime perfor-
mance di vendita
anche per la fiducia
da sempre dimo-
strata: da oltre
trentanni, infatti,
lazienda umbra
continua a sce-
gliere con succes-
so Philips Lighting
come unico forni-
tore di sorgenti lu-
minose e principale referenza nel-
lambito della sua offerta di prodotti
per lilluminazione.
Un rapporto che dura
da oltre trentanni
Significative nuove nomine e importanti conferme si sono avute nellambito di Anie,
la Federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, che ha proceduto al
rinnovo delle presidenze delle associazioni federate per il prossimo biennio.
Questi i nuovi presidenti: Assil - Associazione nazionale produttori illuminazione:
Paolo Targetti (Targetti Sankey); Aice - Associazione italiana industrie cavi e
conduttori elettrici: Valerio Battista (Pirelli Cavi); Csi - Associazione componenti e
sistemi per impianti: Sergio Salio (Gruppo Urmet); Associazione nazionale
componenti elettronici: Ivano Faccin (STMicroelectronics); Assoautomazione -
Associazione italiana automazione e misura: Luigi Sacchi (Siemens); Anciss -
Associazione italiana sicurezza e automazione edifici: Mirco Damoli (D.E.S.);
Associazione elettromedicali: Carlo Castellano (Esaote); Associazione nazionale
telecomunicazioni informatica ed elettronica di consumo: Domenico Ferraro (Alcatel
Italia). I presidenti confermati sono: Assifer - Associazione industrie ferroviarie: Luigi
Morisi (Ansaldo Trasporti); Assoascensori - Associazione nazionale industrie
ascensori e scale mobili: Marco Bonissone (Kone); Associazione nazionale industrie
apparecchi domestici e professionali: Massimo Giorgino (Merloni Elettrodomestici).
Sono inoltre state prorogate fino a fine anno le presidenze delle tre associazioni
dellenergia.
Definiti i vertici
a
c
u
r
a
d
i Fulvia
C
a
t
t
a
n
e
o
La banca aperta
Aldo Bigatti, chairman di Philips Lighting, consegna
il premio a Maurizio Minuti, titolare e amministratore
unico di Rimep
La filiale della Banca di Credito
Cooperativo Camusa a Montecchio
di Darfo Boario Terme
servizio lettori 1579
PANORAMA
6
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
un marchio
SISTEMI DI SICUREZZA
EL.PA s.a.s. Via Pontarola, 64/a
35011 Reschigliano di Campodarsego - Padova - Italy
Tel. +39 049 9202312 r.a. - Fax +39 049 9202314
e-mail: info@iessonline.com - www.iessonline.com
POWER PC
Modello: AMILO PRO V1000
Processore: CEL-2.5G
Hard Disk: 40GB
Ram: 512MB
Monitor: 15.1TFT
Masterizzatore CD, e Lettore Dvd
Sistema Operativo:WXPProfessional
Borsa
>>
PALMARE
Intel 400MHz PxA255
Memoria 64 MB SDRAM 32/64 MB
Flash ROM
Risoluzione display 240x320, Touch
Panel 3,5 TFT, Schermo Transflective,
65536 colori
Audio Jack 3,5mm per cuffie stereo,
speaker integrato, casse integrate
Batteria ricaricabile al Litio 1300mAH -
durata fino a 18-19 ore
Accessori in dotazione (connettore,
custodia, ....)
>>
IESS si riserva
la facolt di
consegnare un
prodotto analogo o
dalle caratteristiche
simili a quelle
pubblicizzate
in base alla
disponibilit dello
stesso.
Promozione valida
dal 01/05/04 al
31/12/04
PEN USB
Display grafico ID3 TAG
MP3/WMA - DVR - Radio FM -
Flash Disk USB 128 Mb
Registratotore vocale per 8 ore di registrazione
con equalizzatorew 5 posizioni
Uso anche come "Dta Storage" USB FLASH
Microfono incorporato e Uscite cuffie 5mWx2
Alimentazione 1 batteria Ni-MH da 70 mAh
ricaricabile (3/4 ore di durata)
Accessori in dotazione (auricolari stereo di
alta qualit, cavo USB, ...)
>>
servizio lettori 1644
Contro il blocco delleolico
L
a notizia allarmante giunge
dalla stampa sarda: la Giun-
ta regionale ha revocato il ban-
do per la realizzazione in Sar-
degna di nuovi parchi eolici per
una potenza complessiva di 900
MW, bando pubblicato lo scorso
giugno e con scadenza settem-
bre. Per sei mesi, inoltre, sa-
rebbe sospeso lesame delle
istanze non ancora definite cor-
rispondenti ad una potenza in-
stallabile di oltre 1.000 MW.
Lo stop alla realizzazione di nuo-
vi impianti eolici, preannuncia-
to in campagna elettorale dal
neoeletto presidente Renato So-
ru, si realizza con una marcia
indietro rispetto alle scelte di
politica energetica della prece-
dente amministrazione regio-
nale, a solo un mese di distanza
dalla presentazione delle do-
mande per lammissione alla
graduatoria prevista dal bando.
Aper (Associazione produttori
energie rinnovabili) intende co-
ordinare le istanze di tutti colo-
ro che vorranno presentare ricorso
a questo provvedimento, facen-
dosi tramite degli operatori pres-
so il proprio studio legale.
Campione
dEuropa
C
hloride ha ottenuto il Frost
& Sullivan Market Leaders-
hip Award 2004, relativo al
mercato europeo degli Ups di
media e alta potenza.
Si tratta di un riconoscimento
che viene assegnato solo alle
aziende che conseguono lec-
cellenza in tutti i processi che con-
tribuiscono alla strategia di bu-
siness: dalla corretta identifica-
zione degli obiettivi e delle sfi-
de di mercato fino alla scelta
degli strumenti e delle politiche
per raggiungere il successo.
Laspetto tecnologico solo uno
dei parametri presi in conside-
razione per lassegnazione del
premio. Frost & Sullivan ha va-
lutato lapproccio complessivo
che Chloride adotta nei confronti
del mercato. Nello specifico
stata considerata la natura cu-
stomer centric, che non si li-
mita a fornire soluzioni di elevato
livello ma si caratterizza come un
vero e proprio partner per tutte
le aziende che fanno della con-
tinuit del servizio un punto
qualificante.
Ergonomia, design, processi di te-
sting e simulazione, attivit di
formazione e informazione e una
piattaforma di servizi - come il
sistema di telemonitoraggio in re-
moto life.net - ideata partendo
dalle concrete esigenze del mer-
cato: questi alcuni degli aspet-
ti che hanno determinato la de-
cisione di Frost & Sullivan.
Il riconoscimento certamen-
te motivo di orgoglio e soddi-
sfazione. Vediamo certificato da
un istituto di prestigio un ap-
proccio aziendale che stiamo
perseguendo da molti anni e che
ci vede protagonisti sia a livello
tecnologico sia nella costruzioni
di soluzioni globali che assicurino
ai clienti le pi ampie garanzie di
protezione dei loro sistemi vitali
ha commentato Giancarlo Battini,
managing director di Chloride Si-
lectron.
L
app Italia, specialista nella
produzione e distribuzione
di cavi per l'automazione e ac-
cessori per cavi, dal 1 agosto
si trasferita nella nuova sede di
Desio, sita nel "Polo tecnologico
della Brianza", un imponente
complesso che sorge nello spa-
zio della "Ex Autobianchi" e
ospita, su una superficie di oltre
253.000 metri quadrati, attivit
industriali e commerciali, unit ri-
cettive e ricreative.
Il cambiamento segna per Lapp
Italia un momento importante
di crescita, di rinnovamento e
di riorganizzazione.
Clienti, fornitori e partner po-
tranno beneficiare di una ge-
stione logistica notevolmente
migliorata, di un magazzino pi
ampio e quindi di una immedia-
ta disponibilit di prodotti grazie
anche allintroduzione di un nuo-
vo sistema informatico.
Una novit consiste nella pre-
senza di unampia sala confe-
renze destinata alla formazione
sia interna sia esterna: un am-
bizioso progetto che coinvolge-
r anche gli studenti.
PANORAMA
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004
7
servizio lettori 1786
I
l 4 e 5 dicembre a Forl, nel-
lambito della Grande fiera del-
lelettronica, ritorna un appun-
tamento atteso e curioso: il Con-
corso dell'inventore elettrico-
elettronico, che questanno
giunge alla decima edizione.
Il concorso aperto a tutti; chiun-
que ritenga di avere avuto unin-
tuizione innovativa e inedita, in
ambito elettro-elettronico, pu fa-
re domanda di partecipazione.
Liscrizione e la partecipazione so-
no completamente gratuite; le in-
venzioni proposte saranno esa-
minate da una giuria di esperti
che decreter il vincitore delle-
dizione 2004, che si aggiudi-
cher un oscilloscopio; tutti i
partecipanti riceveranno una
targa ricordo dellevento.
Ma al di l dei premi, il Concor-
so dell'inventore elettrico-elet-
tronico anche unoccasione
per mostrare le proprie invenzioni
al grande pubblico.
La Grande fiera dellelettroni-
ca, infatti, una vetrina impor-
tante, con oltre 20.000 visitato-
ri; un pubblico molto
interessato a idee di
nuove apparecchia-
ture: si pensi che va-
rie invenzioni pre-
sentate a Forl sono
state acquistate da
importanti aziende,
oppure gli stessi in-
ventori le hanno mes-
se "sul mercato" con
successo. Chi fosse
interessato a parteci-
pare deve fare do-
manda a Blu Nauti-
lus, indicando i propri dati, una
breve descrizione dellinvenzio-
ne presentata al concorso e even-
tuale documentazione fotografica.
Il progetto rimarr di propriet
dellinventore.
Sul sito www.blunautilus.it
possibile scaricare il modulo di
ammissione al concorso.
Il concorso
per gli inventori elettrici
Crescita e rinnovamento
Dopo il successo delledizione 2004, la sesta di
Solarexpo, mostra convegno internazionale su energie
rinnovabili, generazione distribuita e architettura
sostenibile, si svolger dal 19 al 21 maggio 2005 presso
la Fiera di Vicenza.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.solarexpo.com.
Il sole a Vicenza
Lapp Italia: la nuova sede di Desio
ONDA la nuova
gamma di l ampade d emergenza
professionale dellATS Elettronica che grazie alla variet cromatica
delle sue cornici la rende un oggetto perfettamente integrato nellambiente in
cui viene installato. ONDA disponibile nelle potenze 6w, 8w, 11w PL, 18w PL,
24w PL, sia in grado di protezione IP40 che in IP65 con versione tradizionale,
autodiagnosi e controllo centralizzato.
unOnda da incorniciare
83100 Avellino
Via Pianodardine, 1
tel +39 0825 628020 fax +39 0825 627850
numero verde 800 132525
Onda, la lampada demergenza professionale made in in Italy. atselettronica.it - info@atselettronica.it
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
1
0
Il tuo business ha bisogno di stabilita:
scegli la protezione assoluta
SOCOMEC SICON UPS Via della Tecnica,1 36030 Villaverla
(
VI
)
Tel. 0445 359111 Fax 0445 359222 E-mail: info.it.ups@socomec.com www.masterys.com
GRUPPO SOCOMEC INTERRUTTORI INDUSTRIALI E UPS
P
U
B
1
0
6
0
1
6
-
3
COME PROTEGGERE LE TUE
A P P L I C A Z I O N I S E N S I B I L I
I N Q U A T T R O M O S S E
PI SICURO PERCH?
Allinterno di ogni UPS tutti i componenti critici di
potenza e controllo sono ridondanti, per garantire
una disponibilit assoluta.
Una tecnologia a difesa del vostro business.
PI ECONOMICO PERCH?
Non solo protezione ma anche sensibilit al
consumo elettrico. MASTERYS
riduce al minimo il
valore di distorsione armonica verso la rete grazie
alla tecnologia IGBT (THDi < 3%).
Risparmiare il primo modo per guadagnare.
PI VERSATILE PERCH?
Di ffi ci l e non trovare l a gi usta confi gurazi one.
MASTERYS
rappresenta la gamma di UPS pi
completa per offerta in potenza, alimentazione e
personalizzazione delle configurazioni.
Per ogni vostra esigenza c una nostra soluzione.
PI INTELLIGENTE PERCH?
Pi disponibilit di servizio per una maggiore
capacit di gestione e controllo. MASTERYS
offre
linnovativo servizio e-Service via modem e via
Internet ed una connessione LAN integrata per il
completo controllo remoto dellUPS.
Gli abbiamo insegnato ad esprimersi meglio.
MASTERYS
M A K E Y O U R BUSI NESS SAFE
UPS da 8 a 90 kVA
n o v i t 2004
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
6
1
L
a svedese Perstorp, operante nel
settore delle specialit chimiche,
ha lanciato Polygiene, una serie
nuova di compound stampabili an-
tivirali e antibatterici destinati al-
la realizzazione di una vasta gam-
ma di apparecchiature elettriche
quali interruttori e relative plac-
che safe to touch. La formulazione
(patent-pending) delle masse da
stampaggio la prima ad essere sta-
ta testata e ad aver dimostrato di
poter eliminare, al contatto, il corona-
virus oltre ad una vasta gamma
di batteri e lieviti.
Le masse da stampaggio Polygie-
ne adottate per dispositivi elettri-
ci, grazie alle loro eccellenti carat-
teristiche antivirali e antimicrobiche,
contribuiscono a salvaguardare
questi prodotti dal diventare veicolo
di trasmissione di malattie e infezioni.
Secondo Lennart Holm, presidente
e Ceo della Perstorp, Risulta chia-
ro sia dagli studi cinesi sia da quel-
li italiani, che la resina antimicrobica
e antivirale Polygiene pu aiutare
lindustria elettrica a creare nuove
generazioni di dispositivi di uso
quotidiano safe to touch nor-
malmente usati nelle nostre case e
negli edifici pubblici.
Lazione antimicrobica pu essere
ottenuta senza compromettere le al-
tre propriet per cui le resine am-
miniche sono conosciute: resistenza
al graffio, buona finitura superfi-
ciale, stabilit termica nonch sta-
bilit cromatica in caso di esposizione
ai raggi UV.
PANORAMA
10
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Dispositivi elettrici
safe to touch
Il giusto spazio
servizio lettori 1634
Si concluso il XV convegno nazionale Git - Gruppo
italiano telesicurezza, lappuntamento annuale
organizzato da Hesa. Si trattato di un appuntamento
molto importante in quanto la Hesa, mantenendo fede
allimpegno di diffondere cultura nel mondo della
sicurezza ha organizzato questo convegno per
informare le aziende facenti parte del Git circa le nuove
normative su Impianti e sistemi di sicurezza: le
responsabilit civili e penali.
Il relatore del convegno stato lavvocato Antonio Oddo,
professore a contratto presso lUniversit di Pavia e
docente al Collegio europeo di Parma.
Dal convegno si pu dedurre la direzione intrapresa da
Hesa: fare cultura e informazione sia verso i propri
installatori sia verso l'utente finale, per essere
competitivi in un mercato che sta registrando altissimi
tassi di crescita ed quindi molto appetibile per tutti
coloro che vi operano.
Un convegno
per informare
D
al 1 luglio Eplan Italia ha una
nuova sede: lazienda si tra-
sferita nei pi ampi uffici di via
Achille Grandi 21 a Vimodrone,
proprio alle porte di Milano, dove
ha trovato una collocazione pi
consona alle esigenze di spazio da
dedicare non solo alle proprie ne-
cessit, ma anche a quelle dei clien-
ti. Maggiore accoglienza per gli
utenti, quindi, nella nuova sede
con uffici pi moderni e spazi at-
trezzati pi funzionali per le aule de-
dicate ai corsi di aggiornamento
e formazione, che da sempre co-
stituiscono una delle colonne por-
tanti dei servizi offerti da Eplan
Italia. Lo spostamento nella nuova
sede cade in concomitanza con
una data importante per Eplan Ita-
lia, che compie proprio questanno
i quindici anni di attivit.
Nuovi compound assicurano unazione antimicrobica a interruttori e placche
HOME OFFICE
Urmet ti invita a un nuovo sprint. Con tutti i prodotti di 2GO!, il sistema videocitofonico facile e veloce
da installare, raccogli punti e parti per un fantastico viaggio, verso il mare e il sole. 2GO! utilizza solo 2
fili non polarizzati in qualsiasi parte dell'impianto e in pi "Color Ready" perch la telecamera a colo-
ri di serie, lasciando all'utente la libert di scegliere il suo monitor, b/n o colori.
Facile linstallazione e facile partire,
con la grande iniziativa 2GO!
HOME & BUILDING
SOLUTIONS
HOME
@
www.urmetdomus.com
info@urmetdomus.it
OFFICE
To win
To go!
Per informazioni sul regolamento,
visita il sito www.urmetdomus.com
o chiedi il depliant al tuo distributore
sistema videocitofonico
a 2 fili non polarizzati
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
3
1
PANORAMA
12
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
0
5
Sulle armoniche di corrente
A
blerex Europe - filiale euro-
pea della multinazionale Tai-
wanese Uis Abler, che si occupa del-
la progettazione, produzione e
commercializzazione di Ups, i grup-
pi statici di continuit, e di filtri
attivi - e Eei - azienda attiva nel set-
tore del trasporto a fune e degli im-
pianti industriali della lavorazio-
ne del ferro, nella produzione di con-
vertitori e invertitori, filtri attivi e
sistemi rigenerativi - hanno rea-
lizzato, presso i Collegi dei periti di
Vicenza e Padova, due seminari
di aggiornamento sul tema: Ar-
moniche di corrente, il problema e
le soluzioni.
Finalit di tali incontri stata of-
frire ad un target specifico di pe-
riti industriali una soluzione in-
novativa ed efficace alla proble-
matica delle armoniche di cor-
rente che si possono generare
negli impianti con grosse appli-
cazioni di elettronica di potenza.
Durante i seminari si sono alter-
nati interventi degli addetti ai la-
vori di Ablerex ed Eei, che hanno
presentato le normative in studio
per regolamentare il problema e
offerto possibili ed efficaci soluzioni
allinquinamento delle reti causate
dalle armoniche di corrente.
Sono stati esposti i risultati, per
ora sperimentali, ottenuti con
una nuova struttura di filtro atti-
vo offerta da Ablerex in collabo-
razione con Eei.
Certificazione
ambientale
a Monza
P
hilips Italia ha ottenuto la cer-
tificazione ambientale Iso 14001
della propria sede di Monza per le
divisioni Corporate, CE-Elettroni-
ca di consumo, Dap-Piccoli elet-
trodomestici, Lighting e Semicon-
ductors.
Sgs ha verificato e attestato che il
sistema di gestione ambientale
creato da Philips Italia risulta essere
appropriato alla natura dellazienda
e coerente con quanto richiesto
dalla normativa Iso 14001.
La politica ambientale di Philips Ita-
lia risulta coerente con la politica
per lo sviluppo sostenibile - Su-
stainability Policy - del Gruppo
Philips nel mondo, che stabilisce gli
intenti generali dellorganizzazio-
ne e contiene limpegno alla pre-
venzione e al contenimento di tut-
te le sostanze pericolose e inquinanti
e al conseguente continuo miglio-
ramento.
In particolare, Philips Italia ade-
gua costantemente limpostazione
del proprio sistema di gestione
ambientale ai possibili cambia-
menti sia allinterno sia allesterno
dellorganizzazione.
Attraverso lottenimento della cer-
tificazione Iso 14001, Philips Italia
interpreta a livello locale la politi-
ca ambientale di Royal Philips Elec-
tronics, che si dichiara unazienda
eco-efficiente, convinta che per-
seguire obiettivi di miglioramento
negli aspetti ambientali sia anche
unopportunit di innovazione e
rinnovamento.
Un momento del seminario
di aggiornamento sulle armoniche
di corrente
servizio lettori 1617
PANORAMA
14
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Incontrare
linstallatore
di sicurezza
S
i tenuto recentemente a
Bologna il convegno: Il Vi-
deocontrollo Over IP: dallana-
logico al digitale, organizzato
da Excelsa in collaborazione con
Aips, Associazione installatori
professionali di sicurezza.
Le tematiche di grande attuali-
t, concentrate sulla migrazione
da analogico a digitale, hanno at-
tirato numerose societ ope-
ranti nel settore della sicurezza.
Lapertura a cura di Aldo Coro-
nati, presidente Aips, si con-
centrata sulla legge 46/90, at-
tualmente lunico riferimento
per il settore dellinstallazione e
manutenzione di impianti di si-
curezza, e sulla nuova legge in
materia di sicurezza privata che
il legislatore sta sviluppando.
Si sono poi alternati sulla scena
Riccardo Botrini, direttore di-
visione Rts (Real Time Secu-
ri ty), Davi de De Faveri , re-
sponsabile tecnico Rts, Dome-
nico Rossi, responsabile nuovi
prodotti Rts, di Excelsa, e Mau-
ro Bacchiocchi, Channel Deve-
lopment per il settore Svilup-
po Canali Web Solution di Te-
lecom Italia, presentando Ex-
celsa e la sua piattaforma di
Videocontrollo Over IP.
Settore elettrico:
segnali di crescita
L
indagine congiunturale svol-
ta dal Centro Studi Assistal
(che, allinterno di Confindustria,
rappresenta le societ che pro-
gettano, costruiscono e gesti-
scono impianti tecnologici) sul-
linstallazione dimpianti presen-
ta dati incoraggianti.
LOVATO ELECTRIC S.P.A.
COMPONENTI ELETTRICI
PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
VIA DON E. MAZZA, 12
24020 GORLE (BG) ITALIA
TEL. 035 4282111
FAX: 035 4282200
E-mail: info@LovatoElectric.com
www.LovatoElectric.com
Finecorsa
di posizione
e sicurezza
serie K
Rilevare la posizione di organi
mobili e operare la messa in
sicurezza delle macchine oggi
ancora pi facile e rapido grazie ai
nuovi finecorsa LOVATO Electric
serie KB (custodia plastica) e
serie KM (custodia metallica).
Dimensioni secondo EN 50047.
Massima rapidit e praticit
dinstallazione.
Fissaggio teste a baionetta.
Teste orientabili assialmente
ogni 45.
Leve regolabili a 360.
Teste metalliche
auto contenute ed
intercambiabili
con fissaggio a
baionetta.
Contatti ausiliari
estraibili.
Massima rapidit
e praticit
nel cablaggio.
c
l
a
r
o
@
c
y
b
e
r
g
.
i
t
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
5
7
1
In particolare, il comparto elettrico
sembra beneficiare del rivitalizzarsi
del mercato, mentre restano so-
stanzialmente stazionari, nelle
previsioni, i risultati del compar-
to termico e delle telecomunica-
zioni.
Lanalisi per dimensione azien-
dale evidenzia segnali incorag-
gianti per le aziende con un nu-
mero di addetti superiore a 35,
mentre rimangono in linea con il
periodo precedente le previsioni
per gli altri due comparti (inferiore
a 10 addetti e compresi tra 11 e 35
addetti).
Protezione
in aeroporto
M
T Distribuzione, giovane
azienda attiva nel settore
della consulenza e della com-
mercializzazione di sistemi in-
tegrati per la sicurezza e lau-
tomazione, ha recentemente
contribuito alla realizzazione del
sistema antintrusione dellAe-
roporto Valerio Catullo di Villa-
franca a Verona. Lazienda ha
collaborato, innanzitutto, in qua-
lit di fornitore del materiale ne-
cessario ed ha affiancato lin-
stallatore A. Esse nella messa in
opera dellimpianto, seguendo
accuratamente sia laspetto soft-
ware sia hardware. Per la rea-
lizzazione dellimpianto sono
stati adottati un sistema di pro-
tezione perimetrale esterno, che
rileva larrampicamento e il taglio
di recinzioni attraverso sensori,
e unit elettroniche ad elevata ca-
pacit di analisi e una centrale
espandibile gestita a micropro-
cessore per alta sicurezza.
Cronotermostati da parete
EVO.X BIANCO
Codice Kit KT001600
EVO.X NERO
Codice Kit KT002400
DAFNE
Codice Kit KT006500
Kit EVO.X a 155 Euro
*
!
Cronotermostati da incasso estraibili
Kit DAFNE a 160 Euro
*
!
E
in
p
i
2
5
P
u
n
t
i
p
r
e
m
io
!
E
in
p
i
2
5
P
u
n
t
i
p
r
e
m
io
!
Promozione Kit EV
Operazione a premi denominata Vemer premia la tua fedelt.
www. vemersi ber. i t
Se acquisti ora i kit da 3 cronotermostati
hai diritto a questa imperdibile superofferta:
*
Cad. netto IVA esclusa.
servizio lettori 1750
Con Vemer chi va forte prende i punti.
E porta a casa tanti premi.
VO.X e Kit DAFNE
Valida fino al 31/12/2004, salvo esaurimento scorte.
La tua fedel t
meri ta un premi o.
VemerHappy
COLLECTION
Gran Catalogo Premi 2004
C
A
T00307 - dcsp 0704
Da settembre a dicembre
Grande Promozione Vemer!
Raccogli i punti in regalo
su molti prodotti della nostra
gamma, potrai scegliere gli
splendidi premi selezionati
per te nel catalogo
Vemer Happy Collection 2004.
Regolamento depositato presso Elite Progetti S.r.l. Gessate (MI)
I
l codice sulla privacy fa dis-
cutere le imprese, soprattut-
to quelle piccole. Gli adem-
pimenti per la protezione dei da-
ti, imposti dallAutorit garan-
te, infatti, sono troppo onerosi per
le piccole imprese e poco adatti
alla dimensione dellazienda. Il
Codice sulla privacy resta al cen-
tro delle preoccupazioni del mon-
do produttivo pur con il differi-
mento dei termini per ladozione
delle nuove misure minime di
sicurezza stabilito nel decreto
158/2004 (pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 147 del 25 giu-
gno 2004).
La nuova normativa ha un impatto
impegnativo sulle imprese sia
sul piano della predisposizione dei
sistemi di sicurezza per la tute-
la dei dati personali sia per i co-
sti che si dovranno sopportare per
osservare questa norma. La leg-
ge impone che i dati sensibili
siano tutelati da tutti i soggetti
che li posseggono. Rimanendo
strettamente legati alla piccola im-
presa si pensi ad unimpresa con
due dipendenti, o con un ap-
prendista, oppure ad unaltra
con dei collaboratori che pos-
siedono, in ragione dei rapporti
di lavoro, informazioni.
Da un punto di vista operativo la
legge impone che tutte le azien-
de artigianali, commerciali, in-
dustriali, e tutti i soggetti (anche
onlus, di volontariato etc.), che de-
tengono dati di questo tipo, do-
vranno investire anche in con-
sulenza al fine di poter rispetta-
re la legge.
Se poi pensiamo a particolari ti-
pi di attivit, per esempio le-
stetista, il parrucchiere, lodon-
totecnico e lottico, oltre ai dati
sensibili relativi al personale, si
possono avere, in alcuni casi, in-
formazioni sullo stato di salute dei
propri clienti, necessari per le-
sercizio dellattivit. Queste im-
prese saranno obbligate a redi-
gere un voluminoso e complesso
Documento programmatico del-
la sicurezza. Baster, per esem-
pio, che unestetista compili sche-
de in cui siano contenuti casi di
allergie ai cosmetici dei propri
clienti e per legge scatter lob-
bligo in questione. Le piccole
imprese, ma non solo loro, la-
mentano quindi un aumento dei
costi ma anche un ulteriore ag-
gravio burocratico nellesercizio
dellattivit. Cos, anzich sem-
plificare, si rischia di andare ver-
so la complicazione della vita
dellapparato produttivo nazionale
costituito per lo pi da piccole im-
prese. Tra laltro, senza nessun
beneficio in termini di valore ag-
giunto al prodotto o al servizio che
deve essere commercializzato,
esportato, venduto.
Resta tuttavia lobbligo di ri-
spettare le norme nella speran-
za che il Garante intervenga a fa-
vore di una semplificazione ad
hoc, almeno per le piccole im-
prese. Vediamo ora nel detta-
glio cos il Codice della privacy
e quali sono le sue norme: il de-
creto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003, denominato Codice
in materia di protezione dei da-
ti personali entrato in vigore
il 1 gennaio 2004 e rappresenta
il primo tentativo al mondo di
comporre in maniera organica le
innumerevoli disposizioni rela-
tive, anche in via indiretta, alla pri-
vacy, o meglio libert personale.
Esso riunisce in unico contesto la
legge 675/1996 e gli altri decre-
ti legislativi, regolamenti e codici
deontologici che si sono succeduti
in questi anni, e contiene anche
importanti innovazioni tenendo
conto della giurisprudenza del
Garante e della direttiva UE
2000/58 sulla riservatezza nelle
comunicazioni elettroniche.
Il Testo unico ispirato allin-
troduzione di nuove garanzie
per i cittadini, alla razionalizza-
zione delle norme esistenti e al-
A proposito
di privacy
ATTUALIT
Un provvedimento one-
roso e complicato per le
imprese: slittano i ter-
mini al 31 dicembre, ma
gli adempimenti restano
pesanti
18
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Roberta Leprotti
F
o
t
o
:
A
.
P
a
g
a
n
i
NUOVO CODICE DELLA PRIVACY
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
la semplificazione degli adem-
pimenti e sostituisce la legge
675 del 1996 sulla protezione dei
dati.
Il Codice ha quindi confermato ed
aggiornato la disciplina in materia
di sicurezza dei dati personali e
dei sistemi informatici e tele-
matici introdotti nel 1996. In par-
ticolare, stato confermato il
principio secondo cui le misure
minime sono solo una parte de-
gli accorgimenti obbligatori in
materia di sicurezza (articolo 33
del Codice) ma di tale impor-
tanza da indurre il legislatore a
prevedere anche una sanzione pe-
nale.
Si confermano due obblighi di-
stinti, come nella 675/96:
a) Obbligo pi generale di ridur-
re al minimo determinati ri-
schi: i dati personali oggetto
di trattamento devono essere
custoditi e controllati per con-
tenere al massimo il rischio
di distruzione o dispersione
anche accidentale. Resta lob-
bligo, oltre alle cosiddette
misure minime, di adottare
ogni misura adatta a valutare
i rischi (articolo 31). Come in
passato, linosservanza di que-
sto obbligo rende il tratta-
mento illecito anche se non si
determina danno per gli in-
teressati; viola inoltre i loro di-
ritti, compreso il diritto fon-
damentale alla protezione dei
dati personali che pu essere
esercitato nei confronti del ti-
tolare del trattamento (arti-
coli 1 e 7, comma 3), ed espo-
ne a responsabilit civile per
danno anche non patrimo-
niale qualora, davanti al giu-
dice ordinario, non si dimo-
stri di avere adottato tutte le
misure idonee ad evitarlo (ar-
ticoli 15 e 152);
b) Il dovere di adottare in ogni ca-
so le misure minime: nel
quadro degli accorgimenti pi
ampi da adottare, occorre as-
sicurare comunque un livello
minimo di protezione dei da-
ti personali. Pertanto il Codi-
ce conferma che lomessa ado-
zione delle indispensabili mi-
sure minime (indicate anali-
ticamente nelle 29 regole in-
cluse nellAllegato B del Co-
dice) costituisce anche reato
(articolo 169 che prevede lar-
resto fino a due anni o lam-
menda da 10mila a 50mila eu-
ro e leventuale ravvedimento
operoso di chi adempie pun-
tualmente alle prescrizioni
del Garante una volta accer-
tato il reato ed effettua un
pagamento in sede ammini-
strativa, ottenendo cos le-
ATTUALIT A PROPOSITO DI PRIVACY
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 19
STRUTTURA ORGANIZZATA
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
3
7
MISURE DI SICUREZZA
MISURE DI SICUREZZA
stinzione del reato).
Il Codice diviso in tre parti:
- la prima dedicata alle dispo-
sizioni generali, riordinate in
modo tale da trattare tutti gli
adempimenti e le regole del
trattamento con riferimento ai
settori pubblico e privato;
- la seconda la parte speciale de-
dicata a specifici settori. Que-
sta sezione, oltre a disciplinare
aspetti in parte inediti (infor-
mazione giuridica, notificazioni
di atti giudiziari, dati sui com-
portamenti debitori), comple-
ta anche la disciplina attesa da
tempo per il settore degli or-
ganismi sanitari e quella dei
controlli sui lavoratori;
- la terza affronta la materia del-
le tutele amministrative e giu-
risdizionali con il consolida-
mento delle sanzioni ammini-
strative e penali e con le dis-
posizioni relative allUfficio del
Garante.
Come si diceva il nuovo Codice
impone oneri e difficolt alle pic-
cole imprese; tuttavia dobbia-
mo riconoscere che in una so-
20
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
ATTUALIT A PROPOSITO DI PRIVACY
I RUOLI PRIMA DEL CODICE
I RUOLI CON IL NUOVO CODICE
- Per la generalit dei casi, il 31 dicembre 2004, invece
del 30 giugno 2004 (anche per la redazione del Docu-
mento programmatico sulla sicurezza);
- per i casi in cui, alla data del 31 dicembre 2003, il ti-
tolare fosse stato in possesso di strumenti elettroni-
ci tecnicamente inadeguati, il 31 marzo 2005, invece
del 31 dicembre 2004.
f
o
c
u
s
I nuovi termini
NUOVO CATALOGO ELETTRICI
F.lli AMOS& C. S.p.A.
Viale Europa 68/70, I-20093 COLOGNO M. (MI) - ITALIA
Tel. 02 251111.1 - Telefax 02 2538379
www.amos.it - e-mail: amos@amos.it
TORINO COLOGNO M. PADOVA BOLOGNA ROMA NAPOLI CATANIA
Impugnatura
anatomica bicomponente
con bloccaggio
automatico della lama
Cappuccio e
anello in morbida
gomma per lavori
di precisione
Set compatto di utensili VDE
con 12 lame intercambiabili
1000 V
DIN EN 60900
CATALOGO ELETTRICI
R i c h i e d e t e l o
al vostro rivenditore
E smart
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
3
9
TABELLA 1 - AUTENTICAZIONE INFORMATICA
Che cos?
Il trattamento dei dati consentito solo mediante lutilizzo di una credenziale
di autenticazione (USER-ID pi password riservata; dispositivo di autenticazione -
es. smartcard - eventualmente associato a utenza o password; caratteristica biometrica
eventualmente associata a utenza o password);
Tutti gli incaricati devono essere dotati di credenziale di autenticazione.
Come deve essere la user-ID?
Individuale;
Non riutilizzabile;
Disattivata in caso di mancato utilizzo (6 mesi eccetto che per le utenze tecniche)
o di perdita della qualit;
Ogni utente pu comunque disporre di pi credenziali di autenticazione.
Come deve essere la password?
Lunga almeno 8 caratteri, o il massimo consentito dal sistema;
Modificata al primo utilizzo e comunque ogni 6 mesi (ogni 3 mesi se utilizzata
per accedere a dati sensibili o giudiziari);
Non contenente riferimenti riconducibili allincaricato.
Come deve essere gestita?
Il Titolare fornisce istruzioni agli incaricati in merito a:
Gestione e conservazione delle credenziali di autenticazione;
Custodia degli eventuali dispositivi di autenticazione;
Gestione e custodia dello strumento elettronico durante le sessioni di trattamento;
Modalit di accesso ai dati, in caso di assenza prolungata o impedimento dellincaricato,
per esigenze organizzative e di sicurezza aziendale.
Scopri i vantaggi
dellImpianto Elettrico Integrato
S
i
c
u
r
e
z
z
a
D
e
s
i
g
n
F
u
n
z
i
o
n
a
li
t
S
ic
u
r
e
z
z
a
D
e
sig
n
Funzionalit
Sicurezza Design Funzionalit Sicurezza
D
esig
n
F
u
n
z
io
n
a
lit
S
i
c
u
r
e
z
z
a
D
e
LImpianto Elettrico Integrato
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
5
5
22
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
ATTUALIT A PROPOSITO DI PRIVACY
ciet civilmente sviluppata non
pu non esistere, tra le qualit
proprie dellattivit di produzio-
ne e di distribuzione, la tutela dei
dati personali. Cos come ha sta-
bilito la Carta dei diritti fonda-
mentali dellUnione Europea ri-
conoscendo che la protezione
dei dati personali costituisce un
diritto della persona, autonomo
e distinto dalla generale tutela del-
la vita privata. Nel seguito ven-
gono analizzati alcuni dei punti
rilevanti del testo, che in molte
parti recepisce e codifica le nu-
merose pronunce emanate e i
pareri forniti in questi anni dal Ga-
rante.
SANIT
In ambito sanitario si semplifica
linformativa da rilasciare agli
interessati e si consente di ma-
nifestare il necessario consen-
so al trattamento dei dati con
ununica dichiarazione resa al
medico di famiglia o allorganismo
sanitario (il consenso vale an-
che per la pluralit di trattamenti
a fini di salute erogati da distin-
ti reparti e unit dello stesso or-
ganismo, nonch da pi strut-
ture ospedaliere e territoriali).
Per il settore sanitario vengono
inoltre codificate misure per il
rispetto dei diritti del paziente:
distanze di cortesia, modalit
per appelli in sale di attesa, cer-
tezze e cautele nelle informa-
zioni telefoniche e nelle infor-
mazioni sui ricoverati, estensio-
ne delle esigenze di riservatezza
anche agli operatori sanitari non
tenuti al segreto professionale.
Vengono introdotte (a partire
dal 1 gennaio 2005) le cosid-
dette ricette impersonali, la pos-
sibilit cio di non rendere sem-
pre e in ogni caso immediata-
mente identificabili in farmacia gli
intestatari di ricette attraverso un
tagliando predisposto su carta co-
piativa che, oscurando il nome e
lindirizzo dellassistito, consen-
te comunque la visione di tali
dati da parte del farmacista nei
casi in cui sia necessario. Per i da-
ti genetici viene previsto il rila-
scio di unapposita autorizza-
zione da parte del Garante, sen-
tito il Ministro della salute. Per
quanto riguarda le cartelle cliniche
sono previste particolari misu-
re per distinguere i dati relativi
al paziente da quelli eventual-
mente riguardanti altri interessati
(comprese le informazioni relative
ai nascituri), ma anche specifiche
cautele per il rilascio delle cartelle
cliniche a persone diverse dal-
linteressato.
LAVORO
Viene confermata lelaborazio-
ne di un codice di deontologia e
buona condotta che dovr fissa-
re regole per linformativa ed il
consenso anche degli annunci
per finalit di occupazione (se-
lezione del personale) e della ri-
cezione dei curricula. Il Codice af-
fronta anche la questione dei
controlli a distanza con la riaf-
fermazione di quanto sancito
dallarticolo 4 dello Statuto dei la-
voratori (legge 300/1970). Il la-
voratore domestico tenuto a
mantenere la necessaria riser-
vatezza per tutto quanto si rife-
risce alla vita familiare.
TRATTAMENTO
DATI PERSONALI
IN AMBITO GIUDIZIARIO
Vengono meglio garantiti i di-
ritti della personalit delle parti.
Il Codice prevede anche che lin-
teressato possa chiedere, nel
processo, di apporre sulla sen-
tenza unannotazione con la qua-
le si avvisa che, in caso di pub-
blicazione del verdetto su riviste
giuridiche o su supporti elettro-
nici o di diffusione telematica,
devono essere omessi i dati del-
Tecno Service Building & Lighting Automation Service Hotel
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Completa gestione del clima, illuminazione, sicurezza con protocollo TCP-IP su reti LAN
Service Hotel: lautomazione per Hotel e comunit
Tecno Service: la versione per lindustria, gli uffici, i teatri, ecc.
Lilluminazione con scenari comandata col touch screen o mouse
Il quadro elettrico gestito dal Computer
La centrale termica completamente automatizzata e sotto controllo
con ALTECON sempre al passo coi tempi, sempre un passo pi avanti
Via F.lli Cairoli, 17 - 20035 LISSONE (MI) Tel. 039.6853048 Fax 039.6081406 e-mail info@altecon.it
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
1
6
0
TABELLA 2 - ALTRE MISURE
Misure per tutti i dati personali
Ambito di trattamento - aggiormanento periodico e verifiche (almeno annuali) dellambito
di trattamento consentito agli incaricati e redazione della lista degli incaricati;
Antintrusione (antivirus, firewall) - installazione ed aggiornamenti (almeno ogni 6 mesi);
Patch di sicurezza - aggiornamenti periodici dei software volti a prevenire la vulnerabilit
di strumenti elettronici e a correggere difetti (almeno annualmente; ogni 6 mesi in caso
di trattamento di dati sensibili);
Backup - istruzioni tecniche ed organizzative per il salvataggio dei dati (almeno
ogni settimana).
Misure specifiche per i dati sensibili
Supporti rimovibili (anche cartacei) - istruzioni organizzative e tecniche per la loro custodia,
il loro uso, la loro distruzione e per la cancellazione delle informazioni contenute;
Ripristino dei dati - adozione di idonee misure per il ripristino in caso di danneggiamento
dei dati e/o degli strumenti (entro 7 giorni);
Firewall - attivazione di idonei strumenti elettronici contro laccesso abusivo;
Accesso agli archivi (anche cartacei) - accesso autorizzato, controllato e registrato
dopo lorario di ufficio.
Misure di tutela e garanzie
Il Titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni
alla propria struttura, per provvedere allesecuzione riceve dallinstallatore
una descrizione scritta dellintervento effettuato che ne attesta la conformit
alle disposizioni del disciplinare tecnico.
STRUMENTI PRIMA DEL CODICE
SEMPLIFICAZIONE
STRUMENTI
CON IL NUOVO CODICE
Artt. 4 - Definizioni
Artt. 32/33 - Misure
di Sicurezza
Artt. 33/36 - Misure Minime
di Sicurezza
Allegato B - Disciplinare tecnico
Art. 15 - Risarcimento danni
Art. 169 - Sanzioni penali
Art. 180 - Disposizioni
transitorie
MISURE DI SICUREZZA NORMATIVA
*
D
a
t
i
D
e
m
o
s
k
o
p
e
a
2
0
0
3
e servizi esclusivi
P e r s u p p o r t a r e l a
progettazione con servizi
all'avanguardia.
Software, manuali e guide tecniche per
garantire valore aggiunto alle attivit di
progettazione: il prodotto si sposa con il
s er vi zi o dando vi t a a s ol uzi oni
tecnologicamente sempre pi avanzate.
Per forni re sol uzi oni di
qualit, in tutta sicurezza.
Si cur ezza, des i gn e f unzi onal i t per
soddisfare ogni desiderio e necessit:
l'impianto elettrico diventa sinonimo di
sicurezza e rende semplice e piacevole il
vivere quotidiano.
I ns i e
m
e
p
e
r
i
l
f
u
t
u
r
o
I
n
s
t
a
l
l
a
t o
r
e
P e r pr opor r e un
impianto integrato,
oltre il prodotto.
Sviluppo come costante della
gestione alla base di un'offerta con
pi di 15.000 referenze in un unico
ordine, per ottimizzare la gestione
del magazzi no e svi l uppare
vantaggiose economie di scala.
D
i
s
t
r
i
b
u
t o
r
e
C
o
m
m
i
t
t
e n
t
e
Per garantire grande risparmio di tempo
e risorse.
L'unico sistema d'impianto che assicura totale coordinamento
delle soluzioni per design e funzionalit e modalit di
installazione e manutenzione concretamente semplificate.
Cataloghi, depliant e listini per unofferta chiara e completa. Il portale pi visitato*, per avere il mondo GEWISS a portata di mano.
Software, manuali, guide e formazione per promuovere cultura d'impianto. Un Servizio Assistenza Tecnica personalizzato, anche on-line.
GEWISS CLUB: un aggiornamento gratuito e tempestivo sulla realt GEWISS. Consegne in 48 ore con 80.000 m
2
di magazzino informatizzato.
gewi ss. com LImpianto Elettrico Integrato
Un mondo di certezze
P
r
o
g
e
t
t
i s
t
a
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
5
6
24
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
ATTUALIT A PROPOSITO DI PRIVACY
linteressato. La versione della
sentenza cos pubblicata va sem-
pre criptata quando si tratta di
minori. Con disposizione espres-
sa si attribuisce maggiore tute-
la ai minori non solo nel proces-
so penale, ma anche nei proce-
dimenti civili e amministrativi.
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Il Codice innova anche, racco-
gliendo indicazioni del Garante,
nella materia della notificazio-
ne degli atti giudiziari e degli
atti amministrativi e impone la re-
gola della busta chiusa per i ca-
si di notifica effettuata a perso-
na diversa dal destinatario. Vie-
ne sancita espressamente la ne-
cessit per gli enti pubblici di
approvare regolamenti per i trat-
tamenti dei dati sensibili, ma so-
lo con il parere conforme del Ga-
rante.
LISTE ELETTORALI
Le liste elettorali non possono
essere pi usate per promozione
commerciale, ma solo per scopi
collegati alla disciplina elettora-
le e per finalit di studio, ricerca
statistica, scientifica o storica o
a carattere socio assistenziale.
TELECOMUNICAZIONI
I cittadini potranno meglio sce-
gliere se essere inseriti nellelenco
telefonico o le modalit con le
quali comparire sullelenco: po-
tranno decidere, in particolare,
se far usare i loro numeri tele-
fonici e indirizzi anche per in-
formazioni commerciali o solo
per comunicazioni interperso-
nali.
SPAMMING
Linvio di messaggi attraverso
sistemi automatizzati (sms, mms,
fax, posta elettronica) richiede il
consenso degli interessati. Il
cliente deve essere informato
della possibilit di opporsi a
messaggi indesiderati.
SETTORI PARTICOLARI
Per internet, videosorveglianza,
direct marketing, centrali ri-
schi private, il codice confer-
ma la previsione di appositi co-
dici deontologici che fissano re-
gole specifiche.
SANZIONI
Sanzioni pecuniarie e penali au-
mentate per chi viola la privacy,
in particolare per luso dei dati
senza consenso degli interessa-
ti, per il mancato adempimento
nei confronti di un provvedi-
mento del Garante, per la man-
cata informativa agli interessati
sulluso che si intende fare dei da-
ti che li riguardano.
MISURE DI SICUREZZA
Vengono rafforzate, in un quadro
di evoluzione tecnologica, le mi-
sure di sicurezza contro i rischi di
distruzione, intrusione o uso im-
proprio. Alle precauzioni gi pre-
viste nella normativa precedente
(password, codici identificativi,
antivirus...) che sono entrate in vi-
gore il 1 gennaio 2004, se ne ag-
giungono altre come: password di
non meno di otto caratteri, au-
tenticazione informatica, sistemi
di cifratura, procedure per il ri-
pristino dei dati, eccetera.
NOTIFICAZIONE
Semplificata la notificazione, ov-
Geo,lerogatore
di dimensioni ridotte
non pi
sporgenze
di cavi con
spine
inserite!
con spine da 32A inserite
con spine da 16A inserite
620.0
580.0
300.0
via DellArtigianato,2/4 - LUGO (Ra)
tel. 0545 32900 - 25413 ric. aut.
Fax 0545 32932
e-mail: info@gigieffe.com
web site: www.gigieffe.com
M
O
D
E
L
LO
COMUNITARIO DEPOSITATO
-
EU
D
E
P
O
S
IT
E
D
M
O
D
E
L
N
o
v
it
2
0
0
4
Aquarius
Sistema
prepagato
Erogatori per uso esterno IP44/66 adatti per:
Porti turistici - Campeggi - Villaggi turistici - Terziario - Aree di mercato
Allacciamenti mobili. Gamma completa fino 250A.
Versioni standard, con sistema Prepagato e gamma Antincendio.
Vano
porta apparecchi
CS IMQ IP44/66
Vano
porta apparecchi
IP44/66
servizio lettori 1497
DISCIPLINARE TECNICO
In confronto al Regolamento del DPR 318/99 il Disciplinare Tecnico:
Rappresenta un salto di qualit
Ha maggior chiarezza
svincolato da situazioni tecnologiche
Rafforza le misure minime e d maggiori garanzie
Presta particolare attenzione ai dati sulla salute
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Rappresentano il livello minimale
Non rappresentano lobiettivo voluto dalla legge misure idonee
Elenco predefinito (Allegato B)
Identificate nel disciplinare tecnico incluso nel Codice Privacy (Allegato B)
SANZIONI
Mancata adozione misure idonee
Risarcimento danno patrimoniale e non ex art. 2050 codice civile
Mancata adozione misure minime
Sanzione penale - Titolare, responsabile, incaricato
Risarcimento danno patrimoniale e non ex art 2050 codice civile
C
e
n
t
r
a
l
i
n
o
A
C
T
I
V
O
R
E
S
T
A
R
T
c
o
n
A
U
T
O
T
E
S
T
C
O
M
A
N
D
O
P
E
R
R
E
S
T
A
R
T
R
E
M
O
T
O
L
A
M
P
A
D
A
A
N
T
I
B
L
A
C
K
-
O
U
T
C
A
R
I
C
H
I
N
O
N
P
R
I
O
R
I
T
A
R
I
S
E
G
N
A
L
A
Z
I
O
N
E
A
C
T
I
V
O
g
e
w
i
s
s
.
c
o
m
L
I
m
p
i
a
n
t
o
E
l
e
t
t
r
i
c
o
I
n
t
e
g
r
a
t
o
R
i
v
o
l
u
z
i
o
n
a
r
i
o
d
i
s
p
o
s
i
t
i
v
o
d
i
r
i
a
r
m
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
o
p
e
r
i
n
t
e
r
r
u
t
t
o
r
i
d
i
f
f
e
r
e
n
z
i
a
l
i
,
c
o
n
v
e
r
i
f
i
c
a
d
e
l
l
i
m
p
i
a
n
t
o
.
D
a
o
g
g
i
f
u
l
m
i
n
i
o
s
o
v
r
a
c
c
a
r
i
c
h
i
n
o
n
s
o
n
o
p
i
u
n
p
r
o
b
l
e
m
a
:
m
a
i
p
i
s
i
s
t
e
m
i
d
i
a
l
l
a
r
m
e
s
c
o
l
l
e
g
a
t
i
,
f
r
i
g
o
r
i
f
e
r
i
s
c
o
n
g
e
l
a
t
i
o
a
p
p
a
r
e
c
c
h
i
d
i
s
a
t
t
i
v
a
t
i
.
R
E
S
T
A
R
T
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e
c
o
n
l
'
e
s
c
l
u
s
i
v
a
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
A
U
T
O
T
E
S
T
,
p
e
r
l
'
a
u
t
o
d
i
a
g
n
o
s
i
s
e
t
t
i
m
a
n
a
l
e
d
e
l
d
i
f
f
e
r
e
n
z
i
a
l
e
s
e
n
z
a
t
o
g
l
i
e
r
e
a
l
i
m
e
n
t
a
z
i
o
n
e
a
l
l
'
i
m
p
i
a
n
t
o
.
L
a
S
e
r
i
e
i
n
s
t
a
l
l
a
b
i
l
e
n
e
l
c
e
n
t
r
a
l
i
n
o
A
C
T
I
V
O
,
u
n
a
c
e
n
t
r
a
l
e
d
i
c
o
n
t
r
o
l
l
o
d
e
l
l
'
i
m
p
i
a
n
t
o
e
l
e
t
t
r
i
c
o
.
B
I
O
C
O
M
F
O
R
T
I
N
T
E
R
R
U
T
T
O
R
I
M
A
G
N
E
T
O
T
E
R
M
I
C
I
C
O
M
P
A
T
T
I
D
I
F
F
E
R
E
N
Z
I
A
L
E
A
U
T
O
T
E
S
T
C
O
N
R
E
S
T
A
R
T
R
i
a
c
c
e
n
d
e
l
a
t
u
a
v
i
t
a
servizio lettori 1757
26
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
ATTUALIT A PROPOSITO DI PRIVACY
vero latto con cui limpresa, il pro-
fessionista o la pubblica ammi-
nistrazione segnala allAutori-
t i trattamenti di dati che in-
tende effettuare.
La notifica dovr essere effet-
tuata solo in particolari casi di
trattamento di dati sensibili (spe-
cie se sanitari) con determinate
modalit duso, ma anche per
trattamenti particolarmente a
rischio, effettuati con strumen-
ti elettronici, nel campo della
profilazione dei consumatori, op-
pure in relazione a procedure di
selezione del personale e ricer-
che di marketing, nonch in ipo-
tesi di utilizzo di informazioni
commerciali e relative alla sol-
vibilit.
Diminuiscono le ipotesi di noti-
fica obbligatoria, e vengono snel-
lite anche le modalit della stes-
sa: solo per via telematica, se-
guendo le indicazioni del Ga-
rante quanto allutilizzo della
firma digitale.
CONSENSO
Il codice della privacy sviluppa
il principio del bilanciamento
degli interessi con uno snelli-
mento degli adempimenti a ca-
rico delle aziende.
Resta sostanzialmente confer-
mata la necessit del consen-
so, ma si prevedono alcune altre
ipotesi di esonero con riferi-
mento a settori specifici.
INFORMATIVA
Rimane fermo ladempimento
dellinformativa agli interessati
preventiva al trattamento dei
dati.
Il Garante pu, comunque, in-
dividuare modalit semplifica-
te in particolare per i servizi te-
lefonici di assistenza e informa-
zione al pubblico (call center).
UNAOHM START S.p.A.
Via Di Vittorio 49 20068 - Peschiera Borromeo (MI) Italy
Tel 02.51665.1 Fax 02 51650195
info@unaohm.it www.unaohm.it
pi Piccolo,
pi Leggero,
pi UNAOHM
i
n
f
o
@
p
r
o
l
o
.
i
t
Sempre primi dal 1935.
La leggerezza, la trasportabilit e le dimensioni con una profondit di soli
24 cm, rendono veramente unico questo piccolo strumento.
Nasce come combinato Tv-Sat e puoi personalizzarlo con COFDM o
QPSK oppure QAM .
I L N U O V O M I S U R A T O R E D I C A M P O .
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
8
0
3
ULTERIORI NOVIT DEL DISCIPLINARE
Doppio controllo di accesso informatico:
autenticazione
autorizzazione
Robustezza password: obbligo di almeno 8 caratteri (numeri e lettere)
Vulnerabilit: obbligo di installazione di antivirus e firewall e di aggiornamento
almeno ogni 6 mesi
Salvataggi/ripartenze
Separazione dei dati identificativi dai dati sanitari
Relazione a bilancio
SISTEMA PROFILO DI AUTORIZZAZIONE
Cos il sistema di autorizzazione?
Linsieme di strumenti e procedure che abilitano laccesso ai dati e alle modalit
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente
Cos il profilo di autorizzazione?
Linsieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente
di individuare a quali dati essa pu accedere, nonch i trattamenti ad essa consentiti
assegnato al singolo incaricato o per classi omogenee
I criteri del profilo sono individuati preventivamente
Esistono criteri di revoca del profilo stesso
Sono svolte verifiche periodiche sui criteri assegnati
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA-DPS
Cos?
una delle misure minime di sicurezza elencate nel disciplinare tecnico
Va aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno (con esclusione del 2004 per cui sono
stati differiti i termini)
obbligatorio per i dati sensibili/giudiziari trattati elettronicamente
Non obbligatorio ma obbligato in relazione a tutti i dati
Sintetizza la Policy di sicurezza adottata
il prerequisito per le misure idonee
Contenuto del DPS:
Elenco dei trattamenti
Analisi dei rischi
Distribuzione dei compiti e delle responsabilit
Misure adottate
Salvataggio e ripristino dei dati
Education degli incaricati
Sicurezza dei dati affidati in gestione a terzi
Separazione dei dati sanitari dai dati identificativi della persona
I
l
n
u
o
v
o
c
r
o
n
o
t
e
r
m
o
s
t
a
t
o
a
r
a
d
i
o
f
r
e
q
u
e
n
z
a
S
e
r
i
e
S
Y
S
T
E
M
R
F
,
a
t
t
i
v
a
b
i
l
e
a
n
c
h
e
v
i
a
t
e
l
e
f
o
n
o
,
p
e
r
m
e
t
t
e
d
i
g
e
s
t
i
r
e
i
l
c
l
i
m
a
d
a
q
u
a
l
s
i
a
s
i
p
u
n
t
o
d
e
l
l
a
c
a
s
a
:
i
n
c
u
c
i
n
a
,
i
n
s
o
g
g
i
o
r
n
o
o
i
n
c
a
m
e
r
a
d
a
l
e
t
t
o
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
p
i
a
d
a
t
-
t
a
i
n
o
g
n
i
m
o
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
g
i
o
r
n
a
t
a
.
T
u
t
t
o
q
u
e
s
t
o
s
e
n
z
a
o
p
e
r
e
m
u
r
a
r
i
e
,
g
r
a
-
z
i
e
a
l
l
a
r
i
v
o
l
u
z
i
o
n
a
r
i
a
t
e
c
n
o
l
o
g
i
a
s
e
n
z
a
f
i
l
i
.
I
l
c
r
o
n
o
s
t
e
r
m
o
s
t
a
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
o
i
n
u
n
s
i
s
t
e
m
a
d
i
c
o
m
a
n
d
o
e
c
o
n
t
r
o
l
l
o
a
r
a
d
i
o
f
r
e
q
u
e
n
z
a
,
p
e
r
t
o
t
a
l
e
l
i
b
e
r
t
d
i
s
c
e
l
t
a
.
S
Y
S
T
E
M
R
F
T
a
g
l
i
a
i
f
i
l
i
c
o
l
p
a
s
s
a
t
o
D
e
s
i
g
n
e
r
g
o
n
o
m
i
c
o
p
e
r
l
a
m
a
s
s
i
m
a
l
e
g
g
i
b
i
l
i
t
L
i
b
e
r
t
d
i
i
n
s
t
a
l
l
a
z
i
o
n
e
e
d
i
m
o
v
i
m
e
n
t
o
P
r
o
g
r
a
m
m
a
z
i
o
n
e
f
a
c
i
l
i
t
a
t
a
F
u
n
z
i
o
n
i
p
a
r
t
y
e
h
o
l
i
d
a
y
C
r
o
n
o
t
e
r
m
o
s
t
a
t
o
a
r
a
d
i
o
f
r
e
q
u
e
n
z
a
c
o
m
a
n
d
a
b
i
l
e
v
i
a
t
e
l
e
f
o
n
o
S
e
r
i
e
S
Y
S
T
E
M
R
F
g
e
w
i
s
s
.
c
o
m
L
I
m
p
i
a
n
t
o
E
l
e
t
t
r
i
c
o
I
n
t
e
g
r
a
t
o
servizio lettori 1758
G
li ausiliari di comando so-
no dispositivi meccanici
che hanno la funzione di
comandare la manovra delle ap-
parecchiature incluse le segna-
lazioni, gli interblocchi elettrici ecc.
e sono costituiti da uno o pi
elementi di contatto azionati da
un unico sistema.
Questa definizione, tratta dalla
norma Cei EN 60947-5-1, si rife-
risce ad una vasta gamma di ap-
parecchiature destinate agli equi-
paggiamenti elettrici di macchi-
ne e impianti, volte ad assolve-
re le funzioni di ausiliari, verifi-
care la giusta successione delle
manovre, svolgere - in senso pi
generale - quella funzione di in-
terfacciamento, o meglio di anel-
lo di collegamento, tra luomo e
la macchina.
Limportanza degli ausiliari di
comando e soprattutto la loro
scelta ed installazione (elemen-
ti questi non sempre giusta-
mente considerati nel passato) so-
no diventate, alla luce delle recenti
norme e direttive europee, un
aspetto prioritario ai fini della
sicurezza
(1)
.
La norma Cei EN 60947-5-1, oltre
a definire le caratteristiche degli
attuatori da impiegarsi come au-
siliari di comando e le prove a cui
devono essere sottoposti, pre-
cisa quali sono gli organi di co-
mando ammessi, nonch le ti-
pologie degli elementi di con-
tatto. Relativamente ai primi (or-
gani di comando) la norma li am-
mette: a pulsante, a trazione, a
pressione-trazione (push-pull),
rotativi, a chiave, ad aggancio, a
pedale, a leva, luminosi. Nel se-
guito verranno brevemente pre-
sentati i principali dispositivi di
comando e segnalazione, richia-
mando le funzioni che devono
essere svolte, le corrette moda-
lit di scelta e installazione, le ca-
ratteristiche tecniche peculiari.
Per quanto riguarda invece le ti-
pologie di contatto si rimanda il
lettore alla tabella 1, diretta-
mente estrapolata dalla norma Cei
EN 60947-5-1.
I PULSANTI
Il pulsante, funzionalmente, la
riunione di uno o pi contatti
azionati manualmente dallope-
ratore. Costruttivamente, invece,
formato dallinsieme dei contatti,
dal perno di azionamento e dal-
lelemento di comando, che pu
essere a fungo, a leva, a bottone,
a chiave...
Il colore dellelemento di co-
mando deve essere coerente con
quanto prescritto dalla norma
Cei 16-3 la quale, per altro, ha do-
vuto tener conto di differenti
realt; ci ha indotto il normatore
a vietare taluni colori per pul-
santi destinati ad alcune fun-
zioni, ad attribuire il termine di
preferenziale ad altri e, infine,
a consentire luso di altri colori an-
cora. La tabella 2 riassume quan-
to sopra. In ogni caso la norma
prevede espressamente che il co-
lore rosso deve essere utilizzato
esclusivamente per le seguenti
funzioni: arresto, disinserzione
ed emergenza.
GLI ATTUATORI LUMINOSI
Costituiscono una variante del
pulsante (pur conservando la ca-
ratteristica di essere quella par-
te dellorgano di comando che
entra in contatto diretto con lo-
peratore e che pertanto realizza,
anche in questo caso, linterfac-
La scelta e linstallazione sono
diventate, alla luce delle recenti
norme e direttive europee, un
aspetto fondamentale ai fini del-
la sicurezza
Gli ausiliari
di comando
Antonio Porro
NORMATIVA
28
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
F
o
t
o
:
G
i
o
v
e
n
z
a
n
a
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
(1) La stessa norma Cei EN 60947-5-1 precisa, allart. 2.1.3, che gli ausiliari di comando
sono destinati a fornire un maggiore grado di sicurezza al personale che lavori sullapparec-
chiatura comandata. Per tale ragione, essi devono essere azionati manualmente facendo
affidamento sullintelligenza delle persone addestrate per una pronta reazione nel caso in cui
loperazione dovesse fallire, come per esempio in caso di contatti insufficientemente aperti.
Figura 1 - Pulsante multifunzione e selettore a manopola
La norma Cei
EN 60947-5-1,
precisa quali sono
gli organi di comando
ammessi, nonch le
tipologie degli
elementi di contatto.
F
o
t
o
:
G
i
o
v
e
n
z
a
n
a
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
g
e
w
i
s
s
.
c
o
m
L
I
m
p
i
a
n
t
o
E
l
e
t
t
r
i
c
o
I
n
t
e
g
r
a
t
o
L
a
S
e
r
i
e
6
8
Q
-
M
C
s
i
v
e
s
t
e
d
i
n
u
o
v
o
:
t
u
t
t
a
l
a
g
a
m
m
a
d
i
t
e
r
m
i
n
a
l
i
d
i
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
d
a
o
g
g
i
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e
a
n
c
h
e
i
n
v
e
r
s
i
o
n
e
b
i
a
n
c
a
,
p
e
r
u
n
r
i
s
u
l
t
a
t
o
a
n
c
o
r
p
i
e
l
e
g
a
n
t
e
e
i
n
a
r
m
o
n
i
a
c
o
n
i
l
p
a
e
s
a
g
g
i
o
.
L
o
f
f
e
r
t
a
c
o
m
p
r
e
n
d
e
n
u
o
v
i
m
o
d
e
l
l
i
c
o
m
p
a
t
t
i
p
e
r
p
o
n
t
i
l
i
g
a
l
l
e
g
g
i
a
n
t
i
,
c
a
m
p
e
g
g
i
,
a
r
e
e
e
s
t
e
r
n
e
d
i
v
i
l
l
e
e
c
o
n
d
o
m
i
n
i
,
p
a
r
c
h
i
e
p
i
a
z
z
e
,
m
e
r
c
a
t
i
e
p
e
r
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
i
m
o
b
i
l
i
.
6
8
Q
-
M
C
E
n
e
r
g
i
a
o
v
u
n
q
u
e
servizio lettori 1759
cia uomo-macchina) e come tali
possono presentarsi, oltre che
nella tradizionale forma di bottone,
anche come leva, impugnatura e,
talvolta, come immagine virtua-
le a video di un computer.
La codificazione cromatica ca-
ratterizza gli attuatori luminosi co-
me portatori di un indirizzo offerto
alloperatore per lindividuazio-
ne degli organi di comando e
per impostare e/o impartire ordini,
sequenze, predisposizioni o altro
ancora. La norma di riferimento
sempre la Cei 16-3 (classifica-
zione europea Cei EN 60073),
che identifica tre tipi di attuato-
ri luminosi:
- tipo A: mantiene lo stesso colore
sia spento sia acceso;
- tipo B: assume da acceso un co-
lore diverso da quello che lo
caratterizza nella posizione di
spento;
- tipo C: privo di significato
cromatico quando spento,
mentre quando acceso pu
assumere pi colorazioni, cia-
scuna delle quali ha un diverso
significato.
La norma, inoltre, identifica due
distinte modalit duso: per se-
gnalazione e per conferma.
Ogni attuatore luminoso de-
vessere pertanto conforme sia a
tabelle cromatiche attinenti la
funzione segnalazione sia alla
tabella 3, attinente la funzione di
comando.
A titolo desempio, nella figura 1,
vengono riportati un pulsante
multifinzione e un selettore a
manopola.
I COMANDI
DI EMERGENZA
I dispositivi preposti a questa
funzione devono porre in essere,
nel minor tempo possibile, si-
tuazioni e/o stati di sicurezza
della macchina o dellimpianto.
Il loro intervento previsto quan-
do si verificano eventi in cui le bar-
riere protettive sono state su-
perate e situazioni di pericolo
possono coinvolgere le persone
o lambiente. Il comando - con i
dispositivi elettrici ad esso as-
30
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NORMATIVA GLI AUSILIARI DI COMANDO
w
w
w
.a
z
i
e
n
d
a
i
m
m
a
g
i
n
e
.c
o
m
20065 Inzago (Milano) ITALY - Via G. Leopardi, 5 - Tel. 02 954381 - Fax 02 9548528
www.aecosensors.com - e-mail: aeco@aecosensors.com
I sensori capacitivi
sono adatti a rilevare, con elevata immunit
ai disturbi, materiali metallici e non, solidi o
liquidi nellindustria alimentare, chimica, della
plastica, del legno, della ceramica, del vetro
e dellimballaggio. Installabili vicino ad inverter
o in ambienti con presenza di forti cariche
elettrostatiche, non risentono di interferenze
causate da cellulari GSM o ponti
radio.
Scusate, togliamo il disturbo.
SENSORI MAGNETICI REED
CONTROLLI DI LIVELLO
CONTROLLI DI ROTAZIONE
CONNETTORI M8-M12
SENSORI INDUTTIVI
SENSORI CAPACITIVI
SENSORI FOTOELETTRICI
SENSORI A FIBRE OTTICHE
ALIMENTATORI
AMPLIFICATORI
SENSORI ATEX GRUPPO II 1G
SENSORI ATEX GRUPPO II 3G - 3D
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
9
8
TABELLA 1 - TIPOLOGIE DI CONTATTO PREVISTE
DALLA NORMA CEI EN 60947-5-1
TABELLA 2 - COLORI DEI PULSANTI
E LORO SIGNIFICATO
Colore Significato del colore Esempi di impiego
- Arresto demergenza
Azione in caso di emergenza - Attivazione di un dispositivo
antincendio
- Arresto generale
- Arresto di uno o pi motori
- Arresto di un elemento
Rosso Arresto o disinserzione di una macchina
- Apertura di un dispositivo
dinterruzione
- Ripristino combinato con larresto
- Intervallo per sopprimere
Giallo Intervallo condizioni anormali o per evitare
cambiamenti non desiderati
- Avviamento generale
- Avviamento di uno o pi motori
- Avviamento di un elemento
di una macchina
- Chiusura di un dispositivo
dinterruzione
- A questo colore pu essere
Qualsiasi significato specifico non assegnato, in casi particolari,
compreso in quelli sopra descritti un significato non coperto
dai colori: rosso, giallo e verde
- Possono essere utilizzati
Non viene attribuito per tutte le funzioni salvo
alcun significato specifico che per i pulsanti con la sola
funzione di arresto o disinserzione
Verde
Blu
Avviamento o inserzione
Nero
Grigio
Bianco
Figura 2 - Segnale luminoso monolampada a Led
F
o
t
o
:
G
i
o
v
e
n
z
a
n
a
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
NORMATIVA GLI AUSILIARI DI COMANDO
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 31
sociati - deve essere congegna-
to secondo i principi generali
della sicurezza esposti nella nor-
ma Cei EN 60204-1 Equipag-
giamento elettrico delle mac-
chine (classificazione Cei 44-5)
ed realizzato mediante il pul-
sante rosso (corredato con tar-
ghetta a sfondo giallo) a fungo
(figura 3).
Il comando deve sempre essere
a disposizione delloperatore e
pertanto la sua accessibilit e vi-
sibilit devessere garantita in
tutte le possibili condizioni di la-
voro; inoltre, lallegato I della
Direttiva Macchine indica chia-
ramente, allart. 1.2.4, la ne-
cessit di munire ogni macchi-
na di uno o pi dispositivi di ar-
resto di emergenza, indicando-
ne altres i requisiti e le funzio-
ni, che sono:
- comprendere dispositivi di co-
mando chiaramente individua-
bili, ben visibili e rapidamente
accessibili;
- provocare larresto del proces-
so pericoloso nel tempo pi
breve, senza creare rischi sup-
plementari;
- eventualmente avviare, o per-
mettere di avviare, alcuni mo-
vimenti di salvaguardia.
GLI INDICATORI
LUMINOSI
Da ultimo, un cenno sugli indicatori
luminosi, ossia quei dispositivi
che servono alla realizzazione
pratica delle segnalazioni lumi-
nose necessarie per la verifica
dellandamento delle varie fun-
zioni operative.
I colori specifici, che non posso-
no essere derogati, e le infor-
mazioni che gli indicatori luminosi
trasmettono sono sintetizzate
nella tabella 4, dedotta dalla nor-
ma Cei 16.3.
TABELLA 3 - COLORE DEGLI ATTUATORI ATTINENTI LA FUNZIONE DI COMANDO
Colore Significato Spiegazione Esempi applicativi
- Comando di emergenza
- Comando di arresto
Da azionare in caso di pericolo demergenza
o di emergenza - Attivazione dei sistemi
antincendio
- Arresto o disinserzione
- Intervento per sopprimere o
per sopperire ad una condizione
anormale
- Intervento manuale per
riavviare un ciclo automatico
interrotto
- Avviamento aspiratori
di sicurezza
- Chiusura protezioni
antinfortunistiche
- Avviamento generico o
inserzione
Da azionare obbligatoriamente - Ripristino dei rel di
Blu Obbligatoriet in determinate condizioni protezione
(non coinvolgenti la sicurezza)
- Avviamento
- Inserzione
- Arresto
- Disinserzione
- Comando ad impulso
- Comando alternativo di
avviamento/arresto o
inserzione/disinserzione
TABELLA 4 - COLORI DEGLI INDICATORI LUMINOSI E LORO SIGNIFICATO
Colore Significato del colore Spiegazione Esempi di impiego
- Mancanza di pressione in un
sistema di lubrificazione
- Temperature che oltrepassano
Avvertimento di un pericolo i limiti di sicurezza specificata
Rosso Pericolo o allarme potenziale o di una situazione - Apparecchiature di primaria
che necessita unazione immediata importanza bloccate da
un dispositivo di protezione
- Pericolo inerente a parti accessibili
in movimento o sotto tensione
- Temperatura (o pressione)
Cambiamento o imminente diversa da un livello normale
cambiamento di condizioni - Sovraccarico, ammesso solo per
un periodo limitato
- Fusibile refrigerante
in circolazione
- Controllo automatico di caldaia
in servizio
- Macchina pronta per la messa
in marcia
Al blu pu essere attribuito
un significato non coperto - Indicatore di comando a distanza
dai tre colori sopra menzionati: - Selettore in posizione predisposto
rosso, giallo o verde
Qualsiasi significato; pu essere
utilizzato tutte le volte che si ha
Bianco un dubbio sullutilizzazione dei tre
colori: rosso, giallo verde e, per
esempio, per indicare una conferma
Da azionare in condizioni anormali Anormalit Giallo
Rosso Emergenza
Verde Sicurezza
Da azionare per produrre
condizioni normali o per predisporre
una condizione di sicurezza
Bianco
Nero
Grigio
Funzioni generali
Funzioni generali
Funzioni generali
(non specificato)
(non specificato)
(non specificato)
Giallo Attenzione
Verde Sicurezza
Indicazione di una condizione
sicura o autorizzazione a procedere
(via libera)
Blu
Significato specifico attribuito
secondo le necessit
del caso considerato
Figura 3 - Pulsante di emergenza
La norma identifica
due distinte modalit
duso: per segnalazione
e per conferma
F
o
t
o
:
G
i
o
v
e
n
z
a
n
a
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
Non ha significato specifico
(neutro)
N O N S O L O
c o n n e s s i o n i . . .
www. bm- spa. com
DAL 1958
LEADER NEL MONDO
DELLE CONNESSI ONI
ELETTRICHE...
DAL 2004
PRESENTA LA NUOVA LI NEA
DI UTENSILI PROFESSIONALI
PER LINSTALLATORE
ELETTRICO
ToolLine
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
1
2
E
sistono oggi direttive eu-
ropee rivolte a giocattoli,
dispositivi medici, appa-
recchiature radio, apparecchi ter-
minali di telecomunicazione...
concepite, nella maggior parte
dei casi, con lo scopo di tutela-
re la qualit funzionale e la si-
curezza del prodotto finale. Esse
dettano precise regole pertinen-
ti limmissione sul mercato co-
munitario di un certo prodotto, e
sono quindi divenute di fonda-
mentale importanza, oltre che
per lacquirente del prodotto finale,
anche per produttori, progetti-
sti, installatori o consulenti. A
meno di non volersi riferire ad
una ristretta classe di problema-
tiche (o di prodotti), gli aspetti
coinvolti sono cos tanti da im-
pedire unanalisi esaustiva in bre-
vi spazi. Nel corso di questo ar-
ticolo si affronter quindi il tema
con specifico riferimento alle prin-
cipali esigenze sentite dagli ope-
ratori del settore elettrico/elet-
tronico. Ci si far guidare allo
scopo direttamente dalle specifi-
che contenute nelle direttive e
nelle norme tecniche in vigore.
COME NACQUERO
LE DIRETTIVE?
Il mercato comune europeo trae la
propria origine dal Trattato di Ro-
ma firmato dai rappresentati di
alcuni stati (tra i quali lItalia) nel
1957. Uno dei principali traguar-
di era quello di creare un unico
grande mercato di oltre 250 milioni
di consumatori che coinvolgesse
le nazioni aderenti ed i relativi
produttori.
Apparve subito evidente che af-
finch ci potesse realizzarsi, era
necessario far cadere molte bar-
riere, di natura sia tecnica sia bu-
rocratica, che rendevano difficol-
tosi gli scambi di merci tra i diversi
stati membri. Per quanto attiene
agli ostacoli di natura tecnica, oc-
correvano ad esempio validi rife-
rimenti comuni che tutti i co-
struttori europei potessero adot-
tare nelle fasi di progetto, produ-
zione, valutazione delle presta-
zioni, redazione della manualisti-
ca, eccetera.
Gli ostacoli di natura burocratica
derivavano invece da alcune dif-
ferenze inevitabilmente esistenti
tra le giurisprudenze dei diversi
paesi.
Gli esperti concordarono che la
via migliore da percorrere fosse
quella di predisporre appositi stru-
menti legislativi comuni che di-
sciplinassero argomenti, fino a
quel momento regolati in manie-
ra autonoma da ogni singolo sta-
to membro. Tali strumenti furono
indicati con il nome di Direttive
comunitarie: fu stabilito che es-
se venissero fatte proprie e deli-
berate dal pi alto organo legife-
rante della Comunit: il Consiglio
dellUnione Europea formato dai
Ministri di tutti gli Stati membri.
IL NUOVO APPROCCIO
Come sovente accade nella rea-
lizzazione di sistemi basati su in-
novative visioni, lidea di origine
spesso brillante ma le modalit
con le quali essa viene imple-
mentata possono rivelarsi, col
Direttive europee
e marcatura CE
NORMATIVA
Un tempo la certificazione e limmissione sul
mercato dei prodotti avveniva, nei singoli stati, con
riferimento a decreti legge e norme nazionali;
oggi, invece, ci sono disposizioni e regole comu-
nitarie
34
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Mario Giorgio Bartolo
TABELLA 1 - ALCUNE DIRETTIVE
DEL SETTORE ELETTRICO
Titolo Acronimo ufficiale Numero ID
Apparecchiature radio ed apparecchi R&Tte 99/05/EC
terminali di telecomunicazione
Compatibilit elettromagnetica Emc 89/336/EEC
Dispositivi medici Med3 93/42/EEC
Dispositivi medici impiantabili attivi Med2 90/385/EEC
Equipaggiamenti elettrici destinati ad essere Lvd 73/23/EEC
utilizzati entro certi limiti di tensione
Giocattoli Toys -
Macchine Md 89/392/EEC
Nel testo
della direttiva
vengono stabiliti
solamente
dei requisiti minimi
tempo, inadeguate. Fu cos anche
nel caso delle direttive per le qua-
li non pochi problemi contribuirono
a renderne la diffusione pi diffi-
coltosa del previsto. Per porre ri-
medio a ci, fu effettuata unap-
profondita analisi del nuovo stru-
mento legislativo e ci consent di
individuare nella sua filosofia di
approccio al problema le cause
delle citate difficolt. Si corse ai ri-
pari modificando radicalmente
alcuni criteri fino ad allora giudi-
cati come capisaldi inamovibili
dalla giurisprudenza classica. La
strada condusse alle cosiddette di-
rettive del nuovo approccio,
termine oggi molto diffuso sul si-
gnificato del quale utile spendere
qualche parola.
La tecnica legislativa classica ri-
chiedeva che il campo di appli-
cazione di ogni direttiva fosse li-
mitato ad una ristretta catego-
ria di prodotti e che contenesse ob-
bligatoriamente anche le relative
prescrizioni tecniche da attuare.
Appare evidente che in tal modo
il numero di direttive sarebbe
stato eccessivo ed in aggiunta a
ci ladattamento dei dettagli tec-
nici al progresso tecnologico ri-
chiedeva continui aggiornamen-
ti ad ognuna di esse.
Dal 1985 in poi stato adottato un
nuovo approccio al problema, sia
in termini legislativi sia pi pu-
ramente tecnici. Una lettura an-
che sommaria al testo di una di-
rettiva del nuovo approccio suf-
ficiente per rendersi conto di co-
me il campo di applicazione sia sta-
to esteso evitando che la stessa
fosse indirizzata a ristrette cate-
gorie di prodotti: un pi ampio
campo di applicazione riduce il
numero di direttive emesse a tut-
to vantaggio della flessibilit.
Nel testo della direttiva vengono,
inoltre, stabiliti solamente dei re-
quisiti minimi che devono obbli-
gatoriamente possedere tutti i
prodotti rientranti nel campo di ap-
plicazione. Si tratta ovviamente di
specifiche differenti a seconda
della direttiva considerata ma
poich le direttive abbracciano
unampia gamma di prodotti, i
requisiti non possono che essere
dati in termini generali mante-
nendo cos il testo svincolato da
dettagli tecnici.
Il non legare le tecniche di co-
struzione e funzionamento dei
prodotti a rigide disposizioni le-
gislative, bens fornire solamen-
te alcuni requisiti essenziali
inerenti tutti i prodotti di un de-
terminato tipo, permette una pi
libera evoluzione tecnica nella
maggior parte dei campi co-
struttivi.
Nei testi delle direttive vengono
in altre parole indicati unicamente
gli obiettivi finali che i costrutto-
ri (o chi per loro) dovranno per-
seguire sui prodotti, lasciando
una certa libert sul come que-
sti possano essere ottenuti. In
tal modo anche prodotti tecno-
logicamente innovativi, costruiti
adottando soluzioni allavan-
guardia e non ancora codificate
normativamente, potranno esse-
re immessi sul mercato qualora
soddisfacenti i requisiti essen-
ziali prescritti. Di converso i co-
struttori di prodotti con tipolo-
gia pi classica, per i quali esistono
precise specifiche normative, tro-
veranno senzaltro pi agevole il
riferimento a queste ultime.
Per i dettagli tecnici stato invece
adottato il sistema del rimando
esplicito a specifici documenti di
riferimento emanati da organi-
smi di normazione riconosciuti:
le norme tecniche armonizzate.
Con tale sistema, ladeguamento
delle disposizioni tecniche allo
stato dellarte pu essere limita-
to, nella maggior parte dei casi, al-
le sole norme tecniche senza che
risultino necessarie continue mo-
difiche al testo della direttiva in
questione. Effetto di ci una
maggiore stabilit temporale
dei testi delle direttive i quali
non necessitano cos di continue
revisioni e risultano nel contem-
po pi semplici, snelli e fruibili
anche ai non esperti. Le norme
NORMATIVA DIRETTIVE EUROPEE E MARCATURA CE
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 35
FOCUS
Alogena/ioduri
dicroica
FULGENS
Alogena/ioduri
lineare
ECOLUCIS
Fluorescenza
compatta
ELIOS
Fluorescenza
lineare T5
PLANETARIUS
Sistema di illuminazione
su cavo a tensione di rete.
Ideato per risolvere
i progetti di illuminazione
di grandi spazi come:
uffici, open-space, musei,
chiese, show room.
SINTEX
Serie di apparecchi da incasso
per lampade fluorescenti
compatte in termoplastico
autoestinguente.
Esistono due dimensioni
con alimentazione induttiva,
elettronica, elettronica
dimmerabile, digitale (DALI),
elettronica autodimmerabile
(SMART) ed emergenza
con inverter.
SINTEX 26
SINTEX 30
NUOVA MIZAR srl via Bosco, 1 31050 Badoere di Morgano (TV) tel 0422 8393 fax 0422 839444 www.nuovamizar.com Gruppo Laguna Light
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
6
6
vanno in tal modo a costituire un
riferimento tecnico ben preciso
per costruttori e progettisti: i pro-
dotti realizzati seguendo tale ri-
ferimento devono essere con-
siderati conformi ai requisiti es-
senziali imposti. Riepilogando,
lenorme vantaggio della filosofia
del nuovo approccio (presente in
tutte le direttive emesse dopo il
1985), pu essere riassunto nei se-
guenti tre punti:
- ampio campo di applicazione;
- prescrizione di soli requisiti es-
senziali;
- rimando a norme armonizzate di
riferimento per dettagli tecnici.
IL RECEPIMENTO
DELLE DIRETTIVE
Le direttive comunitarie sono do-
cumenti legislativi che, dopo un
preciso iter, vengono adottate
dal Consiglio dellUnione Euro-
pea. Una volta adottato, il testo di
ogni direttiva viene pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Co-
munit Europea (Ojec) con lo sco-
po di ufficializzarlo e notifi-
carlo ai singoli Stati membri. im-
portante focalizzare lattenzione
sul fatto che sono questi ultimi i
destinatari naturali delle di-
sposizioni legislative contenute nel-
le direttive.
I singoli stati hanno poi il dovere
di recepire la direttiva entro
un ben preciso lasso di tempo
stabilito nella stessa.
Allatto pratico ci avviene me-
diante emissione, da parte dello
Stato membro, di un apposito De-
creto attuativo pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dello stesso
Stato. Tale Decreto traduce il te-
sto della direttiva e lo adatta,
senza stravolgerne il significato,
alla legislazione dello Stato in
questione. Questultimo inol-
tre tenuto ad abrogare tutte le
eventuali precedenti disposizioni
legislative interne che risultino
in contrasto con le specifiche con-
tenute nella direttiva appena re-
cepita. Non difficile intuire che
un tale sistema porter in breve
tempo ad una uniformit tra le leg-
gi nazionali dei singoli stati con
conseguente abbattimento di
molte barriere tecniche e com-
merciali che hanno ostacolato,
nel passato, il libero scambio di per-
sone, capitali, beni e servizi tra i
paesi comunitari.
LE DIRETTIVE
SI POSSONO MODIFICARE?
Nonostante tutte le misure adot-
tate, la necessit delladegua-
mento al progresso tecnico e le-
gislativo porta a lievi ma frequenti
modifiche ai testi delle direttive.
Allo scopo vengono emesse dal-
la stessa comunit altre direttive
cosiddette di modifica che pos-
sono riguardare contemporanea-
mente una o pi direttive gi in vi-
gore, nonch uno o pi aspetti
delle stesse. Un caso eclatante
in merito costituito dalla diret-
tiva 93/68 del 22 luglio 1993, det-
ta in gergo anche Direttiva mar-
catura CE, la quale ha modificato
il testo di un gran numero di di-
rettive allora in vigore (tra cui
anche la 89/336 Emc e la 73/23 Lvd
di cui si parler diffusamente nel
seguito) introducendo, tra laltro,
luso dellespressione marcatu-
ra CE in luogo di marchio CE.
COSA SI PU
TRARRE DAL NOME
DI UNA DIRETTIVA
Tutte le principali informazioni
inerenti una particolare diretti-
va (oggetto, anno di emissione,
ecc...) possono essere desunte
dal modo in cui la stessa iden-
tificata. Lidentificazione di ogni
direttiva , infatti, effettuata me-
diante tre campi che costituisco-
no una sorta di codifica:
- primo campo: contiene un iden-
tificativo numerico composto
da due numeri separati dalla
barra /. Il primo numero for-
mato da due cifre ed indica lan-
no nel quale la direttiva stata
emessa, il secondo numero
costituito da due o pi cifre ed
riservato alla numerazione
progressiva di emissione allin-
terno dellanno considerato. Co-
s la sigla numerica 89/336 indica
la direttiva con identificativo
336 emessa nellanno 1989; ana-
logamente la sigla 99/05 indica
la direttiva identificata con il
numero 05 emessa nellanno
1999;
- secondo campo: contiene un
acronimo con il quale la direttiva
stessa viene indicata dagli ad-
detti ai lavori; lacronimo ha
lo scopo di sintetizzare, nella
maniera pi efficiente possibi-
le, il titolo ufficiale della direttiva,
il quale ha a sua volta lovvio sco-
po di indicarne le caratteristiche
essenziali nonch il contenuto
e/o il campo di applicazione
(e.g. Lvd Low voltage directive,
R&Tte Radio and terminal te-
lecomunication equipments);
- terzo campo: contiene il titolo uf-
ficiale della direttiva che viene
stabilito rispettando il criterio
del massimo contenuto infor-
mativo nel minimo testo.
Ad esempio, esso pu essere fis-
sato in base alla categoria di ap-
parecchi ai quali la direttiva
rivolta (cio con riferimento di-
retto al gi citato campo di
applicazione): in questo caso
rientrano la maggior parte del-
le direttive in vigore (esempio:
dispositivi medici, macchi-
ne...). Il titolo pu tuttavia es-
sere stabilito anche in base ad
eventuali requisiti intrinseci
della direttiva stessa: esempio
di ci la direttiva generale
compatibilit elettromagneti-
ca. La tabella 1 riassume titoli
ufficiali, acronimi e sigle iden-
tificative di alcune tra le diret-
tive pi presenti nel settore
elettrico.
DUE DIRETTIVE
GENERALI
La grande variet di dispositivi
elettrici e/o elettronici oggi utilizzati
sia a livello professionale che con-
sumer, nonch la ricchezza di
aspetti tecnici coinvolti, hanno
inizialmente indotto gli organi le-
gislativi ad affiancare alle direttive
destinate ad una precisa classe di
prodotti (come ad esempio quel-
le concernenti i dispositivi medi-
ci, o quella relativa agli apparati
radio e terminali di telecomuni-
cazione solo per citarne due), due
direttive non specifiche bens di
carattere pi generale; esse sono:
- la direttiva Emc 89/336 relativa
alle prescrizioni sulla compati-
bilit elettromagnetica;
- la direttiva Lvd 73/23 relativa al-
le prescrizioni sulla sicurezza
elettrica.
Tranne i casi di prodotti rientranti
nel campo di applicazione di di-
rettive maggiormente specifiche
cui si accennava prima, buona
parte degli apparati elettrici e/o
elettronici rientra nel campo di
applicazione delle due citate di-
rettive.
36
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NORMATIVA DIRETTIVE EUROPEE E MARCATURA CE
Come spiegato nel corso dellarticolo il campo di applicazione
di ogni direttiva del nuovo approccio stato esteso per evi-
tare che la stessa fosse indirizzata a ristrette categorie di
prodotti. quindi frequente la situazione nella quale un de-
terminato dispositivo rientri nel campo di applicazione di di-
rettive differenti e non mutuamente esclusive. In tal caso pre-
stazioni, caratteristiche, regole di immissione sul mercato,
ecc... di quel prodotto dovranno essere valutate con riferi-
mento a tutte le direttive applicabili.
Circa la mutua esclusivit tra direttive risulta esplicativo, ad
opinione di chi scrive, lesempio direttamente proveniente
dallarticolo 2 paragrafo 2 della direttiva 89/336 Emc il quale
recita testualmente: Nella misura in cui delle direttive speci-
fiche armonizzino taluni requisiti di protezione specificati nel-
la presente direttiva, per taluni apparecchi, gli apparecchi in que-
stione ed i requisiti di protezione in questione non sono o ces-
sano di essere compresi nel settore di applicazione della presente
direttiva, non appena dette direttive specifiche siano entrate in
vigore.
UNA DOMANDA RICORRENTE: COSA SUCCEDE
SE UN PRODOTTO RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DI PI DIRETTIVE?
servizio lettori 1738
Massima libert con Vela.
Nuova Serie Civile Vela: Tonda e Quadra.
Copritasto e copripresa li posizioni alla fine dellinstallazione.
www.legrand.it
Legrand presenta Vel a, l a
Serie funzionale e ricca di
varianti estetiche che com-
pleta il sistema di installa-
zione civile Legrand. Facile
da instal l are, dal design
elegante, Vela soddisfa le
esigenze di stile del cliente
permettendo di decidere tipo
di placca (Vela Tonda o Vela
Quadra) e colore dei tasti (chiari
o scuri) alla fine del lavoro.
Nuova Serie Civil e Vel a.
Garantisce Legrand.
Vela Quadra Vela Tonda
servizio lettori 1602
La nuova norma UNI EN 12464-
1 sostituisce la norma UNI
10380 Illuminazione di inter-
ni con luce artificiale
C
hi si occupa di illuminazione
di ambienti interni abi-
tuato ad utilizzare, ormai da
10 anni, la norma UNI 10380 (1994)
Illuminazione di interni con luce
artificiale e relativa variante A1
(1999).
Ben pochi sanno che tale norma, in
realt, non pi in vigore (dal 20
novembre 2003) e che stata so-
stituita dalla norma EN 12464-1
sullilluminazione dei luoghi di la-
voro allinterno.
A dire il vero, la norma EN 12464-
1 gi in vigore da oltre un anno
(1 luglio 2003), ma tale fatto
passato inosservato perch lUNI
non lha ancora tradotta in italiano,
cosicch la nuova norma non era ri-
portata nel catalogo informatico
delle norme UNI (consultabile sul
sito www.uni.com) e poteva es-
sere acquistata solo come norma eu-
ropea. Poich il ritardo nella tra-
duzione della nuova norma ha or-
mai dellincredibile (a meno che
non sia stata pubblicata mentre
la rivista era in stampa), in consi-
derazione della sua importanza ai
fini pratici, in questa sede si pre-
ferisce riportare una breve sintesi
dei contenuti della norma, antici-
pando la sua pubblicazione come
norma UNI. Il testo che segue si ba-
sa sulla versione inglese della nor-
ma EN 12464-1, che lUNI pu so-
lo tradurre, senza introdurre mo-
difiche. Rispetto alla versione uf-
ficiale della norma UNI che verr
pubblicata in futuro, pertanto, ta-
le testo potr discostarsi solo per
quanto riguarda la terminologia
utilizzata, ma non per i contenuti.
I CONTENUTI
DELLA NUOVA NORMA
La norma EN 12464-1 specifica le
caratteristiche illuminotecniche
che deve soddisfare lilluminazio-
ne (naturale e/o artificiale) negli am-
bienti di lavoro interni. Sono quin-
di esclusi i luoghi di lavoro ester-
ni, per i quali sono in preparazione
specifiche disposizioni normative.
Parlando di luoghi di lavoro, ven-
gono subito alla mente le disposi-
zioni legislative sulla salute e sul-
la sicurezza dei lavoratori (decre-
to legislativo n. 626/1994; decreto
del Presidente della Repubblica
n. 547/1955; ecc.). A questo pro-
posito, opportuno notare come la
norma EN 12464-1 premetta che i
requisiti da essa riportati non sia-
no mirati a salvaguardare la salu-
te e la sicurezza dei lavoratori, il che
appare effettivamente un po stra-
no. Il lettore non si preoccupi: nel-
la stragrande maggioranza dei ca-
si, il rispetto della norma consen-
te di garantire la sicurezza e la sa-
lute dei lavoratori.
Tuttavia, possono esistere situazioni
lavorative particolari, che richie-
dono prestazioni illuminotecniche
pi restrittive di quelle indicate
dalla norma stessa.
Quello che la norma intende af-
fermare, quindi, che non suffi-
ciente rispettarne le prescrizioni per
garantire, sempre e comunque, la
sicurezza e la salute dei lavorato-
ri. Prima di poter affermare ci,
deve sempre essere condotta unat-
tenta valutazione dei rischi.
CARATTERISTICHE
DELLILLUMINAZIONE
Lilluminazione di un ambiente,
ottenuta artificialmente o natu-
ralmente, deve sempre assicurare:
una buona visibilit;
un adeguato comfort ambien-
tale.
Questi requisiti possono essere
garantiti solo se i parametri illu-
minotecnici che caratterizzano lil-
luminazione soddisfano quanto
previsto dalla norma EN 12464-1.
Nel seguito, analizzeremo i principali
parametri illuminotecnici, evi-
denziando le novit introdotte dal-
la norma in esame, alla quale si ri-
manda per un maggiore appro-
fondimento.
ILLUMINAMENTO
Il parametro illuminotecnico pi im-
portante ai fini progettuali sen-
za dubbio lilluminamento, ossia la
quantit di flusso luminoso che
incide sulla superficie illuminata.
Rispetto alla norma UNI 10380,
con la norma EN 12464-1 cambia-
no alcuni valori di illuminamento
imposti negli ambienti di lavoro: in
proposito vedasi la tabella 2.
La principale novit introdotta
dalla nuova norma, per, consi-
ste nella definizione di due diver-
se aree in cui devono essere ga-
rantiti limiti di illuminamento dif-
ferenti.
La norma, infatti, distingue larea
del compito visivo, ossia la zona (o
meglio linsieme di zone) allinter-
no dellambiente di lavoro dove si
svolge lattivit visiva, e le aree
immediatamente circostanti, os-
sia le zone che circondano (per al-
meno 0,5 m) la suddetta area del
compito visivo (Figura 1).
Se in un ambiente di lavoro non so-
no ben definite le zone in cui si
svolge lattivit visiva, larea del com-
pito visivo si estende praticamen-
Lilluminazione
dei luoghi di lavoro
Paolo Micelotta
NORMATIVA
38
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
TABELLA 1 - LIMITI DI ILLUMINAMENTO
MANTENUTO
Limiti di illuminamento Limiti di illuminamento
mantenuto dellarea mantenuto nelle aree immediatamente
del compito visivo circostanti le aree del compito visivo
750 lx 500 lx
500 lx 300 lx
300 lx 200 lx
200 lx Uguale allilluminamento mantenuto
dellarea del compito visivo
NORMATIVA LILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 39
TABELLA 2 - LE CARATTERISTICHE DELLILLUMINAZIONE NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO PREVISTE DALLA NORMA EN 12464-1.
ZONE DI CIRCOLAZIONE E SPAZI COMUNI ALLINTERNO DEGLI EDIFICI
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Zone di circolazione
Aree di circolazione e corridoi 100 28 40 1. Illuminamento a livello pavimento.
2. Ra e UGR simili alle zone adiacenti.
3. 150 lx se ci sono veicoli sul percorso.
4. Lilluminazione di uscite o entrate deve prevedere una zona
di transizione per evitare improvvise differenze di illuminamento
tra interno ed esterno, durante il giorno e la notte.
5. Occorre evitare labbagliamento di mezzi e pedoni.
Scale, ascensori, tappeti e scale mobili 150 25 40
Rampe di carico 150 25 40
Locali di attesa e riposo, infermeria e primo soccorso
Mense 200 22 80
Locali di riposo 100 22 80
Locali per lesercizio fisico 300 22 80
Guardaroba, gabinetti, bagni, toilette 200 25 80
Infermeria 500 19 80
Locali per visita medica 500 16 90 Temperatura di colore 40000 K
Sale di comando o di controllo
Locali impianti, Locali interruttori 200 25 60
Locali telex, posta, quadri di controllo 500 19 80
Magazzini
Zone di immagazzinamento e stoccaggio 100 25 60 200 lx se occupato continuamente
Zone di trasporto, imballaggio, spedizione 300 25 60
Magazzini con scaffali
Corridoi: senza personale 20 - 40 Illuminamento a livello pavimento
Corridoi: con personale 150 22 60 lluminamento a livello pavimento
Centrale di controllo 150 22 60
ATTIVIT INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, ECC.
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Agricoltura
Carico e gestione delle merci, uso di equipaggiamenti e macchinari 200 25 80
Edifici per il bestiame 50 - 40
Zone per animali malati, celle parto 200 25 80
Preparazione mangimi, caseifici, lavaggio utensili 200 25 80
Forni, panifici, pasticcerie
Preparazione, cottura al forno 300 22 80
Finitura, glassatura, decorazione 500 22 80
Cemento, prodotti in cemento, calcestruzzo, mattoni
Asciugatura 50 28 20 I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Preparazione dei materiali, ecc. 200 28 40
Lavorazioni generiche alle macchine 300 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Lavorazioni grossolane 300 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie
Asciugatura 50 28 20 I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Preparazione, lavorazioni generiche con macchinari 300 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Smaltatura, laminatura, stampaggio, formatura di parti semplici, 300 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
montaggio, soffiatura vetro
Molatura, incisione, brillantatura vetro, formatura di precisione, 750 19 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
fabbricazione strumenti in vetro
Molatura di lenti per ottica, molatura manuale cristallo, incisione 750 16 80
Lavori di precisione, ad esempio molatura, decorativa, pittura a mano 1000 16 90 Temperatura di colore 4000 K
Lavorazione di pietre preziose sintetiche 1500 16 90 Temperatura di colore 4000 K
Industria chimica, della plastica e gomma
Impianti di processo controllati a distanza 50 - 20 I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Impianti di processo con intervento manuale limitato 150 28 40
Impianti di processo con presenza 300 25 80
continua di personale
Ambienti per misure di precisione, laboratori 500 19 80
40
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NORMATIVA LILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
ATTIVIT INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, ECC.
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Produzione farmaceutica 500 22 80
Produzione pneumatici 500 22 80
Verifica colori 1000 16 90 Temperatura di colore 4000 K
Taglio, finitura, ispezione 750 19 80
Industria elettrica
Produzione di cavi e conduttori 300 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2 (nota generale)
Avvolgimento bobine di grandi dimensioni 300 25 80
Avvolgimento bobine di medie dimensioni 500 22 80
Avvolgimento bobine di piccole dimensioni 750 19 80
Impregnazione bobine 300 25 80
Galvanizzazione 300 25 80
Assemblaggio grossolano (ad es. grandi trasformatori) 300 25 80
Assemblaggio medio (ad es. quadri elettrici) 500 22 80
Assemblaggio fine (ad es. telefoni) 750 19 80
Assemblaggio di precisione (ad es. strumenti di misura) 1000 16 80
Produzione materiale elettronico, collaudo, aggiustaggio 1500 16 80
Generi alimentari e industrie alimentari di lusso
Postazioni e zone di lavoro in fabbriche di birra, fermentazione 200 25 80
del malto, per lavaggio, riempimento barili, pulizia, setacciamento,
sbucciatura, cottura in fabbriche di conserve e cioccolato,
luoghi e zone di lavoro in zuccherifici, fermentazione
e asciugatura del tabacco, cantine di fermentazione
Selezione e lavaggio prodotti, tritatura, miscelatura, confezionamento 300 25 80
Zone di lavoro e zone critiche in macelli, macellerie, caseifici, mulini; 500 25 80
filtraggio in raffinerie dello zucchero
Taglio e selezione di vegetali e frutta 300 25 80
Produzione gastronomica, lavori di cucina, produzione sigari e sigarette 500 22 80
Ispezione di vetri e bottiglie, controllo prodotti, guarnitura, selezione, 500 22 80
decorazione
Laboratori 500 19 80
Controllo dei colori 1000 16 90 Temperatura di colore 4000 K
Fonderie e simili
Gallerie di manutenzione, celle, ecc. 50 - 20 I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Piattaforme 100 25 40 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2 (nota generale)
Preparazione sabbie 200 25 80
Spogliatoi 200 25 80
Zone di lavoro presso miscelatori, ecc 200 25 80
Colate 200 25 80
Modellazione a macchina 200 25 80
Modellazione manuale 300 25 80
Pressofusione 300 25 80
Reparti modelli 500 22 80
Parrucchieri
Taglio di capelli 500 19 90
Produzione gioielli
Lavorazioni con pietre preziose 1500 16 90 Temperatura di colore 4000 K
Produzione gioielli 1000 16 90
Montaggio di orologi (manuale) 1500 16 80
Montaggio di orologi (automatica) 500 19 80
Lavanderie e tintorie
Ricevimento prodotti, marcatura e smistamento 300 25 80
Lavaggio e pulizia a secco 300 25 80
Stiratura 300 25 80
Ispezione e riparazione 750 19 80
Pelle e prodotti in pelle
Lavori presso tini, vasche, fosse 200 25 40
Scarnatura, follatura, tiratura, lucidatura 300 25 80
delle pelli
Lavori di selleria e manifattura scarpe: cucitura, lucidatura, formatura, 500 22 80
taglio, foratura
Scelta e selezione 500 22 90 Temperatura di colore 4000 K
Tintura del cuoio (a macchina) 500 22 80
Controlli di qualit 1000 19 80
NORMATIVA LILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 41
ATTIVIT INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, ECC.
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Controllo dei colori 1000 16 90 Temperatura di colore 4000 K
Produzione scarpe 500 22 80
Produzione guanti 500 22 80
Lavorazione e trasformazione dei metalli
Fucinatura libera 200 25 60
Fucinatura a stampo 300 25 60
Saldatura 300 25 60
Lavorazione grossolana o media: tolleranza 0,1 mm 300 22 60
Lavorazione fine: tolleranza < 0,1 mm 500 19 60
Tracciatura, ispezione 750 19 60
Laboratori di trafilatura e realizzazione tubi o cavi;
formatura a freddo 300 25 60
Lavorazione laminati: spessore 5 mm 200 25 60
Lavorazione fogli: spessore < 5 mm 300 22 60
Fabbricazione utensili e attrezzi da taglio 750 19 60
Assemblaggio grossolano 200 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Assemblaggio medio 300 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Assemblaggio fine 500 22 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Assemblaggio di precisione 750 19 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Galvanizzazione 300 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Preparazione superfici e verniciatura 750 25 80
Attrezzi, preparazione sagome e calibri, meccanica di precisione, 1000 19 80
micromeccanica
Carta e oggetti di carta
Preparazione dellimpasto, raffinazione 200 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Fabbricazione e trasformazione della carta, macchine per carta 300 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
e cartone ondulato, fabbricazione del cartone
Lavori di rilegatura, ad es. piegatura, smistamento, incollaggio, taglio, 500 22 80
stampa, cucitura
Centrali elettriche
Impianto di alimentazione combustibile 50 - 20 I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Locale caldaie 100 28 40
Sala turbine 200 25 80
Locali annessi, ad es. locali pompe, locali condensatori, quadri 200 25 60
di controllo interni
Sale di controllo 500 16 80 1. I quadri di controllo sono spesso verticali
2. Possono essere necessari apparecchi con regolazione del flusso
luminoso
3. Per postazioni di lavoro con videoterminali vedasi il testo
Dispositivi esterni di controllo 20 - 20 I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Stamperie
Taglio, doratura, stampa in rilievo, lavori su pietra, macchine da stampa, 500 19 80
costruzione matrici
Selezione fogli e stampa a mano 500 19 80
Montaggio caratteri, ritocco, litografia 1000 19 80
Controllo colori (stampa policromatica) 1500 16 90 Temperatura di colore 5000 K
Incisione su acciaio e rame 2000 16 80 Pu essere necessaria lilluminazione direzionale
Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio
Impianti di produzione senza intervento manuale 50 - 20 I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Impianti di produzione con intervento manuale occasionale 150 28 40
Impianti di produzione con intervento manuale continuo 200 25 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Magazzini laminati 50 - 20 I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Fornaci 200 25 20 I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Laminatoi, avvolgitori, linea di taglio 300 25 40
Piattaforme di controllo, quadri di controllo 300 22 80
Prova, misura e controllo 500 22 80
Gallerie di manutenzione, zona cinghie, ecc. 50 - 20 I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Lavorazione e manifattura tessile
Zone di lavoro a lato delle vasche di lavaggio, apertura balle 200 25 60
Cardatura, lavaggio, stiratura, disegno, pettinatura, incollaggio, 300 22 80
punzonatura cartoni, prefilatura, filatura juta e canapa, ecc.
42
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NORMATIVA LILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
ATTIVIT INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, ECC.
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Filatura, ritorcitura, aspatura, bobinatura 500 22 80 Occorre impedire leffetto stroboscopico
Ordinatura, tessitura, intrecciatura, maglieria 500 22 80 Occorre impedire leffetto stroboscopico
Cucitura, maglieria fine, rimagliatura, rammendo 750 22 80
Disegno manuale, disegno trame 750 22 90 Temperatura di colore 4000 K
Finitura, tintura 500 22 80
Camera di asciugatura 100 28 60
Stampaggio automatico 500 25 80
Annodatura, ispezione della trama, ecc. 1000 19 80
Ispezione colori, controllo fabbricazione 1000 16 90 Temperatura di colore 4000 K
Rammendo invisibile 1500 19 90 Temperatura di colore 4000 K
Manifattura cappelli 500 22 80
Costruzione veicoli
Lavori su carrozzeria e assemblaggio 500 22 80
Verniciatura, spruzzatura, lucidatura 750 22 80
Verniciatura: ritocco, ispezione 1000 19 90 Temperatura di colore 4000 K
Rivestimenti interni (ambienti con personale) 1000 19 80
Ispezione finale 1000 19 80
Lavorazione e manifattura del legno
Processi automatici, ad es. essiccazione, 50 28 40
produzione compensato
Camere del vapore 150 28 40
Lavorazioni con seghe 300 25 60 Occorre impedire leffetto stroboscopico
Lavori al banco di falegnameria, incollaggio, assemblaggio 300 25 80
Lucidatura, verniciatura, falegnameria artistica 750 22 80
Lavorazioni su macchine utensili, ad es. tornitura, 500 19 80 Occorre impedire leffetto stroboscopico
scannellatura, sgrossatura, ribassatura, scanalatura,
taglio, segatura, cavatura
Selezione legno per impiallacciatura 750 22 90 Temperatura di colore 4000 K
Lavori di intarsio 750 22 90 Temperatura di colore 4000 K
Controllo qualit, ispezione 1000 19 90 Temperatura di colore 4000 K
UFFICI
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Archiviazione, copiatura 300 19 80
Scrittura, dattilografia, lettura, elaborazione dati 500 19 80 Per postazioni di lavoro con videoterminali vedasi il testo
Disegno tecnico 750 16 80
Postazioni CAD 500 19 80 Per postazioni di lavoro con videoterminali vedasi il testo
Sale conferenze e riunioni 500 19 80 Lilluminazione deve essere regolabile
Reception 300 22 80
Archivi 200 25 80
VENDITA AL DETTAGLIO
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Zone di vendita 300 22 80 Lilluminamento Em e lUGR richiesti sono determinati dal tipo di negozio
Casse 500 19 80
Tavolo di imballaggio 5000 19 80
LUOGHI E LOCALI PUBBLICI
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Spazi comuni
Ingressi 100 22 80 UGR solo se applicabile
Guardaroba 200 25 80
Sale di attesa 200 22 80
Biglietterie 300 22 80
Ristoranti e hotel
Reception/cassa, portineria 300 22 80
Cucina 500 22 80 Deve esserci una zona di transizione tra la cucina e la sala ristorante
Sala ristorante, sala da pranzo, sala ricevimenti - - 80 Lilluminazione deve creare unatmosfera appropriata
Ristoranti self-service 200 22 80
Buffet 300 22 80
Sale conferenze 500 19 80 Lilluminazione dovrebbe essere regolabile
NORMATIVA LILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 43
LUOGHI E LOCALI PUBBLICI
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Corridoi 100 25 80 Durante la notte livelli di illuminamento pi bassi sono accettabili
Teatri, sale concerto, cinema
Sale di prova, spogliatoi 300 22 80 Lilluminazione degli specchi per il trucco deve essere priva
di abbagliamento
Fiere, padiglioni espositivi
Illuminazione generale 300 22 80
Musei
Oggetti esposti insensibili alla luce - - - Lilluminazione determinata dalle esigenze di esposizione
Oggetti esposti sensibili alla luce - - - 1. Lilluminazione determinata dalle esigenze di esposizione
2. La protezione contro le radiazioni dannose
di somma importanza
Librerie
Scaffali 200 19 80
Zona di lettura 500 19 80
Casse, punti informazione al servizio del pubblico 500 19 80
Parcheggi pubblici (al coperto)
Rampe di ingresso/uscita (durante il giorno) 300 25 20 1. Illuminamento a livello suolo
2. I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Rampe di ingresso/uscita (durante la notte) 75 25 20 1. Illuminamento a livello suolo
2. I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Corsie di circolazione 75 25 20 1. Illuminamento a livello suolo
2. I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
Zone di parcheggio 75 - 20 1. Illuminamento a livello suolo
2. I colori dei segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
3. Un illuminamento verticale elevato aumenta il riconoscimento del viso
delle persone e quindi il senso di sicurezza
Biglietteria 300 19 80 Occorre evitare la riflessione nelle finestre e labbagliamento
dovuto allesterno
STRUTTURE SCOLASTICHE
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Asili nido, scuole materne
Aule gioco 300 19 80
Nursery 300 19 80
Aule per lavoro manuale 300 19 80
Edifici scolastici
Aule scolastiche 300 19 80 Lilluminazione deve essere regolabile
Aule in scuole serali e per adulti 500 19 80 Lilluminazione deve essere regolabile
Sale lettura 500 19 80 Lilluminazione deve essere regolabile
Lavagna 500 19 80 Occorre evitare le riflessioni speculari
Tavolo per dimostrazioni 500 19 80 Nelle sale lettura 750 lx
Aule educazione artistica 500 19 80
Aule educazione artistica in scuole darte 750 19 90 Temperatura di colore 5000 K
Aule per disegno tecnico 750 16 80
Aule per educazione tecnica e laboratori 500 19 80
Aule lavori artigianali 500 19 80
Aule di musica 300 19 80
Laboratori di informatica 300 19 80 Per postazioni di lavoro con videoterminali vedasi il testo
Laboratori linguistici 300 19 80
Aule di preparazione e officine 500 22 80
Ingressi 200 22 80
Zone di circolazione, corridoi 100 25 80
Scale 150 25 80
Sale comuni per gli studenti e aula magna 200 22 80
Sale professori 300 19 80
Biblioteca: scaffali 200 19 80
Biblioteca: zone di lettura 500 19 80
Magazzini materiale didattico 100 25 80
Palazzetti, palestre, piscine (uso generale) 300 22 80 Per specifiche attivit vedere la norma UNI EN 12193
Mensa 200 22 80
Cucina 500 22 80
44
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NORMATIVA LILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
STRUTTURE SANITARIE
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Locali di uso generale
Sale attesa 200 22 80 Tutti gli illuminamenti a livello del pavimento
Corridoi: durante il giorno 200 22 80 Tutti gli illuminamenti a livello del pavimento
Corridoi: durante la notte 50 22 80 Tutti gli illuminamenti a livello del pavimento
Day room 200 22 80 Tutti gli illuminamenti a livello del pavimento
Locali per il personale
Uffici 500 19 80
Stanze del personale 300 19 80
Reparti, reparti maternit
Illuminazione generale 100 19 80 Occorre evitare luminanze troppo elevate nel campo visivo dei pazienti
Illuminamento a livello del pavimento
Illuminazione di lettura 300 19 80 Occorre evitare luminanze troppo elevate nel campo visivo
dei pazienti - Illuminamento a livello del pavimento
Visita semplice 300 19 80 Occorre evitare luminanze troppo elevate nel campo visivo dei pazienti
Illuminamento a livello del pavimento
Visita e trattamento 1000 19 80 Occorre evitare luminanze troppo elevate nel campo visivo dei pazienti
Illuminamento a livello del pavimento
Luce notturna, luce di sorveglianza 5 - 80 Occorre evitare luminanze troppo elevate nel campo visivo dei pazienti
Illuminamento a livello del pavimento
Bagni, toilette per pazienti 200 22 80 Occorre evitare luminanze troppo elevate nel campo visivo dei pazienti
Illuminamento a livello del pavimento
Locali per visite diagnostiche
Illuminazione generale 500 19 90
Visita e trattamento 1000 19 90
Locali per visite oculistiche
Illuminazione generale 300 19 90
Visita esterna dellocchio 1000 - 90
Test di lettura e visione dei colori su pannelli 500 16 90
Locali per visite otorinolaringoiatriche
Illuminazione generale 300 19 80
Visita orecchio 1000 - 90
Locali analisi
Illuminazione generale 300 19 80
Analisi con amplificatore di immagini e sistemi televisivi 50 19 80 Per postazioni di lavoro con videoterminali vedasi il testo
Sale parto
Illuminazione generale 300 19 80
Visita e trattamento 1000 19 80
Locali di cura
Locale dialisi 500 19 80 Lilluminazione dovrebbe essere regolabile
Locale dermatologia 500 19 80
Locale endoscopia 300 19 80
Locale ingessatura 500 19 80
Bagni medicali 300 19 80
Locale massaggio e radioterapia 300 19 80
Sale operatorie
Locale pre-operatorio e risveglio 500 19 90
Sala operatoria 1000 19 90
Area operatoria (paziente) - - - Em da 10000 lx a 100000 lx
Rianimazione e cure intensive
Illuminazione generale 100 19 90 Illuminamento a livello pavimento
Visita semplice 300 19 90 Illuminamento a livello pavimento
Visita e trattamento 1000 19 90 Illuminamento a livello pavimento
Osservazione notturna 20 19 90
Odontoiatria
Illuminazione generale 500 19 90 Lilluminamento sul paziente deve essere esente
da abbagliamento
Sul paziente 1000 - 90 Valori superiori a 5000 lx quando necessario
Zona operatoria (bocca del paziente) 5000 - 90
Verifica del colore dei denti 5000 - 90 Temperatura di colore 6000 K
te a tutto lambiente, ad eccezione
delle zone dove si pu escludere lo
svolgimento dellattivit.
Limportanza del definire esatta-
mente le aree del compito visivo e
quelle immediatamente circostanti
consiste nel fatto che la norma ri-
chiede il rispetto dei limiti di illu-
minamento mantenuto (Em) da es-
sa indicati solo in queste aree.
Pi nel dettaglio, i limiti di illumi-
namento mantenuto indicati nella
tabella x riportata nellarticolo
vanno rispettati nelle aree del
compito visivo, mentre nelle aree
immediatamente circostanti i limiti
sono minori, come indicato nella
tabella 1.
Per quanto riguarda i limiti di illu-
minamento mantenuto si possono
sottolineare i seguenti aspetti:
Essi si riferiscono alla superficie
di riferimento dellarea da illu-
minare, che pu essere orizzon-
tale, verticale o inclinata.
raccomandato un aumento
dellilluminamento mantenuto se
il compito visivo dellattivit
svolta critico, mentre in casi
particolari ammessa una sua
riduzione.
Nelle aree occupate in modo con-
tinuativo, lilluminamento man-
tenuto non pu scendere sotto i
200 lx.
In unarea, lilluminamento deve es-
sere garantito nel modo pi uni-
forme possibile.
Per tale ragione, la norma EN
12464-1 richiede ununiformit di
illuminamento di almeno 0,7 nelle
aree del compito visivo, mentre
nelle aree immediatamente circo-
stanti si accontenta di ununi-
formit di almeno 0,5.
ABBAGLIAMENTO
La seconda novit della norma EN
12464-1 consiste nellintroduzio-
ne di un nuovo parametro finaliz-
zato alla limitazione dellabba-
gliamento. Si tratta di una vera e
propria rivoluzione, in quanto spa-
riscono la classe di qualit G per
la limitazione e le relative curve li-
mite di luminanza previste dalla nor-
ma UNI 10380 ed al loro posto
compare lindice unificato di ab-
bagliamento UGR (Unified Glare Ra-
ting). Questo indice UGR consiste
in un numero, compreso tra 10
(condizioni di abbagliamento mi-
nimo) e 30 (condizioni di abba-
gliamento massimo). La norma ri-
porta una formula (improponibi-
le) con cui calcolare lindice UGR,
che dipende da numerosi para-
metri (luminanza del corpo illumi-
nante e dello sfondo, posizione di
tale corpo rispetto allosservato-
re, ecc.).
Nella pratica, il valore di UGR pu
essere calcolato per mezzo di soft-
ware realizzati dai costruttori dei
corpi illuminanti, in funzione delle
caratteristiche dellambiente di in-
stallazione e della posizione dei
corpi stessi.
Ai fini pratici, durante la realizza-
zione dellimpianto di illuminazio-
ne di un ambiente occorre verificare
che lindice UGR non assuma va-
lori superiori al limite previsto dal-
la norma (tabella x). Di fatto, la li-
mitazione dellabbagliamento pu
essere garantita se le sorgenti lu-
minose sono adeguatamente scher-
mate. La tabella 3 indica langolo
di schermatura minimo dei corpi il-
luminanti in funzione della lumi-
nanza delle sorgenti.
RESA DEL COLORE
Per resa del colore si intende la
capacit dellilluminazione artifi-
ciale di rendere correttamente i
colori dellambiente, degli oggetti
e della pelle umana. Per caratte-
NORMATIVA LILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 45
STRUTTURE SANITARIE
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Laboratori e farmacie
Illuminazione generale 500 19 80
Ispezione colori 1000 19 90 Temperatura di colore 6000 K
Locali di decontaminazione
Locali sterilizzazione e simili 300 22 80
Locali per autopsia e camere mortuarie
Illuminazione generale 500 19 90
Tavolo per autopsia e dissezione 5000 - 90 Valori superiori a 5000 lx quando necessario
AREE PER TRASPORTI
Tipo di ambiente, compito o attivit svolta E
m
(lx) UGR
L
R
a
- Note e osservazioni
Aeroporti
Sale di arrivo e partenza, zone ritiro bagagli 200 22 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Zone di collegamento, scale e tappeti mobili 150 22 80
Banchi informazioni, accettazione 500 19 80 Per postazioni di lavoro con videoterminali vedasi il testo
Dogana e controllo passaporti 500 19 80 Lilluminamento verticale importante
Sale attesa 200 22 80
Deposito bagagli 200 25 80
Zone controllo di sicurezza 300 19 80
Torre di controllo traffico aereo 500 16 80 1. Lilluminazione deve essere regolabile
2. Per postazioni di lavoro con videoterminali vedasi il testo
3. Labbagliamento da luce diurna deve essere evitato
4. Occorre evitare la riflessione sulle finestre, specialmente durante
la notte
Hangar per le riparazioni ed i controlli 500 22 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Zone controllo motori 500 22 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Zone di misura allinterno degli hangar 500 22 80 Per ambienti di grande altezza vedasi la norma, art. 4.6.2
Stazioni ferroviarie
Banchine e sottopassi per passeggeri 50 28 40
Atri e sala vendita biglietti 200 28 40
Biglietterie, depositi bagagli, casse 300 19 80
Sale di attesa 200 22 80
TABELLA 3 - ANGOLO DI SCHERMATURA
MINIMO DEI CORPI ILLUMINANTI
Luminanza della sorgente Angolo di schermatura minimo
Da 20 kcd m
-2
(compreso) 15
a 50 kcd m
-2
Da 50 kcd m
-2
(compreso) 20
a 500 kcd m
-2
Oltre 500 kcd m
-2
(compreso) 30
La norma EN 12464-1 tratta numerose altre problematiche,
che non si potuto affrontare in questa sede, per ragioni di spa-
zio, e per le quali si rimanda alla norma stessa.
Si possono citare ad esempio:
lilluminazione direzionale;
lo sfarfallamento e gli effetti stroboscopici;
la riduzione dei consumi energetici;
lintegrazione tra luce naturale e luce artificiale.
ULTERIORI ASPETTI TRATTATI DALLA NORMA
rizzare la resa del colore delle sor-
genti luminose, la norma EN 12464-
1 utilizza lindice di resa del colo-
re Ra, che consiste in un numero
compreso tra 0 e 100: a valori mag-
giori dellindice Ra corrisponde
una migliore resa del colore della
sorgente. Rispetto alla norma UNI
10380 non pi definito il gruppo
di resa del colore.
Ai fini pratici, durante la realizza-
zione dellimpianto di illuminazio-
ne di un ambiente occorre verificare
che lindice Ra non assuma valori
superiori al limite previsto dalla
norma (tabella x).
La resa del colore di una sorgente
ovviamente legata allapparenza
del colore della sorgente stessa, che
viene caratterizzata con la tem-
peratura di colore, come indicato nel-
la tabella 4.
DISTRIBUZIONE
DELLA LUMINANZA
La distribuzione della luminanza nel
campo visivo importante per as-
sicurare una corretta visibilit ed
un adeguato comfort visivo.
Se le luminanze sono ben bilanciate,
infatti, si ha un aumento della chia-
rezza della visione, una maggiore
nitidezza dei contrasti; migliora
inoltre lefficienza delle funzioni
oculari (movimenti degli occhi,
contrazioni delle pupille, conver-
genza, ecc.). Se le luminanze e/o i
contrasti di luminanza sono trop-
po elevati, invece, si hanno problemi
di abbagliamento e di affatica-
mento visivo. Al tempo stesso, lu-
minanze e/o contrasti di luminan-
za troppo bassi rendono lambiente
spento e poco stimolante. Per ot-
tenere luminanze ben bilanciate, la
norma EN 12464-1 prevede che le
superfici che delimitano gli am-
bienti presentino i seguenti fatto-
ri di riflessione:
- soffitto: da 0,6 a 0,9;
- pareti: da 0,3 a 0,8;
- piani di lavoro: da 0,2 a 0,6;
- pavimento: da 0,1 a 0,5.
FATTORE
DI MANUTENZIONE
A differenza della norma UNI 10380,
che specificava i valori del fattore
di manutenzione da assumere in ba-
se alla tipologia di lampada ed al li-
vello di polverosit dellambiente,
la norma EN 12464-1 non dice nul-
la al riguardo. Spetta pertanto al pro-
gettista dellimpianto di illumina-
zione definire il fattore di manu-
tenzione, tenendo conto delle ca-
ratteristiche dellambiente, dei cor-
pi illuminanti, ecc.
Il progettista deve inoltre preparare
un adeguato programma di ma-
nutenzione, nel quale siano ripor-
tati la frequenza di sostituzione
delle lampade, gli intervalli di pu-
lizia di ambienti ed apparecchi, i me-
todi utilizzati per questa pulizia, ecc.
ILLUMINAZIONE
DELLE POSTAZIONI
DI LAVORO
CON VIDEOTERMINALI
La presenza di videoterminali in
un ambiente di lavoro complica la
realizzazione dellimpianto di il-
luminazione, poich occorre evi-
tare le riflessioni sui loro schermi.
A tale scopo, necessario posi-
zionare in modo opportuno i cor-
pi illuminanti. Se un corpo illu-
minante riflesso sullo schermo
di un videoterminale, la sua lu-
minanza media non deve superare
il limite riportato nella tabella 5 (ap-
plicabile a corpi illuminanti po-
sti in modo da avere angoli di
elevazione di 65 o superiori ri-
spetto alla verticale, per lillumi-
nazione di ambienti con schermi
inclinati fino a 15).
46
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NORMATIVA LILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
Figura 1 - Esempio di aree di compito
visivo(A.C.V.) e relative aree
immediatamente
circostanti (A.I.C.)
TABELLA 4 - LEGAME TRA TEMPERATURA
DI COLORE E APPARENZA
Temperatura di colore Apparenza del colore
di una sorgente
Minore di 3300 K Calda
Da 3300 K a 5300 K Intermedia
Maggiore di 5300 K Fredda
TABELLA 5 - LIMITI DI LUMINANZA
Qualit dello schermo (classe Massima luminanza media
secondo la norma ISO 9241-7) dei corpi illuminanti
Buona (I) 1000 cd m
-2
Media (II) 1000 cd m
-2
Scarsa (III) 200 cd m
-2
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
8
7
Unazienda competente per risolvere le tue necessit impiantistiche?
CEB. Libert di scelta, scelta di sicurezza
CEB ITALIA SRL Carpenteria per quadri elettrici / Via del Lavoro, 4 / 20040 Usmate Velate (Mi)
Telefono 039-62884.1 / Fax 039-6829421 / Internet: www.cebitalia.it / E-mail: ceb
@
cebitalia.it
Con CEB
trovi sempre soluzioni
Ceb non teme confronti. Per la sua competenza tecnica
e per lampia gamma di soluzioni: armadi, casse e leggii
per soddisfare le condizioni di impiego pi critiche nella
distribuzione di energia e nellautomazione.
Per la grande flessibilit: una serie estremamente completa
di accessori e componenti per qualsiasi necessit.
Per la completa libert: produzioni speciali con forature,
colori e allestimenti su misura per esigenze specifiche.
Per le forti prestazioni: armadi anche in versione Inox AISI
304 per ambienti difficili. Per la sicurezza e la qualit:
grado di protezione IP55, rigorose prove di laboratorio,
di tenuta al cortocircuito e ai limiti di sovra-
temperatura per ottenere le certificazioni
UL, TUV, CESI e ACAE-LOVAG.
Informatevi, con un armadio Ceb
non esiste scelta migliore.
M
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
1
1
L
a nuova tecnica digitale
destinata a cambiare pro-
gressivamente il modo di
fruire del servizio televisivo e, in pro-
spettiva, di modificare molte abi-
tudini di diversi milioni di italiani.
Lunione europea ha fissato per il
31-12-2010 la cessazione delle tra-
smissioni televisive analogiche,
mentre lItalia ha decretato il ter-
mine ultimo per il 31-12-2006.
Le trasmissioni analogiche do-
vranno essere sostituite dalle tra-
smissioni digitali diffuse via etere:
ci vuol dire che entro tale data 50
milioni di tv presenti nelle famiglie
italiane dovranno essere dotate
di ricevitori digitali terrestri.
Nel corso di questo approfondi-
mento, viene data maggiore enfa-
si ai servizi associati alla diffusio-
ne della nuova tecnica televisiva,
al confronto con gli altri modi di dif-
fusione del segnale digitale, al si-
gnificato della cos detta piatta-
forma digitale, unitamente ad al-
cune informazioni di ordine com-
merciale e di orientamento per il con-
sumatore.
Si cercher poi di capire pi da vi-
cino cosa si intenda effettivamen-
te per servizio interattivo, qua-
li siano le opportunit legate a
questo nuovo modo di intendere la
televisione, quale sia e in qual mi-
sura esista una novit in ordine
alla strumentazione tecnica ne-
cessaria per la ricezione delle
nuove trasmissioni in digitale gi
disponibili nelletere e, in parti-
colare, come orientarsi per la scel-
ta del decoder che pi sia alli-
neato con le aspettative.
Verr, inoltre, analizzato cosa stia
accadendo a livello europeo.
Al di l dei dati numerici di un
mercato in forte crescita, stimato
attraverso le varie societ di ana-
lisi, va detto che ormai forte il li-
vello di percezione attorno alla co-
siddetta tv del futuro. Se ne sen-
te parlare con curiosit tra amici e
colleghi e sono sempre pi fre-
quenti le campagne pubblicitarie
attraverso la comunicazione tele-
visiva di prima serata, per non par-
lare della grande attenzione riser-
vata dalla stampa specializzata.
La televisione del futuro gi real-
t per le zone coperte dal servizio:
ventisei sono i canali televisivi gi
diffusi e in onda con la nuova mo-
dalit tutta numerica ed oltre
400.000 i decoder interattivi venduti
con il contributo dello Stato, a cui
si aggiungono altri 100.000 non
interattivi.
Le stime per limmediato futuro
parlano di una rapida espansione
del nuovo sistema, cio di circa
800mila famiglie attivate dai
nuovi servizi resi disponibili dai
decoder interattivi.
Le previsioni per i prossimi due
anni indicano un parco installato di
decoder vicino alle 4 milioni di uni-
t che rappresenta un dato rile-
vante se sommato alle oltre 7 mi-
lioni di antenne paraboliche dellaltro
contenitore digitale, quello satel-
litare, che darebbe un totale di 11
milioni di ricevitori digitali in fun-
zione.
Ed sicuramente un fatto positivo
che la diffusione del nuovo sistema
si stia sviluppando in unera in cui
la tv digitale satellitare, gi cos ra-
dicata, sembra possa fargli da apri-
pista, in quanto complementare e
non concorrente, essendo rivolta ad
un target di utenza tematico e pi
specialistico. Il digitale terrestre,
quello che permette di moltiplica-
re per 4 o addirittura per 5 le attuali
reti nazionali che tutti riceviamo nel-
le nostre case e che, da 12, diven-
teranno perci 50-60, va messo in-
vece in relazione con la tv gene-
ralista dei canali nazionali e loca-
li diffusi via etere in analogico ai qua-
li subentrer in modo definitivo. Inol-
tre tutta questa abbondanza di
canali sar via via arricchita con am-
pie possibilit di comunicazione
interattiva e multimediale.
Lavvento generalizzato del digitale
rappresenta in definitiva una base
comune per tutti i mezzi di comu-
nicazione elettronica che potranno
interagire tra loro in modo pi na-
turale: radio, tv, telefonia fissa e mo-
bile, Internet, parleranno final-
mente la stessa lingua.
La rivoluzione televisiva digitale ha
gi mostrato i suoi effetti con la tv
via satellite, con la proliferazione di
canali tematici, in genere a paga-
mento, diretti alle cosiddette fa-
sce alte della popolazione .
Per il digitale terrestre si tratta
adesso di coniugare insieme una
proposta forzatamente genera-
lista, in quanto diretta al gran-
de pubblico, con una serie di ca-
nali tematici non a pagamento, ri-
volta ad uno spettatore pi adul-
to e in grado di fare le sue scelte
come pure di influenzare il broad-
caster a causa della nuova forza
che gli ora attribuita dallinte-
rattivit.
Per questi e altri motivi auspicabile
che il digitale terrestre si diffonda
molto pi rapidamente di quanto
non abbia fatto il satellitare.
Inoltre c anche unaltra grande op-
portunit. Si tratta di risolvere una
volta per tutte il problema della
qualit televisiva in un mercato
aperto, in una democrazia moder-
na della comunicazione: fare del di-
gitale terrestre un vero motore per
la qualit del sistema televisivo
italiano.
In Italia si parla di unindustria
forte che allargherebbe i concorrenti,
Gli sviluppi e limpatto della
televisione digitale sul mercato
dellinstallazione; che cosa suc-
cede in Italia e in Europa
Nuove tecnologie:
levoluzione della tv
Pierfrancesco Sodini
48
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
SPECIALE
IL DIGITALE TERRESTRE
Gli anni 2004 e 2005 sono e saranno di transizione per
la diffusione, presso i cittadini, della conoscenza dei
nuovi servizi associati al digitale terrestre e, da parte dei
broadcaster, per la costruzione delle nuove reti digita-
li capaci di assicurare coperture via via maggiori che, co-
me fissato da Governo e Parlamento, hanno pianificato
dei programmi di sviluppo per la progressiva copertura
del territorio nazionale.
Rai, Mediaset e La7 hanno dichiarato, al 31 dicembre 2003,
una copertura superiore al 50% della popolazione italiana,
attivando le seguenti citt principali: Aosta, Torino, Mi-
lano, Trento, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firen-
ze, Ancona, Perugia, LAquila, Roma, Campobasso, Na-
poli, Bari, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari.
Mediaset ha nel frattempo dotato di set-top-box duemila
famiglie in Lombardia per testare canali e servizi inte-
rattivi. Il passo successivo sar quello del 31 dicembre
2004, quando dovr essere coperto il 70% della popolazione.
f
o
c
u
s
Obiettivi di copertura
F
o
t
o
:
T
o
s
h
i
b
a
SPECIALE NUOVE TECNOLOGIE: LEVOLUZIONE DELLA TV
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 49
oltre a Rai e Mediaset, anche a
La7 e Telecom e forse anche a Tim
e Fastweb.
Lingegnere Guido Salerno, diret-
tore generale della fondazione Ugo
Bordoni, sensibile a questo tipo
di causa, ha evidenziato che tra
le due tecnologie - digitale satelli-
tare e terrestre - non c concorrenza
ma complementariet, a comin-
ciare dai mercati di riferimento: la
tv satellitare sar sempre pi orien-
tata al modello pay, che potr reg-
gere economicamente lofferta di
grandi eventi sportivi e di spetta-
colo, a cominciare ovviamente dai
campionati di calcio.
Il futuro del digitale terrestre il free-
to-air (cio la tv non a pagamento):
arricchir i contenuti e i servizi
della televisione generalista di
massa.
ATTUALIT DESTATE
A conforto della tesi secondo la
quale il digitale terrestre stato con-
cepito come un servizio di largo
utilizzo destinato alla totalit dei cit-
tadini, nelle ultime settimane si
sono verificate le prime scherma-
glie commerciali tra alcuni degli
attori principali, per un tema come
il calcio al quale gli operatori da sem-
pre attribuiscono grande atten-
zione, segno che intravedono un
mercato di sicuro business anche
per la nuova modalit di trasmis-
sione. Da sottolineare, in primo
luogo, il terremoto che ha scon-
volto gli equilibri dei diritti tv per
il calcio italiano, mettendo di fatto
Mediaset contro Sky, a causa del-
la prossima introduzione, da par-
te di Mediaset, della scheda pre-pa-
gata per acquistare prodotti lega-
ti ad alcune partite di calcio di se-
rie A, fruibili sul digitale terrestre
gi dal prossimo autunno in via
sperimentale.
Di fatto Mediaset, acquistando in
esclusiva i diritti di Juve, Milan ed
Inter per il digitale terrestre, di-
ventata la diretta avversaria degli
abbonamenti Sky per la tv satelli-
tare. Ci non bastasse, questi club,
con laggiunta di Roma, Sampdo-
ria, Atalanta, Livorno e Messina, era-
no freschi di accordo firmato con Sky
per il satellite.
Dallautunno partiranno le prime
sperimentazioni territoriali al nord
(inizialmente per le sole partite in-
terne dei tre club), bacino delle
tre big interessate allaffare mes-
so a segno da Cologno Monzese. Ba-
ster passare in tabaccheria o dal
giornalaio, comprare una scheda si-
mile a quella telefonica, investire
una cifra che a detta di molti po-
trebbe oscillare tra i due ed i tre eu-
ro a partita per vedere la squadra
del cuore sul digitale irradiato via
etere da Mediaset.
Sembra possibile che in casa Me-
diaset si stia pensando di portare
sul digitale terrestre tutta la serie
A, quando invece Murdoch puntava
proprio allesclusiva calcistica per
portare in utile Sky Italia.
In casa Sky tutto questo suona-
to come un campanello dallarme
e non devono averla presa bene se
adesso si sta cercando di far pas-
sare il nuovo principio secondo il
quale i prezzi pagati alle societ di
calcio potranno essere fissati sol-
tanto in base al reale bacino di
utenza di ciascuna squadra. In-
fatti da qualche tempo le tifoserie
vengono costantemente monitorate
per stabilirne il relativo valore eco-
nomico. Secondo le rilevazioni del-
la Nielsen, gli appassionati di cal-
cio in Italia sarebbero circa 27 mi-
lioni: di questi il 24% della Juven-
tus, il 12% del Milan, il 12% dellInter,
il 4% della Roma, eccetera.
Inoltre, sostengono in casa Sky,
un conto vedere le partite in
esclusiva solo su Sky, un altro sa-
r vedere le stesse partite anche sul
digitale terrestre, sui telefonini e sui
computer.
Per altro, dice sempre Sky, oggi
per un tifoso vedere tutte le partite
della squadra del cuore sulla nostra
emittente costa il 40% in meno di
quando doveva abbonarsi a Tele-
pi e Stream. La concorrenza, si di-
ce sempre, non fa paura alla pay tv
italiana che fa parte di un gruppo
(quello di Murdoch appunto) abi-
tuato a concorrere su tutti i mercati
con unofferta completa e di alta
qualit articolata su 130 canali e de-
cine di migliaia di ore mensili di
sport, cinema, news, educational,
programmi per ragazzi, intratte-
nimento e grande calcio.
Sta di fatto che la sfida al monopolio
Sky lanciata: il diretto concor-
rente sta investendo ingenti ri-
sorse nel multimediale e proba-
bilmente la vera partita si gioche-
r nel 2007, quando Mediaset avr
la prelazione su tutti i diritti delle
tre squadre Juve, Milan e Inter,
compresi quelli satellitari.
Se infatti al momento il digitale
terrestre ancora una nicchia con
i suoi 500 mila decoder venduti, con-
tro i quasi 2,7 milioni di abbonati del-
la TV satellitare, il passo compiu-
to da Mediaset ha destato Sky dai
sonni tranquilli nei quali sarebbe pro-
babilmente rimasta fino al 2006, da-
ta che ad oggi risulta fissata per la
fine delle trasmissioni analogiche.
Fonti ufficiali attestano linteresse
di Mediaset per quella che sar la
piattaforma digitale del futuro,
cio linsieme di tecnologie e in-
frastrutture con cui un fornitore
distribuir agli utenti servizi tele-
visivi e multimediali (il segnale
trasmesso, elaborato da un servi-
ce provider, viene ripetuto attraverso
una rete di trasporto detta net-
work delivery system e ricevuto dal-
lutente). Lesigenza di Mediaset sa-
DISTRIBUTORI CODIME SUL TERRITORIO DISTRIBUTORI CODIME SUL TERRITORIO A Ar r e ea a N No or rd d I I t t a al l i i a a www.codime.it www.codime.it
ASSOCIATI CODIME
Piemonte - Liguria - Val dAosta
DEMA S.r.l. - Borgomanero (NO)
EF 90 S.r.l. - Camporosso Mare (IM)
IDG S.p.a. - Alba (CN)
MANNA S.p.a. - Torino
TIEM S.p.a. - Grugliasco (TO)
Lombardia
CEA S.p.a. - Rho (MI)
CIGNOLI ELETTROFORNITURE S.r.l. - Casteggio (PV)
ELETTROBERGAMO S.p.a. - Seriate (BG)
ELETTROWATT S.p.a. - Milano
F.E.E.I. S.r.l. - Cremona
F.E.E.I.2 S.r.l. - Brescia
F.E.E.I.3 S.r.l. - Crema
FEVAL S.r.l. - Chiuro (SO)
GRUPPO SIGMA Distribuzione S.r.l. - Rho (MI)
MAT.EL S.a.s. - Varese
M.E.A.R. S.r.l. - Lecco
Veneto - Friuli - Trentino Alto Adige
PORDELETTRICA S.p.a. - Cordenons (PN)
Emilia Romagna
CA.M.EL. S.r.l. - Modena
ELETTROSERVICE S.r.l. - Reggio Emilia
EL.SA S.r.l. - Sassuolo (MO)
GENERAL COM S.p.a. - SALVATERRA di Casalgrande (RE)
I.F.E. S.r.l. - San Nicol (PC)
I.F.E. Nord S.r.l. - Codogno (LO)
S.E.P. S.r.l. - Parma
AFFILIATI CODIME
Lombardia
ELETTRICA ESSEVI S.r.l. - Sesto S. Giovanni (MI)
FL. FORNITURE ELETTRICHE - Seveso (MI)
GRASSI CARLO & C. S.n.c. - Busto Arsizio (VA)
Emilia Romagna
E.M.E. S.a.s. DI SANTINI PAOLO - Cesena (FO)
Figli di Guido Meluzzi S.r.l. - Rimini
Franciosi Fernando - Carpi (MO)
Ropa Vittorio & C. S.n.c. - Bologna
SEA S.r.l. - Anzola dellEmilia (BO)
POLO COMMERCIALE
Lombardia - Piemonte Emilia
GRUPPO SIGMA Distribuzione S.r.l. - Rho (MI)
una m
area di prem
i dalla
Prom
ozione C
odim
e 2004 richiedi il depliant
al tuo grossista di fiducia
servizio lettori 1792
La rivoluzione
televisiva digitale
ha gi mostrato
i suoi effetti con
la tv via satellite
rebbe quindi quella di diventare
Content provider cio non solo
fornitore ma anche produttore di
contenuti, possibilmente di buona
qualit.
Infatti, sar proprio il digitale uno
dei principali artefici della cosiddetta
convergenza che riunir sotto
un unico comune denominatore
la tv digitale ed internet, linfor-
matica e lelettronica di largo con-
sumo, in unofferta trasversale che
proporr diverse soluzioni parallele
a scelta del consumatore in funzione
delle sue capacit/aspettative per
effettuare la medesima operazione.
Liniziativa di Mediaset sul digita-
le terrestre ha indubbiamente mo-
dificato gli equilibri fin qui costituiti
e, come si usa dire, ha rotto le uo-
va nel paniere al concorrente: se
infatti Sky detiene fino al 2007 il mo-
nopolio di tutte le squadre di serie
A e di una decina di B, non va di-
menticato che sono ancora in cor-
so le trattative tra la tv satellitare
e le societ di calcio per i diritti
relativi al 2005-2007. Al momento
sono 17 le societ di serie A che han-
no ceduto i diritti a Sky per la pros-
sima stagione 2004-2005: Milan,
Juve, Inter, Roma, Lazio, Parma, Bo-
logna, Brescia, Cagliari, Lecce, Li-
vorno, Reggina, Sampdoria, Sie-
na, Udinese, Atalanta e Chievo;
inoltre, per quanto riguarda la Ro-
ma, le trattative per le successive
stagioni sarebbero ferme alla ri-
chiesta della societ capitolina di
ottenere la stessa cifra data al-
lInter (circa 60 milioni di euro a sta-
gione contro i 37,2 milioni attuali),
mentre laccordo con la Lazio sa-
rebbe in dirittura di arrivo con una
cifra che secondo indiscrezioni si ag-
girerebbe intorno ai 35 milioni di eu-
ro. A questo punto Sky, per i fatti
intervenuti, cercherebbe di chiudere
in tempi brevi le negoziazioni in so-
speso.
Altro discorso che tocca ancora
Sky invade invece la sfera del ri-
spetto della legge e delle regole del
gioco.
Il fatto che segue riguarda pi pro-
priamente la tv digitale satellitare,
ma possibile offrire un ulteriore
spunto di valutazione per coloro che
si accingano allacquisto o intendano
rinnovare il proprio ricevitore digitale
satellitare, anche se la notizia ri-
guarda pi propriamente i decoder
satellitari e non quelli terrestri.
La legge violata, secondo lasso-
ciazione dei consumatori Adicon-
sum, sarebbe la n. 79 del 29/03/1999
sul decoder unico che ricorda: i de-
codificatori devono consentire la frui-
bilit delle diverse offerte di pro-
grammi digitali con accesso con-
dizionato e la ricezione dei pro-
grammi radiotelevisivi digitali in
chiaro mediante lutilizzo di un
unico apparato... dal 1 luglio 2000
sono vietate la commercializza-
zione e la distribuzione di appara-
ti non conformi alle predette ca-
ratteristiche ....
Secondo Adiconsum, Sky elude-
rebbe la legge con comportamen-
ti monopolistici ed unilaterali in
quanto non consentirebbe la libera
ricezione di tutti i programmi in
chiaro trasmessi dal satellite at-
traverso limposizione non richie-
sta dai consumatori di uno speci-
fico sistema operativo implemen-
tato sia sui decoder Gold Box con
codifica Seca (ex Tele+), sia su
quelli Nds, sia di propriet sia a no-
leggio.
Inoltre Adiconsum ha chiesto lin-
tervento dellAntitrust per la que-
stione dellabbandono della codi-
fica Seca da parte di Sky. La chiu-
sura delle trasmissioni in Seca, pro-
segue Adiconsum, render inu-
tilizzabili milioni di ricevitori, com-
presi i cosiddetti Common Interface
(cio i decoder equipaggiati con
slot dove possibile inserire il mo-
dulo di accesso condizionato (Cam)
con la relativa smart card della
pay-tv dalla quale si intende ac-
quistare programmi a pagamento),
con caratteristiche tecnologiche
evolute, rispondenti totalmente ai
requisiti di legge e acquistati a ca-
ro prezzo dai consumatori.
Inoltre va aggiunto per comple-
tezza che i decoder non dedicati a
Sky, oltre alla totale libert di visione,
50
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
SPECIALE NUOVE TECNOLOGIE: LEVOLUZIONE DELLA TV
AMRA SpA
Via SantAmbrogio, 23
20050 Macherio (MI)
Tel. : 039 2457545 - Fax : 039 481561
e-mail: info@amra-chauvin-arnoux.it
internet: www.amra-chauvin-arnoux.it
CA 6547/49 CA 6547/49
Il riferimento per la
misura disolamento
a 5000V
(con memoria e
RS232)
Robusto e pratico per
misure fino a 1000V
Lisolamento a 1000V
professionale
(con memoria e RS232)
CHAUVIN ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX
una soluzione per ogni misura disolamento una soluzione per ogni misura disolamento
1kV 1kV
CA 6543 CA 6543
CA 6525 CA 6525
5kV 5kV
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
3
0
SPECIALE NUOVE TECNOLOGIE: LEVOLUZIONE DELLA TV
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 51
offrono delle applicazioni che tec-
nologicamente risultano di inte-
resse rilevante, essendo per esem-
pio dotati di hard disk per la regi-
strazione digitale di quanto ricevuto
o potendo essere integrati con de-
coder per la ricezione del digitale
terrestre.
La questione resta aperta.
Altra informazione di ordine com-
merciale che preme dare in questa
fase di passaggio dal vecchio al
nuovo riguarda il tentativo di ven-
dita on line di un falso decoder
Mediaset.
Lo scorso luglio Mediaset ha diffi-
dato, con una nota ufficiale indi-
rizzata ad alcuni siti web, i riven-
ditori di decoder, dalluso improprio
del marchio aziendale. stato in-
fatti rilevato che in numerose pro-
mozioni on line su Internet ven-
gono utilizzate le diciture decoder
Mediaset o box interattivo uffi-
ciale Mediaset, mentre si precisa
che nessuna societ del gruppo
ha mai prodotto o distribuito de-
coder. In questo modo nessun box
interattivo pu essere scambiato per
un prodotto Mediaset: uninfor-
mazione in pi per il consumatore
e maggior attenzione da parte di chi
ha tratto eventualmente benefi-
cio da questa operazione.
AMBITO
DI APPLICAZIONE
Il digitale terrestre un sistema che
in termini di filosofia di program-
mazione si rivolge ad un bacino
di utenza confrontabile con quel-
lo che attualmente permette di ri-
cevere la normale programma-
zione Rai o Mediaset, il telegiornale
della sera o il programma sportivo
che pi interessa, ben diverso quin-
di dalla tv via satellite.
Si continua a servire degli stessi si-
stemi di antenna attualmente esi-
stenti (con eventuali aggiusta-
menti), con la sola introduzione di
un dispositivo, simile nella forma ad
un videoregistratore, per tradurre
il segnale non pi analogico ma
digitale e renderlo intelligibile in in-
gresso al nostro apparecchio tv.
Essendo il segnale comunque dif-
fuso via etere, come accade ades-
so per lanalogico, le antenne uti-
lizzate continuano ad essere le
stesse, eventualmente potenziate
o ri-posizionate, nei casi in cui il tra-
smettitore digitale abbia diverso si-
to, anche se sembra che le nuove
reti digitali si avvalgano degli stes-
si siti di trasmissione usati per la
tv analogica.
Da quanto detto, sembra del tut-
to evidente che il digitale terrestre
di cui si parla un servizio terre-
stre come lanalogi-
co ma di tecnologia
pi evoluta e dalle
grandi potenzialit,
da non confondere
con la televisione sa-
tellitare, la quale per
definizione invece
irradiata con lausilio
di satelliti e per la ri-
cezione della quale
occorre invece unan-
tenna parabolica.
Si noti, inoltre, che per la tv satel-
litare sono completamente diver-
se le frequenze, il tipo di modula-
zione utilizzata e anche la tipologia
di programmazione per lo pi te-
matica e a pagamento, mentre ri-
sulta che il digitale terrestre do-
vrebbe seguire uno sviluppo che per
le finalit prima accennate risulter
totalmente indirizzato verso la tv
in chiaro.
LA NASCITA
La trasmissione digitale terrestre
costituisce una tappa di fonda-
mentale importanza nello svi-
luppo tecnologico dei sistemi te-
levisivi in quanto guider il pas-
saggio essenziale per la conver-
genza tra il settore dellinforma-
tica a quello delle telecomunica-
zioni, consentendo di trasforma-
re lapparecchio televisivo in quel-
la piattaforma digitale per lo svi-
luppo dei servizi interattivi di cui
talvolta si sente parlare, che si an-
dr ad aggiungere al-
la tradizionale fun-
zione di diffusione cir-
colare dei segnali.
Allorigine delle atti-
vit europee in questo
campo c il progetto
Digital Video Broad-
casting (Dvb) pro-
mosso dalla Commis-
sione europea allo sco-
po di definire standard comuni.
Il progetto, cui hanno partecipa-
to 170 societ coinvolte nei di-
versi settori dellindustria tele-
visiva, ha raggiunto lobiettivo di
stabilire un unico standard con-
diviso su scala europea per le
trasmissioni televisive via satel-
lite (Dvb-S), via cavo (Dvb-C) e
via terra (Dvb-T).
Tali standard sono stati succes-
sivamente adottati anche dal
Giappone e da altri paesi non eu-
ropei. Gli standard digitali, svi-
luppati in seno al Consorzio eu-
ropeo Dvb, sono stati ratificati
dallEtsi (European Telecommu-
nications Standards Institute),
lIstituto europeo di normazione
per il settore delle telecomuni-
cazioni con sede a Sophia Antipolis
(Francia).
COME RICEVERE
Grazie allintroduzione del digita-
le terrestre, la tv italiana potr
proporre sempre pi nuovi pro-
grammi e canali tematici in chiaro,
in grado di soddisfare, insieme al-
lintrattenimento e ai servizi, anche
le istanze di consumo culturale e di
approfondimento che scaturiscono
da un pubblico sempre pi esi-
gente. Per accedere alla nuova te-
levisione digitale terrestre possibile
gi da ora acquistare un adattatore
denominato set-top-box che con-
sente di continuare a utilizzare,
oltre allapparecchio televisivo gi
in uso, lo stesso impianto esisten-
te salvo piccole modifiche o inte-
grazioni a livello del sistema dan-
tenna.
Infatti i nuovi trasmettitori digita-
li dei maggiori Network televisivi
sono installati, come detto, sugli
stessi siti e mantengono in linea di
massima gli stessi puntamenti de-
gli impianti analogici; pertanto in
generale, acquistando il decoder
possibile trovare, nelle citt gi
coperte dal servizio, il segnale in an-
tenna senza operare grandi modi-
ficazioni sullimpianto.
INTERATTIVIT
Nellambito del Consorzio euro-
peo Dvb, Digital video broadca-
sting, stata messa a punto la
piattaforma multimediale per le
applicazioni domestiche, deno-
minata Mhp, Multimedia Home
DISTRIBUTORI CODIME SUL TERRITORIO DISTRIBUTORI CODIME SUL TERRITORIO www.codime.it www.codime.it
ASSOCIATI CODIME
Toscana - Umbria
ELECTRA COMMERCIALE S.r.l. - Poggibonsi (SI)
ELETTROMARKET BASSONI S.r.l. - Pisa
I.M.E.F. S.r.l. - Foligno (PG)
INNOCENTI & CAMMELLI S.p.a. - Firenze
UMBRA ELETTROFORNITURE S.r.l. - Perugia
Marche - Abruzzo
ELETTRO S.r.l. - San Benedetto del Tronto (AP)
I.M.E.C. S.r.l. - Corinaldo (AN)
Lazio
ELETTROFORNITURE PADUA - Aprilia (LT)
FEP S.r.l. - Roma
ELETTROFORNITURE BORGHINI S.p.a. - Roma
Sardegna
GIORGIO DESSY - Cagliari
ELETTROCOLLI S.r.l. - Nuoro
SETZI OLBIA S.r.l. - Olbia
AFFILIATI CODIME
Toscana - Umbria
EFA S.r.l. - Massa (MS)
Elettroforniture Montauti di Montauti Fabio
& C. S.n.c. - Piombino (LI)
ELFI S.r.l. - Lunata Capannori (LU)
ELIN S.r.l. - Gualdo Tadino (PG)
FO.M.EL. di Bartolini & C. S.n.c. - Cerbara
Citt di Castello (PG)
IMEV S.r.l. - Figline Valdarno (FI)
Pancani Roberto - Pistoia
Sardegna
PORRA COMMERCIALE S.n.c. - Tortol (NU)
Aldo Sias di Sias Giovanni - Iglesias (CA)
POLO COMMERCIALE
Campania - Calabria -Lazio
GRUPPO C.D.C. ELECTRIC S.p.a. - (NA)
Toscana - Sardegna
DELTA ELECTRIC S.p.a. - Pisa
A Ar r e ea a C Ce en nt t r ro o I I t t a al l i i a a
una m
area di prem
i dalla
Prom
ozione C
odim
e 2004 richiedi il depliant
al tuo grossista di fiducia
servizio lettori 1793
52
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
SPECIALE NUOVE TECNOLOGIE: LEVOLUZIONE DELLA TV
platform. Con questa definizio-
ne si vuole indicare tutta una se-
rie di applicazioni interattive crea-
te su misura per il pubblico do-
mestico, che saranno disponibili
nelle case degli italiani utilizzan-
do il digitale terrestre (Dvb-T),
come veicolo di trasmissione.
importante ricordare questo acro-
nimo (Mhp), in quanto al momen-
to dellacquisto occorrer control-
lare che il decoder interattivo che
intendiamo acquistare con il con-
tributo statale di 150,00 euro rechi
sul pannello frontale il logo del-
linterattivit domestica Mhp.
Nellambito della piattaforma Mhp
stato messo a punto il profilo
denominato enanched broadca-
sting (televisione arricchita con ser-
vizi interattivi di varia tipologia), dal-
le cui seguenti caratteristiche tra-
spare la potenzialit dei servizi
fruibili e dei terminali di ultima
generazione (televisori a tutto
schermo, impianti HiFi evoluti, ec-
cetera), utilizzabili in associazio-
ne con il digitale terrestre, per me-
glio sfruttarne le potenzialit:
- formato delle immagini in for-
mato 16:9, pi vicino allo standard
adottato in cinematografia ri-
spetto allattuale 4:3 (per for-
mato si intende il rapporto fra le
dimensioni orizzontale e verticale
dellimmagine);
- possibilit di diffondere immagini
ad alta definizione (Hdtv - High
definition television), partico-
larmente adatto alla visione di
film ed eventi sportivi con tele-
visore di ultima generazione (Lcd
e plasma);
- audio con qualit cd (compact
disk);
- possibilit di avere pi canali au-
dio per un programma multilingue;
- aggiornamento programmazio-
ne mediante tecnica Epg, Elec-
tronic programme guide, in gra-
do di fornire notizie in tempo rea-
le sulla programmazione dei pa-
linsesti;
- Super Teletext con contenuti gra-
ficamente arricchiti, immagini,
ipertesti, clip audio e video, ec-
cetera.
Anche il lettore meno esperto
in grado di comprendere che ri-
sulta quanto mai vasta e diversi-
ficata lofferta associata al nuovo mo-
do di fare televisione, sia in termini
di contenuti e di creativit dei ser-
vizi associati alla programmazione,
sia anche per il business dei nuo-
vi terminali con i quali sfruttare i
plus offerti dalla nuova tecnica
tutta numerica, per le varie ap-
plicazioni.
Pensando per esempio alla ripro-
duzione del suono e dellimma-
gine, si consideri che man mano
che i costi dei televisori ultrapiatti
a grande schermo andranno di-
minuendo, sar possibile pensa-
re allo sviluppo su larga scala di si-
stemi audio/video digitali, in gra-
do di offrire allutente prodotti di
straordinaria qualit, ove immagine
e suono raggiungono livelli in gra-
do di simulare, anche nel piccolo
ambiente di un salotto residen-
ziale, lesperienza della grande ci-
nematografia, con effetto deno-
minato home theatre, la cui rea-
lizzazione sembra a portata di ma-
no, a breve, anche per il grande
pubblico, impiegando: un letto-
re Dvd (Digital video disk), un
set-top-box Dvb, un display pla-
nare a grande schermo e diffusori
audio di qualit HiFi.
Passando ora a quelli che sono pi
propriamente, ad oggi, i due filoni
di sviluppo legati allinterattivit,
si trova che gli standard digitali svi-
luppati in seno al Consorzio euro-
peo Dvb supportano gi da ora
una serie di servizi, che possono in-
quadrarsi come:
- televisione interattiva;
- accesso a internet.
La prima specie di interattivit og-
gi realizzabile tramite il nostro te-
levisore integrato da un set-top-box
di tipologia Mhp; la seconda ap-
partiene ad un periodo successivo
di diffusione, quando sar stata
completata la convergenza delle tec-
nologie digitali.
Le funzioni e le applicazioni con-
tenute nella prima categoria rive-
Felici di sorprendervi
nel farvi risparmiare.
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER LITALIA
La Filometallica srl - Via Balduccio da Pisa, 18
20139 Milano - Tel 02 55210995 - Fax 02 5394314
www.megaman.it
Minor consumo di elettricit = risparmio sulla bolletta elettrica
...Durata 15.000 ore: Risparmio costi manutenzione
Minore temperatura di esercizio: Minori spese di climatizzazione
Tecnologia davanguardia: tecnology - Elevata efficienza luminosa
ALBERGHI, UFFICI, NEGOZI, GRANDI COMUNIT, NAVI, OSPEDALI
un solo denominatore comune...
Sostituire le lampadine alogene dicroiche con lampadine fluorescenti compatte,
attacco GU10 da 7 o 9 Watt -230 Volt di simile luminosit.
S
T
U
D
IO
L
IN
E
A
IM
M
A
G
IN
E
F
U
T
U
R
A
M
IL
A
N
O
7
0
4
0
Reflector GU10 Reflector GU10
7 Watt 7 Watt
9 Watt 9 Watt
L
A
M
P
A
D
I
N
A
B
R
E
V
E
T
T
A
T
A
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
9
1
SPECIALE NUOVE TECNOLOGIE: LEVOLUZIONE DELLA TV
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 53
stono per il Dvb un carattere di
priorit, nellottica di una rapida evo-
luzione del mercato e dei terminali.
La categoria che metter in gio-
co anche la rete internet riguar-
da il discorso della piattaforma
digitale domestica allargata, che
si ipotizza entrer a far parte del
gioco in un momento successivo
di ulteriore radicamento della tec-
nologia.
Approfondiamo invece il discorso
sulla televisione interattiva inda-
gando quali sono le possibilit in
questo campo, essendo questo un
altro punto fondamentale.
Utilizzando un decoder interattivo,
due sono i possibili scenari di in-
terattivit nei quali potremo im-
batterci:
- uninterattivit locale;
- uninterattivit con canale di ri-
torno.
Esistono delle applicazioni multi-
mediali di base, rese disponibili
attraverso la tecnologia digitale
terrestre, sempre presenti in an-
tenna perch trasmesse tramite
letere.
Ci significa che, se un utente
avesse la linea telefonica mo-
mentaneamente non disponibi-
le, potrebbe comunque accedere
ai servizi associati in quel mo-
mento a quel determinato pro-
gramma e scaricare le applica-
zioni multimediali presenti in an-
tenna: operando con il teleco-
mando per accedere ad un parti-
colare servizio (meteo, notizia-
rio), si abiliter il decoder a rice-
vere nuove informazioni.
Premendo il tasto Ok e i tasti
freccia sul telecomando, si po-
tr praticare una vera e propria
navigazione semplificata, para-
gonabile a quella effettuata su
internet, con la differenza che
anche lutente non avvezzo a que-
sto genere di procedure sar in gra-
do di effettuare operazioni com-
plesse, agendo con grande sem-
plicit.
Dopo alcuni secondi, acquisite le
informazioni presenti in antenna,
si renderanno disponibili sul nostro
televisore alcune maschere relative
ai contenuti selezionati (con even-
tuale suddivisione della scher-
mata in due o pi settori), segno
che lapplicazione cercata sar
stata scaricata correttamente.
Si pu rendere meglio lidea fa-
cendo un semplice esempio.
Si supponga si stia vedendo lo
spot pubblicitario di un costruttore
di televisori. Se durante il video clip
il costruttore ci mette a disposi-
zione delle applicazioni multi-
mediali, premendo il tasto Ok,
si scarica dallantenna (utiliz-
zando la sola etere) lindice ge-
nerale e lo si visualizza insieme al-
la home page. Premendo Ok
si accede, per esempio, alla sezione
ricevitori digitali terrestri. Pre-
mendo ancora Oke continuan-
do a navigare, si visualizzano le ca-
ratteristiche tecniche, le dimen-
sioni, i prezzi di una certa serie di
ricevitore.
Si noti che tutte le informazioni
multimediali fin qui utilizzate non
hanno comportato nessun costo
di connessione, in quanto linte-
rattivit rimasta di tipo locale,
cio le informazioni sono state
scaricate unicamente attraverso
lantenna terrestre: il modem non
entrato mai in gioco e sarebbe
potuto rimanere scollegato dalla
presa telefonica.
A questo punto se invece si de-
cidesse di acquistare on line il
ricevitore digitale, si dovrebbe in
qualche modo interagire con il
centro dati del costruttore: solo al-
lora si andrebbe ad utilizzare
uninterattivit del tipo con ca-
nale di ritorno verso il centro
dati, mettendo in gioco lutilizzo
del modem telefonico.
Prima dellavvio della connessio-
ne si visualizzer un banner sul-
lo schermo del televisore, con in-
dicati tutti i costi di accesso alla
linea telefonica con addebito del-
la connessione conteggiato nella
bolletta telefonica.
Il canale di ritorno, come si evince,
non via etere. Questo significa che
le attuali antenne delle abitazioni
non devono essere sostituite con
antenne ricetrasmittenti: linte-
rattivit resa possibile attraver-
so un collegamento telefonico.
questo un semplice esempio di
come possibile utilizzare nella
pratica il nuovo sistema e di qua-
li siano le potenzialit se si pensa
che i servizi attivati prossimamente
andranno ad interessare molte del-
le nostre quotidiane attivit con una
semplicit di operazione studiata
apposta per servire la totalit del-
la collettivit.
Qualche indicazione sullimpatto che
la nuova tecnologia dovrebbe po-
ter esercitare sulla collettivit pu
essere desunta da queste brevi
informazioni di come si stia lavo-
rando alle-government, cio al-
linsieme dei servizi interattivi che
permetteranno a breve di colle-
garsi, attraverso il televisore, di-
rettamente ai server della pubbli-
ca amministrazione per richiedere
informazioni, certificati...
Il Cnipa, Centro nazionale per
linformatica nella pubblica am-
ministrazione, ha stanziato 7 mi-
lioni di euro per il cofinanzia-
mento di applicazioni informative
di e-government, basate sul di-
gitale terrestre e destinate al
grande pubblico.
Contestualmente presso il Cnipa
stato costituito il centro di com-
petenza sul digitale terrestre per as-
sistere le amministrazioni pubbli-
che locali interessate a sperimen-
tare questa nuova tecnologia.
Al Cnipa stata gi affidata la rea-
lizzazione di un progetto per por-
tare sul canale digitale terrestre
alcuni servizi e informazioni con-
tenuti nel portale nazionale del cit-
tadino (www.italia.gov.it) da do-
ve, gi oggi, con il proprio pc con-
nesso ad Internet, si possono sca-
ricare oltre 1.000 moduli, rag-
giungere quasi 8mila servizi pub-
blici collegati a pi di 160 guide e
a 126 eventi. Ai 7 milioni di eu-
DISTRIBUTORI CODIME SUL TERRITORIO DISTRIBUTORI CODIME SUL TERRITORIO www.codime.it www.codime.it
ASSOCIATI CODIME
Campania - Calabria
G. ALFIERI & C. S.p.a. - Caserta (CE)
APRILE S.r.l. - MATERIALE ELETTRICO - Aversa (CE)
ELCA S.r.l. - Corigliano Scalo (CS)
ELETTROINDUSTRIALE S.r.l. - Casoria (NA)
GAM COPPOLA S.r.l. - Mugnano (NA)
EGRUPPO C.D.C. ELECTRIC S.p.a. - (NA)
MEP di Porri Mario & C. S.p.a. - Villaricca (NA)
ORTOLOMO S.r.l. - S. Maria La Carit (NA)
TUFANO SAS DI CAFARELLI A. & C. - Casoria (NA)
Puglia - Basilicata
DIMET S.r.l. - Modugno (BA)
Sicilia
ELETTROINGROSS 94 S.p.a. - Palermo
SCIACCA I. S.r.l. - Palermo
GR SICILIA S.r.l. - Palermo
AFFILIATI CODIME
Campania - Calabria
COZZOLINO S.r.l. - Nola (NA)
GEA S.r.l. - Ischia (NA)
Puglia - Basilicata
CIRIOLO S.r.l. - Ortelle (LE)
DEL.FO.LUCE S.n.c. - Lucera (FG)
ELETTROLAMP S.n.c. - San Severo (FG)
FOEL S.p.a. - San Giorgio Jonico (TA)
LA PIGE S.r.l. - Cerignola (FG)
NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. - Maglie (LE
Sicilia
RI-EL S.r.l. - Canicatt (AG)
BOLOGNA S.r.l. - Palermo
POLO COMMERCIALE
Campania - Calabria -Lazio
GRUPPO C.D.C. ELECTRIC S.p.a. - (NA)
Sicilia
GR SICILIA S.r.l. - Palermo
A Ar r e ea a S Su ud d I I t t a al l i i a a
una m
area di prem
i dalla
Prom
ozione C
odim
e 2004 richiedi il depliant
al tuo grossista di fiducia
servizio lettori 1794
Per lutente che acquisti il decoder in una delle citt
italiane coperte dal servizio, sono disponibili dei Bouquet
di canali (gruppi di canali), ad oggi cos suddivisi:
Canali RAI
Multiplex A: Rai1, Rai2, Rai3
Multiplex B: Rai Utile, Rai Doc, Rai Edu1, Rai News 24,
Raisportsatellite
Radio1, Radio2, Radio3, FD auditorium
Canali Mediaset
Rete 4, BBC World, Class News, 24 ore Tv, Coming Soon
Vj Tv, reti locali
Canali D Free
SI,LCI, Radio Italia TV, Italia1, Canale 5, emittenti locali
Canali Telecom
La7, MTV, INTV, emittenti locali
Canali Svizzera (zone Como e Varese)
TSI1, TSI2, SF1,TSR1, eccetera.
V
i
s
t
i
d
a
v
i
c
i
n
o
I canali disponibili
54
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
SPECIALE NUOVE TECNOLOGIE: LEVOLUZIONE DELLA TV
ro resi disponibili tramite il Cni-
pa, si sommano altri 3 milioni di
euro della Fondazione Bordoni
per conto del Ministero della Co-
municazione, per cofinanziare
applicazioni avanzate come la
telemedicina.
QUALE DECODER
Diamo adesso alcune informazio-
ni di base per orientarci nella scel-
ta del decoder, meglio denomina-
to set-top-box, o anche indicato
con il solo suffisso Stb.
I decoder per la ricezione del digi-
tale terrestre non vanno confusi con
i decoder utilizzati per la ricezione
delle trasmissioni via satellite, per
i quali esistono le tipologie Free to
air (solo ricezione in chiaro), Com-
mon Interface (completi di slot per
linserimento di schede a paga-
mento) e Personal video recorder
(completi di slot e altre funzioni
memoria, hard disk...), i quali esu-
lano da questo contesto e che ab-
biamo citato per sola completezza
di trattazione.
I set-top-box per la ricezione del di-
gitale terrestre sono invece di due
fondamentali categorie: Zapper ed
Mhp.
I decoder Zapper sono unicamen-
te abilitati alla ricezione dellof-
ferta televisiva associata al se-
gnale digitale ricevuto via etere, con-
sentendo la sola visione dei cana-
li senza la possibilit di alcuna in-
terattivit, essendo sprovvisti di mo-
dem e Smart card reader.
Il modello base del semplice rice-
vitore digitale per programmi te-
levisivi consente lorganizzazione
di liste di programmi preferiti e
permette di accedere al teletext. Un
tale dispositivo, privo di funzioni in-
terattive, il minimo indispensabile
per rendere un televisore analogico
capace di ricevere programmi tv in
digitale.
Questa tipologia di decoder, per i
motivi esposti, non gode del con-
tributo governativo in quanto non
permette di sfruttare le potenzia-
lit messe a disposizione dalla tec-
nologia.
I decoder Mhp possono invece, ol-
tre che ricevere lofferta della tv di-
gitale terrestre, accedere a tutte le
applicazioni multimediali dei pro-
dotti interattivi presenti e futuri
quali: giochi, concorsi, sondaggi, te-
levoto, prenotazione biglietti ol-
tre che ai servizi relativi alla pub-
blica amministrazione come ho-
me-banking, t-government, e-com-
merce, e-sanity da cui il finanzia-
mento di 150 euro del governo.
Il prezzo di vendita di un set-top-
box interattivo si aggira intorno
ai 250,00 euro, che con lo sconto di
150,00 euro del contributo statale,
fornisce un costo allutente finale
di circa 100,00 euro.
Inoltre sar auspicabile che il no-
stro decoder risulti dotato di al-
meno due prese Scart in modo da
potervi collegare il videoregistra-
tore.
Gli Stb attualmente in commercio
permettono di vedere un solo ca-
nale per volta.
Se si ha lesigenza di estendere la
visione tv anche ad altri ambienti
della casa, esistono dispositivi via
radio in grado di ripetere il se-
gnale su pi televisori, tenendo
conto che la ripetizione si riferi-
sce sempre alla stessa program-
mazione.
Certamente sviluppi successivi le-
gati alla tecnologia potranno por-
tare sul mercato decoder sempre
pi sofisticati, eventualmente in-
tegrati nello stesso apparecchio
televisivo o unificati con il servizio
satellitare ma si esclude, come
spesso si sente dire, che i decoder
acquistati oggi possano risultare inu-
tilizzabili domani, in quanto ormai
lo Standard europeo Mhp per il
decoder interattivo stato ratificato
dallEtsi in seno al Consorzio eu-
ropeo Dvb.
Oltre al prezzo del decoder, non vi
sono altri costi aggiuntivi se si
escludono piccoli adattamenti de-
gli impianti pre-esistenti di cui vie-
ne data di seguito qualche indi-
cazione.
IN ITALIA ED IN EUROPA
Secondo una ricerca dellistituto
inglese Datamonitor, la penetra-
zione della televisione digitale in Eu-
ropa avr questo sviluppo: il satellite
crescer fino a raggiungere circa 25
milioni di case nel 2004 e 30 milioni
nel 2006; il cavo si attester in se-
conda posizione, con un balzo dai
poco pi di dieci milioni agli oltre
20 milioni nel 2006; infine, per il di-
gitale terrestre, si prevede una
forte spinta allo sviluppo tra il 2005
e il 2007. Se infatti la sua presen-
za nel 2004 dovrebbe limitarsi a cir-
ca quattro milioni di abitazioni, tra
quattro anni arriver a sfiorare i 20
milioni. Le politiche governative
europee, come nel caso dellItalia
che ha reso obbligatoria lintrodu-
zione della tecnologia, saranno de-
cisive per il passaggio tecnologico
dalla tradizionale tv via etere al
digitale terrestre.
In Italia lintroduzione di questa
tecnologia legata allofferta del-
la tv generalista (Rai, Mediaset,
La7): non bisogna sottoscrivere
abbonamenti aggiuntivi di alcun ti-
po. I programmi in multiplex (pi
programmi sulla stessa frequenza)
sono proposti gratuitamente.
Il digitale terrestre quindi gi
una realt per le citt attivate dal
servizio. La Rai trasmette, oltre
che gli stessi canali trasmessi an-
cora in analogico (Rai1, Rai2, Rai3),
anche canali tematici quali Rai
Doc, dedicato allintrattenimento cul-
turale di qualit (arte, musica, tea-
tro, cinema, letteratura); rai utile,
pensato per essere al fianco del-
lutente ed informare su previsio-
ni del tempo, andamento del traf-
fico, trasporti, rapporti cittadini;
Rai Educational, canale tematico per
i servizi educativi; Rai News 24, te-
matico per le notizie.
Vediamo invece come sta andan-
do negli altri paesi europei.
Lo scenario che si apre per la Dtt
nei principali Paesi del vecchio
continente presenta una situazio-
ne di grande movimento.
In Germania, a novembre 2002 sta-
ta sperimentata per la prima volta
in assoluto la trasmissione in digitale
terrestre basata sulla free-tv.
Emblematica lesperienza pilota
di Berlino, che ha completato il
passaggio totale dallanalogico al
digitale a fine agosto 2003. Sulla ba-
se di questa esperienza, si stanno
muovendo gli altri laender, come il
Nord-Reno Westfalia, dove 8,5 mi-
lioni di famiglie a partire dal 2004
sono coinvolte nel passaggio al
digitale.
Di grande interesse la situazione in
Spagna e Gran Bretagna, i due
Paesi che hanno sperimentato per
primi il digitale terrestre ma in
versione pay. Unesperienza ne-
gativa per Quiero Tv nella penisola
iberica e Itv digital in Inghilterra,
che sembra aver tolto dal gioco, per
un bel p di tempo, questo mo-
dello di business relativo alla te-
levisione a pagamento che non
sembra aver funzionato. Dalle ma-
cerie per, in UK, nato un suc-
Accesso
condizionato
Sistema di codifica dei contenuti e di
gestione degli abbonati di un bouquet
di televisione a pagamento (pay-tv).
Questo tipo di fruizione di programmi
richiede di solito una smart-card da
inserire nel ricevitore.
Analogico
Segnale elettrico che varia con il va-
riare della grandezza fisica che rap-
presenta. Nella radiotelevisione si
fa largo uso di tecniche analogi-
che per il trattamento, la memo-
rizzazione e la trasmissione di im-
magini in movimento e suoni.
Bouquet
Insieme di canali radio-tv e servizi
multimediali, reso disponibile da
un singolo fornitore e fruibile in
modo omogeneo.
Content Provider
Fornitore di contenuto. Chi si de-
dica allideazione, produzione e
acquisto dei contenuti predispo-
nendo anche lofferta in un pa-
linsesto definito.
Decoder
Apparato dutente necessario per
decodificare programmi radiotele-
visivi da analogico a digitale.
Digital Divide
Fenomeno che indica, allinter-
no di un Paese, una situazione di
disparit tra chi ha accesso e ca-
pacit di gestione delle informa-
zioni e dei contenuti digitali del
mondo multimediale, e chi ne
escluso per cause economiche, cul-
turali o ambientali.
Digitale
Grandezza che rappresenta un fe-
nomeno fisico con variabili discon-
tinue, che si ottengono in genere da
un campionamento degli elemen-
ti della realt.
Dolby surround
Modalit di trasmissione audio mul-
ticanale per una migliore riprodu-
zione sonora, adottato sia in molti
sistemi di riproduzione domestica
o professionale, sia nelle sale ci-
nematografiche.
Oltre al segnale stereofonico, per-
mette la trasmissione di canali ef-
fetti che danno la sensazione allo
spettatore di essere allinterno del-
la scena.
Anche il decoder digitale terrestre
pu supportare tale standard di
qualit audio.
Dtt - Digital terrestrial
television
Sistema di diffusione di segnali te-
levisivi digitali attraverso trasmet-
titori-ripetitori terrestri, ricevibili
con le antenne esistenti.
Dvb-Digital video
broadcasting
Standard di trasmissione digitale
adottato in Europa, basato sul si-
stema di compressione Mpeg2 e
utilizzato in tre varianti: Dvb-S
per il satellite, Dvb-C per le reti
cavo e Dvb-T per la diffusione at-
traverso ripetitori terrestri.
Enhanced Television
Televisione arricchita con servizi
interattivi di varia tipologia, che
permette allutente di avere infor-
mazioni aggiuntive sul program-
ma, partecipare a giochi, son-
daggi...
Epg - Electronic
program guide
Guida elettronica ai programmi
che permette allo spettatore, at-
traverso il telecomando, di leg-
gere con facilit sullo schermo in-
formazioni relative ai programmi
in onda e previsti nel seguito del-
la giornata.
Free-to-air
detto di servizi radiotelevisivi che
non prevedono il pagamento di
abbonamenti.
Interattivit
Contenuti aggiuntivi trasmessi
dalla piattaforma digitale che per-
mettono allutente televisivo di
selezionare opzioni sul televisore
per accedere ad informazioni ag-
giuntive, servizi di pubblica utili-
t, giochi, acquisti...
Internet
Rete di reti di computer che uti-
lizzano lo stesso protocollo di
Piccolo glossario
cesso: Freeview, lanciata alla fine
dello scorso anno, il servizio Dtt
della Bbc che ha conquistato uten-
ti al ritmo di 100mila al mese. At-
tualmente risultano complessiva-
mente 1,5 milioni di fruitori della tv
digitale terrestre in Gran Breta-
gna. Lottima performance, se-
condo gli esperti, da attribuire ad
alcune caratteristiche del servizio:
semplicit nelluso e nei paga-
menti (se ne effettua uno solo al-
linizio, nessun abbonamento), un
bouquet di una trentina di canali do-
ve per la parte del leone la fanno
i canali tradizionali della Bbc.
Freeview ha successo perch attrae
un pubblico diverso, neofita del
digitale e con unet media piuttosto
alta: il 40% ha pi di 55 anni.
La Francia ha fissato un calenda-
rio del passaggio al digitale ter-
restre: il governo ha lobiettivo di
avviare le trasmissioni nel 2004, rag-
giungere il 50% della popolazio-
ne nel 2005 e l80% entro il 2008.
Il lancio della Dtt in tutti i Paesi del-
lUe stimato entro la fine del
2005. Ma lo switch off, cio lab-
bandono definitivo della tv analo-
gica, potrebbe avere tempi pi
lunghi: comincer lOlanda nel
2004, poi seguiranno tutti gli altri.
IL FINANZIAMENTO
DELLO STATO
Per facilitare la diffusione della tv
digitale terrestre, lo Stato eroga, a
partire dal 1 gennaio 2004, un
contributo di 150 euro agli abbonati
tv in regola con il pagamento del
canone 2004 (Rif. Decreto Mini-
steriale 30.12.2003, Ministero del-
le Comunicazioni).
Il contributo consiste in una ridu-
zione del prezzo complessivo del de-
coder, iva inclusa, della tipologia in-
terattiva, al netto di ogni even-
tuale sconto commerciale.
Limporto viene rimborsa-
to al rivenditore. Il contri-
buto viene erogato nei limiti
dello stanziamento di leg-
ge: il Ministero delle co-
municazioni ha predisposto
un contatore dei contri-
buti, visibile sul proprio
sito, che aggiorna in tem-
po reale lo stanziamento re-
siduo. Il contributo pu es-
sere erogato una sola volta
per ciascun abbonato alla te-
levisione.
Vediamo in pratica cosa ac-
cade in caso di acquisto del
decoder interattivo, da par-
te di un titolare di abbona-
mento tv.
Bisogna innanzi tutto re-
carsi presso un rivenditore
autorizzato (per conoscere quelli del-
la propria zona si pu consultare il
sito predisposto dal Ministero del-
le comunicazioni: www.deco-
der.comunicazioni.it nella pagina
consumatori o telefonare al nu-
mero: 840.022000) muniti di:
- documento didentit;
- copia del codice fiscale;
- numero di abbonamento o ricevuta
di pagamento;
- autocertificazione di non aver in
precedenza fruito del contributo
(il modello scaricabile dallo
stesso sito del Ministero) e di es-
sere in regola per lanno 2004
ove ci non risulti dalla banca
dati degli abbonamenti.
Se si nuovi abbonati sempre con-
sigliabile produrre la ricevuta di
pagamento.
Il rivenditore da parte sua:
- provvede ad inserire il codice
fiscale del cliente nel sistema
telematico di verifica predispo-
sto, per conto del Ministero del-
le Comunicazioni, dalle Poste
Italiane;
- verifica cos che il cliente in re-
gola con il pagamento e non ha
ancora usufruito del contributo;
- emette scontrino fiscale o fattu-
ra, indicando il prezzo di vendita
ed il corrispettivo pagato dal
cliente scontato del contributo;
- acquisisce fotocopia del docu-
mento didentit, del codice fi-
scale e dellautocertificazione del
cliente abbonato.
Si noti che il governo eroga tale con-
tributo unicamente a vantaggio
dei decoder interattivi, proprio per-
ch il finanziamento va nella dire-
zione di sostenere la diffusione
del digitale terrestre, con forte en-
fasi verso quelli che sono i servizi
di interattivit associati alla nuova
tecnologia.
Il governo italiano vede infatti nel-
la televisione digitale interattiva loc-
casione per una diffusione dei ser-
vizi della societ dellinformazione
presso la totalit dei cittadini, allo
scopo di massimizzare lefficien-
za dei servizi, renderli meno co-
stosi per la collettivit ed utilizza-
bili comodamente da casa, evi-
tando file agli sportelli ed inutili spo-
stamenti. Solo i set top box inte-
rattivi possono assicurare lutiliz-
zo di servizi di pubblica utilit, fa-
vorendo la diffusione dei servizi
della societ dellinformazione.
Per questo motivo lo stato inco-
raggia esclusivamente lacquisto di
decoder interattivi.
Fino ad ora sono stati erogati po-
co pi della met del blocco dei pri-
mi 700.000 finanziamenti previsti
per questa prima fase, per i deco-
der interattivi, con una vendita
giornaliera che si aggira intorno
alle 2.500 unit.
SEMPLICIT
DELLA RICEZIONE
Grazie alle sue molteplici potenzialit
la televisione digitale terrestre,
lanciata in Gran Bretagna nellau-
tunno del 1998, destinata a di-
ventare nel medio e lungo periodo
la forza trainante di un mercato
di massa di portata europea, in
grado di soddisfare le richieste
daccesso, da parte degli utenti, sia
ai servizi informativi di base, sia ai
servizi promossi dal mercato del-
la comunicazione.
Punti di forza della nuova televisione
saranno infatti la facilit e leco-
nomicit di ricezione, oltre che lu-
niversalit del servizio offerto, pre-
valentemente rivolto al grande
pubblico, proprio di un servizio
diffuso via etere, come quello at-
tuale, ma con altra tecnologia.
Il digitale terrestre potr inoltre
integrare e completare lofferta
dei canali satellitari e via cavo per
rispondere alle esigenze dei servizi
SPECIALE NUOVE TECNOLOGIE: LEVOLUZIONE DELLA TV
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 55
comunicazione, attraverso con-
nessioni permanenti via telefono,
cavo e fibra ottica, satellite, ec-
cetera. possibile anche veico-
lare sulla Rete immagini in mo-
vimento, limitatamente alla ban-
da esistente, nonch fruire di
servizi avanzati di posta elet-
tronica, trasmissione e ricezio-
ne di file, ricerca di informazioni
di ogni tipo.
Modem
Acronimo di Modulatore-Demo-
dulatore. Apparato che converte
uninformazione digitale in un
segnale analogico per consen-
tirne la trasmissione attraverso
la rete telefonica tradizionale.
Mhp - Multimedia
home platform
uno standard della famiglia Dvb
che definisce linterfaccia tra le
applicazioni interattive digitali e
gli apparati dove queste sono at-
tivate. basata sul linguaggio di pro-
grammazione Java, e costituisce un
software intermedio e aperto per
la messa a punto di molti tipi di ap-
plicazioni e servizi, anche quelli
relativi alla televisione digitale ter-
restre con modalit interattive.
Mpeg2-Moving pictures
experts group
Standard internazionale per la
compressione dei segnali digitali
di immagini e suoni. La versione
2 riferita tipicamente ai formati
utilizzati per il broadcasting.
Multiplexer
Limpianto attraverso il quale i se-
gnali tv, radio e dati vengono
combinati (multiplexing) in un
unico flusso di trasmissione.
Network provider
Operatore di rete che provvede al-
la trasmissione dei segnali radio-
televisivi verso la popolazione, ge-
stendo sistemi di trasmissioni di va-
rio tipo, terrestri, via satellite, via
cavo e su larga banda.
Personal video
recording (Pvr)
Videoregistratore digitale che uti-
lizza come supporti di registrazio-
ne dischi rigidi simili a quelli dei per-
sonal computer, capace di memo-
rizzare molte ore di programmi te-
levisivi.
Service provider
Fornitore del servizio.
Nellaccezione radiotelevisiva
cura lorganizzazione del servizio,
della migliore gestione della ri-
sorsa di rete che acquisisce dal
network provider, curando an-
che i rapporti con lutenza.
Simulcast
Diffusione contemporanea dello
stesso programma o bouquet di
programmi con diverse modalit,
ad esempio analogica e digitale
o terrestre e satellite.
Stb (Set-top-box)
Apparato in grado di decodifi-
care il segnale digitale ricevuto
da antenna e inviarlo ad un te-
levisore analogico collegato.
Permette inoltre lutilizzo delle ap-
plicazioni interattive distribuite
con il segnale televisivo. Per una
reale interattivit necessario
che il set-top-box sia dotato di un
collegamento telefonico.
Switch-off
Termine che indica la fine della dif-
fusione in analogico.
Switch-on
Termine che indica lavvio della
diffusione in digitale.
Switch-over
Termine che indica il periodo in
cui la diffusione analogica e quel-
la digitale convivono.
T-Banking
Insieme dei servizi interattivi
che permettono di collegarsi, at-
traverso il televisore, agli istitu-
ti bancari per richiedere infor-
mazioni, estratti conto ed effet-
tuare operazioni bancarie.
T-Commerce
Possibilit di acquistare beni e ser-
vizi attraverso il televisore con mo-
dalit analoghe a quelle utiliz-
zate da Internet.
T-Government
Insieme dei servizi interattivi che
permettono di collegarsi attra-
verso il televisore alla Pubblica
Amministrazione per richiedere
informazioni, certificati...
T-Learning
Possibilit di seguire attraverso
il televisore lezioni di varie disci-
pline, eseguire esercizi, richiede-
re chiarimenti, eccetera. Lutente
pu pianificare autonomamente
la fruizione delle lezioni.
nazionali e locali. La Dtt, consen-
te un sostanziale aumento del-
lofferta (4/5 programmi digitali al
posto di un programma analogico)
anche in modalit portatile con
lausilio di piccole antenne e si-
stemi a basso costo. Inoltre pos-
siede, rispetto al digitale satellitare
e via cavo, la non trascurabile ca-
ratteristica di avere una ricezione
compatibile con gli attuali siste-
mi condominiali, a costi aggiunti-
vi marginali per lutente.
NUOVE OPPORTUNIT
PER TUTTI
La Dtt offrir progressivamente
nuove opportunit per tutti: uten-
ti, fornitori dei servizi, gestori del-
la rete e industria del settore, in un
mercato, come accennato in pre-
cedenza, caratterizzato dalla con-
vergenza fra radiodiffusione, te-
lecomunicazioni e information tech-
nology.
I consumatori non solo disporran-
no, sul televisore domestico e sen-
za significativi aggravi di spesa,
di una assai pi ampia gamma di
programmi, ma potranno anche
compiere da casa operazioni che og-
gi richiedono lutilizzo del compu-
ter o implicano spostamenti in luo-
ghi specifici (banca, posta, pub-
blica amministrazione). Con le-
commerce o lhome banking sar
possibile compiere operazioni che
gi oggi si possono fare da casa o
dallufficio, ma solo se si dispone di
una connessione internet e si sa uti-
lizzare un pc, avendo stipulato un
contratto con un provider.
Per lindustria elettronica di largo
consumo si apriranno ottime pro-
spettive, determinate dal necessario
rinnovo degli apparecchi televisi-
vi e dalla maggiore produzione di
set-top-box che si delinea negli
anni a venire.
Nella attuale fase di transizione
sufficiente aggiungere al proprio te-
levisore il set-top-box; in futuro i
componenti elettronici necessari a
ricevere le trasmissioni digitali (de-
coder) saranno incorporati allinterno
di televisori pi evoluti, che di-
venteranno in tal modo apparati in-
tegrati per la ricezione di servizi di-
gitali domestici.
Gli standard Dvb forniscono in-
fatti la soluzione globale alla do-
manda crescente di nuovi servizi ge-
neralistici e tematici, free to air e a
pagamento, multimediali ed inte-
rattivi, che consentono inoltre un
sensibile miglioramento della qua-
lit del servizio.
SCENARI IN EVOLUZIONE
La tv digitale terrestre, in sigla
Dtt, Digital terrestrial television,
rappresenta levoluzione tecnolo-
gica dellattuale sistema televisivo
analogico.
Al giorno doggi, ormai, compu-
ter, cellulari, compact disc, tut-
to funziona in digitale, solo la
radio e la televisione sono ancora
analogici. Con lanalogico, la te-
levisione era ferma ad una tecno-
logia di trasmissione messa a pun-
to tra la fine degli anni quaranta ed
i primi anni cinquanta, mentre il so-
lo cambiamento di un certo rilievo
stato introdotto con lavvento
del colore, avvenuto tra gli anni
sessanta e settanta.
Ma i cambiamenti non hanno mai
interessato la modalit di tra-
smissione, che rimasta a uno
stato tecnologico piuttosto involuto
rispetto ai cambiamenti che si so-
no avuti ad esempio nelle teleco-
municazioni: mentre la tv rimane-
va ancorata allanalogico, in tutti gli
altri settori dellelettronica diodi
e transitor lasciavano la scena ai mi-
croprocessori, con relativa minia-
turizzazione di apparecchi e com-
ponenti. Tecnicamente linnova-
zione per il digitale terrestre rap-
presentata dalladozione di un si-
stema di trasmissione numerico, os-
sia di una modalit che non risen-
te di interferenze, abbassamenti di
livello del segnale n disturbi e
che permette di moltiplicare il nu-
mero di canali disponibili.
Il nuovo sistema consentir, in al-
cuni casi, la ricezione di segnali
pi robusti rispetto allanalogi-
co e di realizzare coperture fin do-
ve lattuale segnale analogico non
in grado di arrivare per motivi
strutturali (attenuazioni).
Per cui rispetto ad una debolezza
del vecchio segnale analogico ter-
restre, Rai o Mediaset di una cer-
ta zona dItalia, grazie alla nuova
tecnica Dtt, otterrebbero condi-
zioni del tutto migliorate. Inoltre il
segnale digitale, per sua caratte-
ristica strutturale, ha la peculiari-
t di essere presente in antenna con
buona qualit oppure di essere
non intellegibile. Per cui con lav-
vento dellera digitale non saran-
no pi possibili i casi in cui per
una data trasmissione si potr di-
re che un programma si vede ma-
le; si avranno invece unicamente
due possibilit: buona qualit o
assenza totale di segnale.
PERCH CONVIENE
I principali vantaggi del digitale
terrestre possono cos riassu-
mersi:
1) multicanalit e potenziamen-
to qualitativo del servizio te-
levisivo;
2) interattivit e servizi aggiuntivi;
3) minore inquinamento elettro-
magnetico ed efficiente utiliz-
zo delle frequenze;
4) portabilit del servizio;
5) regionalit;
6) accelerazione della diffusione
di internet presso il grande
pubblico;
7) impulso alle nuove tecnologie e
ri-posizionamento a livello in-
ternazionale;
8) rilancio dei consumi attraver-
so lindustria del software e
dellhardware.
1) Uno dei principali vantaggi del-
la televisione digitale legato al-
la possibilit di moltiplicare il nu-
mero dei canali che possono essere
trasmessi attraverso le stesse fre-
quenze gi oggi in uso. Ogni sin-
gola frequenza, utilizzata in modo
analogico, permette infatti di tra-
smettere un solo canale tv; in tec-
nica digitale invece possibile tra-
smettere audio e video insieme,
attraverso un sistema di codifi-
ca/decodifica numerica delle in-
formazioni. Le informazioni da tra-
smettere, ridotte a dati numerici,
sono inoltre compresse, cio trat-
tate secondo un procedimento in-
formatico (di invenzione italiana),
denominato Mpeg-2 (Movie pic-
ture expert group), che permette
di moltiplicare il numero di canali
trasmessi contemporaneamente
da ununica frequenza. Questo si-
gnifica che con gli stessi televiso-
ri e le stesse antenne di adesso, uti-
lizzando un adattatore digitale (de-
coder) e qualche aggiustamento
supplementare, sar realistico pre-
vedere la possibilit di ricevere
una gran numero di canali tv.
2) Per ci che riguarda linteratti-
vit diciamo che lapplicazione del
digitale per le trasmissioni televi-
sive permette gi da ora, acqui-
stando un opportuno decoder abi-
litato a tale servizio, linterazione
con il mondo esterno, con scambio
di informazioni non solo dallemit-
tente (canale televisivo) al rice-
vente (spettatore), ma anche dal-
lo spettatore allemittente secon-
do un canale di ritorno. Linterattivit
si crea in sostanza compiendo ope-
razioni semplici attraverso il tele-
comando, con una modalit ac-
cessibile anche a coloro che non han-
no dimestichezza con il pc. In alcuni
Paesi linterattivit diventata
parte integrante dei nuovi format
televisivi, come ad esempio il te-
levoto in quiz e concorsi, o le-
spressione di giudizio di gradi-
mento sui programmi trasmessi, fi-
no allinvio di brevi messaggi di
testo da e verso lemittente e tra i
telespettatori.
3) Una ricaduta positiva del pas-
saggio alla nuova tecnologia si
avr sulle emissioni elettroma-
gnetiche associate ai segnali diffusi
nelletere dai trasmettitori digita-
li. Al momento dello switch-off de-
gli apparati analogici si avr in-
nanzitutto un abbassamento del li-
vello di campo elettromagnetico
presente in aria in quanto per dif-
fondere segnali in digitale occor-
56
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
SPECIALE NUOVE TECNOLOGIE: LEVOLUZIONE DELLA TV
Di fondamentale importanza risulta la figura pro-
fessionale dellinstallatore elettrico.
Gli installatori rappresentano linterfaccia ver-
so lutenza per lintroduzione di questa nuova piat-
taforma tecnologica in Italia.
Saranno loro a raccogliere, individuare e risolvere
sul territorio tutti i problemi esistenti per il pas-
saggio al digitale.
I passi fondamentali che un installatore elettri-
co deve compiere su un impianto tradizionale che
stia passando al digitale terrestre sono in breve:
- installazione di nuovo impianto o verifica impianto
di ricezione tv esistente + eventuale rifaci-
mento parziale;
- verifica copertura del segnale digitale terre-
stre di zona;
- installazione decoder + adattamento sistema pre-
esistente (videoregistratore, decoder satellita-
re, eccetera);
- effettuazione prima sintonia;
- collegamento e prova canale di ritorno;
- introduzione utente allutilizzo dei servizi in-
terattivi.
In termini impiantistici diremo che nei casi di im-
pianto mono-utente in buona efficienza (cavo a
basse perdite, connessioni non ossidate...) ci so-
no buone possibilit di ricevere correttamente la
programmazione digitale diffusa via etere da
Rai e Mediaset subito dopo aver inserito nella li-
nea dantenna il set-top-box.
Nei casi meno fortunati potrebbe essere neces-
sario installare una nuova antenna e/o, nel caso
di impianti di tipo condominiale, aggiungere un
modulo di amplificazione di canale.
Andando pi nel dettaglio, le principali cause di
intervento su impianto di ricezione digitale ter-
restre centralizzato possono essere date da:
- problemi legati al centralino di testa;
- equalizzazione e riallineamento dei livelli di
potenza;
- interventi di misura;
- aggiunta di filtri alla centrale a larga banda;
- installazione di filtri passa canale e/o elimina ca-
nale;
- insufficienza numero di ingressi del centralino;
- installazione nuova antenna;
- gestione diversa antenne esistenti;
- verifica collegamenti scart, antenna, Vcr, eccetera;
- adeguamenti cavi, prese, derivatori, partitori, ec-
cetera.
Fondamentale potr risultare, anche per lin-
stallatore pi esperto, un certo numero di ore di
formazione specifica, tenuto conto della natura
innovativa della tecnica digitale terrestre e di un
settore in continuo fermento ed evoluzione so-
prattutto per ci che riguarda le diverse appli-
cazioni.
Inoltre, necessario segnalare lesistenza sul
territorio di varie iniziative rivolte, oltre che agli
installatori, che devono per primi rispondere con
soluzioni efficaci, anche ai rivenditori che hanno
contatti con il pubblico nella vendita dei box in-
terattivi, e agli amministratori di condominio,
chiamati a dare le prime indicazioni di eventua-
li problemi di adeguamento degli impianti di ri-
cezione centralizzati.
IL RUOLO DELLINSTALLATORE ELETTRICO
rono potenze pi modeste. Inoltre
vengono poste le condizioni per un
utilizzo pi efficiente dello spet-
tro Hertziano con la liberazione di
una parte delle frequenze da de-
stinare a ulteriori canali televisi-
vi terrestri, ad altri servizi diffu-
si o di telecomunicazione, da ri-
partire tra le diverse funzioni, in
quanto, come detto, le trasmissioni
digitali occupano minori porzioni
di frequenza.
4) Altra caratteristica non di po-
co conto, per un servizio che vuo-
le rimanere di massa come lo sta-
to lanalogico, legata al fatto di
poter essere ricevuto ovunque,
grazie allutilizzo di unantenna mo-
bile, senza dover predisporre pun-
ti di allacciamento alla rete.
5) Come noto, la variet dei ser-
vizi e la diversit del territorio
italiano impongono unintegra-
zione tra trasmissioni nazionali
e locali secondo criteri dettati
dalla normativa vigente connes-
si alla pianificazione delle fre-
quenze per la radiodiffusione ter-
restre. Tali criteri vanno nella di-
rezione di un garantismo della
programmazione e della pubblicit
a livello regionale, su un binario
distinto da quello nazionale.
A livello europeo, come anche da
noi, la diffusione analogica tele-
visiva terrestre assicura da tem-
po una copertura capillare del
territorio, essendo disponibile
nella quasi totalit delle abita-
zioni (oltre il 95%). Passando al di-
gitale, pur continuando a consi-
derare con attenzione gli altri
due servizi complementari al ter-
restre (satellite e cavo) che anzi
si pensa facciano da traino per lo
stesso terrestre, lecito attri-
buire una netta centralit al ser-
vizio digitale diffuso via etere,
per la sola ragione di poter coprire
il territorio in modo non possibi-
le per il satellite e il cavo: il primo
ha infatti una copertura geogra-
fica troppo ampia, non circoscri-
vibile su scala regionale, mentre
il cavo risulterebbe troppo co-
stoso per estensioni comunque non
trascurabili.
6) Nel medio periodo, quando le-
ra digitale avr preso piede anche
per la televisione, si potranno ti-
rare le prime somme sulla sem-
plificazione intervenuta nel modo
di usufruire dei servizi di pubbli-
ca utilit, con il pi familiare ap-
parecchio televisivo. Tutto ci
avr una benefica ricaduta an-
che sullincremento del numero di
accessi alla rete internet (e al suo
infinito bacino culturale) e, a pa-
rit di contenuti, si potr sce-
gliere, dalla nostra piattaforma
digitale, se navigare per esem-
pio con il telecomando tv oppure
attraverso il web.
7-8) Il passaggio ad una tecnolo-
gia pi evoluta dalle prospettive
perfino imprevedibili nel lungo
periodo, dovrebbe contribuire a ri-
mettere in moto quel ciclo vir-
tuoso che partendo dal rilancio dei
consumi dei sistemi elettronici
del settore (per lo pi decoder di
varia tipologia e televisori di nuo-
va generazione, lcd, plasma) pas-
sa attraverso i fornitori di conte-
nuti e dei servizi di accesso con-
dizionato, arrivando fino alle istan-
ze di maggior formazione e di dif-
fusione culturale, necessarie per
riposizionare il Paese a livello in-
ternazionale. In ultima analisi la
transizione dallanalogico al di-
gitale terrestre rappresenta un
processo complesso con implica-
zioni socio-economiche che ne-
cessitano di unazione coordina-
ta dei vari operatori del settore. La
strada che porta alla diffusione ge-
neralizzata della nuova tecnologia
in Italia richieder di non essere
percorsa precipitosamente. Sotto
il profilo strettamente economico,
il governo, in linea con gli altri
paesi europei, sancendo il pas-
saggio alle trasmissioni digitali
via etere, dovrebbe aver gene-
rato effetti economici di lungo
termine, essendo la nuova tec-
nica ed i servizi ad essa associa-
ti una risorsa per lo Stato, i con-
sumatori e lindustria dei prodotti
elettronici di largo consumo.
SPECIALE NUOVE TECNOLOGIE: LEVOLUZIONE DELLA TV
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 57
OTTOBRE DICEMBRE 2004
TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE SUI NUOVI COMPONENTI E SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE A CURA DEI SERVIZI DI MARKETING DI OMRON ELECTRONICS SPA - VIALE CERTOSA, 49 - 20149 MILANO - TEL. 02 3268.1 - WWW.OMRON.IT
G
I
E
DESIDERO RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI SEGUENTI PRODOTTI:
cod. 04641
Nome ______________________________________ Posizione____________________ Societ __________________________ Attivit Azienda______________________________
Indirizzo __________________________________________ CAP________________ Localit ____________________ Tel. ____________________ Fax ____________________
Acconsento che i dati forniti vengano trattati da Omron Electronics SpA per l'attivit di diffusione e promozione dei propri prodotti (D. L. 196/03).
Spedire a Omron Electronics Spa - Viale Certosa, 49 - 20149 Milano Fax 023268.282 E-mail: info.it@eu.omron.com Indirizzo internet: www.omron.it
Omron Super MY il
prodotto di riferimento
nellambito dei rel per uso
industriale che questanno
ha raggiunto
limpressionante primato di
500 milioni di pezzi venduti
sul mercato mondiale.
Omron presenta ora una
nuova generazione di Super
MY caratterizzata dal tasto
di prova bloccabile e da un
nuovo led di segnalazione
ad altissima visibilit, rosso
per i modelli in corrente
alternata e verde per i
modelli in continua.
Il tasto di prova ha
caratteristiche ergonomiche
tali da renderne semplice
lutilizzo e
contemporaneamente
improbabile lattivazione
accidentale. In pratica il
tasto coperto da una
linguetta che spostata nella
prima posizione permette di
accedere al tasto con un
cacciavite. Facendo fare un
ulteriore scatto alla linguetta,
il contatto commuta, e
rimane attivo fino a quando
non si agisce sulla stessa
sbloccandola. La parte
superiore della calotta del
classico grigio Omron.
Questa soluzione, che
caratterizza anche la famiglia
dei nuovi G2RS consente
una migliore visibilit
dellindicatore meccanico.
Le caratteristiche tecniche
del Super MY restano quelle
che lo hanno fatto ritenere
per 500 milioni di volte la
scelta ottimale per il cliente.
Questa cifra nasconde una
serie di significati molto
importanti, prima tra tutti la
garanzia di un prodotto di
qualit: un attento
controllo delle specifiche
ed un continuo confronto
con il mercato ci
permettono infatti di offrire
un prodotto che fa
dellaffidabilit un suo
punto di forza.
Le innovazioni non si
fermano solo al rel ma
perseguono lobiettivo di
dare una risposta
completa agli utilizzatori di
questo semplice ma
fondamentale dispositivo.
In questa ottica va inserita
la realizzazione della
gamma completa di
zoccoli a molla per MY.
Questi zoccoli migliorano
decisamente la resistenza
delle connessioni alle
Rel Super MY:
ora con tasto di prova bloccabile
Un pieno di formazione
con Omron
Omron presenta il nuovo
Programma di Formazione
Tecnica da ottobre 2004 a
settembre 2005.
Costantemente impegnata
nell'adeguamento dei
programmi e dei contenuti
in funzione dell'evoluzione
tecnologica, Omron
quest'anno aggiunge anche
una nuova sede per i suoi
corsi: Verona. Con l'intento
di soddisfare le esigenze
formative di un numero
sempre crescente di tecnici,
Omron ha infatti stretto un
accordo con il CNOSFAP
per la realizzazione di 16
sessioni di corsi presso la
sede del Centro a Verona,
11 delle quali serali.
Queste sessioni hanno
esattamente lo stesso
programma, la stessa
durata e gli stessi prezzi di
quelle tenute nella
tradizionale sede Omron a
Milano. Anche i materiali
rilasciati sono identici.
Il programma formativo
2004/2005, che si svolge
perci in due sedi, si
articola in 16 corsi
organizzati su cinque aree
tematiche per un totale di
87 sessioni:
Programmazione PLC
Sysmac;
Meccatronica: inverter e
servoazionamenti;
Interfaccia
uomo/macchina;
Sensori e sensori di
visione artificiale;
Regolazione.
La descrizione completa dei
corsi e maggiori dettagli
sulla formazione e sul
Centro Addestramento
Omron sono nel sito
www.omron.it
vibrazioni riducendo
contemporaneamente i
tempi di cablaggio. Rel di
potenza Super MY: 500
milioni di buone ragioni per
fidarsi.
c o d . 0 4 6 4 1
servizio lettori 1798
PI PICCOLO
FUORI,
PI GRANDE
DENTRO.
NUOVI QUADRI E ARMADI MAS 400
CON FONDO ATTIVO E SISTEMA TIFAST.
servizio lettori 1790
SOLIDO
La nuova struttura di MAS LDX400
e il monoblocco di MDX400 con-
feriscono a tutti i contenitori robu-
stezza e solidit ai massimi livelli,
garantendo protezione fino a IP65.
COMPATTO
Grazie alla profondit ridotta a
soli 175 mm, tutta la gamma MAS
400 fornisce elevate prestazioni
anche dove lo spazio diventa una
risorsa limitata.
www. mas. bt i ci no. i t
TECNOLOGICO
Il nuovo Fondoattivo e il sistema
Tifast Moduli garantiscono la mas-
sima equipaggiabilit, aumentando
le prestazioni e permettendo un
cablaggio rapido, semplice e sicuro.
Ser vi zi o Cl i ent i 199. 145. 145
MAS
U
n sistema elettrico lin-
sieme delle apparecchia-
ture e delle linee che han-
no una determinata tensione no-
minale. In particolare, per siste-
ma elettrico di distribuzione si in-
tendono gli impianti che con-
sentono la distribuzione e luti-
lizzazione dellenergia elettrica in
bassa tensione.
Il sistema IT ha tutte le parti at-
tive isolate da terra o un punto
collegato a terra attraverso unim-
pedenza mentre le masse del-
limpianto sono collegate a terra
separatamente o collettivamen-
te o connesse collettivamente
alla terra del sistema.
Il sistema IT (figura 1) normal-
mente viene adottato quando
esistono particolari esigenze di
continuit del servizio come nel
caso ospedaliero. In tal caso, la
corrente dovuta al primo gua-
sto che si verifica di valore li-
mitato, perch si richiude attra-
verso le capacit verso terra del-
limpianto ed eventualmente an-
che attraverso limpedenza in-
serita tra un punto (di solito il neu-
tro) del sistema di alimentazione
e la terra stessa.
Il valore ridotto della corrente
di terra (figura 2) consente di
soddisfare facilmente la condi-
zione:
R
T
I
d
U
L
dove:
R
T
: resistenza di terra del dis-
persore al quale sono colle-
gate le masse.
I
d
: corrente di guasto
U
L
: tensione di contatto limite
convenzionale che 50 V che
si riduce a 25 V nei locali me-
dici di gruppo 1 (locale ad
uso medico nel quale le parti
applicate sono destinate ad
essere utilizzate esternamente
o invasivamente entro qualsiasi
parte del corpo, ad eccezio-
ne della zona cardiaca) e grup-
po 2 (locale ad uso medico
nel quale le parti applicate
sono destinate ad essere uti-
lizzate in applicazioni quali
interventi intracardiaci, in-
terventi chirurgici, o il pa-
ziente sottoposto a tratta-
menti vitali dove la mancanza
di alimentazione pu com-
portare pericolo di vita).
In un sistema elettrico isolato da
terra, un guasto a terra determi-
na il passaggio di una corrente pre-
valentemente capacitiva, dovu-
ta soprattutto ai cavi. La corren-
te di guasto franco a terra I
d
costituita dalla corrente capacitiva
e dalla corrente di dispersione
resistiva. Poich il valore di tale cor-
rente rimane molto modesto, del-
lordine dellampere (eccezional-
mente supera la decina di ampere
negli impianti pi estesi), la re-
lazione
R
T
I
d
25
facilmente soddisfatta, non co-
stituendo un pericolo per le per-
sone, potendo permanere per
un tempo indefinito per quanto
riguarda i contatti indiretti.
Inoltre, il non dover interrompe-
re il circuito al primo guasto a ter-
ra, come ad esempio in alcune ti-
pologie di locali ad uso medico,
rappresenta il maggior vantaggio
del sistema IT.
I principali inconvenienti, invece,
sono le sovratensioni (svantag-
gio tipico dei sistemi a neutro
isolato) ed il doppio guasto a
terra (su unaltra fase di un altro
circuito stabilendo in tal caso
una corrente di doppio guasto
a terra, alimentata dalla tensio-
ne concatenata, che pu deter-
minare lintervento dei disposi-
tivi di protezione a massima cor-
La sicurezza
elettrica del paziente
TECNOLOGIE
Il sistema IT viene solitamente adottato quando esi-
stono particolari esigenze di continuit del servi-
zio, come nel caso ospedaliero
60
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Armando Ferraioli
Figura 1 - Il sistema IT
Non interrompere
il circuito al
primo guasto
a terra rappresenta
il maggior vantaggio
del sistema IT
rente su entrambi i circuiti), ve-
nendo meno il vantaggio della
continuit di esercizio del siste-
ma IT. Da tenere anche in conto
che il verificarsi di un secondo
guasto a terra rende problema-
tica la protezione contro i contatti
indiretti e contro le sovraten-
sioni.
Per ridurre la probabilit del ve-
rificarsi di un secondo guasto a
terra, quando il primo non sta-
to ancora risolto, necessario
prevedere tra neutro e terra un
dispositivo per il controllo del-
lisolamento e provvedere ad eli-
minare, in un tempo ragionevo-
le, il guasto a terra.
La norma Cei 64-8/7; V2 Im-
pianti elettrici utilizzatori a ten-
sione nominale non superiore a
1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c. -
Parte 7: Ambienti e applicazioni
particolari - Sezione 710: Locali ad
uso medico richiede per i loca-
li di gruppo 2 lutilizzo del si-
stema elettrico IT-Medicale (IT-
M), vale a dire una protezione per
separazione elettrica con con-
trollo permanente della resi-
stenza di isolamento.
Il sistema IT-M deve essere ali-
mentato con trasformatore di
isolamento ad uso medicale (fi-
gura 3) e deve essere dotato di un
dispositivo di controllo perma-
nente dellisolamento.
Ai sistemi IT-M non si applicano
le regole generali richieste per i
sistemi IT dalla norma Cei 64-8.
Si raccomanda per che una in-
dicazione abbia luogo anche
quando si interrompe il collega-
mento a terra o allimpianto sor-
vegliato.
Pertanto, il sistema IT-M un
sistema elettrico isolato da ter-
ra (I) e le masse non sono colle-
gate a terra (T), ma non il so-
lito sistema IT, perch il trasfor-
matore non pu essere ordinario,
ma deve essere di isolamento e
di tipo medicale che ha tra gli av-
volgimenti una separazione di
protezione, cio un isolamento
doppio o rinforzato oppure uno
schermo collegato a terra. La se-
parazione di protezione deve
sussistere anche tra i circuiti ali-
mentati dal trasformatore di iso-
lamento e gli altri circuiti colle-
gati direttamente alla rete; di-
versamente, un guasto tra tali cir-
cuiti comprometterebbe la se-
parazione della rete stessa. Li-
deale, dove possibile, posare i
cavi in tubi o canali separati da
quelli di altri circuiti oppure se-
parati da setti.
Inoltre, il sistema elettrico che ali-
menta deve essere limitato solo
ad un locale o ad alcuni locali,
quelli di gruppo 2, nei quali
sussiste il massimo rischio elet-
trico ovvero il microshock. In-
fatti, in tali locali - come ad esem-
TECNOLOGIE LA SICUREZZA ELETTRICA DEL PAZIENTE
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 61
Multitecno S.r.l.
Via Ita Marzotto, 8 - 30025 Fossalta di Portogruaro - Ve - Italy
Tel. 0421.246111 - Fax 0421.246447 - e-mail: info@multitecno.com
www. mul ti tecno. com
La grande maggioranza dei cortocircuiti
causata da aggressioni ai cavi elettrici da
parte dei topi, ma ora puoi disporre della
soluzione definitiva.
BLACK TERRIER, infatti, con l'emissione
variabile di onde di pressione acustica a
media frequenza, protegge volumetricamente
ogni tipo di conduttura elettrica in quadro,
cunicolo o controsoffitto.
Pu essere alimentato direttamente a 230
Volt oppure da una centrale elettronica di
comando e controllo.
Per informazioni pi dettagliate chiamaci al
nostro numero telefonico.
g
u
s
e
l
l
a
-
a
d
v
.
c
o
m
servizio lettori 1557
Figura 2 - La corrente di terra
nel sistema IT
Figura 3 - Trasformatore di isolamento
pio le sale operatorie - il pazien-
te potrebbe avere il cuore in col-
legamento elettrico con lester-
no, rendendolo particolarmente
sensibile alle correnti elettriche.
In tal caso, correnti dellordine del-
la decina di microampere (10
-6
A) potrebbero innescare la fi-
brillazione ventricolare.
Per tale problematica occorre
utilizzare misure di protezione
non solo sullimpianto elettrico ma
anche sulle apparecchiature elet-
tromedicali.
Le norme specifiche che regola-
no tali apparecchiature (Cei EN
60601-1) dettano i limiti delle
correnti di dispersione prescrit-
ti per la classe di appartenen-
za. Inoltre, non bisogna sotto-
valutare gli errori del personale
medico e paramedico che possono
compromettere notevolmente la
sicurezza elettrica del paziente.
da ricordare che si pu rite-
nere il valore di 1020 microam-
pere ragionevolmente non peri-
coloso per il paziente. Tale valo-
re di corrente estremamente pic-
colo mille volte pi piccolo del
limite di pericolosit relativo a con-
dizioni normali.
Nei locali di gruppo 2 risulta
pertanto indispensabile conse-
guire la massima equipotenzia-
lit tra tutte le masse e le mas-
se estranee (una parte metallica
che presenta una resistenza ver-
so terra minore di 0,5M) diret-
tamente o indirettamente ac-
cessibili al paziente. Se, infatti, fac-
ciamo riferimento alle correnti
su esposte quale limite di peri-
colosit per il paziente ed assu-
miamo come resistenza del cor-
po umano 5001000, ne con-
segue una tensione limite di si-
curezza di circa 10 mV che da
intendere quale tensione mas-
sima da non superare, indipen-
dentemente dal tempo di inter-
vento delle protezioni. Per tale mo-
tivo, la norma Cei 64-8/7 preve-
de il nodo equipotenziale a cui
vanno collegate tutte le parti si-
tuate o che possono entrare nel-
la zona paziente quali le masse
(conduttori di protezione), le
masse estranee (conduttori equi-
potenziali), gli schermi, se in-
stallati, contro le interferenze
elettriche, le eventuali griglie
conduttrici nel pavimento e le-
ventuale schermo metallico del
trasformatore di isolamento.
La sezione nominale dei con-
duttori equipotenziali non de-
ve essere inferiore a 6 mm
2
in ra-
me. Solo in tal modo un guasto
di isolamento in un apparecchio
esterno allinsieme equipotenziale
non ha conseguenza alcuna.
Lesigenza dellutilizzo del tra-
sformatore di isolamento nasce
dal fatto che un guasto a terra, in
uno degli apparecchi connessi
al nodo equipotenziale, deter-
minerebbe una differenza di po-
tenziale, nei confronti degli altri
apparecchi, pari al prodotto del-
la corrente di guasto per la resi-
stenza del tratto di conduttore di
protezione compreso tra lappa-
recchio ed il nodo equipotenzia-
le. Ad esempio, una corrente di
guasto di 10A su una resistenza
di 0,1 darebbe origine a condi-
zioni di pericolo mortale per il
paziente.
Poich la norma Cei 64-8/7 pre-
scrive un limite di 0,2 per la
resistenza dei conduttori e delle
connessioni tra il nodo equipo-
tenziale ed i morsetti previsti
per il conduttore di protezione del-
le prese a spina e degli appa-
recchi utilizzatori fissi o per qual-
siasi massa estranea, nel caso
di utilizzo del trasformatore di
isolamento, essendo le correnti
di primo guasto prevalentemente
capacitive e molto piccole se il
circuito non esteso (dellordi-
ne di alcuni milliampere), di-
vengono trascurabili le cadute di
tensione sui conduttori di pro-
tezione in caso di primo guasto
a terra.
Se il trasformatore di isolamen-
to alimenta per esempio solo un
locale, la corrente capacitiva del-
lordine dei milliampere e per-
tanto la caduta di tensione sul
conduttore di protezione di al-
cuni millivolt.
In questa situazione, la corrente
che attraversa il paziente, in con-
tatto con lapparecchio guasto
e un altro apparecchio o una
massa estranea collegati al nodo
equipotenziale, dellordine dei
microampere. Infatti, con il limi-
te di resistenza di 0,2 anche
una corrente di 10mA portereb-
be ad una caduta di tensione di
dV = 10 x 0,2 = 0,2 mV
e, pertanto, una corrente di
dV 0,2
I
_________
=
_________
= 2
R
paziente
1000
molto inferiore alla soglia di 50A,
ritenuta accettabile per il pa-
ziente soggetto a microshock.
Si pu, in definitiva, ritenere il si-
stema IT-Medicale il connubio
tra la separazione elettrica ed il
sistema IT. Bisogna ricordare
che la norma Cei 64-8/7 esclude
lutilizzazione del sistema IT-M per
i circuiti per unit a raggi X e i cir-
cuiti per apparecchi con una po-
tenza nominale maggiore di 5kVA.
Ovviamente, questo dettato
da ragioni pratiche ed economi-
che. In tali casi si ritiene suffi-
ciente una protezione differenziale
ad alta sensibilit ( 0,03A) di
tipo A o B. Tale protezione non li-
mita la corrente di guasto ma
solo il tempo (3040 ms) per cui
essa fluisce.
Durante tale intervallo di tempo,
la tensione verso il nodo equi-
potenziale dellapparecchio pu
raggiungere valori elevati ed il
paziente, se accidentalmente
in contatto simultaneamente
con unaltra massa o massa
estranea, potrebbe essere in se-
rio pericolo.
Per tale motivo, quasi tutte le
apparecchiature di questa tipo-
logia sono dotate di un trasfor-
matore dingresso che svolge la
funzione di trasformatore di iso-
lamento nei confronti dei circui-
ti a valle.
Se, viceversa, al paziente ap-
plicato un circuito appartenente
ad un altro apparecchio elettro-
medicale, la sua sicurezza di-
pende dallisolamento verso ter-
ra di quel circuito.
Per controllare permanentemente
lisolamento verso terra dellim-
pianto, come gi precedentemente
evidenziato, bisogna inserire, tra
il secondario del trasformatore di
isolamento ed il conduttore di pro-
tezione, un dispositivo di control-
lo dellisolamento che sia in ac-
cordo con la norma Cei EN 61557-
8 Sicurezza elettrica nei sistemi
a bassa tensione fino a 1KV c.a.
e 1,5 KV c.c. - Apparecchi per
prove, misure o controllo dei si-
stemi di protezione - Parte 8:
Apparecchi per il controllo del-
lisolamento nei sistemi IT.
La norma Cei 64-8/7 impone per
tale dispositivo requisiti ben pre-
cisi quali limpedenza interna di
almeno 100K, la tensione di
prova minore di 25 V c.c., la cor-
rente di prova minore di 1mA
c.c. anche in condizioni di guasto,
la disinseribilit del dispositivo,
lindicazione della resistenza di
isolamento quando scende a
50K, la presenza di un dispo-
sitivo di prova per tale verifica.
Inoltre, la norma impone anche
linstallazione, in un posto idoneo,
di un sistema di allarme ottico-
acustico in modo che il perso-
nale medico possa sorvegliare
permanentemente il sistema IT-
M (figura 4).
La norma non richiede lutilizzo
del dispositivo di controllo del-
lisolamento quando il trasfor-
matore alimenta un singolo ap-
parecchio elettromedicale, perch
in tal caso un guasto a terra su
di un solo circuito poco pro-
babile e ancor pi un secondo
guasto a terra.
62
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
TECNOLOGIE LA SICUREZZA ELETTRICA DEL PAZIENTE
Figura 4 - Ripetitore per il controllo
dellisolamento
Antincendio
Resistente al
fuoco
certificata
REI 120
(VVF)
Uffici e depositi: Via Boncompagni,57 - 20139 Milano
Tel. ++39 0257403726 - 025692603 - Fax ++39 0257403703
http://www.Inexportitalia.it - E-mail: Info@Inexportitalia.it
C
E
R T I F I E
D
M
A
N
AGEME NT SYS
TE
M
AZIENDA CERTIFICATA
UNI ENISO9002 n 9105 INEX
servizio lettori 903
C sicurezza. C Fracarro.
La sicurezza di vedere sempre quello che accade, per esercitare un controllo totale dei propri spazi, in qualsiasi ambiente.
La sicurezza di poter contare su una gamma completa di prodotti per la videosorveglianza garantiti dal marchio Fracarro:
telecamere, obiettivi, monitor, selettori ciclici, matrici video, compressori, multiplexer, registratori digitali e trasmettitori video,
videoregistratori, sistemi telemetrici, ponti radio, accessori vari. La sicurezza di essere assistiti in ogni momento, sia telefoni-
camente sia attraverso gli oltre 80 Centri assistenza distribuiti sul territorio nazionale. La sicurezza, quando Fracarro, si vede.
Fracarro Radioindustrie SpA, www.fracarro.com, infosic@fracarro.com
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
5
6
6
L
o sviluppo e la diffusione di ca-
richi alimentati da dispositi-
vi caratterizzati da un largo im-
piego dellelettronica di potenza
ha determinato un radicale muta-
mento delle condizioni di utilizza-
zione dellenergia elettrica rispet-
to alla situazione del passato.
Lo scenario attuale allinterno del
quale il progettista, linstallatore e
il manutentore svolgono le loro ri-
spettive attivit ha subito, nel cor-
so degli ultimi anni, importanti e so-
stanziali modifiche che lo hanno al-
lontanato dallidealit dellelet-
trotecnica classica, introducendo a
tutti i livelli e in modo contingen-
te fenomeni gi noti ma, nel pas-
sato, relegati praticamente ai soli
testi accademici.
Uno tra gli aspetti che
hanno maggiore impatto
sugli impianti elettrici
costituito dalla presen-
za di armoniche di ten-
sione e di corrente, fe-
nomeni che rendono non
pi accettabili alcune
pratiche progettuali e
manutentive basate sui
presupposti relativi al-
lassenza di armoniche
(ovvero di presenza di
sole onde di tensione e di
corrente sinusoidali alla
frequenza nominale di
rete).
In questo articolo viene
preso in esame il problema
del dimensionamento del
conduttore di neutro in
presenza di armoniche di
corrente.
LA CORRENTE
NEL CONDUTTORE
DI NEUTRO
In un sistema trifase simmetrico
a 4 fili, la corrente che percorre
il conduttore di neutro pari al-
la somma vettoriale delle tre
correnti di linea. Nel caso in cui
i carichi siano lineari e perfet-
tamente distribuiti sulle tre fa-
si, la corrente nel conduttore di
neutro risulta essere nulla, men-
tre se le fasi sono caricate in
modo non omogeneo, nel con-
duttore di neutro sar presente
una corrente di squilibrio, ge-
neralmente di ampiezza inferio-
re rispetto a quella delle cor-
renti che interessano le fasi.
Sotto queste condizioni, a partire
da date sezioni, il conduttore di
neutro pu essere scelto di se-
zione inferiore rispetto a quella
dei conduttori di fase (art. 524.3
della norma Cei 64-8
1
).
Venendo meno lipotesi di cari-
co lineare, la scelta del condut-
tore di neutro deve essere ef-
fettuata in funzione dello spet-
tro armonico delle correnti nel-
le fasi in quanto lintensit del-
Per evitare intervento in-
tempestivo delle protezioni,
surriscaldamento, invec-
chiamento precoce o incen-
dio dei cavi, quando si scel-
gono le sezioni dei condut-
tori indispensabile consi-
derare il tipo di carico da
alimentare
Dimensionamento
del neutro
Angelo Baggini
Gabriele Tacchi
TECNOLOGIE
64
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
1
Art. 524.3, Norma Cei 64-8/4: Nei circuiti polifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione
superiore a 16 mm
2
se in rame od a 25 mm
2
se in alluminio il conduttore di neutro pu avere
una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente
le seguenti condizioni:
la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il
conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibi-
le corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro;
la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm
2
se in rame od a 25 mm
2
se
in alluminio.
In presenza
di armoniche
omopolari nelle fasi
la corrente
nel conduttore
di neutro sempre
maggiore di zero
FIGURA 1 - SPETTRO CARATTERISTICO DI
UNA LINEA CHE ALIMENTA LAMPADE
FLUORESCENTI COMPATTE
la corrente nel neutro pu assu-
mere valori anche maggiori ri-
spetto a quelle che circolano nei
conduttori di fase.
La tabella 1 riassume i quattro ca-
si possibili in funzione del tipo di ca-
rico alimentato dalla linea in esame.
In particolare le armoniche che
contribuiscono ad innalzare la cor-
rente nel neutro sono quelle di fre-
quenza multipla di tre rispetto al-
la frequenza della fondamentale, no-
te come correnti omopolari. Tali
correnti hanno la caratteristica di
sommarsi algebricamente nel con-
duttore di neutro anzich di eli-
dersi come accade per le altre com-
ponenti (vedi box). In presenza di
armoniche omopolari nelle fasi la cor-
rente nel conduttore di neutro risulta
essere sempre maggiore di zero, an-
che nel caso di carico equilibrato.
Quando il loro contenuto rispetto
alla corrente fondamentale supera
il 33%, si ottiene una corrente nel
conduttore di neutro addirittura
maggiore di quella osservata nel-
le fasi.
I CRITERI
DI DIMENSIONAMENTO
In presenza di carichi non li-
neari, i criteri di scelta dei con-
duttori ed in particolare del con-
duttore di neutro devono esse-
re rivisti, in quanto la prassi co-
TECNOLOGIE DIMENSIONAMENTO DEL NEUTRO
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 65
Avvolgitori automatici di cavi elettrici
e tubi per usi industriali;
avvolgitori manuali; lampade portatili.
QUALITY AND SECURITY
Strada della Chiara, 25 10080 Feletto Canavese (Torino) Italy
Tel.: Centralino 0124.49.96.11 - Comm.le Italia 0124.49.96.20 - Fax 0124.49.06.69
www.zeca.it E-mail: info@zeca.it
Volete conoscere pi da vicino i prodotti ZECA?
Compilate ed inviate oggi stesso questo tagliando e potrete ricevere senza impegno n spese i nostri cataloghi.
Ditta ...................................................... Sig. ....................................................................................
Via ............................................. .............. N........... CAP.............. Citt .......................................
Tel. ............................. Fax ............................... E-mail....................................................................
servizio lettori 999
Sarebbe forse pi semplice elencare i pochi carichi lineari
tuttora utilizzati. La diffusione dellelettronica di po-
tenza sia in ambito civile domestico che in ambito in-
dustriale ha radicalmente modificato il parco dei carichi
alimentati dalla rete elettrica. Ecco i carichi non linea-
ri pi diffusi nellambiente industriale e del terziario:
- elaboratori elettronici e loro periferiche (Figura 3);
- lampade fluorescenti o comunque dotate di alimentatore
elettronico e/o dimmer (Figura 1 e Figura 2);
- condizionatori dotati di inverter;
- gruppi statici di continuit;
- azionamenti elettrici a velocit variabile;
- raddrizzatori;
A questi vanno aggiunti altri carichi, generalmente di ele-
vata potenza, che producono armoniche per la presen-
za di archi elettrici.
- saldatrici ad arco;
- forni ad arco
f
o
c
u
s
Quali sono i carichi
non lineari?
TABELLA 1 - POSSIBILI SITUAZIONI
RISCONTRABILI TRA I CARICHI TRIFASE
E INDICAZIONI SULLA RELATIVA CORRENTE
DI NEUTRO
Carico equilibrato Carico non equilibrato
Carico lineare I
neutro
= 0 I
neutro
> 0 - generalmente modesta
Carico non lineare I
neutro
> 0 - pu superare I
fase
I
neutro
> 0 - pu superare I
fase
Il comportamento delle componenti della corrente nel
neutro rappresentabile mediante due semplici analogie
meccaniche. Tre correnti uguali e sfasate reciprocamente
di 120 (componenti non omopolari di
un carico equilibrato) possono essere
raffigurate da tre locomotori di ugua-
le potenza tra loro collegati da cavi e
collocati su binari con direzioni reci-
procamente sfasate di 120. evi-
dente che la somma delle forze applicate al punto in
cui i tre cavi si uniscono (neutro) nulla e pertanto i
tre locomotori (e in particolare il nodo che li collega) re-
steranno immobili.
Nel caso delle correnti omopolari (le componenti
a frequenza multipla di tre rispetto a quella del-
la fondamentale che, come noto, in Europa pa-
ri a 50 Hz), la situazione invece raffigurabi-
le mediante tre locomotori tra loro in fase, quin-
di orientati nella stessa direzione. Chiaramente
la forza cos sviluppata nel punto comune alle
tre macchine (neutro) sar tripla rispetto a
quella del singolo locomotore.
COMPORTAMENTO DELLE CORRENTI
NEL CONDUTTORE DI NEUTRO
FIGURA 2 - FORMA DONDA DELLA CORRENTE ASSORBITA
DA UNA LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA:
SI NOTI LA ELEVATA DISTORSIONE RISPETTO ALLA
FORMA DONDA SINUSOIDALE
Questo articolo stato preparato, nellambito del
progetto LPQI (www.lpqi.org), con il supporto
della Commissione Europea e dellInternational Cop-
per Association Ltd. Gli autori precisano per
che il contenuto del presente articolo non riflette
necessariamente la posizione della Commis-
sione Europea e/o non implica alcuna respon-
sabilit da parte della Comunit Europea.
UNA PRECISAZIONE
mune porterebbe a sottodimen-
sionare il conduttore con conse-
guente surriscaldamento, invec-
chiamento precoce o, nel peg-
giore dei casi, distruzione del me-
desimo. I passi da compiere sono
sostanzialmente i seguenti:
acquisizione mediante misu-
razione o attraverso analisi del-
la documentazione dello spet-
tro armonico della corrente as-
sorbita dal carico;
individuazione delle armoni-
che omopolari;
calcolo del contributo alla cor-
rente del neutro da parte delle
armoniche omopolari.
Nel box di testo viene riportata
una breve trattazione analitica
del problema e due esempi rea-
li.Individuata lesistenza del
problema pu essere di aiuto
la norma Iec 364-5-523, che ri-
porta una tabella che fornisce in-
dicazioni sul dimensionamen-
to del neutro in presenza di ter-
za armonica nei conduttori di
fase.
IN BREVE
Alla luce di quanto sopra ripor-
tato e degli esempi proposti nel
box, rappresentativi di situa-
zioni impiantistiche reali e mol-
to diffuse, si comprende la ra-
gione per la quale il sottodi-
mensionamento del conduttore
di neutro rispetto alla sezione
dei conduttori di fase sia da con-
siderarsi ormai una consuetu-
dine da verificare caso per caso.
Per evitare conseguenze poten-
zialmente dannose (intervento
intempestivo delle protezioni,
surriscaldamento, invecchiamento
precoce o, in casi estremi, incen-
dio dei cavi) quando si scelgono
le sezioni dei conduttori per-
tanto indispensabile considera-
re il tipo di carico da alimentare,
acquisendo per mezzo di una
misurazione lo spettro armonico
della corrente assorbita, oppure,
se ci non fosse possibile, uti-
lizzando spettri tipici.
Una volta in possesso dello spet-
tro armonico occorrer indivi-
duare le armoniche omopolari
di ampiezza non trascurabile e
calcolare il loro contributo alla cor-
rente del neutro.
Solo a questo punto sar possi-
bile scegliere correttamente la
sezione del neutro e valutare se sia
possibile o meno adottare una se-
zione ridotta.
In generale, si vedr che nel caso
di circuiti che alimentano carichi
non lineari la sezione del condut-
tore di neutro dovr essere al-
meno pari alla sezione del corri-
spondente conduttore di fase se
non addirittura maggiore come
visto nei casi reali illustrati in que-
starticolo.
Articolo tratto dai convegni
istituzionali CEI 2003
66
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
TECNOLOGIE DIMENSIONAMENTO DEL NEUTRO
TABELLA 2 - FATTORI DI RIDUZIONE
DELLA PORTATA DEI CAVI IN FUNZIONE
DEL CONTENUTO ARMONICO DELLE CORRENTI
NELLE FASI O NEL NEUTRO (IEC 364-5-523)
Corrente di terza armonica Valore selezionato in base Valore selezionato
nella fase (%) alla corrente di fase in base alla corrente
di neutro
0-15 1,00 -
15-33 0,86 -
33-45 - 0,86
45 - 1,00
BIBLIOGRAFIA
[1] Baggini, J. Desmet: Dimensionamento del neutro in impianti af-
fetti da armoniche. Leonardo Power Quality Initiative. (Il materiale
scaricabile gratuitamente dal sito www.lpqi.org)
Noto lo spettro armonico della corrente delle fa-
si, ottenibile mediante una misurazione con un ana-
lizzatore di rete, si devono prendere in conside-
razione le armoniche dispari di ordine multiplo di
tre, tipicamente la terza e la nona.
Le armoniche di ordine superiore (15
a
, 21
a
etc.) so-
no generalmente caratterizzate da unampiezza
molto contenuta e quindi trascurabili. La corren-
te relativa alle armoniche omopolari su ciascuna
fase quindi approssimabile con la seguente
equazione:
I
ao
=
1
2
+ 1
2
3 9
nella quale con I
3
e I
9
si indicano rispettivamente
le correnti di terza e nona armonica, avendo tra-
scurato le restanti componenti omopolari. Nel
caso queste non fossero trascurabili, incluse
eventuali armoniche omopolari di ordine pari (se-
sta, dodicesima etc.), devono essere semplice-
mente aggiunte sotto radice nella formula di cui
sopra. Nel neutro, come gi visto, le componen-
ti omopolari si sommano tra loro, quindi la corrente
che interesser questo conduttore sar il triplo di
quella sopra calcolata:
I
no
= 3 I
ao
Dalla teoria alla pratica
Per chiarire le idee viene proposto, a titolo di
esempio, un caso reale di misura di corrente di un
carico non lineare assai diffuso e caratterizzato da
uno spettro armonico particolarmente pesante
(figura 1): le lampade fluorescenti compatte.
Si considerino i risultati delle misurazioni di un mon-
tante illuminazione. Dallo spettro di figura 1, si no-
ta la presenza di una componente di terza ar-
monica pari al 74,6% della fondamentale, e di
una di nona armonica pari al 33%.
Essendo la fondamentale pari a 14,4 A possibile
ricavare lampiezza della corrente di terza e di nona
armonica:
I
3
= 0,746 14,4 = 10,7 A
I
9
= 0,33 14,4 = 4,75 A
La corrente dovuta alle omopolari in ciascuna fa-
se sar dunque pari a
I
ao
= 10,7
2
+ 4,75
2
= 11,74 A
mentre nel conduttore di neutro sar presente la
somma delle tre correnti omopolari, pari quindi a
I
no
= 3 11,7 = 35,12 A
Il vero valore efficace, che tiene cio conto dei
contributi della fondamentale e di ciascuna ar-
monica, della corrente che scorre in ciascuna del-
le tre fasi pari a 21 A.
Si noti come il valore della corrente nel neutro sia
non solo diverso da zero, ma addirittura superio-
re del 70% rispetto alla corrente in ciascuna fase.
In questo caso quindi la sezione del conduttore di
neutro dovrebbe essere maggiore della sezione
del conduttore di fase.
Come ulteriore esempio si propone un rilievo ef-
fettuato su di una linea che alimenta carichi in-
formatici (figura 3). In questo caso le componenti
di terza e nona armonica valgono rispettivamente
il 42% ed il 7,4% della fondamentale, quindi, pro-
cedendo come prima, il conduttore di neutro
percorso da una corrente pari a 37,6 A. Ancora una
volta la corrente che percorre il neutro risulta
maggiore di quella di fase anche se in misura mi-
nore del caso precedente (1,2 volte circa). A tutto
ci bisogna aggiungere il fatto che, in queste con-
dizioni, il neutro non pu essere trascurato nel
calcolo della portata della linea (4 conduttori ter-
micamente attivi invece che 3).
COME TENER CONTO DELLE CORRENTI OMOPOLARI?
Nel caso di circuiti
che alimentano
carichi non lineari la
sezione del conduttore
di neutro dovr
essere almeno pari
alla sezione
del corrispondente
conduttore di fase
FIGURA 3 - SPETTRO DELLA CORRENTE RILEVATO
SU DI UNA LINEA DI ALIMENTAZIONE
DI PERSONAL COMPUTER
Fracarro gi oggi ha tutta la tecnologia per il Digitale Terrestre. Per entrare subito in questo nuovo
mercato, prendi l'iniziativa. Proponi ai tuoi clienti l'adeguamento degli impianti. Potrai contare su
prodotti all'avanguardia con le nuove tecnologie, garantiti da 70 anni di esperienza.
Antenne Terrestri
Nuove antenne con connettore F.
Amplificatori larga banda multingressi
Nuova serie MBX
Ricevitori
Nuovi ricevitori per il digitale terrestre
Amplificatori da palo
Nuova serie MAP
servizio lettori 1800
P
er diffondere musica di sot-
tofondo e per effettuare chia-
mate selettive in 12 zone
aperte ai clienti, in quello che
uno dei pi prestigiosi casin del
mondo - situato in uno storico pa-
lazzo sul Canal Grande a Venezia
- stato recentemente installato,
dalla societ di installazione loca-
le Vivaldi di Noventa di Piave, un
sistema di amplificazione sonora del-
la divisione Audio Contractor del-
la Fbt Elettronica. Spiega chi ha rea-
lizzato limpianto:La direzione vo-
leva una rete di distribuzione che
consentisse non solo di diffondere
programmi musicali differenti nel-
le varie zone o annunci selettivi, ma
che avesse anche un controllo di Spl
per ogni zona.
Il sistema audio Fbt copre 12 zone
delle aree aperte al pubblico nel pa-
lazzo e sono stati installati 30 dif-
fusori acustici a 2 vie Studio4/BT,
in ogni stanza in un numero che va
da 2 nella sala pi piccola a 8 in quel-
la pi grande (400 m
2
). Il cliente vo-
leva selezionare il programma mu-
sicale da diffondere in ciascuna
delle varie zone del palazzo e la pos-
sibilit di controllare indipenden-
temente il volume. Una console
microfonica MBT8004, dotata di
microfono electrete cardioide, di
pulsanti per la selezione delle zo-
ne e lattivazione dellemergenza,
viene utilizzata per le chiamate
selettive e per la diffusione in au-
tomatico di un messaggio di al-
larme preregistrato al suo interno,
in condizioni di emergenza.
La centrale rack installata in una po-
sizione nascosta consta di una ma-
trice 4x4, MMS4004, di una ma-
trice mixer MMZ8004, con 10 in-
gressi e 4 bus di uscita e di una re-
te di finali di potenza realizzata
con 3 finali multicanale MCA2240A.
Linstallatore continua: Una del-
le condizioni fondamentali richie-
ste dal committente era quella che
i diffusori acustici avessero il minor
impatto estetico possibile sulle sa-
le, splendidamente decorate con
specchi e immensi candelabri in cri-
stallo, pelli sontuose e rivestimenti
in legno; pertanto abbiamo dovu-
to trovare diffusori acustici che
potessero essere installati a soffitto,
nascondendoli tra le travi in le-
gno, e che fossero soprattutto in gra-
do di assicurare unottima ripro-
duzione del suono e un elevato li-
vello di intelligibilit per le comu-
nicazioni vocali. I diffusori acustici
Fbt, in resina termoplastica, mi-
surano 16,2x25,6x15,7 cm, ma han-
no una potenza di 60W Rms.
Il direttore della Divisione Audio
Contractor di Fbt Elettronica, lin-
gegner Antonio Faccioni, ha af-
fermato: Questa sicuramente
una tra le pi prestigiose installa-
zioni realizzate in Italia e alleste-
ro, ma solo una delle molteplici ap-
plicazioni in cui sono stati installati
i nostri prodotti: da fitness club a
centri conferenza di elevato livel-
lo, centri commerciali, centri spor-
tivi e stabilimenti industriali.
UN ESEMPIO
DI AMPLIFICAZIONE
Un esempio di configurazione di un
impianto di amplificazione audio,
che preveda la gestione di 4 zone
indipendenti e la possibilit di in-
terfacciarsi con un sistema di rile-
A Ca Vendramin Calergi, sul
Canal Grande, e nella sala con-
siliare del Comune di Pescara
sono stati installati sistemi au-
dio distribuiti
Ascoltare
al casin e in
consiglio comunale
A cura di
Alma Taddei
IMPIANTI
68
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Ca Vendramin Calergi - la cui data di costruzione viene fatta ri-
salire al 1481 - fu il primo grande palazzo veneziano del Rinascimento
e sicuramente uno dei
pi grandiosi dellepo-
ca doro della Serenissi-
ma. Finita agli inizi del
16 secolo, lelegante
struttura si affaccia mae-
stosamente sul Canal
Grande; il piano nobile si
propone come luogo
ideale per eventi, atti-
vit culturali e servizi di
ricevimento, mentre il
secondo piano ospita le
sale da gioco del Casin
municipale di Venezia.
CA VENDRAMIN CALERGI
Ambienti: 12 saloni (dimensioni max 400 mq).
Esigenza: impianto di amplificazione acustica con sistema che
consente di selezionare 4 sorgenti musicali per 4 zone indipendenti.
Minore impatto visivo possibile dei diffusori.
Sistema di gestione: 1 matrice 4x4 MMS4004; 1 unit mixer
MMZ8004 a 4 bus di uscita.
Finali di potenza: 3 unit multicanale MCA2240A.
Diffusori: 30 diffusori studio4/BT, 2 vie, 60 W rms posizionati a
soffitto.
Basi microfoniche: 1 unit MBT8004 per annunci selettivi nel-
le singole zone ed invio automatico di messaggi di allarme.
IL CASIN MUNICIPALE DI VENEZIA
vazione di una condizione di emer-
genza, pu essere costituito da
un preamplificatore MMZ8004, che
consente di avere 4 bus di uscita
con controllo indipendente e 10
ingressi dotati di microswitch per
lassegnazione di ciascun ingresso
su ciascuna uscita; lamplificatore
che pu essere utilizzato della se-
rie MCA, Multi Channel Ampli-
fier, che si caratterizza per avere fi-
no a 4 finali di potenza allinterno
di un unico chassis, con doppio
ingresso per ciascun finale, di cui
uno prioritario allaltro. La consol-
le microfonica MBT8004, che per-
mette di irradiare messaggi voca-
li con la massima intelligibilit, do-
tata di un robusto flessibile con
microfono dinamico electrete con
filtro anti pop ed costituita da una
elegante struttura in Abs stam-
pato di colore nero, debitamente se-
rigrafato, e fondo in acciaio. La
consolle consentir di inviare an-
nunci microfonici selettivi nelle
singole zone o di effettuare chiamate
generali, abbassando il livello del
segnale musicale solo nella zona in-
teressata allannuncio. Inoltre dal-
la stessa consolle microfonica, ol-
tre ai messaggi via microfono, sa-
r possibile inviare un segnale di
emergenza, preregistrato al suo
interno, contemporaneamente in
tutte le zone al massimo volume.
Il messaggio dallarme, che potr
essere un messaggio vocale per-
IMPIANTI ASCOLTARE AL CASIN E IN CONSIGLIO COMUNALE
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 69
La console microfonica permette
di irradiare messaggi vocali
ad alta intelligibilit
*
servizio lettori 1728
MBT 8004 e MBT 8008: schema a blocchi
Ambiente: area 720 m
2
(36x20 m) per un altezza di 15 m
Diffusori: 6 colonne a direttivit controllata di 200W rms
Basi microfoniche:
- 47 destinate alla votazione con chiave elettronica a traspon-
der per labilitazione/disabilitazione al voto
- 14 abilitate solo agli interventi
Telecamera: Autodome pilotabile, collocata in posizione centrale
Gestione: tramite software Pc che integra ed implementa tut-
te le funzioni del sistema:
1) archiviazione elettronica dei risultati della votazione
2) registrazione audio/video degli interventi
3) controllo movimento telecamera.
LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI PESCARA
sonalizzato, potr essere inviato
automaticamente dal sistema di
rilevazione emergenza con cui ver-
r interfacciato limpianto di am-
plificazione, oppure manualmente
attraverso un apposito pulsante
sulla consolle microfonica stessa.
GESTIONE
CONFERENZE A PESCARA
Come in molti altri Comuni in Ita-
lia, la citt di Pescara ha recente-
mente rinnovato il sistema di ge-
stione conferenze della sala consi-
liare nei suoi 720 m
2
di area. Ac-
cresciute udibilit e intelligibilit e
maggior facilit di gestione del si-
stema durante i dibattiti sono so-
lo alcuni dei benefici apportati dal
nuovo sistema, la cui installazione
stata commissionata dal Comu-
ne ad una azienda locale di instal-
lazione, la Spray Records che, a
sua volta, si rivolta allAudio Con-
tractor, una giovane divisione di
Fbt Elettronica, per la fornitura del
sistema. Antonio Faccioni, linge-
gnere a capo della Divisione Audio
Contractor, spiega ancora: Fbt
Audio Contractor si rivolge al mer-
cato dellinstallazione e la sua spe-
cifica missione quella di soddisfare
le necessit evidenziate da un si-
stema audio, con soluzioni mirate
a risolvere tali esigenze nelle mo-
dalit pi semplici sia nella instal-
70
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
IMPIANTI ASCOLTARE AL CASIN E IN CONSIGLIO COMUNALE
Ancora dopo la prima guerra mondiale, alla foce del fiume omoni-
mo esistevano due cittadine molto diverse tra loro. A sud la pi an-
tica Pescara (ora Porta-
nuova), cresciuta sui re-
sti della fortezza cinque-
centesca che presidiava
il corso dacqua. A nord
del fiume, nella stretta fa-
scia di terra che si allunga
tra le colline e il mare, si era
invece sviluppata, dal 1806,
Castellammare Adriatico,
che con larrivo della fer-
rovia e la costruzione del-
la stazione (1863) aveva
avuto una consistente
espansione. Commerciale, artigianale e popolare Pescara; bor-
ghese, signorile e con vocazione turistica Castellammare Adriati-
co. La fusione dei due comuni avvenne nel 1926, sotto il patrocinio
di Gabriele DAnnunzio.
PESCARA: UNA CITT NUOVA
MCA 2240 e MCA 4240: schema a blocchi
Unit di
potenza
monoblocco
multicanale a
tensione
costante
Se da oltre 100 anni
si sente parlar bene
dei cavi BELDEN
Un motivo ci sar!
Cavi coassiali
Cavi networking
Cavi industriali
Fibre ottiche
Quality cable solutions
S.r.l.
Vi a Aspromonte, 60/62 - Rozzano (MI)
Tel. 02.57510830 - Fax 02.57510858
www. mi croteksrl.it
c
o
n
t
a
t
t
o
.
a
r
t
e
@
t
i
n
.
i
t
servizio lettori 1453
lazione sia nella gestione. La gam-
ma di prodotti Audio Contractor, per
quanto concerne i sistemi Confe-
rence, attualmente consta di 2 si-
stemi e quello pi esaustivo dal
punto di vista delle funzionalit, il
System 400, quello che stato in-
stallato a Pescara.
Sono state installate 58 basi mi-
crofoniche SLBC400: 47 con labi-
litazione al voto, le rimanenti sen-
za tale funzionalit. Il software di
gestione consente 2 differenti mo-
dalit di funzionamento: la moda-
lit conferenza libera e la modalit
conferenza gestita, che a sua vol-
ta pu essere manuale, automati-
ca o a modalit limitata. Faccioni con-
tinua: Con la modalit manuale lo-
peratore in console riceve la ri-
chiesta di parola (fatta premendo il
pulsante ON della base microfo-
nica) e accoda il microfono relativo
(per un tempo prefissato, se ne-
cessario). In modalit automatica,
il sistema opera automaticamente
e le basi microfoniche in coda ven-
gono abilitate quando loratore pre-
cedente ha terminato linterven-
to. Nella modalit limitata, daltro
canto, le basi programmate per
lintervento sono abilitate in grup-
po (fino a 6 alla volta). Si possono
settare limiti sui tempi di inter-
vento.
Il pulsante Inizio votazione con-
sente al delegato con la base mi-
crofonica abilitata di esprimere il
voto, utilizzando la propria smart
card. Le basi microfoniche sono
dotate di un microfono a electre-
te con flessibile e la base dota-
ta di un altoparlante interno, di
un display retroilluminato che mo-
stra lo stato della base, le opera-
zioni svolte e i risultati delle vo-
tazioni e, quando necessario, i
messaggi concludere e rallen-
tare inviati dal presidente o dal se-
gretario.
Tali basi sono anche disponibili a
richiesta con la connessione ad un
sistema di traduzione simulta-
nea. Lunit di alimentazione del
sistema, AASL100, equipag-
giato con un altoparlante monitor,
controlli di volume e toni per i
segnali di ingresso e di uscita,
un ingresso ausiliare e una usci-
ta per la registrazione degli in-
terventi.
I risultati della votazione, oltre ad
essere visualizzati sul display del-
le basi microfoniche, a Pescara ven-
gono proiettati su schermi al plasma
da 42; tali schermi vengono utilizzati
anche per visualizzare le immagi-
ni riprese da una voice-tracking
dome camera installata a soffitto,
che riprende loratore che inter-
viene, focalizzandosi automatica-
mente su di lui nel momento in cui
rileva lattivazione della base mi-
crofonica che gli associata. La
gestione della telecamera sempre
affidata al software Logosoft V80.2,
che gestisce tutto il sistema au-
dio e video. Belfino De Leonardis del-
la Spray Records aggiunge: Il si-
stema di Fbt offre il grande van-
taggio di essere estremamente fa-
cile da installare: fino a 99 basi
possono essere collegate con un sin-
golo cavo e noi abbiamo completato
linstallazione di tutto il sistema in
soli 5 giorni, incluso limpianto di am-
plificazione audio della sala, che
comprende 6 diffusori acustici a
direttivit controllata, le Clima200B
e la centrale audio a rack.
De Leonardis conclude: Il comune
di Pescara ovviamente soddi-
sfatto delle prestazioni del sistema,
dal momento che ci ha gi contat-
tato per installare altre basi mi-
crofoniche aggiuntive.
IMPIANTI ASCOLTARE AL CASIN E IN CONSIGLIO COMUNALE
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 71
Audio Contractor nata ufficialmente nel 1999 come divisione
del Gruppo Fbt Elettronica.
Altamente specializzata in sistemi di amplificazione ambientale, ere-
dita tutto il know-how e lesperienza capitalizzata dalla casa ma-
dre in oltre 40 anni dattivit. In pochi anni la divisione, la cui direzione
stata affidata allingegner Antonio Faccioni, simpone sul mercato,
integrando ed implementando nel proprio settore una serie di ca-
ratteristiche vincenti: soddisfazione totale del cliente, innovazione
continua, variet di gamma, alta qualit della resa acustica, assi-
stenza post-vendita non-stop per 365 giorni lanno. A queste pe-
culiarit si aggiunge una valenza estetica tipica del made in Italy.
Grazie ad un solido know-how orientato ad elevati standard, Au-
dio Contractor realizza architetture acustiche calibrate sulle esigenze
di ogni ambiente. La villa settecentesca Foscarini a Cornaro di Gor-
go al Monticano (Treviso) e il Centro Commerciale Le Brentelle
di Rubano (Padova) sono solo alcune delle sue importanti realizzazioni.
UN GIOVANE, VECCHIO LEADER
Il
preamplifica-
tore mixer
MMZ 8004 S
Schema a blocchi dellMMZ 8004
L
a domotica applicata al-
limpianto elettrico sem-
pre pi richiesta dal mer-
cato residenziale e terziario spe-
cializzato, e Pandolfi ha svilup-
pato un reparto con personale
specializzato e realizzato uno
spazio domotico permanente
presso la sede di Firenze.
In commercio esistono molti pro-
dotti specializzati per la domo-
tica, e tra le caratteristiche di
questi sistemi si possono rico-
noscere i notevoli vantaggi di
montaggio per linstallatore e
praticit di utilizzo per luten-
te. Ci sta portando a una faci-
le diffusione del prodotto e a
una semplice realizzazione del-
limpianto, sacrificando tuttavia
la flessibilit richiesta quando
lapplicazione deve essere per-
sonalizzata. In base alle espe-
rienze affrontate si pu affer-
mare che la scelta della tecnologia
pi appropriata in funzione di
uno studio analitico delle esi-
genze del cliente, in coerenza
con il contesto ove detta tecno-
logia deve essere applicata. In al-
cuni casi, e questo pu avveni-
re per esempio in contesti di
strutture recettive medio-pic-
cole (agriturismi) o in abitazioni
di particolare pregio, accade che
vengano richiesti
controlli di centrali
termiche o impianti
solari generatori di
acqua calda, di pi-
scine, di fontane o
di illuminazione e ir-
rigazione parchi e
giardini, funzioni che
devono essere ge-
stite in modo sem-
plice, elegante e ta-
le da ottimizzare i
consumi e lenergia
termica prodotta. In
questi casi neces-
sario andare incontro
alle esigenze del cliente stu-
diando insieme allinstallatore
soluzioni da realizzare con i pro-
dotti per lautomazione indu-
striale, che offrono la flessibilit
necessaria a risolvere richieste
e problemi.
Analizziamo una di queste ap-
plicazioni, realizzata presso la
Villa Il Palagetto di Bagno a Ri-
poli (Firenze) dalla ditta di im-
pianti elettrici Eurocentro Si-
stemi srl di Firenze, con il con-
tributo - per quanto riguarda la
parte software - dello studio tec-
nico Softsystem srl di Ponte a
Egola (PI).
IL CONTROLLO
INDUSTRIALE
Generalmente si parla di con-
trollo industriale lad-
dove sono utilizzati
dispositivi elettroni-
ci e software per la
gestione di processi
e di attivit produt-
tive manifatturiere,
chimiche e di tra-
sformazione.
Tra gli esempi di ap-
plicazioni eseguite si
annoverano impian-
ti per lo stoccaggio
di olio alimentare, im-
pianti enologici, ce-
mentifici, acquedot-
ti, linee automatiche
di produzione. In que-
sti sistemi il control-
lo centrale spesso
assegnato ad un plc
(programmable logic
controller) collegato
ad un sistema di supervisione (pc
o pannello operatore con display)
e ai sistemi di ingresso/uscita
(I/O) tramite un sistema bus per
semplificare le connessioni tra la
cpu (unit per il controllo di pro-
cesso) e i sistemi remoti I/O o tra
cpu diverse per accentrare i dati
sulla supervisione. Gli apparec-
chi che vengono generalmente
utilizzati rispondono a caratteri-
stiche di affidabilit, reperibilit dei
ricambi e di diffusione sul mercato
tali da garantire sicurezza e con-
tinuit di esercizio come richie-
sto dal mondo dellindustria. La fles-
sibilit che viene con la gestione
del software del plc ha permesso
Una applicazione di controllo
industriale nel residenziale? Si
pu fare, e con ottimi risultati!
Domotica e dintorni
Giacomo Orlandi
IMPIANTI
72
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Figura 1 - Vista della piscina coperta
controllata con il plc
Figure 2 e 3 - Il pannello touch screen
ben inserito nella parete del locale
piscina e laltro nella cucina: tutto a
portata di dita
La scelta
della tecnologia
pi appropriata in
funzione di uno studio
analitico delle esigenze
del cliente, in coerenza
con il contesto ove
deve essere applicata
il controllo dei dati di produ-
zione, la modifica dei valori di
processo in tempi rapidi per
i cambi di prodotto, la dia-
gnostica per semplificare la ri-
cerca guasti e la riduzione
dei tempi di riparazione con
laumento della disponibilit
del sistema.
Si pertanto ritenuto di tra-
sportare senza alcun rischio
le caratteristiche dei siste-
mi di automazione verso le ri-
chieste del cliente.
LA PRIMA RICHIESTA
DEL CLIENTE
La richiesta di lavoro iniziale era
incentrata sulla realizzazione di
un sistema automatico che fos-
se in grado di asservire al con-
trollo delle tapparelle, della cli-
matizzazione ambientale e del-
la centrale termica in una pisci-
na privata coperta (figura 1), da
controllare tramite due display
touch-screen, posti uno nel-
lambiente della piscina (figura
2) e laltro nellabitazione sita a
fianco della piscina stessa (fi-
gura 3). Detta richiesta venne
affrontata tenendo conto del-
lintenzione espressa dal cliente
di procedere successivamente
ad integrare quanto possibile
nel sistema che si stava met-
tendo in opera. La proposta pre-
vede plc di taglia piccola ma ca-
paci di gestire la richiesta in mo-
do completo ed espandibile ad
ogni momento, ed esattamente
sulla serie Siemens S7-200. Con
detto sistema sono stati cablati
tutti i sensori ed attuatori allin-
terno di una struttura BTicino
posta nei locali tecnici sotto la pi-
scina stessa, dove risiede anche
la centrale termica. Tutte le uten-
ze sono state interfacciate con mo-
duli a rel Phoenix Contact e
contattori Telemecanique. Nella
realizzazione, quindi, limpian-
to ha svolto le funzioni di controllo
e supervisione come in un im-
pianto industriale tradizionale,
sfruttando la comunicazione tra
cpu via seriale RS485 e quindi ri-
ducendo il cablaggio che, in un
impianto civile, presenta possi-
bilit di posa dei conduttori di co-
IMPIANTI DOMOTICA E DINTORNI
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 73
Le idee si muovono. www.stagnoli.com
Luce
Movimento
Controllo
tecnologia
precisione
sicurezza
design
Stile
La tecnolologia della cremagliera in plastica.
La precisione della nuova mini fotocellula.
La sicurezza dei semafori e dei lampeggianti.
Il design della colonna e di tutta la serie Mythos.
Una gamma di accessori per lautomazione.
Stagnoli
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
8
5
Figura 4 - Vista del quadro
elettrico nei locali tecnici della
piscina
Figura 5 - Scorcio di una sezione della villa
Figura 6 - Schema base
mando e segnalazione ben pi se-
ri dellindustriale.
LAMPLIAMENTO
DEL SISTEMA
Il committente, che aveva pre-
ventivamente richiesto lam-
pliabilit del sistema, ha esteso
il raggio dazione del controllo,
portandolo a gestire non sol-
tanto la parte termoidraulica e
la piscina, ma anche altre funzioni
legate alla villa: lirrigazione,
lilluminazione con la gestione de-
gli effetti scenici della villa e
del parco, la termoregolazione a
zone della villa, la supervisione
degli impianti di anti-intrusione
e anti-incendio, della caldaia,
dellimpianto di condiziona-
mento. Grazie alla flessibilit
prevista in fase di progettazio-
ne, il sistema esistente compo-
sto dalle cpu226 Siemens sta-
to agilmente ampliato portando
dette cpu sotto una rete Profibus
ricavata mantenendo il cavo
precedentemente steso tra le
cpu per la rete RS485; sono sta-
ti quindi installati un ulteriore plc
con gli elementi di I/O necessari
e una cpu della serie S7-300 con
la porta Profibus-DP master col-
legata ai moduli EM277 (modu-
li slave di rete) aggiunti alle
cpu226. Questo aumento di po-
tenzialit del sistema non ha
comportato modifiche sui ca-
blaggi dei plc gi esistenti, ed
inoltre ha garantito un buon li-
vello di affidabilit in quanto le
singole zone dellabitazione e
della piscina sono comunque
state poste sotto il controllo lo-
cale delle cpu226 per quanto
concerne le funzioni pi impor-
tanti. Il collegamento con lim-
pianto elettrico tradizionale
stato realizzato con gli I/O digi-
tali aggiuntivi.
COMANDI
E CONTROLLI
Il punto di forza di tutto il si-
stema sicuramente il modo di
interfacciarsi con lutente: ci so-
no tre pannelli grafici touch-
screen con display da 10 pollici
a colori tipo UniOP (uno in villa,
uno in piscina e uno nei locali tec-
nici) collegati anchessi in rete
Profibus e con le stesse pagine
grafiche a disposizione, per cui
si possono effettuare i comandi
e accedere ai controlli da pi
posti e con le stesse potenziali-
t. Con i vantaggi del software
di sviluppo, stato possibile ad
esempio integrare nelle pagine
grafiche i vari prospetti della
villa e disegnare cos pagine vi-
deo con comandi facilmente in-
tepretabili in modo intuitivo.
Le caratteristiche del pannello
grafico permettono di creare mol-
te pagine di help e di segnala-
zioni di anomalia leggibili in mo-
do chiaro e a prova di errore, per-
mettendo un rapido intervento
del personale qualificato, pun-
tuale e con il minimo dispendio di
tempo.
La gestione del periodo di fun-
zionamento delle parti soggette
ad usura (pompe, ventilatori) per-
mette di stabilire i tempi di ma-
nutenzione preventiva, cos come
opportuni messaggi possono ri-
cordare gli interventi sui dispositivi
da sottoporre a manutenzione
periodica (caldaia, filtri aria e
acqua piscina). Tutto questo ser-
ve per diminuire i disagi proprio
come avviene nelle macchine au-
tomatiche industriali, dove lin-
terfaccia Hmi segnala alloperatore
le avarie riscontrate, riducendo i
tempi di fermo della produzione.
Sul display viene anche ripor-
tato, come sola ripetizione dei se-
gnali, lo stato dei sensori del-
limpianto di allarme e di antin-
cendio.
In tal modo, si semplifica la ge-
stione della ricerca di anomalie
su detti impianti. Infatti, grazie
alla planimetria dove viene rap-
74
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
IMPIANTI DOMOTICA E DINTORNI
Figure 11 - 12 - Linterfaccia segnala
le avarie e pagine di help
Figura 7 - Schema a blocchi della
prima realizzazione: due cpu
collegate in rete RS485
Figura 8 - Schema a blocchi della
realizzazione dopo lampliamento
con la cpu315-2DP e la rete
Profibus-DP in sostituzione della
rete RS485 peer to peer
Figure 9 e 10 - Tutti i comandi e i controlli sono a portata di dito
Con le tecnologie
del controllo
industriale possibile
focalizzare il campo
di intervento sul
risparmio energetico
ed il comfort
presentata una spia luminosa
in corrispondenza del sensore
attivato, si interviene diretta-
mente sulloggetto che - per
esempio - ha fatto intervenire
il sistema di sicurezza. Ripor-
tando sui pannelli dette segna-
lazioni, si accentra
la supervisione di
tutto l i mpi anto
elettrico. La modi-
fica di dati, come
per esempio orari
di accensi one o
tempi di lavoro o
ancora date del ca-
lendario, avviene in un modo in-
tuitivo e standardizzato per cui
non serve nessuna competen-
za particolare; il tutto poi ac-
centrato su una unica interfaccia
grafica e non su pi componen-
ti modulari come nei sistemi tra-
dizionali.
Con le tecnologie a disposizione,
si potrebbe anche interrogare il
sistema a distanza via modem o
- se disponibile sul luogo il col-
legamento Internet con asse-
gnazione dellIP statico - trami-
te un browser, usando un pc. I
vantaggi sono sia per lutente che
per linstallatore: per il primo,
perch pu accedere ai coman-
di e alla supervisione anche se
fuori sede; per il secondo perch
pu analizzare uneventuale ano-
malia prima di recarsi sul posto
per lintervento necessario.
CONSIDERAZIONI
Il sistema descritto in funzio-
ne da oltre due anni dallultimo
ampliamento, con soddisfazio-
ne da parte del cliente. Ma qua-
li considerazioni sono state trat-
te da questa esperienza?
In analisi, si pu dire che tra le
esigenze che vengono evidenziate
dal vasto mondo del settore re-
sidenziale ci sono:
- sicurezza;
- risparmio energetico;
- comfort ambientale.
Con le tecnologie del controllo in-
dustriale possibile focalizza-
re il campo di intervento sul ri-
sparmio energetico ed il com-
fort; i sistemi realizzati con i
prodotti per lautomazione in-
dustriale possono realizzare con
pieno successo le applicazioni
di ottimizzazione del controllo
di impianti e funzioni accessorie
correlate, la riduzione degli spre-
chi di energia elettrica e termi-
ca, soddisfacendo ai criteri di
benessere ambien-
tale e di comfort ri-
chiesti, con la pos-
sibilit di controllo
(anche remoto) e di
manutenzione pre-
ventiva del siste-
ma.
Un sondaggio su
una web-commu-
nity, seppure non
tenuto i n modo
scientifico, mostra
che, alla domanda
Pensi che le nuove
tecnologie di auto-
mazione e gestio-
ne dellimpianto elettrico do-
mestico contribuiranno a dare
valore aggiunto alla tua abita-
zione e al tuo stile di vita?, le ri-
sposte sono state le seguenti:
evidente che la platea di uten-
ti che conosce le soluzioni di au-
tomatizzazione dellabitazione in
gran parte favorevole poich ne
riconosce i vantaggi in termini di
comfort e utilit ma quel che
pi conta che molti sono colo-
ro che ne sono convinti ma non
hanno la sufficiente conoscenza
delle possibilit e modalit di
realizzazione.
un fattore importante perch
ci presenta un settore ancora in
una fase di crescita, dove lin-
teresse alto e le motivazioni si
basano su richieste concrete (ri-
sparmio, comfort per chi usu-
fruisce del sistema - telecon-
trollo, manutenzione preventi-
va e crescita professionale per i
realizzatori dello stesso).
IMPIANTI DOMOTICA E DINTORNI
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 75
LOMBARDIA (MI-CO-LC-SO-VA-PV-LO-MN + PC)
BIEFFE S.a.s.
Via Mazzini, 70/s - 20056 Trezzo sullAdda MI
Tel. 02 90963740 - Fax 02 90964607
E-mail: info@agenziabieffe.com
LOMBARDIA (BG-BS-CR)
B & C S.r.l.
Via Esterna del Molino, 7 - 24040 Stezzano BG
Tel. 035 4540943 - Fax 035 4379563
E-mail: info@bcrappresentanze.com
VENETO e T.A.A.
ELSYSTEM S.a.s.
Via delle Industrie, 13 - 35010 Limena PD
Tel. 049 8843059 - Fax 049 8843060
E-mail: info@elsystemsas.com
FRIULI V.G.
TECNOMEDIA S.r.l.
Via IV Novembre, 66 - 33010 Tavagnacco UD
Tel. 0432 575584 - Fax 0432 689223
E-mail: info@tecnomediasrl.it
PIEMONTE (NO-VB)
BIEFFE S.a.s.
Via Mazzini, 70/s - 20056 Trezzo sullAdda MI
Tel. 02 90963740 - Fax 02 90964607
E-mail: info@agenziabieffe.com
PIEMONTE (TO-CN-AT) e VAL DAOSTA
ELETTRO 2000 S.a.s.
Via Fabbrichetta, 16 - 10096 Collegno TO
Tel. 011 4157791 - Fax 011 4044212
E-mail: info@elettro2000.info
LIGURIA
BMT S.a.s
Via Curtatone, 26/R - 16122 Genova GE
Tel. 010 8376246 - Fax 010 814532
E-mail: bmt@bmtge.it
EMILIA ROMAGNA
COMEA SERVICE S.n.c.
Via del Fonditore, 2/3 C - 40138 Bologna BO
Tel. 051 6012366 - Fax 051 6011094
E-mail: info@comea.it
TOSCANA
CIPRIANI RAPPRESENTANZE S.r.l.
Via Goffredo Mameli, 11 - 50020 Cerbaia FI
Tel. 055 826303 - Fax 055 825146
E-mail: ciprianirap@bcc.tin.it
UMBRIA
2RP S.a.s.
Via del Rivo, 138 - 05100 Terni TR
Tel. 0744 305105 - Fax 0744 305110
E-mail: rapaccin@tin.it
LAZIO
PALMIERI ROBERTO RAPPRESENTANZE IND.
Via della Palmarola, 201 - 00135 ROMA RM
Tel. 06 30959567 - Fax 06 30959567
E-mail: palmieri.ro@tiscali.it
ABRUZZO e MOLISE
VENDITTI S.n.c.
Via F. Barnabei, 14 - 65126 Pescara PE
Tel. 085 61359 - Fax 085 694998
E-mail: vendittia@tin.it
MARCHE
ELETTRORAPPRESENTANZE AN S.a.s.
Via N. Abbagnano, 10 - 60019 Senigallia AN
Tel. 071 7931229 - Fax 071 7913782
E-mail: elettroinsnc@libero.it
CAMPANIA + POTENZA
RELECOM S.r.l.
Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081 8424081 - Fax 081 8420455
E-mail: relecom@tin.it
PUGLIA + MATERA
PERGOLA ELETTRORAPPRESENTANZE
Via A. Volta, 20/A - 70027 Palo del Colle BA
Tel./Fax 081 3811901 (Pergola Paolo)
Tel./Fax 081 5304625 (Pergola Luigi)
E-mail: pergola.paolo@tiscali.it
CALABRIA
FREGOLA RAPPRESENTANZE S.a..s.
Via Conti di Loritello, 7/B - 88100 Catanzaro CZ
Tel. 0961 62883 - Fax 0961 760259
E-mail: fregolaluigi@libero.it
SICILIA
RUSSO ORAZIO RAPPRESENTANZE IND.
Via L. da Vinci, 8 - 95030 S. Agata li Battiati CT
Tel. 095 212945 - Fax 095 213699
E-mail: ecfner@tin.it
SARDEGNA
SILUX S.a.s.
Via San Tommaso dAquino, 17 - 09134 Pirri CA
Tel. 070 506675 - Fax 070 506337
E-mail: pietrosergi@tin.it
CON.TRADE
S.r.l.
Via Depretis, 11 - I - 24124 BERGAMO
Tel. 035 361 035 - Fax 035 361 025
info@con-trade.com - www.con-trade.com
L 25/100
L 2/20
IL 1/10 2P
sales net
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
9
5
Figure 13 e 14 -
Sul display
possibile vedere lo
stato dei sensori
1. S, le ho provate
personalmente e
ne sono convinto 34,88%
2. S, ma vorrei
saperne di pi 55,04%
3. No, dalla mia
esperienza non
cos 4,65%
4. Non sono al
corrente
dellargomento 5,43%
(fonte:http://www.elettronet.it/commu-
nity/Sondaggio/SondaggioRisultati.asp?ID-
Sondaggio=47 21/06/2004 ore 16,00)
G
razie alla trasmissione radio
Logisty (www.logisty.com)
propone prodotti non sol-
tanto ad alta affidabilit, ma anche
semplici da installare e facili da
usare. Tutti gli elementi possono es-
sere collocati dove risultano esse-
re pi efficaci - in modo rapido,
fissandoli semplicemente al muro
senza bisogno di mettere a soq-
quadro la casa - e sono integrabi-
li in qualsiasi momento.
I collegamenti si effettuano attra-
verso trasmissioni radio codificate
senza alcun collegamento filare
alla rete elettrica; pertanto Logisty
ignora le sovratensioni, le corren-
ti parassite e i fulmini, che sono cau-
sa spesso di falsi allarmi, e non
teme black-out
I prodotti garantiscono laffidabilit
grazie anche alle trasmissioni radio
garantite e qualificate, quali la
Doppia frequenza, Twin Band.
Ogni apparecchiatura dotata di
pile professionali al litio, che per-
mettono unautonomia di 4 anni;
inoltre, tutti i prodotti sono ga-
rantiti fino a 5 anni.
UNA LINEA PER TUTTI
GLI AMBIENTI
Logisty Expert la linea allarme na-
ta per dare una soluzione alle in-
stallazioni risultano pi complesse
e articolate, offrendo il massimo sup-
porto tecnico al lavoro dellinstal-
latore e nella fase di successiva
assistenza. Senza fili e senza col-
legamenti alla rete elettrica, per-
mette di integrare o spostare in
qualsiasi momento e con estrema
rapidit le apparecchiature del-
limpianto. Linstallazione avvie-
ne in tempi brevissimi, senza rom-
pere i muri o spostare i mobili.
La centrale in sintesi vocale bre-
vettata con la tecnologia di tra-
smissione TwinBand che preve-
de la trasmissione e ricezione del-
le segnalazioni su due per ogni
bande distinte (434 e 868) di tra-
smissione. Il disturbo eventuale
su una delle due frequenze non
impedisce allinformazione di arri-
vare; Twin Band porta
quindi unelevata affi-
dabilit della trasmis-
sione in ogni situazione,
qualunque sia lam-
biente radioelettrico e le
sue eventuali evoluzio-
ni nel tempo. Oltre alla
affidabile tecnologia
TwinBand, la linea Lo-
gisty Expert vanta un
altro brevetto: il siste-
ma di alimentazione
TwinPower, basato sul-
lutilizzo di un blocco
dalimentazione con-
tenente due pile, una di sup-
porto allaltra. La centrale inoltre im-
piega un sistema di protezione dei
comandi chiamato rolling code.
Il centro decisionale dellimpianto
la centrale che riceve le infor-
mazioni provenienti dai rivelatori
dintrusione e dalle altre apparec-
chiature del sistema.
La centrale S303-22I incorpora la si-
rena, la tastiera e nel modello S310-
22I anche il combinatore telefoni-
co. Ha la capacit di gestire fino a
40 rivelatori singolarmente iden-
tificabili su 3 zone (3 gruppi) to-
talmente indipendenti, 10 organi di
comando (telecomando e tastie-
re), 5 sirene. Ogni dieci minuti ri-
ceve una segnalazione di buon
funzionamento da ogni apparec-
chiatura dellimpianto. Nel caso
in cui non riceva la segnalazione pre-
vista, la centrale segnala lano-
malia dopo due ore al combinato-
re telefonico, se ne fornita, altri-
menti localmente. Ha unautonomia
di quattro anni cos calcolata: 20 ac-
censioni e spegnimenti al giorno del-
limpianto, 20 cicli dallarme al-
lanno della durata di 90 secondi cia-
scuno, sia delle sirene sia del com-
binatore telefonico; 200 attivazio-
ni al giorno dei rivelatori; la centrale
inoltre memorizza gli ultimi venti
eventi, con data e ora ed dotata
di una scheda di memoria amovi-
bile per la salvaguardia della pro-
grammazione. La programmazio-
ne delle apparecchiature avviene
tramite autoapprendimento: ogni
elemento possiede un codice radio,
attribuito in fabbrica e non modi-
ficabile. Cos permette lappren-
dimento delle singole apparec-
chiature da parte della centrale, con
unoperazione semplice e rapida.
LEVOLUZIONE
DELLA LINEA
Nella linea Logisty Expert sono
da segnalare il rivelatore Specia-
le per animali e i telecomandi in
miniatura bianchi a due e a quat-
tro pulsan-
ti. Il rivela-
tore Spe-
ciale per
ani mal i
S131- 22I
assicura la
protezione
dei locali in
presenza
di animali
domestici.
Il prodot-
to, distin-
g u e n d o
fra un essere
umano e un
cane o un
gatto, per-
mette la pre-
senza di un
animale, per
un peso fino a 25 kg, in un locale ad
impianto attivato. La sua rivela-
zione indirizzabile verso tre zone
indipendenti ed il montaggio pu
essere a parete, ad angolo o con sno-
do auto bloccante. La sensibilit del-
la rivelazione programmabile al
primo o al secondo movimento;
inoltre il prodotto dotato di pul-
sante test e spia luminosa, che
permettono: la programmazione
delle opzioni di funzionamento, la
visualizzazione della zona protet-
ta, la verifica del buon funziona-
mento, del collegamento con la
centrale e della corretta program-
mazione.
Il prodotto si avvale della tecnolo-
gia brevettata Animal Sense che
analizza i segnali secondo due cri-
teri principali: uno di localizzazio-
ne in base allaltezza, in quanto
un animale si muove pi vicino al
suolo rispetto ad un uomo, laltro
di temperatura, essendo il calore
emesso da un animale pi omo-
geneo rispetto a quello di un essere
Una linea di allarmi wireless e
senza collegamenti alla rete elet-
trica - dedicata ai locali del resi-
denziale e del terziario - non te-
me black out ed immune da
falsi allarmi
Senza fili meglio
A cura di
Alessandra Lucaccini
SOLUZIONI
76
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
F
o
t
o
:
E
n
s
t
o
La centrale S303-22I della linea
Logisty Expert
Il trasmettitore
universale stagno
S230-22X
umano. La qualit del prodotto as-
sicurata inoltre dalla tecnologia
radio ultra-affidabile TwinBand,
dove la doppia frequenza opera
su due bande, aumentando in mo-
do esponenziale la sicurezza.
Lapparecchiatura autoprotetta
contro lapertura e il distacco da pa-
rete e trasmette alla centrale il se-
gnale di supervisione ogni dieci
minuti informando sullo stato di ca-
rica della batteria e dellautopro-
tezione. I telecomandi portachiavi
dalle dimensioni ridotte possono es-
sere utilizzati in numero illimitato,
anche in presenza di tastiere a co-
dice segreto. Si programmano in mo-
do digitale tramite pulsanti di cui
sono muniti e vengono utilizzati per
comandare limpianto sia dallinterno
sia dallesterno dei locali protetti;
hanno una portata di 15-30 metri
e sono dotati di una spia luminosa
che segnala il funzionamento e il
buono stato delle pile.
Il telecomando S612-22X corredato
di due pulsanti con funzioni indi-
pendenti: spento, acceso parziale
o acceso totale, mentre il teleco-
mando S614-22X munito di 4
pulsanti con 4 funzioni diverse:
spento, acceso parziale, acceso to-
tale e pulsante programmabile per
emergenza, chiamata, antirapina,
acceso presenza.
LA SICUREZZA
VERSO LA DOMOTICA
Negli ultimi anni sicurezza e do-
motica si stanno integrando sem-
pre pi, al fine di trovare soluzio-
ni sempre pi sicure e confortevoli.
Fra le tante novit della linea Lo-
gisty Expert, uninnovazione in-
teressante consiste nelle appa-
recchiature che, oltre ad assicu-
rare la protezione degli edifici, so-
no capaci di rilevare altri rischi
che si possono presentare negli
ambienti domestici. Un esempio
il rivelatore ottico di fumo (S150-
22X) che, in presenza di una de-
terminata quantit di fumo, invia
la segnalazione dallarme alla cen-
trale. attivo ventiquattro ore su
ventiquattro anche ad impianto
dallarme spento e si installa a sof-
fitto, in cantine, solai, taverne, lo-
cali caldaia, cucine o in tutti i locali
con strutture prevalentemente o
completamente in legno. Sicura-
mente interessante anche il nuo-
vo trasmettitore universale sta-
gno (S230-22X), che pu essere
utilizzato in qualsiasi esigenza,
anche diversa dalla protezione dal-
le intrusioni, come allarme antin-
cendio, come allarme tecnico o per
rilevare lo stato del sistema ed al-
tre funzioni ancora, in base al col-
legamento effettuato degli ingressi.
Il prodotto dispone di due ingres-
si: il primo per sensori e contatti
esterni NA-NC di tutti i tipi in com-
mercio, il secondo per son-
de tecniche.
I sensori disponibili Lo-
gisty sono: rivelatore per
avvolgibili a fune, rivelatore
piezoelettrico rottura ve-
tri, contatto magnetico,
sonde tecniche. Poich
stagna, lapparecchiatu-
ra pu essere installata
in ambienti o condizioni cli-
matiche particolari. Le
sonde tecniche consento-
no di proteggere la casa
contro i rischi pi frequenti
di incidenti domestici qua-
li: abbassamenti della tem-
peratura per rotture o mal-
funzionamenti caldaie, alla-
gamenti per rottura o malfunzio-
namento pompe e scarichi, anomalia
temperatura del congelatore per
malfunzionamenti o mancanza re-
te, mancanza rete elettrica per
lunghi periodi, con conseguente
danneggiamento di apparecchia-
ture delicate (frigoriferi, acquari
ecc.). La sonda di rilevazione man-
canza rete SONCS dotata di pre-
sa passante e pu programmare lin-
vio di segnalazione dopo 18 mi-
nuti o 5 ore di assenza rete. La
sonda di rilevazione temperatura
di congelamento SONGH, ad attacco
magnetico, invia la segnalazione
quando la temperatura scende al
di sotto dei +5 C. La sonda di ri-
levazione allagamento, ad attacco
magnetico, pu regolare la rileva-
zione da un minimo di 2 mm di
acqua. La sonda anomalia conge-
latore SONPC, inserita diretta-
mente nel congelatore, invia la se-
gnalazione quando la temperatu-
ra sale sopra i -12C. Da segnala-
re anche il ricevitore interfaccia
autonomo ad 8 uscite S710-22X, che
permette di interfacciare sistemi fi-
lari, combinatori e ponti radio, ri-
cevendo via radio messaggi dalla
centrale o da altre apparecchia-
ture Logisty e attivando contatti du-
scita. Abbinato ad un combinato-
re telefonico Gsm Logisty, per-
mette una totale autonomia dalla
rete elettrica. Dispone di 8 uscite
a rel totalmente programmabili per
ricevere segnali direttamente dal-
la centrale del sistema, rivelatori,
comandi. I contatti sono disponibili
su morsetti a vite. Lapparecchia-
tura pu essere installata in posi-
zioni riparate sia allinterno, sia
allesterno, ed autoprotetta al-
lapertura. Lalimentazione pu es-
sere a 1 pila al litio 7,2v 13Ah-Bat-
Li02 o alimentazione esterna in
continua 12V. Per concludere, il ri-
velatore di movimento stagno vo-
lumetrico (S141-22X) o a tenda
(S143-22X) a infrarossi passivi
utilizzabile in situazioni ambien-
tali critiche o estreme (serre, loca-
li piscina ecc.) dove il tasso di umi-
dit pu oscillare tra il 70 e l80 % e,
con estrema cautela, pu essere
usato anche allesterno. Dotata di
snodo orientabile autobloccante,
per una pi sicura ed efficace pro-
tezione, in abbinamento ad un ri-
cevitore pu essere utilizzato anche
per comandare automaticamente
laccensione di luci esterne o altri ca-
richi elettrici.
servizio lettori 101
SOLUZIONI SENZA FILI MEGLIO
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 77
Logisty un marchio Atral, specialista in sistemi dallarme
e tecnologie senza fili.
Ha lanciato i sistemi di allarme totalmente wireless, af-
fermandosi in poco tempo come esponente di punta di que-
sto settore.
Logisty offre una gamma di prodotti frutto di una costante
evoluzione, basata sulla forte esperienza nei diversi
campi di applicazione: dagli impianti dallarme senza fi-
li, con le linee Logisty2 e LogistyExpert, i combinatori te-
lefonici, il sistema citofonico senza fili Logico.
v
i
s
t
i
d
a
v
i
c
i
n
o
Chi Logisty
I telecomandi S612-22X a 2
pulsanti e S614-22X a 4 pulsanti
Il rivelatore speciale per animali
S131-22I
Rivelatore
di movimento
stagno
volumetrico
Domotica senza fili via
televisione e cellulare
Totalmente senza fili
Interfaccia visiva sul TV
Tutto con un solo telecomando
Comandi via radio
Comandi via GSM
32 apparecchiature comandabili
Segnali di allarme sul TV
e sul cellulare
Conferma comando avvenuto
sul TV e sul cellulare
A
r
e
a
Tel. 0438.388511 - Fax 0438.388536
www.telecoautomation.com - www.tvlink.it
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
2
3
L
obiettivo del seguente
articolo quello di espor-
re unanalisi di calcolo
delle fasce di rispetto relative
alle emissioni di campo elettrico
e magnetico a 50 Hz, presso un
elettrodotto a 132 kV situato in
Emilia Romagna.
La specificazione della regione
non affatto ininfluente come
pu sembrare, in quanto nei va-
lori limite delle emissioni di cam-
po elettromagnetico, esiste tut-
tora unintersezione, non anco-
ra risolta, fra la normativa na-
zionale e quella regionale.
A questo scopo occorre effet-
tuare una breve premessa ri-
chiamando quelli che sono i ri-
mandi legislativi.
RIFERIMENTI
LEGISLATIVI
A livello nazionale, la legge n 36
22/2/01 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici) demanda ad
un apposito Decreto attuativo
la fissazione dei limiti di espo-
sizione per la popolazione. Que-
sto decreto stato emanato nel
luglio 2003 (D.P.C.M. 8/7/03:
Fissazione dei limiti di esposi-
zione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualit per la pro-
tezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e ma-
gnetici alla frequenza di rete (50
Hz) generati dagli elettrodotti)
e presenta i limiti riportati in
tabella 1.
LE LEGGI REGIONALI
DELLEMILIA ROMAGNA
Dallarticolo 13 della Legge Re-
gionale 31/10/00 n 30 della Re-
gione Emilia - Romagna (Norme
per la tutela della salute e la
salvaguardia dellambiente dal-
linquinamento elettromagneti-
co), si evince che gli strumenti
urbanistici devono assicurare
con riferimento agli impianti di
cui al comma 1 che si realizzi il
perseguimento dellobiettivo di
qualit di 0.2 micro Tesla (uT) di
induzione magnetica valutata
al ricettore in prossimit di asi-
li, scuole, aree verdi attrezzate
e ospedali nonch edifici adibi-
ti a permanenza di persone non
inferiore a quattro ore giorna-
liere. Il perseguimento del valore
di qualit deve essere realizza-
to attraverso gli strumenti ur-
banistici sia per le nuove co-
struzioni nei confronti delle linee
e degli impianti esistenti sia per
i nuovi impianti nei confronti
delle costruzioni esistenti.
Larticolo 15 recita: I Comuni, con
le procedure previste per la lo-
calizzazione delle opere pubbli-
che, adeguano la pianificazione
urbanistica individuando prio-
ritariamente le fasce di rispetto
di cui al comma 4 dellarticolo 13.
Con tale adeguamento indivi-
duano, altres, le linee e gli im-
pianti in esercizio che superano
il valore di 0.5 micro Tesla (uT)
di induzione magnetica misura-
to al ricettore sulla base delle co-
municazioni degli enti gestori
delle reti di trasmissione e dis-
tribuzione di energia elettrica....
Con la delibera di Giunta n 197
20/2/01 - Direttiva per lappli-
cazione della Legge Regionale
31/10/00 n 30 - stata fornita
la seguente interpretazione del-
la L.R. 30/00 (da articolo 13 com-
ma 1): il valore di 0.2 uT un
obiettivo di qualit da perse-
guire attraverso gli strumenti
urbanistici, mentre in partico-
lari aree di espansione con pia-
ni attuativi gi approvati o aree
Calcolo del campo elettrico e
magnetico a 50 Hz nei pressi
di un elettrodotto a 132 kV
Fasce di rispetto:
un fattore regionale
Daniela Di Cola
78
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
ON-LINE
TABELLA 1 - LIMITI DI ESPOSIZIONE
Frequenza 50 Hz Intensit di campo Induzione Magnetica
elettrico E (kV/m) B (T)
Limite di esposizione *
(da non superare mai)
Valore di attenzione **
(da non superare in ambienti
abitativi e comunque nei luoghi - 10
adibiti a permanenze non
inferiori a 4 ore)
Obiettivo di qualit **
(da non superare per i nuovi
elettrodotti o le nuove abitazioni - 3
in prossimit di elettrodotti
esistenti)
Note:
* Valori efficaci
** Media dei valori nellarco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio
5 100
Nei valori
limite delle
emissioni di campo
elettromagnetico, esiste
tuttora unintersezione
fra la normativa
nazionale e quella
regionale
di completamento gi dotate del-
le opere di urbanizzazione, che ri-
sultino in prossimit di impianti gi
esistenti..., ...si ritiene opportuno
che gli 0.5 uT rappresentino lo-
biettivo minimo di qualit da per-
seguire. Tale valore, sino a di-
versa determinazione statale, va
valutato sulla base del valore del-
la corrente media annua di eser-
cizio riferita allanno precedente
incrementata del 5%, ovvero del
50% della corrente massima di
esercizio normale, qualora pi
cautelativo, tenuto anche conto dei
programmi di sviluppo degli eser-
centi.
La corrente massima di esercizio
normale la corrente che pu es-
sere sopportata da un conduttore
per il 100% del tempo con limi-
ti accettabili del rischio di scarica
e dellinvecchiamento.
Si distingue dalla portata nomi-
nale della linea che ha un puro
valore convenzionale (Punto 3.1
della norma Cei 11-60, 2^ ed.).
Quindi il valore di 0.2 uT va con-
siderato come limite per le nuo-
ve costruzioni, mentre per gli
ampliamenti e le ristrutturazio-
ni bisogna considerare il limite
di 0.5 uT. La stessa delibera in-
dividua in 30 metri la dimensione
delle fasce laterali di rispetto per
lindividuazione di potenziali re-
cettori con esposizione superiore
a 0.5 uT (con elettrodotti a 132 kV
a singola terna). Allinterno di
questa fascia di rispetto ne-
cessario fare quindi il calcolo con
la corrente suddetta.
METODOLOGIA
UTILIZZATA
PER IL CALCOLO
Il primo passo il reperimento
dei dati della linea forniti dal ge-
store e calcolati.
Lesempio riguarda una linea pri-
maria a terna singola, in servizio
con una tensione nominale di 132
kV ed equipaggiata da tre con-
duttori di alluminio/acciaio del
diametro di mm 19,4 e da una
fune di guardia di diametro mm
13,10. Il parametro di posa (o
parametro della catenaria) :
C
0
= 1250 (C
0
= tiro (N)/peso
(N/m) = T
0
/P) (dati forniti dal
gestore)
La distanza fra due tralicci di
255 m. Utilizzando lo sviluppo in
serie del coseno iperbolico, nel-
larco compreso tra i due tralic-
ci la catenaria approssimata dal-
lequazione della seguente para-
bola:
Y = X
2
/ (2 C
0
) = 0,0004 X
2
In un sistema cartesiano orto-
gonale X, Y con lorigine coinci-
dente con il vertice della parabola
(questo sistema di coordinate
X;Y diverso da quello usato in
seguito x,y,z).
E la freccia risulta:
ON-LINE FASCE DI RISPETTO: UN FATTORE REGIONALE
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 79
TABELLA 2 - COORDINATE DEI TRALICCI
Tralicci z (m) x (m) Param posa cavi
C
0
(m)
A 0 0 1250
B 255 0 1250
Figura 1 - Significato della formula f = D
2
/(8 C
0
)
Figura 2 - Profilo campata
viale G. Richard 1/a - 20143 Milano - tel. 02 81830.1 - fax 02 81830.406 - www.reedbusiness.it - info@reedbusiness.it
noi non diamo
i numeri...
...li certifichiamo tutti.
Le riviste di Reed Business Information raggiungono i lettori
pi qualificati e sono sottoposte a certificazioni che garan-
tiscono alle aziende inserzioniste la quantit delle copie
diffuse. La certificazione svolta dal CSST-
Certificazione Stampa Specializzata e Tecnica. Comunicate con noi
f = D
2
/ (8 C
0
) = 6,5 m
il cui significato geometrico in-
dicato nello schema di figura 1.
Con questi presupposti e utiliz-
zando il prospetto del traliccio for-
nito dal gestore, il profilo della
linea quello illustrato in figu-
ra 2.
Sullasse delle ascisse (z) vi la
distanza dal traliccio pi vicino
(nel seguito indicato come tra-
liccio A), presa sullasse della li-
nea mentre sullasse delle or-
dinate (y) vi laltezza rispet-
to al terreno. C1, C2 e C3 sono
i tre conduttori, G la fune di
guardia.
Il secondo parametro la corrente
massima di esercizio normale,
determinata seguendo il proce-
dimento indicato al punto 3.1
della norma Cei 11-60, 2^ ed.
fasc. 6507.
Poich la normativa differenzia
tra periodo caldo e periodo fred-
do si ottengono due risultati
per la corrente massima di eser-
cizio normale: I = 305,0 A nel
periodo caldo e I = 358,0 A nel
periodo freddo. A livello
cautelativo viene utiliz-
zata la corrente relativa al
periodo freddo e quindi
la simulazione software
stata effettuata con i
seguenti valori:
I = 358 A
legge nazionale
I = 50 % 358 A = 179 A
legge regionale
Il campo elettrico e ma-
gnetico sono invece stati
determinati seguendo il
metodo indicato nella Gui-
da Cei 211-4 1996-07 ai
punti 4.2 e 4.3.
DATI
DEI CONDUTTORI
E DEI TRALICCI
Si considerato un si-
stema di riferimento di
assi cartesiani ortogona-
li x,y, z, con origine (0,0,0)
situata sulla proiezione del-
lasse del traliccio A sul terreno
dove:
z la direzione della linea, va-
le 0 m nel traliccio A e 255 m nel
traliccio B;
x la distanza in orizzontale dal-
la linea dellelettrodotto, e va-
le 0 m in corrispondenza della
fune di guardia;
y laltezza rispetto al terreno
e vale 0 m a terra.
I tralicci sono uguali e hanno le
coordinate di tabella 2 mentre i
conduttori hanno i parametri ri-
assunti in tabella 3.
RISULTATI
DELLE SIMULAZIONI
PER LA NORMATIVA
NAZIONALE
La simulazione si svolta con
queste caratteristiche:
- altezza recettore 4,5 m - se-
condo piano abitativo;
- corrente I = 358 A;
- posizione relativamente alla
campata: met campata z =
127,5 m.
I risultati delle simulazioni sono
riportate nelle figure 3 e 4.
RISULTATI
DELLE SIMULAZIONI
PER LA NORMATIVA
REGIONALE
La simulazione si svolta con
queste caratteristiche:
- altezza recettore 4,5 m - se-
condo piano abitativo;
- corrente I = 179 A;
- posizione relativamente alla
campata: met campata z =
127,5 m.
I risultati delle simulazioni sono
riportate nelle figure 5 e 6.
CONCLUSIONI
A met campata z = 127,5 m,
per la legge nazionale vengono
raggiunti i valori:
10 micro T a X = - 6,5 m e a X
= + 3 m
3 micro T a X = - 14 m e a X =
+ 12.5 m
Sempre a met campata z = 127,5
m, per la legge regionale vengono
raggiunti i valori:
0,5 micro T a X = - 25 m e a X
= + 23 m
0,2 micro T a X = - 39 m e a X
= + 38 m
Quindi la legge regionale del-
lEmilia Romagna estrema-
mente pi cautelativa di quella
nazionale.
80
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
ON-LINE FASCE DI RISPETTO: UN FATTORE REGIONALE
Figura 4 - Campo elettrico - nazionale
Figura 5 - Campo magnetico - regionale Figura 6 - Campo elettrico - regionale
Figura 3 - Campo magnetico - nazionale
TABELLA 3 - PARAMETRI DEI CONDUTTORI
Per z = 0 m
e z = 255 m
Conduttori x (m) y (m) Diametro Fase () Corrente norm. Corrente norm.
e fune (mm) Regionale Nazionale
di guardia (A) (A)
C1 -4,45 15,2 19,4 240 179 358
C2 +3,5 17,45 19,4 120 179 358
C3 -3,45 19,7 19,4 0 179 358
G 0 23,2 13,1 0 0 0
: la soluzione
intelligente per la partenza
motore
www.moeller.net
www.moeller.it
Moeller Electric S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 43 - 20090 Rodano MI
Tel. 02.95950.1 - Fax 02.95950.400
e-mail: info.@moeller.it - Internet: http://www.moeller.it
Moeller mi aiuta a ridurre notevolmente
i miei costi di progettazione e di
installazione.
Think future. Switch to green.
Una gamma completa
per realizzare partenze
motore. Protezione
e comando in un sistema
semplice ed efficiente.
Contattori di
potenza DIL
Interruttori
protettori PKZ
Partenze motore
complete MSC
Da oltre 100 anni, Moeller partner competente
dellindustria, sempre allavanguardia con soluzioni
uniche e innovative.
la nuova gamma Moeller per il comando,
la protezione e lavviamento di motori elettrici.
Progresso e innovazione sono con assicurati
dalla progettazione, fino al montaggio e
allinstallazione.
Affidatevi alla competenza di Moeller per ogni
applicazione ed esigenza.
w
w
w
.
e
m
p
e
r
.
n
e
t
servizio lettori 1789
Con lultimo catalogo
FANTASY LIGHTS 2004, ARTELETA propone
un vasto assortimento di prodotti professionali
dedicati allesterno, pensati appositamente per linstallatore
professionale. Ci significa osservanza delle normative europee
vigenti e installazione semplice, ma al tempo stesso veloce, sicura
e di effetto. Sono tutti prodotti pensati e realizzati per decorare
illuminando strade, palazzi, giardini, attivit commerciali.
Oltre alloramai conosciutissimo tubo luminoso, e ai numerosissimi
soggetti realizzati con il tubo; particolare attenzione meritano le
tende, ideali per la decorazione di palazzi; le reti per creare tetti di
luce; e la nuova caduta pioggia, lunica sul mercato estendibile
e che consente di realizzare bellissime atmosfere invernali.
Vinvitiamo a consultare il nostro catalogo per scoprire un nuovo
modo di decorare con la luce.
La qualit si mette in luce.
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Pellizza da Volpedo 57
Tel. 02/66013541 r.a. - Fax 02/6122573 - E-mail: info@arteleta.it
B
r
i
e
f
i
n
g
Decorare con la luce.
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
8
1
La tecnologia mi-
gliora la qualit del-
la vita, penetra tra
le mura domestiche e
rivoluziona le abitu-
dini quotidiane della
gente. Dagli elettrodomesti-
ci intelligenti ad alta effi-
cienza allimpianto anti-in-
trusione, dalle fughe di gas al
telesoccorso con la domoti-
ca la casa diventa un luogo
sempre pi sicuro e confor-
tevole.
Queste le tematiche che sono
state al centro di un riuscito
incontro tecnico di installatori
e progettisti elettrici che si
tenuto nel moderno Centro
Tecnofin di Rovereto (Trento).
A
llapertura dei lavori,
Carlo Toffolon ha ri-
cordato come l'inizia-
tiva, che aveva lo scopo di pro-
muovere la sicurezza ed il ri-
sparmio energetico, sia nata
dalla collaborazione dellAlbo
Installatori Unae Trentino con
Aspe, Trentino Servizi, Univer-
sit e Associazione Industriali
di Trento.
Alla riunione era presente anche
lAssessore allEnergia di Pat -
Ottorino Bressanini - che ha sot-
tolineato in particolare limpor-
tanza del risparmio energetico
per i suoi positivi riflessi eco-
nomici e ambientali.
Dopo una breve introduzione
sulla prossime novit del mercato
libero dellenergia per le picco-
le imprese, qualificati relatori
hanno illustrato i vantaggi dei
nuovi contatori elettronici che
creano le condizioni per un mi-
glior utilizzo dellenergia elettrica
nelle abitazioni e le ultime novit
domotiche sulla sicurezza do-
mestica con particolare riferi-
mento al telesoccorso per le
persone bisognose di assisten-
za e disabili.
In conclusione del convegno
Renza Pecoraro - dellEdilizia
Abitativa - ed Elena Robecchi De-
fant - Presidente Itea - hanno il-
lustrato gli aspetti legislativi
del pacchetto domotico LP 16/90
ed alcune significative realiz-
zazioni abitative con soluzioni
domotiche effettuate a Trento
da Itea.
COMITATO SCIENTIFICO
Rino Anelli, Giuseppe Bosisio, Le-
vio Bottazzi, Pasquale Chiovaro, Car-
lo DAmici, Michele Dragagna,
Giuseppe A. Ferretti, Luciano
Gaia, Abele Gobbo, Luigi Paleari,
Francesco Pozzana, Pasquale Pu-
gliese, Antonio Serafini, Pierfran-
cesco Sodini, Franco Stella
COMITATO DI REDAZIONE
Rino Anelli, Manuela Battagli-
no, Giovanni Danielli
A CURA DI
Manuela Battaglino
(manuela.battaglino@
reedbusiness.it)
SEGRETERIA NAZIONALE
Via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Tel. 02-21597248
Fax 02-21597248
(info@unae.it)
Istituto Nazionale
di Qualificazione
delle Imprese
di Installazione dImpianti
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 83
Con la domotica
la casa diventa
intelligente
pagina 84
QUALIFICAZIONE
Qualificazione imprese
appaltatrici
pagina 86
ADDESTRAMENTO
Teoria e pratica per i
giunti
La sala del Centro Tecnofin dove
si svolto il convegno
84
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
N
ellambito della pro-
gressiva terziarizza-
zione delle proprie at-
tivit, Enel sta adottando un
nuovo sistema di qualificazione
delle proprie imprese appalta-
trici, che a partire dal 1 ottobre
2004 prevede gare di appalto da
effettuarsi utilizzando esclusi-
vamente le imprese a cui verr
riconosciuta da Enel S.p.A. la
nuova qualificazione.
Le Imprese interessate ad essere
inserite nellelenco delle im-
prese qualificate di Enel S.p.A.
devono dimostrare il possesso
di determinati requisiti.
Nello specifico, la suddetta qua-
lificazione subordinata al pos-
sesso:
1.della Certificazione del Si-
stema di Qualit aziendale, se-
condo la Norma Uni En Iso
9001: 2000 (Vision);
2. di disponibilit di risorse pro-
fessionali specifiche (in fun-
zione dei comparti di quali-
ficazione e delle classi di im-
porto degli appalti) formate da
Organismi di Formazione Ri-
conosciuti.
In merito al punto 1, la certifi-
cazione di qualit per le im-
prese interessate non sar so-
lo un prerequisito per poter ac-
cedere alle gare di appalto di
Enel, ma unopportunit di
crescita culturale e professionale,
che fornir, alle Imprese stesse,
gli strumenti e le competenze
per gestire il proprio business
con pi efficienza.
Unae, allo scopo di fornire alle
aziende associate i servizi in-
novativi richiesti dal mercato, ha
avviato una collaborazione con
alcune societ di consulenza
specializzate nella certificazio-
ne di qualit, che potr prepa-
rare le aziende alla certifica-
zione del sistema di qualit da
parte dellEnte Terzo accreditato.
In merito al punto 2, Unae Na-
zionale, poich ha conseguito
dallistituto Quaser la certifi-
cazione per la Progettazione ed
erogazione di attivit formati-
ve - EA 37 in conformit alla
Norma Uni En Iso 9001:2000,
organizza a livello periferico
corsi di formazione necessari
a conseguire lAttestato di ido-
neit conforme alla nuova nor-
mativa degli appalti Enel.
In merito al nuovo sistema di
qualificazione delle imprese in-
teressate a partecipare agli ap-
palti Enel, emesso in Specifi-
ca Enel Acqui sti i n data
21/7/2003, nellambito dello svi-
luppo del programma di forma-
zione sulle materie che costi-
tuiscono i cosiddetti profili pro-
fessionali Enel, Unae ha isti-
tuito - in collaborazione con gli
Albi Regionali - dei corsi di for-
mazione professionale per le im-
prese appaltatrici che operano
sulla rete elettrica di distribu-
zione pubblica in media e bas-
sa tensione.
I corsi, interamente progettati
da Unae Nazionale, si riferi-
scono ai seguenti profili pro-
fessionali:
- C, Preposto alla conduzione di
attivit lavorative su impian-
ti elettrici di distribuzione MT
e BT (Capo Squadra);
- D, Tirafili (Tesatore, Amarra-
gista, Guardafili; AT-MT-BT);
- E, Operatore esperto nella
esecuzione di giunti e termi-
nazioni su cavi aerei o inter-
rati a media e bassa tensione;
- F, Operatore addetto al mon-
taggio di cabine secondarie e po-
sti di trasformazione su palo;
- G, Operatore addetto ad at-
tivit sottotensione.
Liniziativa stata sollecitata dal-
lesigenza delle imprese asso-
ciate Unae di poter accedere
agli appalti Enel Distribuzio-
ne, a seconda della classe di
importo dellappalto in que-
stione, con un numero ben de-
finito di addetti qualificati, co-
me indicato nella tabella 1.
Il primo corso certificato da
Quaser, istituto di certificazio-
ne Sincert, stato quello rela-
tivo al profilo E di Operatore
Esperto nella esecuzione di
giunzioni e terminazioni di ca-
vi MT e BT, che si svolto a Bo-
logna nel mese di giugno, or-
ganizzato dallAlbo Emilia Ro-
magna, ed ha visto la parteci-
pazione di 4 imprese con 12 di-
scenti.
Nei mesi di giugno-luglio, in
Qualificazione imprese
appaltatrici
Unae con la ISO 9001 (Vision 2000) istituto di formazione per i corsi
alle imprese che accedono agli appalti Enel
QUALIFICAZIONE
Unae gi da diversi
anni si sta prodigando
per sviluppare
un sistema di piccole-
medie imprese, per
favorire la risoluzione
dei problemi
della qualificazione,
della formazione
e dellaggiornamento
del personale
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004
85
Umbria, sono stati certificati
da Quaser i corsi relativi al pro-
filo G di operatore addetto ad
attivit sotto tensione BT (at-
tivit sui gruppi di misura e
prese in presenza di tensione)
e quello del profilo C di pre-
posto alla conduzione di attivit
lavorative su impianti elettrici
di distribuzione MT e BT (Capo
Squadra), che ha visto la pre-
senza di 5 imprese con 25 par-
tecipanti. A seguire, in Umbria,
in ottobre e novembre, verran-
no indetti altri corsi di forma-
zione relativi ai profili F e
D con la ripetizione di ulteriori
sessioni dei profili gi in pre-
cedenza effettuati. La richie-
sta stata sollecitata dalle-
sigenza prioritaria delle im-
prese associate Unae di esse-
re qualificate per accedere agli
appalti di Enel Distribuzione
per i lavori sugli impianti MT
e BT ed in particolare per lat-
tivit di gestione utenza.
Con il nome di Gestione Uten-
za sintendono, in genere, tut-
te le operazioni condotte in cor-
rispondenza del punto di con-
segna delle forniture in bassa
tensione e riguardano lallaccio
e il distacco delle prese dei
clienti, gli interventi sui grup-
pi di misura per adeguamenti
contrattuali o nuove forniture,
lallacciamento di forniture tem-
poranee; attivit che nella mag-
gioranza dei casi possono essere
eseguite sotto tensione.
LAlbo Unae Umbria ha orga-
nizzato la prima sessione del cor-
so G e C presso la ditta
Cieffe Snc, in localit Madonna
di Lugo di Spoleto, realizzando
un vero e proprio campo scuo-
la per la formazione del per-
sonale adatto a tutti i profili
professionali (C - D - E - F - G)
richiesti da Enel e valido an-
che per altre tipologie di corsi
come quello riguardante la nor-
ma Cei En 50110 (norma spe-
rimentale Cei 11 27/1) con i
moduli 1A+2A parte teorica e
1B+2B parte pratica.
Per questultima tipologia di
corsi, che ha visto formati negli
ultimi 4 anni oltre 1000 addet-
ti per la sola parte teorica, lU-
nae Umbria ha indetto corsi
promozionali per i propri asso-
ciati (a solo copertura dei costi
vivi del corso) al fine di pro-
muovere la cultura della si-
curezza in unattivit in cui il
rischio elettrico impone misure
di sicurezza specifiche, previste
dalle normative di legge e dal-
la regola dellarte.
In particolare, i corsi di forma-
zione Cei En 50110 si soffer-
mano sulla necessit della si-
nergia (informazione, coopera-
zione e coordinamento) fra com-
mittente e appaltatore, sia per
quanto riguarda gli aspetti di ri-
schio elettrico presente nei la-
vori quotidiani che rientrano
nel campo di applicazione del D.
Lgs. 494/96, sia nel caso che
il rischio elettrico costituisca il
rischio specifico di cui allart. 7
del D. Lgs. 626/94. Per questo,
oltre al corso teorico per lavo-
ri elettrici sotto tensione, fuo-
ri tensione e in prossimit con-
forme al modulo 1A+2A, gran-
de importanza assume anche
il corso di formazione progettato
da Unae (relativo alla parte pra-
tica conforme al modulo 1B+2B
della norma Cei 11-27/1) per la
prevenzione e la protezione dai
rischi elettrici per il personale
delle imprese appaltatrici chia-
mate ad operare sulla rete di
distribuzione pubblica e priva-
ta di media e bassa tensione, di
cui ampio spazio stato dato nel
numero 5 del 10 aprile 2004
nel Giornale dellInstallatore
Elettrico.
Unae gi da diversi anni si sta
prodigando per sviluppare albi
regionali delle imprese dellin-
stallazione elettrica, che per
preparazione e formazione pro-
fessionale e consistenza nu-
merica degli aderenti possa
sempre pi rappresentare e
supportare il ruolo delle im-
prese qualificate, in modo che
le stesse possano affrontare in
condizioni adeguate le nuove sfi-
de per competere in un mer-
cato che d gi concreti segnali
di modificazione e di evoluzio-
ne tecnologica. con tali pro-
spettive che Unae sta dedi-
cando sforzi non indifferenti
per favorire questo processo
di crescita delle Imprese rias-
sumibile nel termine Qualifi-
cazione, sforzi che di norma si
indirizzano verso un sistema
di piccole-medie Imprese, per fa-
vorire la risoluzione dei pro-
blemi della qualificazione, del-
lorganizzazione aziendale, del-
la formazione e dellaggiorna-
mento tecnico/normativo del
proprio personale.
TABELLA 1 - LA SPECIFICA ENEL FUNZIONE
ACQUISTI DEL 21/7/2003
Professionalit
Gruppo merceologico
Illuminazione Linee aeree Cabine Gestione
pubblica interrate secondarie utenza
MT e BT MT/BT
C= N 1
Fino a 100.000 I E= N 2
G= N 1
C= N 1 C= N 2 C= N 2
Fino a 200.000 I E= N 2 D= N 2 E= N 1
G= N 1 E= N 1 F= N 2
C= N 2 C= N 3 C= N 3
Fino a 500.000 I E= N 3 D= N 4 E= N 2
G= N 2 E= N 2 F= N 4
C= N 3 C= N 4 C= N 4
Fino a 2.000.000 I E= N 4 D= N 6 E= N 3
G= N 3 E= N 4 F= N 5
C= N 6 C= N 5
Oltre 2.000.000 I D= N 8 E= N 4
E= N 6 F= N 6
Legenda
Tipologia Profilo professionale
C Preposto alla conduzione di attivit lavorative su impianti elettrici di distribuzione
MT e BT (Capo Squadra);
D Tirafili (Tesatore, Amarragista, Guardafili; AT-MT-BT);
E Operatore esperto nella esecuzione di giunti e terminazioni su cavi aerei o interrati a media
e bassa tensione;
F Operatore addetto al montaggio di cabine secondarie e posti di trasformazione su palo;
G Operatore addetto ad attivit sotto tensione BT (attivit sui gruppi di misura e prese
in presenza di tensione).
Alcune immagini dei partecipanti
ai corsi organizzati da Unae
C= N 2
G= N 3
C= N 5
G= N 8
C= N 3
G= N 7
C= N 7
G= N 10
Classe importo
86
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
U
nae, nel quadro delle
azioni formative previ-
ste dalla Specifica di
Enel Acquisti del luglio 2003 per
la qualificazione delle imprese ap-
paltatrici (su questa importante
iniziativa di Enel, Il Giornale ha
gi riferito nel numero di Set-
tembre 2004 con larticolo dello
stesso autore dal titolo Enel:
outsourcing e qualificazione -
La formazione del personale al
centro del nuovo sistema di qua-
lificazione dellEnel riguardante
le imprese appaltatrici che svol-
gono le attivit di costruzione
e manutenzione sulla rete di dis-
tribuzione di AT, MT e BT) chia-
mate ad operare sulla rete di
distribuzione pubblica, ha pro-
gettato il corso di formazione
che prevede il rilascio dellatte-
stazione di idoneit al profilo
professionale di Operatore
esperto nellesecuzione di giun-
zioni e terminazioni su cavi ae-
rei ed interrati a MT e BT (Pro-
filo E). Con la sessione iniziale del
corso, erogata dallAlbo dellEmilia
Romagna, Unae ha conseguito la
certificazione di prodotto, ossia
la certificazione di conformit
alla riferita Specifica, rilasciata dal-
lIstituto Quaser organismo ac-
creditato ai sensi della norma
EN 45011.
Con il presente rapporto si ri-
assumono i contenuti salienti
del corso che, per lampiezza
degli approfondimenti teorici e
soprattutto per la completezza
delle esercitazioni pratiche, sta
trovando interesse anche pres-
so le imprese che si occupano
della costruzione e della manu-
tenzione degli impianti utilizza-
tori (impianti alimentati diret-
tamente dalla rete di distribu-
zione pubblica a MT - clienti con
propria cabina di trasformazione
MT/BT).
Il corso certificato ha una dura-
ta di 32 ore, di cui il 60% ri-
servato alle esercitazioni prati-
che. Lattestato viene prodotto a
fronte del superamento di una
prova teorica e di una prova pra-
tica condotta individualmente.
Entrambe le prove sono volte
ad appurare anche le conoscen-
ze impiantistiche e le misure di
sicurezza previste per lacces-
so a cavi in esercizio.
I PRINCIPALI
CONTENUTI DEL CORSO
Nella logica di trasmettere e far
conseguire ai partecipanti, ol-
tre alle conoscenze di base, an-
che le capacit e le abilit ope-
rative necessarie per operare in
autonomia, il corso si articola in
un vasto programma con inter-
venti didattici, continuamente
alternati fra aula e cantiere, che
prevedono una forte interazione
docenti-discenti e puntuali mo-
menti di verifica plenaria ed in-
dividuale.
In questo senso sono attivati
frequenti test per verificare i
ritorni di apprendimento, lef-
ficacia della didattica e per ri-
cavare elementi oggettivi di
giudizio per lammissione dei
partecipanti alle prove finali
desame.
In sintesi si riportano gli argo-
menti trattati:
elettrotecnica di base e nozio-
ni dimpianti della distribuzio-
ne con specifico riferimento
alle reti in cavo interrato;
leggi e normative riguardanti
lesecuzione e la sicurezza nel-
la costruzione e nellesercizio
delle linee in cavo. Nozioni di
pronto soccorso;
elementi di concetto sulla
struttura e sul funzionamento
dei cavi in particolare sulla
configurazione del campo elet-
trico;
il controllo del campo elettrico;
caratteristiche costruttive dei
cavi a MT e BT con specifico ri-
ferimento allunificazione Enel;
tipologia e tecnologia degli
accessori per cavi (giunti e
terminali);
attrezzatura da lavoro per il
montaggio di giunti e terminali;
metodi per laccesso in sicu-
rezza, secondo la normativa di
legge, CEI e aziendale Enel, a
cavi in esercizio;
attrezzatura di sicurezza e Dpi.
Per la parte pratica sono previ-
ste esercitazioni individuali (nu-
mero cinque) su tutte le tipolo-
gie di accessori riguardanti sia
cavi ad isolamento solido estru-
so sia cavi isolati in carta im-
piegati fino alla met degli anni
novanta.
ELETTROTECNICA
DI BASE E NOZIONI
DIMPIANTI
A questo argomento, per ragio-
ni di tempo, ovviamente, non
viene dedicato molto spazio. Si
tratta pi che altro di un mo-
mento di verifica e di aggiorna-
mento, in particolare per quan-
to attiene:
la struttura della rete ed i vari
stadi del sistema elettrico della
distribuzione pubblica (figura 1);
Figura 1 - Struttura della rete e vari
stadi del sistema elettrico della di-
stribuzione pubblica
Teoria e pratica
per i giunti
Corso di formazione progettato da Unae per operatore provetto nella
esecuzione di giunti e terminali su cavi aerei ed interrati a MT e BT
ADDESTRAMENTO
Andrea Gulinelli
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004
87
le principali caratteristiche co-
struttive delle linee in cavo in-
terrato richiamando in parti-
colare i sistemi di protezione
meccanica dei cavidotti, le pro-
fondit di interramento, le mo-
dalit di posa e gli ordini di
grandezza delle trasportabili-
t in regime permanente per le
sezioni commerciali normal-
mente utilizzate nella rete di
distribuzione di MT e BT.
Il tempo limitato dedicato a ta-
le argomento si giustifica col
fatto che i partecipanti devono
essere in possesso del diploma
Ipsia nella specializzazione elet-
tromeccanica o di conoscenze
equivalenti, in genere acquisite
per aver svolto in affiancamen-
to i compiti che caratterizzano il
profilo professionale in argo-
mento.
LEGGI E NORMATIVE
RIGUARDANTI
LA SICUREZZA
NELLESECUZIONE
E NELLESERCIZIO
DELLE LINEE IN CAVO.
NOZIONI DI PRONTO
SOCCORSO
Per gli aspetti attinenti la pro-
gettazione e la costruzione del-
le linee interrate viene fatto un
cenno ai principali contenuti del-
la norma CEI 11-17, soprattutto
per quanto attiene le distanze di
rispetto da mantenere nelle in-
terferenze con gli altri servizi a
rete presente nel sottosuolo (ac-
quedotti, reti gas e di teleco-
municazioni, ecc.).
Relativamente alla sicurezza,
vengono trattate le normative
di legge specifiche per le co-
struzioni nel cui campo di ap-
plicazione rientra anche la rea-
lizzazione delle canalizzazioni
per le condutture elettriche sot-
terranee. Quindi: i DPR n. 164/56
e n. 547/55, il D.Lgs. n. 494/96,
cos come riformato con le mo-
difiche introdotte dal D.Lgs.
528/99.
Un richiamo viene pure fatto al-
le modalit di dispiegamento
dei cantieri su suolo stradale se-
condo il regolamento di esecu-
zione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada.
Viene fatta solamente una men-
zione, in questa sede, alla nor-
mativa per la prevenzione e la
protezione contro il rischio elet-
trico in quanto successivamen-
te oggetto di puntuale appro-
fondimento applicativo nello
spazio riservato ai metodi di ac-
cesso in sicurezza ai cavi in eser-
cizio.
Dopo una rapida illustrazione
riguardante gli effetti fisiopato-
logici del passaggio della cor-
rente elettrica attraverso il cor-
po umano (figura 2), si passa ad
una dettagliata disamina delle
azioni previste per il pronto soc-
corso ai colpiti da corrente elet-
trica (respirazione bocca-bocca,
massaggio cardiaco, primo trat-
tamento delle ustioni, ecc.).
Nel caso di specie la trattazione
non pu che avere solamente
uno scopo di sensibilizzazione
essendo, come noto, lefficacia di
un intervento di pronto soccor-
so, nei confronti di una persona
elettrocutata, in gran parte di-
pendente dalla pratica acqui-
sita e mantenuta con periodi-
che esercitazioni reali su ma-
nichini, guidate da istruttori
specializzati.
STRUTTURA
E FUNZIONAMENTO
DEI CAVI
Vengono esaminate le principa-
li tipologie e differenze dei cavi
di MT e BT con approfondimen-
ti sulla natura dei moderni iso-
lamenti solidi
estrusi (figura 3),
in particolare
quello in XLPE.
Questi sono por-
tati a confronto
con gli isolamenti
in carta impre-
gnata (miscela
stabilizzata, mi-
grante e non migrante), che co-
munque loperatore esperto de-
ve conoscere, anche se non so-
no pi di impiego prevalente,
per la ricorrente necessit di
realizzare giunzioni con i cavi
esistenti.
Successivamente si passa allil-
lustrazione della struttura del
campo elettrico nei cavi, in par-
ticolare del campo elettrico ra-
diale (figura 4). Introdotta la si-
militudine con il condensatore
cilindrico, si passa alla spiega-
zione del significato di radialit
delle linee di forza del campo, di
concentricit delle linee equi-
potenziali e quindi del concetto
di gradiente con lindividuazio-
ne dei punti dove questo assu-
me il valore massimo e minimo,
sottolineando la distribuzione
non lineare del campo passando
dal conduttore allo schermo.
Uno spazio adeguato pure ri-
servato ai cavi isolati in carta a
campo elettrico non radiale (ca-
vi cinturati) che caratterizzano
ancora gran parte della rete in-
terrata a MT nei centri storici.
Ma non tanto per lanalisi della
complessa configurazione del
campo elettrico, quanto per
chiarire la struttura geometrica
di tali cavi (schermo a cintura,
conduttori settoriali, riempi-
menti, ecc.) e le problematiche,
soprattutto di mero accoppia-
mento, che si pongono nella
giunzione con i
cavi a campo ra-
diale (giunti di
transizione).
Il capitolo, fonda-
mentale dal pun-
to di vista con-
cettuale, viene
concluso con lil-
lustrazione delle
cause che origi-
nano le scariche
parziali nellisola-
mento per far
comprendere la necessit di se-
gregare completamente il cam-
po elettrico fra due strati di ma-
teriale semiconduttore.
Cos facendo si realizza il per-
fetto interfacciamento fra con-
duttore e isolante e fra questi e
lo schermo fisico (da collegare fi-
sicamente a terra quando la
tensione di esercizio dellor-
dine di 56 kV).
IL CONTROLLO
DEL CAMPO ELETTRICO
Vengono illustrati i concetti fon-
damentali su cui si basano le
tecniche di controllo del campo
elettrico quando la sua configu-
razione sia stata deformata (fi-
gura 5) per effetto della elimi-
nazione di una parte dello scher-
mo. Eliminazione che determina
punti di addensamento delle li-
nee di forza sui quali occorre in-
tervenire riportando del mate-
riale di elevata percettivit (per-
mettivit = 1/; dove la co-
stante dielettrica relativa del
materiale.
La permettivit si definisce
quindi come lattitudine dei ma-
teriali a farsi attraversare dalle
linee di flusso del campo elet-
trico) che operi una rifrazione
elettrica (simile a quella ottica)
delle linee di forza in corrispon-
denza di ogni superficie di con-
fine tra due materiali di costan-
te dielettrica diversa. In parti-
Figura 2 - Effetti del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano
Figura 4 - Struttura
del campo elettrico
nei cavi
Figura 3 - Cavi di MT e BT
colare le linee di flusso uscenti
dal conduttore subiscono una
rifrazione passando dallisola-
mento del cavo (r = 2,53,5) al
materiale ad alta costante die-
lettrica (r=2040) e proseguono
entro questultimo per giungere
allo schermo.
Scegliendo un valore conve-
nientemente alto di costante
dielettrica, si pu ottenere un
angolo di rifrazione elevato, in
modo da mantenere le linee di
flusso del campo elettrico com-
pletamente allinterno di que-
sto materiale ausiliario.
Nella figura 5 si pu notare la ri-
frazione delle linee di flusso e la
loro tendenza a concentrarsi nel
materiale per il controllo delle
sollecitazioni piuttosto che nel-
lisolamento del cavo adiacente
alla interruzione dello schermo.
Tramite questa distorsione del
flusso, il gradiente nel punto di
discontinuit viene ridotto a va-
lori comparabili a quelli del cavo.
Nella figura 6 schematizzata la
posizione di installazione del-
lelemento per il controllo del
campo.
Un aspetto critico costituito
dalla presenza dello spessore
di semiconduttore (isolamen-
to in carta circa 0,10,15 mm,
isolamento estruso 0,50,8
mm) la cui asportazione, in cor-
rispondenza dellinterruzione,
pu determinare un vero e pro-
prio scalino daria che di-
venta sede di scariche parziali.
I costruttori di accessori per li-
solamento estruso propongo-
no di smussare il semicondut-
tore oppure di utilizzare ma-
stici o vernici semiconduttrici,
previste nella confezione, per
favorire un interfacciamento
dellelemento per il controllo
del campo senza il rischio di
lasciare inglobate delle bolle
daria.
CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE DEI CAVI
MT E BT CON SPECIFICO
RIFERIMENTO
ALLUNIFICAZIONE ENEL
Dopo un richiamo ai criteri di
designazione dei cavi secondo
quanto stabilito dalla norma Cei
Unel 35011, viene condotta una
ampia panoramica sulla tecno-
logia dei cavi MT e BT utilizza-
ti nella distribuzione con spez-
zoni degli stessi sezionati in pi
parti allo scopo di evidenziarne
la struttura. Un approfondi-
mento particolare riguarda i ca-
vi BT a neutro concentrico e i ca-
vi a MT con isolamento in Xlpe,
mettendo in evidenza la diversa
tecnica di estrusione del semi-
conduttore sullisolante rispetto
a quella praticata sullisola-
mento in Hepr. Aspetto impor-
tante, non sempre attentamen-
te valutato, da cui discende la
necessit di ricorrere ad attrez-
zi per lasportazione del semi-
conduttore fra loro diversi a se-
conda che si tratti di cavi in
XLPE oppure di cavi in Hepr.
TIPOLOGIA
E TECNOLOGIA
DEGLI ACCESSORI
PER CAVI (GIUNTI
E TERMINALI)
In anteprima vengono illustrati
i componenti fondamentali che
costituiscono il giunto e il ter-
minale di un cavo MT. Sono og-
getto dillustrazione accessori
reali, di tutte le tipologie clas-
siche attualmente disponibili
sul mercato ed utilizzate da
Enel, appositamente sezionati,
sia in senso trasversale sia in
senso longitudinale, che qui si
elencano in maniera sintetica
(figura 7):
a) giunti diritti: per il collega-
mento di cavi dello stesso tipo;
b) giunti di transizione: per col-
legare cavi di caratteristiche
differenti per isolamento o na-
tura del conduttore;
c) giunti dinterruzione della
continuit metallica dello
schermo;
d) giunti di riparazione.
Nel campo dei terminali (figura 8):
a) terminali tradizionali da in-
terno;
b) terminali tradizionali da
esterno;
c) terminali sconnettibili per pre-
se a cono interno;
d) terminali sconnettibili per pre-
se a cono esterno.
I moderni accessori sono di tipo
preformato e in pratica consi-
stono in una serie di compo-
nenti che vanno installati se-
guendo rigorosamente le istru-
zioni del fornitore.
Si distinguono in due grandi
categorie: termoretraibili e au-
toretraibili, utilizzabili anche
nei giunti misti con cavi isolati
in carta.
I primi sono manicotti e guaine
che vengono collassati a caldo
mediante apparecchiature a
fiamma libera o ad aria calda; i
secondi invece sono dei veri e
propri tubi in gomma siliconica
speciale aventi incorporata una
memoria elastica che viene at-
tivata realizzan-
do una continua
pressione radia-
le, con laspor-
tazione di un
supporto cilin-
drico predispo-
sto internamen-
te, realizzato
nella maggio-
ranza dei casi
con una spirale
in nylon. La pe-
rizia dellopera-
88
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Figura 5 - Tecniche di controllo
del campo elettrico
Figura 6 - Posizione di installazione dellelemento per il controllo del campo
Figure 7 e 8 -
Componenti
fondamentali del
giunto e del ter-
minale di un cavo
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004
89
tore nella buona riuscita del-
laccessorio dipende dalla pre-
parazione del cavo, dalla cor-
retta giunzione elettrica e dal-
leliminazione di ogni rischio che
si formino bolle daria interne.
ATTREZZATURA
DA LAVORO
PER IL MONTAGGIO
DI GIUNTI E TERMINALI
Unintera unit didattica de-
dicata allillustrazione delle ca-
ratteristiche e della funzionali-
t dellattrezzatura da lavoro, la
cui affidabilit e corretto uso
costituiscono gli elementi de-
cisivi per la buona esecuzione
dellaccessorio.
Lattrezzatura si divide in tre
categorie:
attrezzatura da taglio (per la-
sportazione della guaina
esterna, dellisolante e del se-
miconduttore);
attrezzatura per la giunzione
elettrica (presse idrauliche e
meccaniche e serie di matrici
per connettori e capicorda in
rame ed alluminio - figura 9);
attrezzatura per saldare e ter-
morestringere.
METODI PER LACCESSO
IN SICUREZZA A CAVI IN
ESERCIZIO SECONDO LA
NORMATIVA DI LEGGE,
CEI E AZIENDALE ENEL
Vengono richiamati i principi
fondamentali delle norme CEI
EN 50110 e 11-27/1, con parti-
colare riferimento ai compiti del
Preposto conduzione impianto
(Pci) e del Preposto conduzione
lavori (PCL), nonch la normati-
va di prevenzione e protezione
contro i rischi da elettrocuzio-
ne (P.R.E.) vigente in ambito
Enel. Tale ultima normativa
sintetizzata nel documento, de-
nominato Nota Tecnica, allega-
to al contratto dappalto. La No-
ta Tecnica tratta la regolamen-
tazione dei rapporti fra Enel e le
imprese appaltatrici indicando
i documenti di comunicazione per
la pianificazione dei lavori e la
consegna degli impianti (Piano
di lavoro e Notifica consegna
impianto). Lesame della nor-
mativa riguarda essenzialmen-
te tre aspetti:
la disalimentazione dellim-
pianto;
lindividuazione dellimpianto;
il controllo dei potenziali tra-
sferiti (figura 10 - equipoten-
zializzazione del posto di la-
voro).
Pu infatti determinarsi una ten-
sione pericolosa sul posto di la-
voro, fra i due tronconi di cavo da
giuntare e fra questi e terra,
qualora si verifichi un guasto
verso terra in una delle due ca-
bine dove il cavo stato sezionato
e messo a terra.
I primi due adempimenti sono di
competenza del Pci, per cui an-
che se abitualmente lindivi-
Il corso si articola
in interventi didattici,
continuamente
alternati fra aula e
cantiere, che
prevedono una forte
interazione docenti-
discenti e puntuali
momenti di verifica
Figura 9 - Attrezzatura
per la giunzione elettrica
La nost r a gamma di ut ensi l i per t agl i ar e
va dai t r onchesi ni per l e sezi oni pi
pi ccol e, con t r asmi ssi one di r et t a del l a
f or za, f i no agl i ut ensi l i da t agl i o per i
di amet r i pi gr andi , dove i l movi ment o
meccani co combi nat o con l a speci al e
f or ma del l e l ame da t agl i o r i duce al
mi ni mo l o sf or zo manual e necessar i o.
www. wei dmuel l er. com
Quest o perch i nost ri t est er sono
concepi t i per i pi svari at i campi
d i mpi ego. Si a che si t rat t i di sempl i ci
t est er di t ensi one o di t est er mul t i f un-
zi one, garant i re l a si curezza per noi
un presuppost o i mpresci ndi bi l e.
Un ot t i ma l eggi bi l i t e grande comf ort
d i mpi ego sono i punt i di f orza dei
nost ri st rument i di mi sura.
www. wei dmuel l er. com
TAGL I ARE
SPEL L ARE
CRI MPARE
AVVI TARE
MI SURARE
I NOSTRI UTENSI L I
REAL I ZZANO SEMPRE
I L MI GL I OR COL L EGAMENTO
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
3
2
duazione del cavo viene mate-
rialmente demandata al Pcl,
loperazione resta una respon-
sabilit intrasferibile del Pci.
Relativamente al terzo punto
vengono illustrati i tre metodi
di lavoro per operare in sicu-
rezza.
La scelta di quale impiegare
sempre stabilita dintesa fra
Pci e Pcl in sede di elaborazio-
ne del Piano di lavoro:
a) scollegamento dei condut-
tori e degli schermi del cavo
(ad entrambi gli estremi) da-
gli impianti di terra a cui so-
no collegati dopo lavvenuto
sezionamento;
b) impiego da parte degli ope-
ratori dei Dpi e rivestimento
della buca giunti sul fondo e
sulle pareti con teli isolanti;
c) installazione del dispositivo
di equipotenzializzazione
longitudinale e trasversale
da lasciare in opera almeno
fino al completamento del
giunto di una fase del cavo
(dispositivo mobile di conti-
nuit e messa a terra di cui
al punto successivo).
ATTREZZATURA
DI SICUREZZA E DPI
Pur essendo presenti ovvia-
mente altri rischi nel confezio-
namento degli accessori, si
prendono in considerazione so-
lamente lattrezzatura e i Dpi
previsti per il controllo del so-
lo rischio elettrico.
Cesoia idraulica isolata a 30
kV: conforme alla norma CEI
EN 50340 che consente di
tranciare il cavo in condizio-
ni di sicurezza anche se lo
stesso rimasto in tensione
per un errore di manovra (fi-
gura 11).
Dispositivo mobile di conti-
nuit e messa a terra (figura
12): conforme alla norma CEI
EN 61230 che deve essere in-
stallato indossando i Dpi.
Guanti isolanti di classe 00 o
di classe 0 da utilizzare sotto
i guanti da lavoro.
Tronchetti isolanti.
Questi Dpi sono comunque ne-
cessari, allinterno del metodo
prescelto (qualunque esso sia),
per contenere il rischio deri-
vante dal trasferimento di
eventuali potenziali pericolo-
si, ovviamente per la sola du-
rata di esposizione al rischio.
La parte teorica del corso si
conclude con un test di verifi-
ca dellapprendimento allo sco-
po di accertare lammissibilit
del discente alla prova teorica
desame.
Essa consiste nella compila-
zione di un questionario di 20
domande a fronte di risposte
multiple che ripercorrono lin-
tero itinerario formativo svolto
nei quattro giorni del corso.
ESERCITAZIONI
PRATICHE
Il docente e lassistente gui-
dano lesecuzione delle prove
con lobiettivo di far acquisire:
capacit e abilit operativa
in termini di: corretto uso del-
lattrezzatura, accuratezza
delle varie fasi operative, pu-
lizia e puntuale osservanza
delle istruzioni di montaggio;
capacit applicativa delle pre-
scrizioni di sicurezza e di co-
noscenza delle relative at-
trezzature e Dpi.
prevista leffettuazione di
cinque prove compresa quella
dellesame finale che devono
interessare non pi di 15 can-
didati per ogni sessione.
Le prime quattro sono condotte
a coppie di operatori e vengono
eseguite in un tempo media-
mente compreso fra unora e
mezza e due ore, mentre la quin-
ta, quella relativa allesame fi-
nale, viene svolta dal candidato
in completa autonomia con un
tempo massimo a disposizione di
due ore e mezza.
Il corpo docente illustra le pro-
ve sottolineando i punti salienti
dellattivit:
funzionalit dellattrezzatu-
ra da lavoro;
uso dellattrezzatura di sicu-
rezza e dei Dpi per il controllo
del rischio elettrico ai fini del-
laccesso a cavi in esercizio;
allestimento della postazio-
ne di lavoro;
operazione di taglio e prepa-
razione di un cavo da giunta-
re o terminare.
Ultimata lesercitazione, sem-
pre in plenaria, vengono illu-
strate le criticit emerse e at-
tivata una discussione che co-
involge tutti i discenti in un
clima di piena libert e parte-
cipazione.
Vengono anche approfonditi
gli errori classici riscontrati
su campioni di giunti e di ter-
minali guasti, quindi causa di
disservizi, recuperati dagli im-
pianti. Gli errori pi ricorrenti
sono:
incisione profonda sul con-
duttore;
mancata asportazione (par-
ziale o totale) del semicon-
duttore;
90
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
prevista
leffettuazione di cinque
prove, le prime quattro
sono condotte a coppie
di operatori mentre
quella relativa allesame
finale, viene svolta dal
candidato in completa
autonomia
Figura 10 - Equipotenzializzazione del posto di lavoro
Figura 12 - Dispositivo mobile di continuit e messa a terra
Figura 11 - Cesoia idraulica
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004
91
incisione dellisolante;
mancata pulizia dellisolante;
taglio non corretto del semi-
conduttore;
presenza di aria nellacces-
sorio;
mancata asportazione di ba-
ve o asperit sul connettore.
Durante le prove sono presen-
ti sia il docente sia lassistente
allo scopo di realizzare il co-
stante presidio delle fasi lavo-
rative e la messa in comune
delle osservazioni e delle ri-
chieste di chiarimenti da parte
dei discenti.
Alcune esercitazioni, compre-
sa la prova desame, prevedono
laccesso a cavi in esercizio.
Costituiscono quindi elementi
qualificanti per la valutazione
anche:
il corretto uso dellattrezza-
tura antinfortunistica e dei
Dpi, nonch le misure di si-
curezza previste per il con-
trollo del rischio elettrico da
mettere in atto durante il
montaggio dellaccessorio;
ladeguatezza delle misure
di sicurezza per la predispo-
sizione e la gestione di un
cantiere su strada.
Per ciascuna fase di lavoro ele-
mentare il corpo docente asse-
gna un punteggio (per ogni
esercitazione e per ciascun di-
scente), in modo da utilizzare
un criterio standardizzato ed
oggettivo di valutazione in or-
dine allammissibilit dei di-
scenti alla prova finale desame.
Le fasi di lavoro elementari o
gli accorgimenti considerati si-
gnificativi sono quelli sotto ri-
portati.
a) Rispetto delle quote di sguai-
namento del cavo.
b) Non incisione dellisolante e
del conduttore.
c) Corretta asportazione del se-
miconduttore.
d) Corretta applicazione dei con-
nettori e/o dei capocorda.
e) Eliminazione delle bave e
punte metalliche.
f) Corretta sigillatura delle zo-
ne esposte alla penetrazio-
ne dellacqua.
g) Corretto utilizzo dellattrez-
zatura da lavoro.
h) Pulizia del cavo, delle mani e
degli attrezzi.
i) Rispetto puntuale delle
istruzioni di montaggio.
La valutazione massima della
prova desame conseguibile dal
candidato di 60 punti. Essa
viene ottenuta dalla somma:
delle valutazioni parziali as-
sociate alle fasi lavorative ele-
mentari pi significative di
cui sopra;
dalla valutazione media pon-
derata delle quattro esercita-
zioni svolte durante il corso
ottenuta sulla scorta dei cri-
teri anzidetti e dal grado di
apprendimento rilevato in or-
dine agli elementi di sicurez-
za riguardanti il controllo del
rischio elettrico.
Per quanto attiene lattrezzatu-
ra, la disponibilit di quella da la-
voro non mediamente inferio-
re a una dotazione completa
ogni 45 partecipanti, mentre
per quella di sicurezza sono ri-
tenuti sufficienti due dispositivi
mobili di messa in equipoten-
zializzazione e due cesoie isola-
te tranciatavi MT, anche perch
la procedura di consegna di un
cavo in esercizio non previsto
che sia applicata in tutte le
esercitazioni.
TABELLA 1 - ELENCO DELLE PROVE
Esecuzione di giunto unipolare su cavo isolato in HEPR/XLPE da 185
mm
2
di tipo autorestringente.
Esecuzione di terminale unipolare da esterno su cavo isolato
in HEPR/XLPE da 120 mm
2
di tipo autorestringente.
Esecuzione di giunto unipolare misto, fra cavo isolato in HEPR/XLPE
Prova 3 da 185 mm
2
e cavo isolato in carta della sezione 240 mm
2
di tipo
termorestringente.
Esecuzione di terminale unipolare a T sconnettibile a cono esterno su
cavo isolato in carta della sezione 240 mm
2
di tipo termorestringente.
Prova 5 Esecuzione di giunto o terminale da scegliersi fra le prove 1, 2 e 3.
(Esame finale)
Prova 2
Prova 4
Prova 1
Videoregistratore digitale
multiplexer a 4 canali
Ovunque, sempre.
SICUREZZA 2004
Sistema certificato
UNI EN ISO9001:00
Saremo presenti a:
SICUREZZA 2004
17-20 Novembre
Fiera di Milano
Web server a 2 canali per
videoregistratori serie TVV
" Consente di gestire tramite rete LAN o tramite Internet due videoregistratori
della serie TVV contemporaneamente.
" Connessione automatica alla rete LAN.
" Firmware facilmente aggiornabile tramite software di gestione o tramite FTP.
" Possibilit di collegare fino a 4 ingressi di allarme.
" Software di gestione per Win98/2000/XP con funzionamento duplex
(riproduzione / registrazione simultanei).
" Invio e-mail automatico su attivazione allarmi.
" Connessione RS485 per controllo Pan-Tilt-Zoom o videoregistratori TVV.
RS-232
video
audio
#2 #4
#1
#1
#2
LAN
ADSL
HDSL
IP
pubblico
#1 #3
#3 #4
PC
ROUTER
TVVS2
PC
TVM14CA
TVV524M
" Videoregistratore digitale VCR + Multiplexer
" 4 ingressi audio / 2 uscite audio.
" Display su schermo (On Screen Display).
" Funzione Picture-In-Picture (PIP).
" Motion detection (Rilevatore di movimento).
" Ingresso allarme & Uscita funzione.
" Rilevazione segnale video basso su ogni canale.
" Funzione di memorizzazione power-loss (caduta tensione).
" Zoom lineare (2x~4x).
" Registrazione QUAD (120fps) o schermo intero (30fps).
" Supporto 1 HDD removibile, tipo IDE.
" Ricerca multipla tramite data/ora, allarme, lista completa.
" Password di protezione.
" Protocolli di comunicazione RS-232, RS-485.
servizio lettori 1740
POWERTRONIX spa _ via Abruzzi 1 _ 20056 Grezzago (MI) tel. 02 90968648 _ fax 02 90968658
vendite@powertronix.it www.powertronix.it
servizio lettori 1773
REPORTING CAVI SPECIALI
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 93
Vetrina
I
s
e
n
s
o
r
i
a cura di G
iovanni D
anielli
Misura dinterfaccia
con microonde guidate
Vega Grieshaber - distribuita da
Vega Italia (www.vega.com) -
ha realizzato un nuovo appa-
recchio della famiglia Plics, per
la misura dello strato di separa-
zione fra due prodotti: Vegaflex
67. Il funzionamento del senso-
re di livello sfrutta il principio
delle microonde guidate, noto
anche come Tdr (Time Domain
Reflectometry). I segnali a mi-
croonde scorrono lungo una bar-
ra o una fune e quando incon-
trano la superficie del prodotto
vengono riflesse una prima vol-
ta. Il tempo dandata e ritorno de-
gli impulsi corrisponde alla di-
stanza dal prodotto e quindi al-
laltezza del livello.
Nella misura dinterfaccia, lo
strato di separazione fra i due pro-
dotti genera unulteriore rifles-
sione. Vegaflex 67 elabora, at-
traverso il prodotto superiore,
questa differenza del tempo dan-
data e ritorno e determina cos la
distanza dallinterfaccia, dispo-
nibile come uscita analogica in
corrente. Nel caso di trasmis-
sione del segnale con Hart, Pro-
fibus PA oppure con Foundation
Fieldbus possibile disporre an-
che del valore digitale di misura
di livello. Per ottenere entrambi
i valori di misura sotto forma di
uscite analogiche in corrente si
esegue un collegamento alle-
laboratore Vegamet 625. In que-
sto modo si pu ottenere anche
la misura differenziale, grazie
alla quale sar fornito come cor-
rente analogica anche lo spessore
dello strato di separazione.
Vegaflex, come membro della
famiglia Plics, offre tutti i vantaggi
di questo nuovo concetto tec-
nologico realizzato da Vega: for-
ma ottimizzata della fune, della
barra e dellesecuzione coassia-
le, diversi tipi di custodie e di elet-
troniche e naturalmente il noto
semplice sistema di messa in ser-
vizio mediante il tastierino di ta-
ratura con display Plicscom.
servizio lettori 102
Trasmettitore portatile
per la misura dellumidit
nellolio
Elcam (www.elcam.it) presen-
ta il nuovo portatile MM70 per la
misura dellumidit nellolio.
Prodotto dalla finlandese Vaisala,
leader nella produzione di stru-
menti per il rilevamento di para-
metri ambientali, MM70 un af-
fidabile strumento portatile idea-
le per il monitoraggio dellumi-
dit in oli lubrificanti e per tra-
sformatori. lideale sia per la mi-
sura in linea che per controlli
localizzati: i controlli spot sono
possibili inserendo la sonda di-
rettamente nel processo attra-
verso la ball valve opzionale,
evitando quindi perdite nel si-
stema. Gli strumenti Vaisala mi-
surano lumidit dellolio in ter-
mini di water activity e tem-
peratura. La water activity indica
se c il rischio di formazione di
acqua libera che pu causare il
deterioramento dellolio. Tale
misura indipendente da tipo, et
e temperatura dellolio. anche
disponibile la misura in parti per
milione (ppm) solo per gli oli mi-
nerali per trasformatori. MM70 ha
un display grafico e numerico
che permette allutilizzatore di
monitorare la misura e il trend del
processo.
I dati misurati possono essere re-
gistrati e successivamente tra-
sferiti ad un PC tramite il software
opzionale per Windows.
servizio lettori 104
Soluzioni di pesatura
elettronica
Nbc Elettronica (www.nbc-el.it)
opera nel settore della pesatura
elettronica e forte di unespe-
rienza ventennale lavora al con-
tinuo miglioramento tecnologico
attuato sia in fase di progetta-
zione che di realizzazione dei
propri prodotti. Certificata da
Bvqi, Nbc Elettronica ha otte-
nuto il marchio Iso 9001:2000. I
prodotti della societ sono sem-
pre conformi alle norme vigenti
nel settore (Oiml R60 - EN 45501).
La vasta gamma di prodotti le
permette di rispondere a qualsiasi
richiesta del mercato interna-
zionale soprattutto nel campo
della pesatura elettronica. Tut-
to questo accompagnato dal
servizio pre e post-vendita: Nbc
Elettronica mette a disposizione
del cliente la propria organizza-
zione tecnica ed il suo know-
how per la risoluzione di tutti i
problemi applicativi e la realiz-
zazione di prodotti Custom.
servizio lettori 105
www.reedbusiness.it
Sensori a tutto campo
I sensori dellamericana Honeywell Sensotec
completano ulteriormente il programma di vendita di
Burster Italia (www.burster.it). Limportante
costruttore americano ha nel suo catalogo una
gamma completa di celle di carico, trasduttori di
pressione, accelerometri e sensori Lvdt. Lelevato
standard di qualit di questi sensori e la vasta scelta
disponibile anche per impieghi estremi (come in
atmosfera esplosiva) offrono al mercato italiano una
valida alternativa in questa nicchia. Per esempio le
celle di carico coprono range da pochi grammi a
migliaia di tonnellate, con o senza amplificatore
incorporatato, per compressione, trazione e flessione,
con svariate forme e dimensioni. Idem per i
trasduttori di pressione dove Sensotec dispone di
modelli per pressioni assolute, relative,
barometriche, vuoto e differenziali con in pi
soluzioni per la misura di profondit. Da segnalare:
per gli accelerometri i modelli miniatura per
impieghi dalla DC e quelli per crash test; per gli Lvdt
la miniaturizzazione e il veloce tempo di risposta.
servizio lettori 103
VETRINA SENSORI
94
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Box per sensori/attuatori
con protezione IP67
I nuovi box per sensori/attua-
tori con protezione IP67 di Wa-
go (www.wago.com) sono in gra-
do di acquisire e smistare i segnali
in prossimit di macchine e si-
stemi complessi. I connettori cir-
colari ad innesto, tipo M 12/M 23,
garantiscono una connessione
semplice ed efficace.
In applicazioni dove non pos-
sibile impiegare soluzioni con
Bus di campo in IP67 o attra-
verso un cablaggio parallelo ver-
so il quadro di comando, la so-
luzione ideale e pratica data dai
nuovi box per sensori/attuatori
di Wago. Questi ultimi rilevano i
segnali nelle immediate vicinan-
ze della macchina e vengono smi-
stati e distribuiti verso il quadro
di comando, dove saranno poi ac-
cettati per esempio dal Wago I/O
- System 750 modulare. Compat-
ti e di spessore ridotto, possono
essere montati anche in soluzio-
ni dove lo spazio a disposizione
minimo. I singoli moduli posso-
no essere combinati ad incastro
per mezzo di adattatori.
In questo modo si riducono i co-
sti di installazione e di assi-
stenza, e con i normali connettori
circolari M12 e M23 offrono una
connessione semplice e sicura. La
famiglia di prodotti comprende-
r complessivamente 18 varian-
ti, distributori a 4, 6 e 8 connet-
tori, per uno o due segnali per
connessione. Sono disponibili
versioni precablate o con con-
nettore M23. I Led di diagnosti-
ca integrati forniscono informa-
zioni sullo stato di funziona-
mento, alimentazione ecc.
servizio lettori 106
Trasmettitori di pressione
La serie 2600T di ABB compren-
de trasmettitori di pressione con
precisione 0,04%, o 0,075%, an-
che nelle versioni Safety e multi-
variabile.
Caratterizzati da elevata affidabilit
e tecnologie davanguardia, gli
apparecchi sono utilizzabili in di-
versi settori (chimico, petrolchimico,
farmaceutico, alimentare ecc.)
per le seguenti misure:
- pressione differenziale, relati-
va o assoluta;
- portata con diaframmi calibrati,
Wedge integrale e non, tubi Dall
o Venturi, orifizi integrali, stra-
mazzi a cuneo, rettangolari o
trapezoidali;
- livello di liquidi, livello dinter-
faccia, densit e peso specifico;
- volume di liquidi in serbatoi sfe-
rici, cilindrici orizzontali o con al-
tre conformazioni curve.
I valori di pressione sono rilevati
da un sensore digitale in base al-
lo spostamento della membrana
di misura; un oscillatore multi-
modo (ASIC) attua la commuta-
zione dei valori dando origine al
Segnale Digitale Standardizzato
(SDS); i dati sono memorizzati
nella memoria non volatile. La
piattaforma multivariabile adat-
ta per applicazioni di portata mas-
sica con aria, gas, vapore o in ca-
so di ingressi multipli: lag-
giunta di un sensore esterno
della temperatura di proces-
so, infatti, permette il calco-
lo di livello e portata com-
pensata, oltre ad ottimizzare
la misura e a migliorarne la
precisione.
La piattaforma Safety, certi-
ficata SIL2, progettata con
la necessaria ridondanza e
autodiagnostica per tutte le
applicazioni Safety critiche.
Qualsiasi sistema di control-
lo compatibile Hart/4-20 mA, Pro-
fibus Pa, Foundation Fieldbus e
Modbus pu comunicare con i
trasmettitori, cos da raccogliere
i dati nel sistema, ottimizzare i tem-
pi di modifica e aumentare la si-
curezza dellimpianto.
servizio lettori 107
Sensori antideflagranti
Eisenbau (www.eisenbau.it)
distribuisce la linea completa di
sensori e trasmettitori di pres-
sione UE Transmetrics, strutturata
su varie serie, e comprendente
sensori di pressione relativa, as-
soluta, trasmettitori di pressio-
ne differenziale, barometrici, low
cost, e per impiego con gas puri.
I campi di pi comune impiego di
questi dispositivi sono: banchi
prova veicoli, banchi prova aero-
nautici, presse idrauliche, mar-
telli idraulici, analizzatori, misure
nei settori farmaceutico e biologico,
gas tecnici, industria dei semi-
conduttori.
I nuovi
box per
sensori/attuatori con protezione
IP67 di Wago sono in grado di
acquisire e smistare i segnali in
prossimit di macchine e sistemi
complessi. I connettori circolari ad
innesto, tipo M 12/M 23,
garantiscono una connessione
semplice ed efficace
P
rogettati per la tecnica di mi-
sura e controllo e soprattut-
to per fornire la conversione
di un segnale con un adeguato
isolamento, i cosiddetti trasmetti-
tori prevengono leventualit che
un segnale analogico sia distur-
bato ed in definitiva alterato dalle
condizioni ambientali e da feno-
meni esterni.
Questi tipi di trasduttori assicu-
rano ai sistemi di controllo di lavorare
in un modo migliore incremen-
tando la sicurezza e la qualit, tra-
mite una precisa conversione, un
perfetto adattamento e soprattut-
to un buon isolamento elettrico
dei segnali analogici.
SISTEMI DAUTOMAZIONE
I componenti quali i sensori ed i tra-
sduttori, posti in uninstallazione
dautomazione industriale, sono
collegati ad unit e sistemi che
provvedono al monitoraggio e al
controllo: i pi comuni sono PLC,
RTU, data logger, control-
lori di PID ed indicatori
analogici o digitali. Que-
ste tipologie di unit
e sistemi sono soli-
tamente chiamate
controllori di pro-
cesso, sistemi
dautomazione o
sistemi scada: es-
si hanno la funzione
principale di gestire
i processi tramite il
controllo dei dati
analogici o digitali
provenienti dal cam-
po; quindi visualiz-
zano i risultati ela-
borati. In certe con-
dizioni, il campo e larmadio
di controllo sono relativamente vi-
cini tra loro (entro 50 mt.). In altre
situazioni, le stazioni dove sono
presenti i sistemi di connessione dei
sensori non prevedono la presen-
za di personale. Di conseguenza non
ci sono sistemi di controllo locali;
questi sono invece posti in una
struttura distante, la quale risulta
collegata con pi stazioni. Co-
munque, in entrambe le situazio-
ni, esistono dispositivi program-
mabili e adatti ad acquisire i valo-
ri dei parametri dal campo: essi
sono poi in grado di trasmettere i
dati al gestore locale o remoto.
Naturalmente deve esi-
stere una rete di trasfe-
rimento dei dati tra le va-
rie stazioni. La rete di
comunicazione pu
essere realizzata via
cavo (es. rete tele-
fonica pubblica, li-
nea telefonica dedi-
cata o a noleggio,
collegamento in fi-
bra ottica) oppure
con sistema wire-
less (es. radio, GSM,
satellitare). Mentre
i sistemi dautoma-
zione sono mag-
giormente presenti
nelle fabbriche e nel-
le raffinerie, i sistemi sca-
da sono prevalenti nella distribu-
zione dellenergia elettrica, del gas
e dellacqua.
TRASDUTTORI
E TRASMETTITORI
In alcune situazioni, i segnali ana-
logici prodotti dai sensori posti in
campo possono essere inadegua-
ti, come livello o tipologia, ad essere
SENSORI E TRASDUTTORI DI MAURIZIO GUARNASCHELLI
La trasmissione di un segnale analogico da un punto allaltro, in ambiente industriale, esposta a interferenze
Figura 1 - Senza un adeguato isolamento la differenza di potenziale
crea delle correnti
VETRINA SENSORI
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 95
Inoltre, UE presenta anche un
nuovo trasmettitore di pressio-
ne antideflagrante, in esecuzione
interamente in acciaio inossidabile,
certificato Atex II 2G/D EExd IIC
T5, UL e cUL.
Lo strumento possiede regola-
zione di zero e span; per questa
seconda prevista lo possibilit
di ridurre il range fino al 20% del
campo di misura nominale.
I dodici campi di misura nomina-
li spaziano da 0/3,4 bar fino a
0/1650 bar, con segnale in uscita
4/20 mA e 2 fili. Attacchi al pro-
cesso da 1/4 NPT-F e Autoclave
F-250-C a partire da 690 bar.
Lo strumento pu essere fornito
con range pre-fissato oppure re-
golabile in campo.
Il nuovo trasmettitore di UE tro-
va facile impiego in raffinerie, im-
pianti pretroliferi e offshore, im-
pianti chimici e di trattamento e
distribuzione gas.
servizio lettori 108
Pressostato
dal design innovativo
Il nuovo modello di pressostato
PSD-10 si aggiunge alla gamma
di strumenti elettronici Wika
(www.wika.it) per
la misura della
pressione, in
applicazioni
idrauliche e
pneumatiche
(filtri, pompe,
compressori,
serbatoi di con-
densa ecc.).
Questo mo-
derno presso-
stato com-
bina un
desi gn
innova-
tivo ad
una comprovata
tecnologia di mi-
sura. Il nuovo presso-
stato PSD-10 dispo-
nibile per pressioni da 1
a 600 bar. Secondo il campo di
pressione dellapplicazione, ven-
gono usati sia sensori a film sot-
tile che sensori ceramici.
Il pressostato ha due uscite pro-
grammabili PNP. In opzione
disponibile anche unuscita ana-
logica. Pu essere impiegata an-
che unuscita di segnalazione
aggiuntiva per indicare la pre-
senza di un errore.
Lo strumento conforme alle at-
tuali disposizioni Desina.
Il display, che pu essere ruotato
fino a 280, garantisce unottima
visibilit anche in condizioni di
luce sfavorevoli (7 segmenti Led).
Parametri come lingua, unit,
punti di intervento, punto zero,
span ecc. sono facilmente pro-
grammabili tramite un menu in-
tuitivo.
Una password definibile dallu-
tilizzatore protegge lo strumento
da modifiche del menu di pro-
grammazione indesiderate.
servizio lettori 109
Sensori ultrasuono
made in Switzerland
Telestar (www.telestar-automa-
tion.it) ha acquisito la rappre-
sentanza esclusiva della societ
svizzera Snt Sensortechnik, spe-
cializzata nello sviluppo e nella pro-
duzione di sensori ultrasuono per
lautomazione industriale.
Il vasto programma Snt com-
prende versioni miniaturizzate
M18x90 mm, rettangolari 30x18x46
mm e 45x50x70 mm.
Le distanze di lavoro sono com-
prese nei campi 150-700 mm, 170-
1000 mm (M18); 150-550 mm e
500-5000 mm per le versioni ret-
tangolari.
Le uscite sono disponibili a se-
conda della versione in:
ON/OFF a singola o doppia so-
glia Pnp o Npn (NO - NC a ri-
chiesta)
uscita analogica 0...5V, 5...0V,
0...10V, 10...0V, 4...20mA,
20...4mA
alimentazione 18-35 Vcc, 12-
28Vcc
frequenza di commutazione da
2 a 30 Hz in funzione del modello
e della distanza di lavoro.
I sensori ultrasuono Snt sono il frut-
to di una lunga e concentrata
esperienza (sviluppo e produzio-
ne) nello specifico e particolare set-
tore della tecnologia ultrasuono,
che molto pi complessa e cri-
tica dei sensori induttivi/capaci-
tivi e optoelettronici.
Le caratteristiche di linearit, ri-
petibilit e risoluzione sono otti-
mizzate e costituiscono il limite
consentito dalla tecnica attuale.
Lesperienza Snt nella tecnologia
ultrasuono ha consentito di inte-
grare in sensori di minime di-
collegati direttamente alle unit
di lettura e controllo; oppure ne-
cessario creare un isolamento elet-
trico tra i sensori e le unit men-
zionate. In questi casi sono ne-
cessarie delle interfacce disola-
mento o conversione tra i sensori
ed i controllori: solitamente questi
dispositivi sono detti trasduttori
o trasmettitori.
CONVERSIONE
DEL SEGNALE
La funzione principale di un tra-
sduttore, utilizzato tra un sensore
posto sul campo e lunit di controllo,
la conversione o trasformazione
del segnale.
I sistemi di controllo industriali so-
no stati nel tempo standardizzati
e solitamente sono in grado di ac-
cettare segnali nelle gamme 0-
20mA, 4-20mA, 0-10V o 0-5V. Di con-
seguenza, qualunque sia il valore
e il tipo di segnale rilevato sul cam-
po, necessario che lo stesso sia
trasformato in un segnale come
quelli sopraccitati. I segnali pro-
dotti dai sensori sono di tipo elet-
trico, come corrente, tensione o
resistenza, quindi trasformati in
segnali in corrente o tensione DC,
adatti per essere accettati dalle
unit di controllo, misura, gestione.
Dal rilievo dei parametri fisici tra-
mite i sensori di campo quindi pos-
sibile monitorare i pi svariati pro-
cessi, dalla macchina operativa al-
limpianto pi complesso.
IL PROBLEMA
DELLISOLAMENTO
La trasmissione di un segnale ana-
logico proveniente da un sensore
da un punto ad un altro in am-
biente industriale fortemente
esposta ad interferenze. I segnali
analogici possono essere trasmessi
anche a lunga distanza senza che
ne siano danneggiate le qualit, per
mezzo di accorgimenti quali liso-
lamento elettrico, il migliore adat-
tamento del sensore col sistema di
controllo.
Lo scorrimento di corrente nei
conduttori produce un campo elet-
tromagnetico proporzionale al-
lintensit di corrente; ci crea
uninterferenza sul segnale origi-
nario. Per evitare questo problema
opportuno inserire, vicino al sen-
sore, un trasduttore con isola-
mento elettrico: in questo modo il
rischio di disturbi ridotto al mi-
nimo. Il segnale pertanto ritra-
smesso dal trasduttore in modo rin-
forzato e con un migliore adatta-
mento per il ricevitore.
Questi segnali, generalmente in
corrente, sono molto meno sensi-
bili alle distorsioni elettromagnetiche.
I sensori sono normalmente di-
stanti dal sistema di controllo (da
pochi metri a qualche centinaio).
Senza un adeguato isolamento
elettrico tra i due dispositivi, si
crea una diversa differenza di po-
tenziale verso terra, che genera una
corrente indesiderata tra sensore
e ricevitore (earth loop current). Li-
solamento elettrico, interrom-
pendo il loop tra sensore e unit
di controllo, serve proprio ad evi-
tare le differenze di potenziale
tra i due e quindi lo scorrimento di
correnti che disturbano il segnale
(figura 1).
sensori di temperatura
sensori di umidit
sensori di livello
sensori di pressione
sensori di prossimit
sensori di peso, di
forza, di coppia
sensori di
accelerazione, di
inclinazione
sensori ottici, laser,
fibra ottica
sensori fotoelettrici
codificatori lineari,
sensori lineari
sensori diversi
TIPOLOGIE DI SENSORI
PI COMUNI
TABELLA 1 - PROBLEMI E SOLUZIONI COI SENSORI
Problema Soluzione
Cablaggio esteso
e carico
disadattato
Amplificazione
del segnale
Segnali di diversa
tipologia
Conversione
del segnale
Potenziali verso
terra (massa)
Isolamento
elettrico
Interferenze
Filtraggio
del segnale
VETRINA SENSORI
96
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
mensioni funzioni spe-
ciali (a richiesta), che
consentono, ad esem-
pio, di regolare il cam-
po di lavoro, di fissare
inizio/fine misura e di
sfruttare lintero campo
delluscita analogica per
il solo segmento di la-
voro.
Sono anche possibili
funzioni scanner, che
consentono di monta-
re vari sensori affian-
cati senza interferenze
fra di loro.
Per lindustria chimica, alimen-
tare, eccetera sono disponibili
versioni in custodia resistente
agli agenti chimici.
Le applicazioni dei sensori ultra-
suono nellautomazione indu-
striale sono svariate.
I prodotti possono essere impie-
gati con qualsiasi tipo di materiale,
con assenza di interferenza della
luce, su grandi distanze di lavoro
e uscite con ON/OFF (anche con
doppia soglia) e analogiche.
Snt sviluppa o adatta versioni
standard alle specifiche esigenze
del cliente.
servizio lettori 110
Misura in fibra ottica
della temperatura
Fort Fibre Ottiche il distributo-
re per lItalia della societ cana-
dese Fiso Technologies.
Fiso Technologies specializzata
nella progettazione e fabbrica-
zione di sistemi a fibre ottiche
per la misura di temperatura,
pressione, deformazione e tra-
zione.
Per la misura della temperatura al-
linterno degli avvolgimenti dei
trasformatori con raffreddamen-
to ad olio Fort Fibre Ottiche pro-
pone il sistema di misura Nor-
tech. Le sonde immuni da inter-
ferenze elettromagnetiche (Emi)
sono molto flessibili e chimica-
mente resistenti.
Il software di gestione dati fun-
ziona sotto Windows ed con-
figurabile tramite porta seriale
RS232. possibile accedere ai da-
ti e configurare lapparato an-
che a distanza tramite conver-
titore elettro/ottico da RS232 in
fibra ottica, modem telefonico
o rete Lan 10/100Mb.Ogni singolo
sistema Nortech pu avere fino
a 6 canali.
servizio lettori 111
Pinze per corrente alternata
La famiglia di pinze PR1200 pro-
posta da Lem (www.lem.com)
stata progettata in conformit al-
le norme di sicurezza Iec 1010-2-
0.32 o EN 61010-2-32; 600V, Cat III
(o 300V Cat IV), gra-
do di inquinamento 2.
Le pinze PR1200 so-
no idonee a coprire
unampia gamma di
applicazioni grazie
al l avvol gi mento
equamente distri-
buito sul nucleo ma-
gnetico.
La copertura delle
ganasce del mecca-
nismo di apertura le
proteggono dai con-
tatti accidentali sia
con conduttori non
isolati sia provocati
dalla caduta di og-
getti. La copertura
smontabile con un
semplice attrezzo e
pu essere facilmente
sostituita in caso di
usura.
Un secondo dispositivo di sicurezza
chiamato Siac (Safety Internal
Anti short Circuit) protegge dai cor-
to-circuiti interni.
Tra le principali caratteristiche
si segnalano:
- lestremit libera delle ganasce
che facilita laccesso al con-
duttore;
- la facilit di pulizia;
- il facile controllo visivo della
completa chiusura delle ganasce;
- lassenza di usura dovuta al-
labrasione o ad urti con i con-
duttori;
- lassenza di attrito alla chiusu-
ra delle ganasce, frequente cau-
sa di errori di misura;
- nessun bisogno di verifiche pe-
riodiche delle distanze disola-
mento.
Le pinze PR1200 resistono a pe-
santi sovraccarichi: con corrente
nominale permanente di 1200 A
- 50/60 Hz possono sopportare
1500 A - 50/60 Hz in cicli di 1 ora
ogni 2 (60 / 120 min).
servizio lettori 112
Il dispositivo di sicurezza non visibile dallesterno,
ma il suo funzionamento si percepisce allapertura
delle ganasce
LISOLAMENTO
ATTIVO E IN LOOP
Il metodo disolamento pi com-
pleto sicuramente quello a 3 vie:
questo permette di avere un iso-
lamento completo tra le tre com-
ponenti principali, vale a dire lin-
gresso, luscita e lalimentazione.
Questo tipo disolamento for-
nisce lamplificazione ed il fil-
traggio del segnale din-
gresso verso luscita.
Unaltra tipica confi-
gurazione usata fre-
quentemente la
cosiddetta loop-
powered. In questo
tipo disolamento,
la potenza neces-
saria ai circuiti
presa dal circuito
dingresso, oppure
dal circuito du-
scita: queste con-
figurazioni non necessi-
tano di una sorgente separata da-
limentazione. In uscita, i moduli
loop-powered lavorano con lo stan-
dard 4-20mA. In ingresso, gli isolatori
loop-powered processano il se-
gnale attivo. Laddove questi metodi
siano utilizzati, importante che la
sorgente del segnale connesso al-
luscita del modulo (es. lingresso di
un PLC) abbia anchesso un isola-
mento loop-powered e la capacit
dalimentare il proprio carico. Nel-
la configurazione iterativa, anche il
sensore di misura alimentato dal
modulo.
SENSORI DI CAMPO
E TRASDUTTORI
I sensori di campo ed i trasmetti-
tori convertono le grandezze fisiche,
chimiche ed elettriche in segnali elet-
tici. I sensori sono collegati diret-
tamente o indirettamente tramite
amplificatori, regolatori o trasdut-
tori. Normalmente i sensori ne-
cessitano di unalimentazione ester-
na separata oppure fornita dal si-
stema di controllo.
SENSORI
DI TEMPERATURA
La temperatura certamente uno
dei valori pi importanti da man-
tenere sotto controllo in un processo.
il campo in cui esiste la pi vasta
gamma di sensori (dalle tempera-
ture pi basse a quelle pi eleva-
te) e di apparecchiature di misura,
controllo e regolazione.
RESISTENZE
TERMOMETRICHE
Le resistenze termometriche (es.
Pt100) hanno la propriet di va-
riare la propria resistenza in funzione
della temperatura. Il segnale in
uscita sar quindi proporzionale
alla variazione di tem-
peratura originaria. Il
principio di misura
della resistenza si ba-
sa su una sorgente
di corrente molto bas-
sa e stabile e si misura
la caduta di tensione
sulla resistenza. Le
resistenze termome-
triche non hanno una-
zione lineare; di con-
seguenza luso di un
trasduttore permet-
te la linearizzazione
del segnale propor-
zionale alla tempera-
tura. Essendo precise
e relativamente po-
co costose, le resi-
stenze termometri-
che sono molto usate
nellindustria.
TERMOCOPPIE
Le termocoppie sono
sorgenti attive che
producono un segnale
in tensione (mV). La differenza di
temperatura misurata al punto di
rilevamento ed il dato di riferi-
mento trasformata in valore as-
soluto con compensazione del giun-
to freddo. Normalmente nellin-
dustria questi sensori sono utiliz-
zati per le alte temperature, quel-
le cio fuori dalla normale gamma
di misura delle resistenze ter-
mometriche. Le termocoppie
hanno il vantaggio di non ne-
cessitare di una corrente di
controllo e di lavorare a tem-
perature molto elevate.
Figura 2 - Vari tipi di isolamento
VETRINA SENSORI
76.800 punti
sotto controllo termico
La termocamera a infrarossi Ther-
moVision A40 di Flir (www.flir.it)
concentra in s la potenza di un
sensore con risoluzioni di 320 x 240
pixel; la possibilit di connessio-
ne FireWire e Ethernet; la robu-
stezza e la perfezione tecnico-co-
struttiva necessarie per il fun-
zionamento 24 ore su 24 in qual-
siasi condizione ambientale e cli-
matica.
Dotata di un detector microbolo-
metrico non raffreddato di ulti-
ma generazione, la ThermoVision
A40 rileva immagini allinfraros-
so composte da 76.800 punti, di cia-
scuno dei quali possibile misu-
rare la temperatura e utilizzare ta-
le dato per innescare processi
automatici di intervento di vario
tipo, che scattano sulla base di
parametri o di soglie program-
mate in precedenza dallopera-
tore.
Di peso inferiore a 1,4 chili, com-
patta, solida e resistente agli ur-
ti, la ThermoVision A40 opera
nellintervallo tra -40 e +2000C,
cogliendo differenze di 0,08C.
Le funzionalit di I/O consentono
di integrare la A40 in qualsiasi
sistema di controllo, oppure di
configurarla come sistema indi-
pendente.
Diverse le possibilit di connes-
sione. Per trasferire in tempo rea-
le immagini e dati si pu sce-
gliere linterfaccia digitale Ieee-1394
FireWire. Per integrare la termo-
camera in sistemi complessi di
automazione si opta per la con-
nessione Ethernet.
Un meccanismo innovativo di au-
tofocus consente la messa a fuo-
co con comando a distanza.
servizio lettori 113
Sensori per rilievo
diretto di forze e pesi
Tekkal (www.tekkal.com) pro-
pone una linea completa di sen-
sori per rilievo diretto di forze e
pesi (a compressione, trazione,
trazione/compressione, cilindri-
che, a mensola, anello, ecc.).
I campi di misura variano da un
minimo di 0/100 g a 0/1.000
t, con tutti i valori inter-
medi.
I valori di precisione vanno
dallo 0,02% allo 0,5% (nei
vari modelli).
Sono disponibili versioni
speciali per applicazione
diretta su macchine e im-
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 97
Timer e counter con display retroilluminato di facile lettura
Massima precisione
Multiscala fino a 500 ore
Multitensione
Elevato grado di protezione allacqua
M
E
W
-
I
A
d
v
.
2
/
2
0
0
4
Matsushita Electric Works Italia srl
37012 Bussolengo (VR) - Via del Commercio 3-5
Tel. 0456752711 - Fax 0456700444
e - mail: info@matsushita.it
internet: www.matsushita.it
Info-Fax 045 6700444
Ho letto linserzione su................................................................................
Desidero ricevere maggiori informazioni su Timer-Counter NAIS
Nominativo..................................................................................................
Indirizzo.......................................................................................................
Localit....................................................Prov:...........Cap:.........................
Tel..............................................Fax............................................................
e-mail...........................................................................................................
Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Tempi e conteggi precisi
per lautomazione efficiente
Tempi e conteggi precisi
per lautomazione efficiente
servizio lettori 1799
Le termocamere prevedono una serie
completa di accessori comprendente
ottiche che vanno dal grandangolare
al teleobiettivo
@
Servizio lettori
Semplice e rapido:
registratevi al sito
www.serviziolettori.it
Vi sar assegnata una
password personalizzata
e riceverete direttamente
dalle aziende
le informazioni richieste.
pianti, anche preesistenti e con
limitato spazio disponibile, in
qualsiasi contesto, anche per
applicazioni marine di profondi-
t (IP 68). In generale le dimen-
sioni sono estremamente com-
patte. Le tecnologie adottate so-
no di tipo a strain-gauges metallici
resistivi, per misure statiche e
dinamiche (frequenza propria fino
a oltre 10 kHz nei vari modelli). Il
segnale in uscita consente une-
laborazione intelligente dei valo-
ri di misura acquisiti. disponibile
anche una linea di strumentazio-
ne completa di lettura, controllo,
eccetera.
servizio lettori 114
Celle di carico
Le celle di carico Tempo Techno-
logies rappresentano un punto
di riferimento per il rapporto qua-
lit-prezzo nel mercato della pe-
satura e dosaggio.
In particolare si evidenziano le
celle off-center sia per piccole
portate (modelli Aga, Aha, Aaa,
Aac) da 300 grammi a 45 Kg fon-
do scala, sia per le celle off-center
di medio-alta portata (modelli
Aka, Aea, Ada, Afa, Afb) da 60 a
1000 Kg fondo scala che permet-
tono di montare su ununica cel-
la piattaforme fino a 120x120 cen-
timetri. Sono celle di carico adat-
te per le pi svariate applicazioni
nel campo medicale, chimico, in-
dustriale e uniscono unottima
qualit ad un prezzo estrema-
mente contenuto.
Altro punto di forza delle celle
Tempo Technologies sono le cel-
le flessione e taglio come ad esem-
pio i modelli Ada, Sda, Sdc e le cel-
le a S (zeta) con i modelli 7000, Aba,
Sba, Sbb, Sbc con portate da 5
kg fondo scala fino a 40 tonnella-
te di fondo scala.
Picotronik (www.picotronik.it)
di Mirandola distribuisce in Ita-
lia questi prodotti, ed in grado
di dare il supporto tecnico per
ogni esigenza e fornire o pro-
gettare le varie elettroniche di
condizionamento, lettura e tra-
smissione sia analogiche che a mi-
croprocessore con risoluzione fi-
no a 100.000 punti.
Le celle sono sempre disponibili a
magazzino per campionature o
preserie e alcune portate sono
gestite anche in quantit. Si rea-
lizzano personalizzazioni su spe-
cifica del cliente anche per modeste
quantit, come ad esempio il mon-
taggio di connettori, cavi di lun-
ghezza maggiore o lavorazioni
meccaniche supplementari.
servizio lettori 115
Temperature e vibrazioni
Masautomazione propone una va-
sta gamma di sensori, tra cui alcune
serie per la misura di grandezze fi-
siche quali temperatura e vibra-
zioni. I trasmettitori di tempera-
tura non a contatto della serie Con-
vir IL con uscita parallela per PC e
4 - 20 mA prodotti dallinglese Ca-
lex sono sensori pirometrici, cio mi-
surano la temperatura non a con-
tatto e producono in uscita un se-
gnale 4-20 mA linearizzato e pro-
98
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Settembre 2004 www.reedbusiness.it
VETRINA SENSORI
Lanalizzatore di combustione
Chemist
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
8
8
Sensori per la misura della
temperatura non a contatto Calex
VETRINA SENSORI
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 99
porzionale alle variazioni della tem-
peratura. Il segnale di uscita 4-20
mA a due fili ha una precisione ti-
pica del + 1% e pu essere inviato
a qualsiasi strumento di misura, re-
golatore o registratore che abbia un
ingresso di questo tipo, oppure di-
rettamente su un PC o su un Plc
senza interporre schede di con-
versione o di linearizzazione. Ma-
sautomazione offre unampia gam-
ma di strumenti Kubler o Kep com-
patibili con i sensori Calex.
Inoltre i sensori pirometrici della se-
rie Convir-IL hanno un cavo ter-
minante con connettore da inseri-
re alla porta parallela del PC e so-
no forniti con il relativo dischetto
di software. Tramite il PC i senso-
ri possono essere programmati in
una specifica gamma di tempe-
ratura entro - 20C e 500C per
avere una migliore risoluzione del
segnale di uscita. Si pu inoltre
programmare il coefficiente di emis-
sivit tra 0,1 e 1.0 e registrare sul
PC i valori istantanei o di minimo
e massimo della misura o il valore
medio in un determinato interval-
lo. Il software riporta i coefficien-
ti di emissivit per una vasta gam-
ma di materiali.
I due modelli disponibili IL 101 e IL
301 hanno una risoluzione ottica ri-
spettivamente di 10:1 e di 30:1,
intendendo con risoluzione ottica
il rapporto tra la distanza del sen-
sore e le dimensioni minime del-
loggetto di cui si vuole rilevare la
temperatura.
Con il modello IL 301 ad alta riso-
luzione si pu rilevare un oggetto
di diametro di 16 mm a mezzo me-
tro di distanza o di soli 11 mm ad
una distanza di 360 mm.
In genere questi sensori vengono
utilizzati quando non si pu porre
una sonda a contatto del materia-
le se questo in movimento, se
sotto tensione elettrica o se vi il
pericolo di contaminazione. I tra-
smettitori di temperatura non a
contatto Calex sono quindi parti-
colarmente interessanti e a prezzi
competitivi.
Masautomazione rappresenta inol-
tre la societ inglese Monitran,
produttore di sensori di vibrazione,
di spostamento non a contatto e
Lvdt. Particolarmente affermata
sul mercato internazionale la
nuova linea dei sensori di vibrazione
con uscita 4-20 mA direttamente
proporzionale al valore della vi-
brazione espressa in g o della ve-
locit in mm/sec. Facilmente col-
legabili ad un Plc, consentono un
monitoraggio continuo del livello del-
la vibrazione e sono forniti con
protezione IP 67 e ampia gamma di
temperatura operativa da -25C a
+100C. Fornibili anche esecuzio-
ni antideflagranti e completamente
sommergibili con protezione IP 68.
Questi sensori vengono sempre
pi utilizzati per la manutenzione
preventiva di macchine ed impianti
dove il superamento del livello
consentito della vibrazione un
indice preciso dallarme che con-
sente di fermare la macchina e
controllare lo stato dusura o un non
corretto uso o montaggio della
stessa prima di pervenire a danni
irreparabili.
Un nuovo sensore chiamato De-
fender stato posto in produzio-
ne di recente dalla Monitran. Que-
sto sensore dotato di un display
a cristalli liquidi che d unindica-
zione locale dello stato delle vi-
brazioni della macchina su cui
montato. Alimentato a batteria
della durata di 5 anni, comple-
Sicurezza,
dolce sicurezza.
u
e
!
Sistema antintrusione. Rivelatori a 17 fasci su 4 piani, antitamper ottico, centrale a due
moduli a 4 tasti per la programmazione con display grafico e men interattivo. D performance antifurto ai
vertici del mercato. E integrato nel bus del sistema domotico, per dialogare con
gli allarmi tecnici, controllare scenari, gestire il clima. Facilit di gestione e razio-
nalizzazione del numero dei componenti dimpianto: dolce la sicurezza, con Idea.
www.vimar.it
Ener gi a pos i t i v a.
servizio lettori 1801
Sensori di vibrazione Monitran,
unampia gamma per molteplici
applicazioni
VETRINA SENSORI
100
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
zatore. sufficiente montarlo in
qualsiasi posizione su una mac-
china tramite il suo perno filettato
e senza alcun collegamento elettrico
o stesura di cavi d alloperatore co-
stantemente lo stato di salute del-
la macchina.
servizio lettori 116
Laffidabilit
in un pressostato OEM
Beta - distribuita da Innovative In-
struments (www.innovativein-
struments.com) - propone un pres-
sostato OEM denominato Beta-
mini per le applicazioni industria-
li pi impegnative.
Nessun costruttore di macchine
pu sottovalutare la qualit dei
componenti selezionati.
Il risultato un pressostato ad ac-
coppiamento diaframma/pistone
con regolazione di campo a parti-
re da 300 mbar fino a pressioni di
540 bar, anche in presenza di for-
ti variazioni di pressione (oleodi-
namica). Per tutti i campi di mi-
sura, inclusi i bassi campi, la pres-
sione di lavoro pu arrivare a 400
bar continui, con punte di 650 bar.
Il principio Beta si basa su un sen-
sore a pistone auto allineante di al-
tissima qualit. Il pistone, con una
corsa limitata, trasmette la pressione
dal diaframma direttamente al-
linterruttore senza alcun mecca-
nismo di collegamento, proteg-
gendo cos lo strumento contro
sovra pressioni elevate. Il dia-
framma isolato dal processo tra-
mite O-ring di tenuta, contenuto nel
tronchetto di connessione. Que-
sti tre elementi - diaframma - O-ring
- connessione al processo - sono i
soli a contatto con il fluido e sono
disponibili in una vasta gamma di
materiali.
Con lo stesso criterio costruttivo dia-
framma/pistone vengono prodot-
ti termostati a bulbo diretto o con
capillare termometrico.
Sia i pressostati che i termosta-
ti hanno in comune la stessa co-
struzione meccanica (diametro ci-
lindro 40 mm in acciaio inox), lo
stesso contatto elettrico SPDT con
rating di 250 V a.c. - 3A, lo stes-
so sistema di regolazione del
campo di misura mediante re-
golazione della ghiera interna, lo
stesso connettore elettrico Din
43650. Il vantaggio di un simile
componente rispetto a quanto
disponibile sul mercato il valore
della ripetibilit della misura in-
feriore allo 0,2% della taratura,
parametro fondamentale per la
sicurezza e continuit dellin-
tervento dallarme.
servizio lettori 118
Sensore di misura digitale
Il nuovo sistema di
misura magnetico
TM+MP200 proposto
dalla Elap di Corsico
(www.elap.it),
composto dalla testina
magnetica TM che,
scorrendo senza contatto
sulla banda magnetica
MP200, ne rileva i campi
polarizzati e converte la
misura in segnali
digitali. Proprio in virt
del funzionamento magnetico e dellelevato grado di
protezione della testina (IP67) il trasduttore
TM+MP200 particolarmente adatto allutilizzo in
condizioni ambientali gravose, in presenza di acqua,
olio o grasso. Il trasduttore disponibile con
risoluzione di lettura centesimale (TM100 risoluzione
0,01 mm) oppure decimale (TM10: risoluzione 0,1 mm).
La testina di lettura rende disponibile un impulso di
zero ogni 4 mm, ma comunque possibile ottenere
limpulso di zero in posizione differente utilizzando
dei magneti esterni. La banda magnetica MP200
costituita da un nastro in plastoferrite, magnetizzato a
distanza regolare (passo 2+2 mm), supportato da un
nastro in acciaio inox: possibile arrivare a corse di
misura sino a 50 metri. Linstallazione del sistema
estremamente semplice ed economica, la misura
ottenuta precisa, con un ottimo grado di ripetibilit.
servizio lettori 117
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
1
5
VETRINA SENSORI
Gli ultrasuoni
nelle applicazioni industriali
di rilevamento
Rockwell Automation propone
la nuova linea di sensori ad ul-
trasuoni della serie 873P, pro-
gettata per il rilevamento senza
contatto di solidi e liquidi, con ti-
piche applicazioni di misurazio-
ne che includono il controllo di li-
vello, la misura del diametro, la
misura della distanza e il controllo
della presenza, che rendono que-
sto tipo di sensore utile ed ap-
plicabile in molti settori indu-
striali anche molto diversi, come
quello automobilistico, della mo-
vimentazione materiali e del con-
fezionamento. I modelli dispo-
nibili si suddividono tra versio-
ni standard e programmabili en-
trambe con corpo plastico - PBT,
ed hanno un
dia-
metro di
18mm e 30 mm, con un
grado di protezione IP67 e
temperatura di lavoro com-
presa tra -15C e 70C.
Le distanze di rilevamento che ca-
ratterizzano la versione stan-
dard vanno da un minimo di
100mm ad un massi mo di
2500mm, con tre differenti in-
tervalli di sorveglianza (100-
600mm, 200- 1500mm, 300-
2500mm), con possibilit di scel-
ta per ogni intervallo tra uscita
discreta NO (Pnp) che commuta
il proprio stato quando loggetto
si trova allinterno del campo di
funzionamento del sensore o
analogica rispettivamente in cor-
rente da 4-20mA con variazione
lineare crescente passando dal-
la minima alla massima distanza
di rilevamento, o in tensione da
0-10Vcc con variazione lineare
crescente passando sempre dal-
la minima alla massima distanza
di rilevamento; un potenziometro
permette la regolazione della
massima distanza cos da poter
realizzare la soppressione di sfon-
do necessaria in alcuni casi per
ignorare oggetti indesiderati nel-
le vicinanze. La tensione opera-
tiva 18/30Vcc e il cono del-
limpulso sonoro di 8.
possibile mantenere il valore
delluscita indipendentemente
dalla rilevazione, tramite la fun-
zione di Hold e ridurre le mu-
tue interferenze tra sensori adia-
centi crosstalk con lausilio
della funzione di sincronizza-
zione. Le versioni 873P pro-
grammabili sono disponibili per
coprire distanze di rilevamento
che vanno da 150mm a 3500mm
e sono configurabili tramite un
pulsante di programmazione po-
sto sul retro del sensore.
I due setpoint programmabi-
li allinterno della zona di rile-
vazione in ogni punto dellin-
tervallo di sorveglianza, per-
mettono la commutazione delle
due uscite discrete di tipo PNP
configurabili come NO o NC;
inoltre secondo il modello scel-
to disponibile unuscita ana-
logica da 4-20mA o 0-10Vcc, con
variazione lineare a pendenza
positiva o negativa rispettiva-
mente nel caso di allontana-
mento o avvicinamento dellog-
getto nella zona di rilevamen-
to, rispetto al sensore stesso.
Due Led di uscita di colore gial-
lo sono riferiti ai due setpoint,
mentre un terzo Led verde indi-
ca il corretto allineamento.
La perdita di alimentazione non
pu essere causa di perdita del-
la programmazione fatta, per-
ch esiste una memoria Ee-
prom per la memorizzazione
delle impostazioni.
Il funzionamento dei dispositivi
ad ultrasuoni pu es-
sere influenzato da varia-
zioni di temperatura ambiente che
nella serie 873P sono per in-
ternamente compensati trami-
te una regolazione automatica
della frequenza dellimpulso so-
noro trasmesso. Nel caso sia ne-
cessario posare il sensore a 90,
per esempio per ragioni di in-
gombro, previsto un apposito
accessorio in plastica o acciaio
inossidabile che effettua la de-
flessione ad angolo retto del se-
gnale.
La protezione contro il cortocir-
cuito, il sovraccarico, i falsi impulsi
ed i disturbi transitori unita-
mente allinversione di polari-
t, rendono questo dispositivo ap-
plicabile in molteplici ambiti in-
dustriali, grazie anche alla tec-
nologia ad ultrasuoni che ben
si adatta alla rilevazione di oggetti
sia metallici che non metallici, tra-
sparenti o opachi, liquidi, solidi
o granulari, con la limitazione
nelle applicazioni caratterizzate
da oggetti di materiale fonoas-
sorbente come la stoffa, la gom-
ma, la farina e la schiuma, sen-
za per risentire molto della pre-
senza di eventuale condensa
contrariamente a quanto avvie-
ne con i sensori fotoelettrici.
servizio lettori 119
Igrometri primari
e generatore di umidit
GE Infrastructure Sensing ha in-
trodotto recentemente sul mer-
cato la nuova generazione di
igrometri primari, denominati
Optica.
Questa una nuova linea di igro-
metri a condensazione con trac-
ciabilit Nist che pos-
sono essere impie-
gati come strumenti
primari per tarare e
verificare sensori e
strumenti per misura
dellumidit utilizza-
ti nel settore indu-
striale, nella building
automation, nel set-
tore meteorologico e
nella telemetria. Que-
sti igrometri forni-
scono unottima sta-
bilit a lungo termine
e unottima accura-
tezza e per questo
sono indicati per im-
pieghi nei processi di
validazione nellin-
dustria farmaceutica, nei test di
emissioni dei motori per il settore
automotive e aereospace, per
test di scambiatori di calore e
componenti per la climatizza-
zione e nella produzione e ri-
cerca di celle a combustibile.
Optica disponibile in diverse
configurazioni; le dotazioni prin-
cipali sono il display Vga nu-
merico e grafico, le uscite ana-
logiche e digitali, lautodiagno-
stica e un facile interfacciamento
con loperatore. Gli utilizzatori
possono inoltre accedere allo
strumento per settare i para-
metri, vedere i dati acquisiti e la
diagnostica tramite Internet o
Lan. GE General Ea-
stern Instruments,
societ del grup-
po GE Industrial
Systems, ha invece
introdotto la nuova
linea di prodotto
Humilab.
Questo strumento
consiste in un ge-
neratore di umidit
con tracciabilit Nist
la cui camera ha di-
mensioni ideali per ef-
fettuare la verifica e la
taratura di diversi tipi
di sensori, trasmettitori
e strumenti per la misura del-
lumidit relativa, utilizzati in
svariate applicazioni.
Il principio di funzionamento del
generatore Humilab basato
sul metodo del flusso diviso, mi-
scelato proporzionalmente in
modo da ottenere una stabilit
dell Umidit Relativa pari a 0,2%
U.R. Un igrometro a specchio
raffreddato installato nella ca-
mera misura continuamente il
valore di umidit allinterno del-
la stessa inviando poi questi da-
ti al controllore a microprocessore
del generatore. Con Humilab si
pu ottenere unaccuratezza di
+/-1,5% U.R nel campo da 10 a
80% U.R. e +/-2% U.R. nel cam-
po da 80 a 90% U.R.
servizio lettori 120
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 101
Gli igrometri primari Optica forniscono una misura
primaria dellumidit in termini di temperatura di
rugiada
Servizio lettori
Volete ricevere
ulteriori
informazioni
sui prodotti
presentati dal
Giornale
dellInstallatore
Elettrico?
Compilate
la cartolina che trovate
nellultima pagina, ritagliatela e inviatela
via fax al numero: 02 36519123.
Il servizio totalmente gratuito
Il volume della camera
di misura di Humilab,
pari a 10,6 l, permette di tarare
contemporaneamente diversi
igrometri, senza per sacrificare
la portatilit dello strumento
VETRINA SENSORI
102
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Sensori di pressione
e allinfrarosso attivo
I sensori di pressione per aria e
gas non corrosivi DP5/DPH (nella
foto) proposti da Matsushita Elec-
tric Works sono adatti a svariate ap-
plicazioni, tra cui il controllo di bot-
tiglie in Pet.
Sono stru-
menti di
m i s u r a
composti
da due par-
ti: una te-
sta che al-
loggia il tra-
sdut t or e
(DPH con
uscita ana-
logica, or-
dinabile se-
p a r a t a -
mente) e lo
strumento
di controllo visualizzatore (DP5). I
Led del display bicolore virano dal
verde al rosso quando si raggiun-
ge il valore di soglia impostato.
La testa separata permette di au-
mentare la precisione e diminuire
il tempo di risposta. Pesando solo
6 g, tale testa pu essere montata
su tastatori e ventose di suzione mo-
bili. I valori di fondoscala sono:
0..1, 0..+10, -1..+1 bar, con visua-
lizzazione a scelta tra sei unit di
misura. Oltre alluscita analogica,
vi sono due valori di soglia impo-
stabili e funzioni come lautorife-
rimento rispetto alla sorgente di
pressione e lautozero. Il sensore
a infrarossi attivo Amb utilizza la
tecnica di rilevamento a soppres-
sione di sfondo, perch colore e for-
ma delloggetto non influenzino
la lettura. Immune allaccecamento
dalla luce, pu resistere fino a
30.000 lux. La connessione avvie-
ne tramite cavetto quadripolare
con connettore a un capo e terminali
liberi dallaltro. Le tensioni di ali-
mentazione sono 4,5/6,5 V dc o
6,5/27 V dc, con uscita NPN a col-
lettore aperto. Le distanze di lavoro
vanno da 5 cm a 2 m, ma ogni
sensore ha una distanza di lavoro
fissa che azzera i tempi di taratu-
ra in caso di sostituzione del com-
ponente.
servizio lettori 121
Sensore analogico
a linea fotosensibile
Wenglor Sensoric (www.wenglor.de)
introduce una importante novit nel
campo dei sensori analogici ad al-
ta risoluzione. La nuova serie de-
nominata CP funziona con emissione
laser e ricezione con linea di foto-
diodi, sistema che garantisce una
bassissima deriva termica e una
linearit minima.
Inoltre la linea di fotodiodi assicu-
ra unuscita praticamente indi-
pendente dalle caratteristiche su-
perficiali degli oggetti da misurare.
Questo si traduce nella possibilit
di affrontare con affidabilit la mi-
surazione di superfici riflettenti di
qualsiasi colore. Anche la posizio-
ne angolare del sensore rispetto al-
loggetto, con il nuovo sistema, ri-
sulta molto pi semplice da gesti-
re visto che il sensore accetta no-
tevoli inclinazioni anche con le su-
perfici pi riflettenti. La serie CP
disponibile in due versioni con
campi di lavoro 40-160 mm e
50-350 mm con linearit del-
lo 0.2% e 0.4%. I nuovi sensori
sono molto versatili, oltre che
per le caratteristiche sopra
descritte, anche per la possi-
bilit di selezionare il tipo di
uscita tra 0-10 V, 4-20mA, o in-
terfaccia RS232 semplice-
mente premendo un pulsan-
te sul sensore stesso. CP
racchiusa in una custodia IP67
con connettore ruotabile M12x1
di soli 50x50x20mm.
servizio lettori 123
Pesacarico digitale
I costruttori di sistemi di sollevamento
e di veicoli hanno spesso la neces-
sit di misurare il peso del materiale
movimentato evitando di avere so-
vraccarichi o, nel caso di veicoli, ri-
baltamenti. DS Europe (www.dseu-
rope.com), costruttore italiano di
sistemi di misura con esperienza
trentennale, per soddisfare que-
stesigenza propone il Pesacarico Di-
gitale Mod 699. Il sistema Pesaca-
rico Digitale 699 composto dal
giunto mod. 942 e dallelettronica di-
gitale mod. 699. Il giunto di misura
mod. 942 misura il peso ap-
plicato sui sistemi di solleva-
mento e sui veicoli misurando
la deformazione meccanica a
flessione che questo produce
sulla struttura in acciaio (arcata
ascensore, scocca veicolo etc.)
e la trasforma in un segnale
elettrico tramite un ponte
estensimetrico a 4 bracci atti-
vi. Il mod. 942 amplifica mec-
canicamente il segnale, di
basso ingombro, pu misura-
re qualunque forza e trasforma qua-
lunque struttura in acciaio in una cel-
la di carico per pesatura. Lelettro-
nica mod. 699 alimenta il giunto
mod. 942 e ne riceve il segnale tra-
mite un convertitore A/D 24 bit
avendo quindi unalta risoluzione tra-
mite un display a 4 cifre a Led ros-
si. Il mod. 699 - che pu essere ven-
duto inscatolato con frontalino op-
pure come scheda a vista - pu an-
che sommare opzionalmente i segnali
da due giunti mod. 942 nel caso la
piattaforma del sistema di solleva-
mento sia di grandi dimensioni od
il veicolo sposti il suo baricentro
con zampe stabilizzatrici. Lelettro-
nica mod. 699 ha 2 livelli di allarme
con uscita a rel ed opzionalmente
anche 3. Il mod. 699 pu anche tra-
smettere la misura in digitale tramite
porta seriale RS485, RS422 o CAN
Open. Il mod. 699 estremamente
facile da tarare ed usare grazie al
suo men semplificato, ai 4 pul-
santi ed ai messaggi di segnala-
zione derrore.
servizio lettori 124
Sensori a forcella metallici
I sensori a forcella della serie SRF di Datasensor
(www.datasensor.com) sono dispositivi
fotoelettrici ad elevata precisione con LED
ad emissione rossa per risoluzioni
fino a 0,3 mm. La particolare
forma ad U con ricevitore
e proiettore
contrapposti, unita
allelevata resistenza
del contenitore in
metallo, rendono il
montaggio
estremamente semplice e veloce, con un funzionamento
affidabile e resistente agli urti e alle vibrazioni. La serie
SRF comprende versioni con incavi da 30, 50, 80 e 120
mm per meglio adattarsi alle esigenze delle pi svariate
applicazioni quali la rilevazione di etichette su supporto
trasparente, il monitoraggio della corretta posizione e
dimensione di materiali oppure il conteggio di oggetti su
nastri trasportatori. Limpostazione della sensibilit
facilmente regolabile tramite un trimmer posto sul lato
posteriore. Questultimo dispone di un Led rosso con
visibilit a 360 per la segnalazione dello stato
operativo. La gamma presenta versioni sia con uscita
Pnp che Npn e in ognuna di queste la selezione della
modalit luce/buio.
servizio lettori 122
servizio lettori 1572
servizio lettori 1782
104
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Le schede tecniche
T
A
G
L
I
A
E
C
O
N
S
E
R
V
A
Il modo di vivere e di lavorare
in continua evoluzione e le
innovazioni tecnologiche
contribuiscono a questo
cambiamento introducendo
nuovi tipi di applicazioni.
Nelle case del futuro sar di
vitale importanza una corretta
pianificazione delle installazioni e
dei sistemi di cablaggio,
centralizzando pi applicazioni in
modo da poterle gestire anche
con la normale linea telefonica. Il
cablaggio residenziale Home
System - proposto da Qubix
(www.qubix.it) - il sistema per
cablare la casa e per renderne
pi sicuro e piacevole il
soggiorno. Su questo argomento
sono state recentemente
pubblicate
dal Cei le
guide della
serie 64-50 per
lintegrazione nelledificio
degli impianti elettrici
utilizzatori e per la
predisposizione di
impianti ausiliari,
telefonici e di
trasmissione dati.
I requisiti fondamentali di
un sistema di cablaggio in
ambiente residenziale si
possono riassumere in:
semplicit di prima
installazione, che consente un
rapido set-up del sistema,
modularit dei componenti, per
affrontare il processo di
integrazione dei dispositivi
anche in successivi momenti,
con importante frazionamento
dei costi,
integrabilit, che consente di
utilizzare componenti
intercambiabili con pi funzioni
integrate, per ridurre il numero
di apparecchiature da dislocare
nellappartamento/casa.
Le proposte del sistema di
cablaggio in ambiente
residenziale sono rivolte alle
seguenti applicazioni:
soluzione dati
soluzione telefono
soluzione catv-tv
soluzione sat-tv
con la possibilit di distribuire le
prese utenza (pc, telefono, fax,
catv-tv, sat-tv) allinterno
dellabitazione, con relativa
gestione centralizzata.
La gamma di prodotti Qubix
Home System comprende:
soluzione rack, con rack da
incasso e da esterno profondit
100 mm, per contenere moduli
Home System, rispettivamente:
h 400 mm x l 400 mm, 12U
incasso; H 750 mm x L 400 mm,
24U incasso; H 300 mm x L
180 mm, 4U esterno; H 400
mm x L 180 mm, 6U esterno;
soluzione dati, con Patch panel
a 4/8 porte 110 Idc/RJ45 cat.
5E, per collegare attraverso i
cavi a 4 coppie di cat.5E
Utp/Ftp punti utenza dati;
patch cord RJ45-RJ45 Utp Cat.
5E da 0,25 m e 0,50 m, per
eseguire le permutazioni dal
patch panel alle
apparecchiature attive hub,
switch, router, access point...;
mini switch, switch a 5 port;
soluzione telefono, con moduli
telefonici a 8/12 porte con
connettori 110 Idc per
realizzare la commutazione
passiva delle linee telefoniche
e filtro Dsl telefonico un
ingresso RJ45 e 4 uscite
indipendenti RJ45;
soluzione catv-tv, con partitore
catv-tv, connettori tipo f con 4/8
uscite ed 1 ingresso;
amplificatore catv-tv; connettori
tipo F 1 ingresso - 1 uscita;
soluzione sat-tv, con multi-
switch sat-tv, con 4 uscite, 3
ingressi (Lnb A 13V/14V, tv
antenna, Lnb B 17V/18V) 40-
2400 MHz, connettori tipo F;
miscelatore sat-tv, con 2
uscite (tv antenna e sat) e 1
ingresso, 40-2400 MHz,
connettori tipo F. (F.C.)
servizio lettori 125
Lutilizzo di nuove
applicazioni
dati/video a larga
banda ha creato
la necessit
di diffondere
il cablaggio
strutturato anche
nelle applicazioni
in ambienti
residenziali
Per facilitare linstallatore ad integrare pi applicazioni,
sono stati progettati nuovi cavi a struttura singola o
mista, denominati Home Way.
Il primo, R7ST4H22, formato da 4 coppie 22/1AWG
singolarmente schermate di categoria 8 (1200 MHz),
adatto a soddisfare tutte le applicazioni relative ai
sistemi di distribuzione dati e segnali video, conforme
allo standard Iso/Iec 15018. Con questo cavo si ha il
vantaggio che ogni singola coppia pu essere utilizzata
per applicazioni indipendenti rendendo possibile gestire
contemporaneamente qualsiasi tipo di applicazione.
Il secondo cavo, Econet 0835/Ftp Twin Cables,
costituito da due anime: la prima coassiale sat, per
applicazioni video a 3 GHz, e la seconda per applicazioni
dati/telefono lan, formata da 4 coppie di categoria
5Enhanced con schermatura globale per applicazioni dati
fino a 1000 BaseT (Gigabit Ethernet).
Il terzo cavo, Netbus Eib, con tipologia a quarta (2
coppie), ideale per il collegamento di sensori e attuatori
distribuiti allinterno delledificio residenziale.
I TRE CAVI HOME WAY
Rack da incasso
e da esterno
Patch cord
RJ45-RJ45
Utp Cat. 5E
Il sistema per cablare
labitazione
Mini switch
a 5 porte
Multi-switch sat-tv con 4 uscite
e 3 ingressi
Le schede tecniche
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004
105
T
A
G
L
I
A
E
C
O
N
S
E
R
V
A
La scelta di nuclei
ferro-magnetici
con alto rendimento
e a bassa dissipazione
permette di avere
dispositivi con
ingombro contenuto
Come prescritto dalle
norme, i trasformatori
modulari Siemens
(www.siemens.it) si
dividono in due principali
famiglie, a seconda
dellimpiego svolto:
trasformatori per
campanelli (per servizio
intermittente), fino a 40
VA con tensioni da 4 V a
24 V c.a., conformi alla
norma Cei EN 61 558-2-8,
per lalimentazione di
campanelli, di ronzatori
per bagni e docce,
dimpianti citofonici e
dapertura porta
condominiali e di rel
passo-passo. Sono inoltre
disponibili trasformatori
ad un secondario con
suoneria o ronzatore
incorporato;
trasformatori per servizio
continuo, fino a 63 VA e
con tensioni da 8 V a 24
V, conformi alla norma Cei
EN 61 558-2-2, idonei ad
applicazioni industriali e
funzionali come
alimentazione di circuiti di
sicurezza a corrente
alternata in bassa tensione
costituiti da rel di comando
e da contattori. In tale
gamma sono previsti anche
gli alimentatori da corrente
alternata a corrente
continua, conformi alla
norma Cei EN 61 558-2-6
idonei ad applicazioni che
vanno dal civile allindustria
per alimentazione in
corrente continua da 12 V e
24 V c.c. rispettivamente a 2
A e 2,5 A di suonerie,
ronzatori, rel di comando e
contattori in circuiti di
sicurezza a corrente
continua in bassa tensione.
I trasformatori Siemens
sono protetti dal
cortocircuito e dal
sovraccarico per
mezzo di una
resistenza Ptc che
provvede ad
interrompere il
circuito del
primario del
trasformatore in
caso di eccessivo
riscaldamento del
nucleo del
dispositivo. Il
ripristino avviene
automaticamente
dopo circa 30
minuti di assenza
di tensione, in
concomitanza con il
raffreddamento del nucleo
ferro-magnetico.
Inoltre, i doppi secondari
permettono di realizzare dei
collegamenti in serie e
parallelo, in funzione dei valori
di tensione e corrente che
sintendono avere in uscita.
(F.C.)
servizio lettori 126
Tipologia Radice Primario Secondario Potenza Impiego Norma
V c.a. V c.a. VA
Trasformatori 4AC3 0.. 230 4, 8, 12 e 24 8, 16, 40 Centralini, apriporta, Cei EN
per servizio 4AC3 1.. comando di rel 61 558-2-8
intermittente passo-passo...
230 Suoneria o 4 Nelle abitazioni, come Cei EN
ronzatore alimentazione del 61 558-2-8
incorporati campanello dingresso
(alimentati dal o dellallarme dei servizi
secondario) bagno e doccia
Trasformatori 4AC3 4.. 230 4, 8, 12 e 24 8, 16, Comando di contattori, Cei EN
per servizio 4AC3 5.. 24, 40 centralini per citofoni, 61 558-2-2
continuo 4AC3 6.. alimentazione di
allarmi continui
4AC2 4.. 230 12 e 24 (c.c.) 40 e 63 Comando di contattori Cei EN
e rel passo-passo, 61 558-2-6
alimentazione di dispo-
sitivi di comunicazione ed
elettronici di sorveglianza,
impianti tvcc
CARATTERISTICHE DEI TRASFORMATORI MODULARI
Trasformatore per servizio
intermittente
Per servizio continuo
e intermittente
Trasformatore per servizio
continuo
106
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Limpianto centralizzato di
aspirazione Sistem-Air
consente di risolvere in modo
brillante e innovativo il
problema delle pulizie negli
ambienti di ogni tipologia di
fabbricato nel quale
comunemente si passa la
maggior parte del proprio
tempo, evitando il ricircolo
delle polveri (gli insidiosi
acari, i fastidiosi pollini e le
polveri fini PM10) che vengono
espulse - attraverso lapposito
sfiato - al di fuori
dellambiente chiuso.
Le centrali aspiranti della
gamma Tecno Activa
presentano la particolarit di
poter essere collegate
allimpianto con tubazioni in
arrivo sia dal lato destro sia
dal lato sinistro; sono
costruite interamente in
materiale plastico che
conferisce caratteristiche di
assoluto rilievo in termini di
rumorosit ridotta al minimo
e grado di protezione IPX4,
che consente linstallazione
anche in ambienti
particolarmente umidi o
allesterno. Il computer di
bordo, di cui la macchina
dotata, permette una corretta
programmazione dei cicli di
manutenzione.
Il contenitore delle polveri
con capacit di 28 litri,
completo di maniglie per il
trasporto, il coperchio
fonoassorbente, il gruppo
motore aspirante con scarico
di tipo convogliato, la scheda
elettronica di controllo e
comando dotata di
trasformatore a 12V per
lavviamento e spegnimento
della centrale protetta da
fusibile completano la ricca
dotazione di questa centrale
aspirante. Le operazioni di
manutenzione ordinaria sono
davvero minime e
particolarmente facili da
eseguire da qualsiasi tipologia
di utilizzatore.
Per tutti i componenti si
prestata massima attenzione
alle normative della direttiva
macchine, senza per
dimenticare le caratteristiche
costruttive e la funzionalit
legate alla potenza, al design,
allaffidabilit e alla praticit
di utilizzo. (F.C.)
servizio lettori 127
Le schede tecniche
Lotta alla polvere
Una centrale aspirante
monofase, costruita per
applicazioni
in ambito civile,
dotata di computer di
bordo per
una corretta
programmazione dei
cicli di manutenzione.
Particolare attenzione
stata posta alla potenza,
allaffidabilit,
alla praticit e al design
T
A
G
L
I
A
E
C
O
N
S
E
R
V
A
Monoblocco costituito interamente in materiale
plastico
Contenitore polveri da 28 litri
Ganci di chiusura e maniglie per il trasporto del
contenitore polveri
Coperchio fonoassorbente
Gruppo motore aspirante con scarico aria di tipo
convogliato
Scheda elettronica di controllo e comando dotata di
trasformatore per l'avviamento e spegnimento della
centrale
LE CARATTERISTICHE
Centrale aspirante della gamma
Tecno Activa
Tutti i modelli delle centrali aspiranti della linea
Tecno Activa sono dotati di collegamento per la
tubazione di sfiato aria e, per le loro caratteristiche
costruttive, possono essere installate in locali tecnici,
condizione necessaria per poter espellere all'esterno
le micropolveri che la cartuccia filtro non riesce a
trattenere.
La tubazione di sfiato aria aiuta inoltre a ridurre il
rumore causato dal gruppo motore.
Per le caratteristiche costruttive (IP 40) e la
silenziosit, le centrali della linea Tecno Activa
possono essere installate anche in ambienti
particolarmente umidi o all'esterno.
Utilizzando l'apposita dima (art. 4300.0) in fase di
predisposizione dell'impianto, verr effettuata una
corretta installazione della centrale aspirante senza
alcuna difficolt, senza errori e senza sprechi di
tempo.
CONSIGLI PER LINSTALLAZIONE
WWW WWW.ser .serviziolet viziolettori.it tori.it
WWW WWW.ser .serviziolet viziolettori.it tori.it
WWW WWW.ser .serviziolet viziolettori.it tori.it
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004
107
Le schede tecniche
T
A
G
L
I
A
E
C
O
N
S
E
R
V
A
Incasso carrabile a led
resistente, compatto,
versatile, facile
da installare,
di lunga durata
Amazon-Led di Philips Lighting
(www.illuminazione.philips.it)
combina tecnologia e robustezza,
qualit e innovazione. Si tratta
dellestensione della gamma di
incassi carrabili decorativi con
sorgenti luminose tradizionali
Amazon con la tecnologia pi
innovativa dellilluminazione: i
led. Proposto in 3 versioni - Mini
4led, Midi 6led e Maxi 12led -
stagno e carrabile, disponibile in
5 differenti colori (bianco, giallo,
rosso, verde e blu), ideale per
creare guide visuali ed effetti di
luce e colore negli ambienti.
Grazie a un indice di protezione
IP67 e alla resistenza fino a una
tonnellata di peso, rappresenta la
soluzione ideale sia per interni sia
per esterni: dal giardino al centro
commerciale, dal parcheggio
allhotel. Il cuore dellapparecchio
costituito dai led ad altissima
emissione luminosa, caratterizzati
da elevata brillantezza. Una
vernice speciale ricopre la scheda
elettronica di alimentazione dei
led e la protegge nel tempo
(tropicalizzazione), mentre un
innovativo sistema di controllo
protegge i led da fluttuazioni
della corrente, allungandone la
vita utile e mantenendone
costanti le prestazioni.
Linvolucro in tecnopolimero,
lanello esterno in acciaio
inossidabile, il diffusore in
vetro satinato (nelle
versioni Maxi e Midi) o
policarbonato (nella
versione Mini)
costituiscono la garanzia di
un apparecchio di qualit.
Il diffusore in vetro
protetto da una sottile
pellicola in policarbonato
che, in caso di rottura, ne
assicura la tenuta evitando
la dispersione di
frammenti e proteggendo i
led dagli agenti
atmosferici. Il sistema
brevettato e protetto dal
marchio Led Guard.
La pellicola in
policarbonato funziona
anche da filtro ai raggi UV,
consentendo linstallazione
anche in ambienti sensibili
allultravioletto. Proposto
anche nella pratica
versione kit, in blister (10
Mini 4led e un
alimentatore), Amazon-Led
risulta semplice e veloce da
installare e, grazie alla durata
ExtraLong, per anni non
richiede alcun intervento di
manutenzione. La scatola da
incasso spaziosa e a perfetta
tenuta; le versioni Maxi e Midi
sono equipaggiate con due
pressacavi rigidi PG11 IP67, la
versione Mini viene fornita
precablata con cavo da 50 cm.
La gamma comprende inoltre
una serie di pratici accessori:
una scatola da incasso per
linstallazione di Amazon-Led
Midi a 6 led, un anello in
alluminio satinato sostituibile
allanello in acciaio inossidabile,
staffe per incasso in controsoffitti
per Amazon-Led Maxi a 12 led e
Midi a 6 led. (F.C.)
servizio lettori 128
Suggestivi percorsi di luce
e colore
Amazon-Led, incasso carrabile in tre versioni
e in cinque colori
Amazon-Led ha indice di protezione IP67
Il trasformatore/alimentatore 230V/24V viene fornito in
scatola da incasso stagna con anello cieco. In questo
modo possibile alimentare fino a 10 Amazon-Led,
integrandolo direttamente nellimpianto. La scatola da
incasso e lanello in acciaio inossidabile semplificano
linstallazione e facilitano la manutenzione.
IL TRASFORMATORE MASTER
Mini 4Led classe III: la versione a 24V Mini
equipaggiata con 4 led. Il corpo in alluminio e il
diffusore integrato in policarbonato satinato.
disponibile anche in un comodo multipack
comprendente 10 apparecchi e un alimentatore
230V/24V. Miniaturizzazione e semplicit duso lo
rendono un apparecchio interessante. Potenza
assorbita: 0,5W
Midi 6Led classe III: la versione a 24V Midi
equipaggiata con 6 led. Il corpo in tecnopolimero e il
diffusore in vetro satinato alloggiato nellanello in
acciaio inossidabile. La compattezza e la solidit ne
garantiscono la flessibilit applicativa sia in ambienti
interni sia esterni. Potenza assorbita: 0,5W
Maxi 12Led classe II: la versione a 230V Maxi
equipaggiata con 12 led. Il corpo in tecnopolimero e
il diffusore in vetro satinato alloggiato nellanello in
acciaio inossidabile. Grazie alla possibilit di
cablaggio passante e alla presenza di trasformatore
integrato la soluzione ideale per applicazioni in
condizioni difficili. Potenza assorbita: 0,8W.
LA GAMMA
Tecnologia e robustezza:
involucro in tecnopolimero,
anello esterno in acciaio inox,
diffusore in vetro satinato o
policarbonato, led a basso
assorbimento
NUOVI CANALI
PORTAPPARECCHI
SISTEMA DLP
N U O V O P O R T A P P A R E C C H I S I S T E M A D L P .
L A F L E S S I B I L I T P R E N D E F O R M A .
www.legrand.it
Montaggio
semplice e veloce
Particolare del coperchio
flessibile
Angoli interni
ed esterni
Innovazione, guadagno e sicurezza.
Con i nuovi canali portapparecchi del Sistema
DLP, Legrand risponde alle vostre esigenze di
rapidit ed efficacia di installazione. E grazie
alla nuova estetica dal profilo arrotondato si
ottiene una integrazione perfetta in tutti i locali.
Il nuovo coperchio di DLP flessibile, riduce le
sporgenze negli angoli, e con il suo sistema di
aggancio costituito da una dentellatura
brevettata si adatta allandamento del percorso.
Garantisce Legrand.
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
3
7
4
servizio lettori 532
Con tecnopolimeri
termoplastici
La richiesta di nuove soluzioni sti-
listiche, maggior qualit estetica,
conformit alla direttiva UE sui ri-
fiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche sono alcune delle
esigenze con cui devono fare i con-
ti le societ manifatturiere che ope-
rano nel settore elettrico. La chia-
ve per soddisfare sia le richieste dei
consumatori che le disposizioni
normative da ricercare nella scel-
ta dei materiali, come dimostra nel
settore elettrico la tendenza a so-
stituire i materiali termoindurenti
con materiali riciclabili nei proces-
si di produzione. Schneider Electric
Espaa SA ha scelto gi da diver-
si anni di utilizzare i tecnopolime-
ri termoplastici per le loro doti di li-
bert di design, facile processabi-
lit, ottima qualit estetica e rici-
clabilit. Per individuare il materiale
pi adatto a soddisfare tutti i re-
quisiti relativi a una importante
serie di prese ed interruttori pro-
dotti nello speciale colore bianco
polare, Schneider si rivolta a GE
Advanced Materials (www.gead-
vancedmaterials.com) e con il suo
supporto ha scelto Geloy. Con le
sue caratteristiche di stabilit cro-
matica, brillantezza e qualit su-
perficiale questo prodotto si di-
mostrato la scelta ideale per que-
sta applicazione in vista. Il ma-
teriale scelto una versione mi-
gliorata della normale resina Geloy
e offre lesatto insieme di proprie-
t e caratteristiche richieste.
Inoltre, le nuove resine Geloy uti-
lizzano la nuova tecnologia ecolo-
gica di autoestinguenza sviluppa-
ta da GE Advanced Materials per
assicurare la conformit ai requisiti
del marchio di qualit ecologica
eco-label. Negli interruttori e nelle
prese Schneider, montati a parete
e per loro stessa natura molto vi-
sibili, la qualit superficiale e la
brillantezza di Geloy, unite alla sua
resistenza allUV, hanno permesso
di ottenere lelevata qualit este-
tica richiesta. Per soddisfare nel
modo pi preciso possibile i requi-
siti tecnici indicati nel capitolato, so-
no stati scelti due gradi: Geloy
Exgy0009 per le cornici e Geloy
Exgy0010, che presenta una resi-
stenza termica pi elevata
(BPT>125C), per le prese di cor-
rente. Il bianco molto utilizzato
nei componenti degli impianti elet-
trici impiegati in edifici residenzia-
li, uffici, hotel e ospedali, ed il co-
lore preferito dalla maggior parte di
consumatori per gli interruttori e le
prese. La resina Geloy utilizzata
per questa applicazione disponi-
bile in un grandissimo assortimento
di colori; oltre che in bianco polare,
stata fornita in color avorio per le
prese e gli interruttori destinate
ad un segmento di nicchia.
servizio lettori 130
Un sistema flessibile
Clipline Complete la nuova ge-
nerazione di morsetti componibili
di Phoenix Contact (www.phoe-
nixcontact.it): con vite, molla, ad in-
serimento diretto e tecnica ad at-
tacco rapido Quickon che mette a
disposizione le tecniche di colle-
gamento ad hoc per ogni applica-
zione. Tutti i sistemi di connessio-
ne sono combinabili tra di loro gra-
zie al sistema di ponticellamento ad
innesto brevettato. Questo com-
porta un notevole vantaggio per il
costruttore di armadi elettrici che
utilizzer gli stessi accessori per
le quattro tecniche di collegamen-
to riducendo sensibilmente i costi
di gestione a magazzino. Tra i com-
ponenti essenziali del sistema di
accessori standardizzati figurano:
- il sistema di ponticellamento ad
innesto che, grazie ai due vani al
centro del morsetto, rende pos-
sibile un ponticellamento a ca-
tena, a gradini o saltato;
- il sistema di prova modulare
che permette di testare ogni po-
sizione con spine individuali in-
seribili a pressione o con spine
di prova multipolari affiancabi-
li singolarmente;
- il sistema di siglatura standar-
dizzato nel quale i morsetti ven-
gono marcati con il nastro Zack.
Come optional disponibile an-
che leconomica siglatura con si-
stemi a trasferimento termico.
Clipline Complete offre allutente
un elevato grado di flessibilit ed
un notevole risparmio sui costi.
servizio lettori 131
Multimetri digitali
Quando le dimensioni sono impor-
tanti, la Serie 110 di Fluke
(www.fluke.it) rappresenta sicu-
ramente la scelta migliore.
Questi piccoli strumenti racchiu-
dono pi funzioni di quante non
ne possiedano molti multimetri di
doppie dimensioni. La serie 110,
costituita dai modelli 110, 111 e
112, offre agli utenti professionali
un multimetro compatto di valore
per una versatile ricerca e ripara-
zione dei guasti. Tutti i modelli of-
frono come standard la misura del
vero Rms A, un display a 6000 pun-
ti e la registrazione dei valori mi-
nimi/medi/massimi; inoltre, la pos-
sibilit di misurare la frequenza e la
capacit li rende decisamente po-
tenti. La classe di sicurezza Cat III
600V e la garanzia di tre anni assi-
curano massima affidabilit.
servizio lettori 132
NOVIT
Novit
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 111
a
c
u
r
a
d
i
Alessia
V
a
r
a
l
d
a
Efficienti sistemi dilluminazione
Mareco Luce (www.marecoluce.it) presenta la tecnologia
led, utilizzata per lo sviluppo di soluzioni nel segmento di
mercato dellilluminazione residenziale e terziaria (uffici,
negozi, luoghi pubblici, eccete-
ra). I Led rappresentano lulti-
ma frontiera di ricerca e svilup-
po delle fonti luminose a rispar-
mio energetico e Mareco Luce
investe mese dopo mese in pro-
gettazione e sviluppo per idea-
re prodotti allavanguardia in
grado di sfruttare pienamente
le potenzialit offerte dalla tec-
nologia. Il Led consente, infatti,
di realizzare efficienti sistemi
dilluminazione tecnica dai con-
sumi ridotti, oppure di creare
architetture di forme e decori di luci colorate e suggestive,
in linea con le moderne esigenze di gusto e di arredo.
servizio lettori 129
Placche realizzate con resina Geloy
La nuova
generazione di
morsetti Clipline
La Serie 110 ha un display a 6000
punti
Modulo display/pannello
operatore
Con i nuovi moduli Mfd-CP4-500
e Mfd-CP4-800 Moeller (www.
moeller.it) offre la possibilit di
collegare unefficiente interfac-
cia uomo-macchina (la medesi-
ma utilizzata per i pi perfor-
manti Mfd-Titan) a tutta la
gamma di micro-controllori easy.
Utilizzando la tecnologia plug
& play possibile collegare di-
rettamente il display della serie
Mfd-Titan (Mfd-80 o Mfd-80-B) ad
un rel di controllo della serie easy
(easy500, easy700, easy800) at-
traverso il modulo di comunica-
zione e alimentazione Mfd-CP4.
La comunicazione tra display
Mfd-CP4 e controllore easy av-
viene mediante interfaccia e cavo
seriale; a questo scopo il modulo
Mfd-CP4 viene venduto comple-
to di 5 mt di cavo di comunica-
zione che pu essere tagliato nel-
la misura che meglio si adatta al-
la vostra applicazione.
I vantaggi di questa soluzione
sono molteplici: ad esempio non
richiesto nessun software o dri-
ver per il collegamento tra Mfd-
CP4 e controllore easy. Il sistema
pu essere cos definito un reale
plug & play.
Il modulo display (Mfd-80 o Mfd-
80-B) viene montato sul pannello,
semplicemente praticando due
fori del diametro di 22,5 mm.
Il grado di protezione del fronta-
le del display IP65 ed offre
unefficiente retroilluminazione
con grado di contrasto e lumino-
sit regolabili.
Per la famiglia di controllori easy
sono disponibili le due seguenti
versioni di Mfd-CP4:
Mfd-CP4-500, per applicazioni
con controllori easy500 ed
easy700;
Mfd-CP4-800, per applicazioni
con controllori easy800 e Mfd-
CP8.
servizio lettori 133
Per la trasmissione di dati
su linee ad alta tensione
Il nuovo sistema power line car-
rier (Plc) Powerlink realizzato da
Siemens Power Transmission and
Distribution (www.siemens.it)
non trasmette soltanto dati di co-
mando, segnali per funzioni di si-
curezza, fax e voce, ma anche in
grado di trasferire dati video sul-
la rete ad alta tensione.
Sviluppato sulla base dei pi re-
centi standard di comunicazione
per reti di alimentazione elettrica,
il sistema plc raggiunge una ve-
locit di trasmissione massima
di 76,8 kbit/s con una larghezza di
banda di 8 kHz. Tramite interfac-
ce standard, Powerlink pu es-
sere integrato anche in sistemi di
comunicazione che impiegano
tecnologie di trasmissione a fi-
bra ottica o satellitari.
Con Powerlink di Siemens le
aziende erogatrici di energia elet-
trica possono estendere la tec-
nologia di trasmissione esistente
per la sicurezza delle sottosta-
zioni di trasformazione senza pre-
sidio o sostituire gli attuali siste-
mi plc per consentire nuove pos-
sibilit di comunicazione nella
propria rete di trasmissione dati.
Questo si applica soprattutto per
i sistemi plc che stanno gi sfrut-
tando appieno i canali disponibi-
li, ma necessitano di ulteriori ri-
sorse: il sistema Powerlink digi-
tale impiega lo spettro di fre-
quenze esistenti in modo tal-
mente efficiente da poter sosti-
tuire da solo fino a sei sistemi
analogici. Nella banda di fre-
quenze limitata rimangono co-
munque capacit per altre fun-
112
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NOVIT
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
1
9
Modulo display/
pannello operatore
per easy 500/700/800
con elevato grado
di protezione
NOVIT
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 113
zioni di comunicazione. dotato
di un on-board multiplexer, che
consente il multiplexing e il de-
multiplexing dei dati diretta-
mente sullunit del processore
dei segnali centrale del sistema.
Il multiplexer trasmette cos i da-
ti in modo asincrono tramite un
massimo di otto canali.
Rispetto alla maggior parte dei si-
stemi tradizionali, Powerlink van-
ta tre canali vocali senza com-
pressione, invece dei consueti
due. Se loperatore impiega la
compressione vocale con multi-
plex, possibile incrementare fi-
no a dodici volte il numero dei
canali vocali, ad esempio per la
telefonia.
Siemens fornisce il Powerlink con
opzione di upgrade al fine di ag-
giungere altre funzioni alle pos-
sibilit di trasmissione gi esi-
stenti, senza che i clienti debba-
no necessariamente disporre a
magazzino di ulteriori compo-
nenti.
La maggior parte degli aggior-
namenti interessano puramente
il software, garantendo cos mas-
sima flessibilit per successive
modifiche o estensioni del siste-
ma plc.
servizio lettori 134
Manopole per tutto
Uniformare la produzione di ma-
nopole per il mercato internazio-
nale continuamente in evoluzione
e adeguarle alle norme di legge
sempre allordine del giorno per i
produttori.
Per questa ragione, la Okw, rap-
presentata in Italia da Alhof di
A. Hofmann (www.alhof.com),
ha sviluppato due gamme di ma-
nopole che garantiscono al pro-
dotto finale una immagine mo-
derna e innovativa, grazie al de-
sign esteticamente piacevole, nel
rispetto degli standard interna-
zionali (Din 41591).
La serie di manopole chiamata
Top-Knobs ha vinto lIF Design
Award ed il prodotto ideale per
potenziometri elettromeccanici a
rotazione; sono disponibili in due
colori per la base (grigio e nero),
diametro da 16 a 40 mm, con 5 di-
verse versioni di marcature late-
rali intercambiabili in 5 colori dif-
ferenti.
Laltra serie denominata Com-
Knobs componibile (corpo base,
coperchio e elemento di marca-
tura) ed quindi adatta per ap-
plicazioni universali. La gamma
disponibile in misure da 16 a 50
mm, modelli e colori uniformi al-
le top-knobs, garantendo cos an-
che una visione armonica se si
utilizzano, sulla stessa apparec-
chiatura, le due serie.
servizio lettori 135
N. 11
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
2
3
8
La serie di manopole chiamata
Top-Knobs
@
Servizio lettori
Semplice e rapido:
registratevi al sito
www.serviziolettori.it
Vi sar assegnata una
password personalizzata
e riceverete direttamente
dalle aziende
le informazioni richieste.
Presa e spina per galleria
Il gruppo FP di Palazzoli (www.pa-
lazzoli.it) realizzato in lega di al-
luminio ed dotato di un inter-
ruttore sezionatore ad alte pre-
stazioni di categoria AC22A e
blocco meccanico.
La serie FP stata realizzata per
erogare 125A senza interruzione
di servizio ad una temperatura
di 400C per una durata non in-
feriore alle 2 ore.
Il progetto FP nato in partico-
lare per installazione allinterno di
gallerie per lalimentazione delle
apparecchiature elettriche quali
per esempio i grossi ventilatori di
aerazione, la cui continuit di ser-
vizio essenziale in ogni mo-
mento per lo smaltimento dei gas
di scarico delle vetture in transito
ed addirittura vitale per lo smal-
timento dei fumi derivanti da in-
cendi a seguito di incidenti in gal-
leria. Proprio a seguito degli ulti-
mi incidenti verificatisi (come per
esempio quello avvenuto presso
il traforo del Monte Bianco), le
autorit competenti (ministero e
Anas) hanno adottato provvedi-
menti per lincremento della si-
curezza della circolazione allin-
terno delle gallerie stradali, con
lemanazione di nuove direttive.
Tra queste, si legge nella circola-
re dell8 settembre 1999, si spe-
cifica che il materiale presente
in galleria dovr essere ignifugo,
antifumo e non tossico, ed in par-
ticolare le apparecchiature quali
armature per limpianto di illu-
minazione, i ventilatori e le rela-
tive prese di alimentazione do-
vranno essere in grado di resi-
stere a temperature di 400C per
almeno 90 minuti. Tutte le galle-
rie monodirezionali pi lunghe
di 3000m e per quelle bidirezio-
nali superiori a 1000 m dovranno
essere dotate di impianto di ven-
tilazione per la diluizione degli
inquinanti e dei fumi derivanti da
potenziali incendi.
La presa FP per galleria ha su-
perato la prova di resistenza al-
la temperatura di 400C presso i
laboratori dellIntek superando
ampiamente il limite minimo di
90 minuti specificato nella cir-
colare.
servizio lettori 136
Pi scelta per lenergia
Alberghi, centri commerciali,
ospedali, utilities, call e data cen-
ters, ma non solo. Realt diverse
hanno bisogno di gruppi di emer-
genza e proprio per questa ra-
gione Caterpillar e Cgt
(www.cgt.it) per il 2005 ampliano
ulteriormente la gamma dei grup-
pi elettrogeni per la fornitura con-
tinua di energia elettrica o per
situazioni di emergenza. Con il
3456, il C18 e nuovi modelli della
serie Olympian, che vanno a com-
pletare gli oltre 40 modelli, Cgt
in grado di proporre soluzioni per-
sonalizzate con potenze da 11 a
15.710 kW per molteplici appli-
cazioni. Cgt propone la vendita,
lassistenza e il noleggio di grup-
pi elettrogeni, impianti di coge-
nerazione, sistemi ups, motori
diesel e gas per utilizzo indu-
striale e opera anche nel seg-
114
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NOVIT
UN SERVIZIO TIRA L'ALTRO ICIM
Membro di
Member of
Ispezioni, controlli, collaudi, certifica-
zione di sistemi di gestione e di pro-
dotto, valutazione dei fornitori, expedi-
ting, certificazione siti E-commerce,
direttive, verifiche periodiche di messa
a terra e di ascensori, assistenza
tecnica e formazione.
Fra questi e molti altri servizi ICIM
pu esserci la soluzione alla tua
esigenza.
Migliaia di aziende ed organizzazioni
dell' industria, dell'artigianato, agricol-
tura, terziario, nel pubblico come nel
privato, hanno trovato in ICIM la giusta
risposta.
Prendici gusto anche tu.
ICIM S.p.A.
Piazza Diaz, 2 - 20123 MILANO
Tel. 02-725 4 3 1 Fax 02-72002098
E-mail: icimorg@tin.it
Web site: www.icim.it
w
w
w
.
a
d
v
e
r
t
e
a
s
e
r
.
i
t
servizio lettori 1230
.
Gruppo elettrogeno Olympian
GEP 110 cofanato
NOVIT
mento dei motori marini, per im-
barcazioni da diporto e da lavoro.
I prodotti a marchio Caterpillar
vengono sempre affiancati da una
gamma di servizi a garanzia Cgt:
consulenza nella scelta del pro-
dotto pi adeguato, assistenza
alle aziende nella valutazione dei
costi e dei consumi energetici,
studi di fattibilit sui risparmi
energetici, valutazione degli in-
vestimenti necessari, contratti di
manutenzione programmata, as-
sistenza 24 ore su 24.
servizio lettori 137
Sicurezza e comfort negli edifici
Belimo (www.belimo.ch) studia,
costruisce e commercializza at-
tuatori per lautomazione dei
dispositivi di controllo negli im-
pianti di riscaldamento, ventila-
zione e condizionamento dellaria.
La continua innovazione tecnolo-
gica e lesperienza acquisita con-
tribuiscono alla realizzazione di
componenti sempre pi efficienti e
affidabili per il controllo dei fluidi
negli impianti HVAC e, oltre a ga-
rantire il comfort negli ambienti,
si incrementa la sicurezza delle
persone e degli edifici. Sono rea-
lizzati con materiali eco compatibili
e di elevata qualit per una lunga
vita di servizio. Le loro eccellenti
funzionalit e precisione permet-
tono allimpianto di raggiungere il
livello ottimale di efficienza ed un
conseguente risparmio energeti-
co. Gli attuatori Belimo sono rea-
lizzati con i migliori motori elettri-
ci e ingranaggi e con avanzate tec-
nologie elettroniche di controllo.
La standardizzazione delle funzio-
ni e delle interfacce semplifica la
progettazione e riduce al minimo le
possibilit di errore nellinstalla-
zione e messa in servizio.
servizio lettori 138
Unapplique
per le pareti colorate
Wing di Biffi Luce (www.biffi-
luce.com) nasce dallintuizione
di utilizzare la sezione di unala
quale forma/contenitore per una
lampada alogena. Disponibile co-
me sospensione, applique e da
terra, Wing ribadisce la filosofia
costruttiva del marchio milane-
se: creare apparecchi illuminanti
per la casa, adattabili ad ambienti
diversi e dallutilizzo estrema-
mente flessibile. Unidea elegan-
te e allo stesso tempo creativa
per i punti luce delle pareti colo-
rate. in acciaio cromato opaco e
vetri pirex satinati, a luce orien-
tabile girevole sullasse orizzon-
tale, disponibile in due diverse
dimensioni: Midi da 210X210 mm
e Mini da 140X140 mm.
servizio lettori 139
Telecamera e trasmettitore
per reti Tcp/Ip
Lutilizzo degli apparati che im-
piegano le reti Lan anche come
mezzo trasmissivo del segnale
video sempre pi sviluppato
per cui la Aci Farfisa (www.aci-
farfisa.it) ha introdotto nella sua
gamma elementi in questo am-
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 115
Semplicit nellutilizzo e rapidit nellelaborazione dello schema
Facile approccio al prodotto, tempi dapprendimento limitati
Versione completa scaricabile da internet
Assistenza telefonica gratuita per tutta la durata della prova
Compila il coupon allegato e invialo allo 035 424 3793
P
R
O
V
A
L
O
P
E
R
3
0
G
IO
R
N
I
G
R
A
T
U
IT
A
M
E
N
T
E
on
Niente di pi semplice...
IL NUOVO CAD ELETTRICO IGE-XAO
Con CADdy
++
potete realizzare facilmente e rapidamente
qualsiasi tipo di schema elettrico (potenza, ausiliari,
distribuzione), idraulico e pneumatico, e disegnare
planimetrie civili e industriali.
Societ: _______________________________________________________________________________
Cognome: _____________________________________________________________________________
Nome: _________________________________________________________________________________
Via: ____________________________________________________________________________________
Citt: _________________________________________________________________________________
C.A.P: __________________________________ Prov.: _____________________________________
Telefono: _____________________________________________________________________________
Fax: ___________________________________________________________________________________
IGE-XAO s.r.l. - Via Canovine, 46 - 24126 Bergamo
Tel. 035 459 6167 - Fax 035 424 3793
E.mail: info@ige-xao.it - www.ige-xao.it
Per saperne di pi visita il nostro sito:
www.ige-xao.it
w
w
w
.g
r
a
f
o
c
o
m
.it
7
/
0
4
5
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
2
3
Wing Applique su parete nera
Massima funzionalit per gli attuatori
Hvac
bito specifico. La telecamera a
colori Tvt61Web, oltre alla usua-
le uscita video composito, do-
tata anche di una porta RJ-45
per poter essere collegata a reti
Tcp/Ip. La sua installazione
dunque particolarmente sempli-
ce in tutti i casi in cui una rete
Lan risulti gi cablata (uffici pub-
blici e privati, in-
dustrie...) e per-
mette un efficace
controllo del sito da sorvegliare
tramite Browser o tramite soft-
ware dedicato. Per questo di-
venta decisamente indicata in
tutte le situazioni in cui richie-
sto il controllo, anche remoto, di
immagini provenienti da una po-
stazione di sorveglianza avvan-
taggiandosi della flessibilit del-
la trasmissione del video in tem-
po reale su reti Ip a giovamento
del livello di sicurezza della sor-
veglianza. Il trasmettitore TxWeb
dotato delle stesse caratteri-
stiche e funzionalit della tele-
camera Tvt61Web ma, essendo
concepito mancante della sezio-
ne di ripresa video, permette di
trasmettere un qualunque se-
gnale video composito standard
(b/n o colore) su rete Tcp/Ip. Il se-
gnale da trasmettere, in questo
caso, pu essere prelevato da
una telecamera standard ad es-
so collegabile o da un impianto
tvcc, gi esistente, e poter esse-
re cos trasmesso e visionato con
modalit analoghe a quanto de-
scritto sopra.
Ambedue i dispositivi sono, inoltre,
dotati di porte ingresso e uscita di-
gitali che consentono la trasmis-
sione e la ricezione dellaudio o il
controllo di telecamere tipo Speed
Dome tramite linea RS-485.
Attraverso il software fornito in
dotazione possibile impostare la
velocit e la modalit di trasmis-
sione delle immagini, visualizzarle
in diretta, registrarle su pc, attivare
o disattivare funzioni particolari
come Motion Detector, invio di e-
mail con immagini allegate o mes-
saggi a schermo.
servizio lettori 140
Spazio e luce alla creativit
Philips Lighting (www.eur.ligh-
ting.philips.com/ita_it/) presenta
levoluzione della linea di incassi a
bassa tensione Zadora, una gam-
ma di prodotti dal design accatti-
vante e discreto, realizzati in lega
di alluminio (zamak) e disponibili in
due versioni: fissa e orientabile fi-
no a 30. Da oggi, infatti, Zadora
disponibile in kit elettronico, nel
nuovo imballo visuale, equipag-
giato con linnovativo trasforma-
tore elettronico compatto, leggero,
silenzioso ed affidabile. La versio-
ne in kit, che contiene incasso, lam-
pada e trasformatore, con prote-
zione elettrica in accordo con le
normative Iec 742, semplifica lac-
quisto grazie alla confezione com-
pleta di tutto il necessario. Il tra-
sformatore alimenta a 12Vdc la
lampada alogena dicroica. La gam-
ma Zadora stata realizzata in 8
differenti colori e finiture - bianco,
oro, cromato, brunito, nero, sati-
nato, grigio metallizzato, antracite
- che montano lampade alogene
dicroiche da 50 mm MasterLine Es
con fascio da 8, 24, 36 e 60 per
potenze fino a 50 W. Gli apparecchi
Zadora sono in classe III, conformi
agli standard internazionali Iec598
e soddisfano le norme europee
En60598 edizione 4 - 1999. In en-
trambe le versioni una clip fronta-
le esterna consente una facile ma-
nutenzione grazie allaccesso di-
retto alla lampada. A completare la
116
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NOVIT
In tutte le lingue,
protezione elettrica si traduce:
[ Ferraz Shawmut ]
Quando la sicurezza il criterio principale per la
protezione elettrica, il fusibile la soluzione pi
sicura ed affidabile.
Ferraz Shawmut, grazie alla completa gamma di
prodotti, propone una risposta per ogni esigenza di
fusibili e per ogni normativa.
Ferraz Shawmut il riferimento mondiale per la
protezione elettrica.
Il Carbonio Spa - Via Dei Missaglia, 97/B1 - 20142 Milano - Tel. +39 02 8268131 - Fax +39 02 82681399 - E-mail: protezione@ilcarbonio.it - www.ilcarbonio.it - www.ferrazshawmut.com
Distributore: Elettro Italia - Via Grassina, 9 - 20010 Pogliano Milanese (MI) - Tel. 02 93550779 - Fax 02 93550785 - E-mail: elettroitalia@elettroitalia.it - www.elettroitalia.it
servizio lettori 1217
La telecamera a
colori Tvt61Web
dotata anche di
una porta RJ-45
NOVIT
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 117
gamma Zadora ci sono le versioni
Mini e Deco che si caratterizzano
per le dimensioni molto ridotte ri-
spetto agli altri modelli e per fini-
ture sofisticate. I primi sono perfetti
per creare illuminazione daccento
applicandoli allinterno di mobili o
scaffalature; i secondi si contrad-
distinguono per il design elegante
e delicato e per i vetri decorativi e
i profili metallici di cui sono dotati;
Zadora Deco, anche nei colori rosa
e azzurro, offre uno stile speciale e
raffinato in qualsiasi applicazione.
Particolarmente attraente anche
la versione kit con lampada aloge-
na dicroica Twistline che funziona
a tensione di rete 230V e non ne-
cessita quindi di trasformatore. Ci
consente di installare i faretti sen-
za ricablare limpianto elettrico
standard, in modo rapido e veloce.
Lassenza del trasformatore ne
permette linstallazione anche in
spazi ridotti. Massima garanzia di
sicurezza assicurata per tutta la
gamma Zadora: oltre ad essere
conforme alle norme europee elet-
triche sopracitate, i faretti sono
certificati Vde Enec e hanno grado
di protezione IP20, sono dotati di
connessione di terra, doppio isola-
mento e alimentazione di sicurez-
za a bassissima tensione e a pro-
tezione da scosse elettriche. Zadora
si pu trovare presso tutti i distri-
butori, grossisti e rivenditori di ma-
teriale elettrico.
servizio lettori 141
Tutta la flessibilit
dellenergia
Con la serie di quadri di distribu-
zione Polifemo, Fanton (www.
fanton.com) ha creato una nuova
specie di prodotti elettrici dedi-
cati al settore industriale.
Prendono cos forma prodotti de-
stinati a far cambiare limmagine
che tutti noi abbiamo della sicu-
rezza e del design. Frutto di
unimpegnativa ricerca realizza-
ta nel reparto Fanton R&D, re-
centemente certificato Uni En
Iso 9001:2000, i nuovi quadri di
distribuzione Polifemo si arric-
chiscono di contenuti importanti
come le nuove prese interbloc-
cate serie Key Block e le
nuove cerniere rinforzate
in acciaio inox. I nuovi
quadri di distribuzione
Polifemo sono un prodot-
to dalle elevate presta-
zioni. Il design, la scelta
dei materiali, lampia of-
ferta di modelli e la ricer-
ca di soluzioni innovative come il
sistema produttivo di stampaggio
a soffiaggio, fanno di questo pro-
dotto uno strumento indispensa-
bile per molti ambienti di lavoro.
Sono conformi alle norme Cei En
60439-1 e Cei En 60439-4.
Rispondendo a queste normative
sono definiti di tipo Asc (appa-
recchiatura costruita in serie per
cantiere). La struttura portante in
colore grigio chiaro (ral 7035) co-
struita in materiale termoplastico
con sistema di produzione stam-
paggio a soffiaggio, offre unal-
ta resistenza agli urti, allinvec-
chiamento e ai raggi ultraviolet-
ti. Con grado di protezione IP55,
LA TRIVENETA CAVI
E-mail: info@latrivenetacavi.com
www.latrivenetacavi.com
I cavi,
prodotti in Italia,
pi venduti
in Europa.
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
3
5
I quadri Polifemo Maxi e Midi
La gamma Zadora stata realizzata
in 8 differenti colori e finiture
doppio isolamento elettrico e au-
toestinguenza (glow-wire test
650 C), si conferisce ai prodotti
una idonea sicurezza dimpiego a
quanto stabilito dalle norme dei
cantieri edili. Sono disponibili
quadri con pulsante demergenza
posto allesterno, per linterruzio-
ne dellalimentazione in caso di
pericolo. Possibilit di fissaggio a
parete mediante staffe in dotazio-
ne o a pavimento tramite il sup-
porto in acciaio zincato. Per il tra-
sporto la struttura provvista di
maniglie, ha la possibilit di chiu-
sura a chiave anche con spine in-
serite (il fondo aperto permette
luscita dei cavi). I quadri possono
essere alimentati mediante spina
fissa (adatti per repentini sposta-
menti) o morsettiera (adatta per
supportare amperaggi elevati).
Tutti i quadri cablati in fabbrica
sono corredati di dichiarazione di
conformit e schema elettrico,
inseriti in una apposita cartella
portadocumenti e contraddistinti
da targhette che definiscono le
caratteristiche di ciascun pro-
dotto. In ogni quadro viene in-
serito un kit contenente ferma-
cavo, morsettiera (25 mm
2
), pres-
sacavo, viti, etichette...
servizio lettori 142
Misura il costo
dei consumi elettrici
Quando arriva la fattura del for-
nitore di energia elettrica lunica
cosa che salta subito allattenzio-
ne il costo totale della bolletta,
quella voce in neretto in basso a
destra. Decifrare il resto cosa
difficile, esercizio adatto solo per
gli esperti del settore e cos pochi
sanno che il costo del consumo di
elettricit basato sul calcolo del-
la media oraria dei kW collegati.
Diventa difficile allutilizzatore fi-
nale stabilire quanto costa uno-
perazione semplice come fare il
bucato, o come usare un forno.
Palm Consumer di Elcotronic
(www.elcotronic.it) in grado di
calcolare il costo ora istantaneo ed
il costo totale dallultimo reset,
di qualsiasi operazione domestica.
Basta collegare Palm alla presa
di corrente di casa e lelettrodo-
mestico alla presa del Palm.
Dopo aver inserito il costo per
kWh, indicato nella vo-
stra bolletta, lo stru-
mento visualizzer in di-
retta sulllcd il costo del-
lenergia elettrica che
si sta utilizzando;
inoltre saranno visualizzati tutti i
parametri fondamentali del carico,
che serviranno ad indicare il cor-
retto funzionamento dellelettro-
domestico, come dalle indicazioni
fornite dal costruttore. Inoltre nel-
le versioni superiori, Palm offre
la lettura di altri parametri, come
la dispersione verso terra. Nelle
diverse versioni, a seconda delle
necessit, Palm si presta a capire
non solo quanto si spende di elet-
tricit, ma anche dove e come si
spende; in questo modo pi fa-
cile intervenire e risparmiare sui
consumi di energia. Indicato per il
controllo dellenergia elettrica in
ambiente domestico, grazie alla
dotazione di spina e presa in
grado di visualizzare il costo istan-
taneo e totale dei consumi di un
qualsiasi elettrodomestico. Per
esempio semplicemente colle-
gando lo strumento ad una lava-
trice possiamo sapere il costo di
un ciclo di lavaggio e conoscere il
valore in mA della corrente di dis-
persione e capire se la resi-
stenza, il motore o la pompa che
scarica a terra. Questo facilita il la-
voro del manutentore.
servizio lettori 143
118
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NOVIT
Milano,
17-20 novembre
12
a
mostra
internazionale
biennale
per un mondo
pi sicuro
S
T
U
D
IO
M
A
R
T
IN
E
L
L
O
O
.G
.
P
a
v
ia
www.sicurezza.it
www.intelshow.com
segreteria@fieramilanotech.it
S
I
C
U
R
E
Z
Z
A
2
0
0
4
ASSOCIAZIONE ITALIANA
SICUREZZA ED AUTOMAZIONE EDIFICI
Organizzata da: Promossa da:
RegioneLombardia
Vota on line il tuo
prodotto preferito!
Preregistrati on line
entro il 15 ottobre
Con il patrocinio di:
In contemporanea con:
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
0
3
Strumento di misura dellenergia
elettrica che d istantaneamente
il costo dei consumi elettrici
NOVIT
Affidabili, facili da manutenere,
scalabili e semplici
Industrie di processo, banche,
ospedali, telecom: la maggior
parte delle organizzazioni mo-
derne oggi utilizza complesse
architetture telematiche ed elet-
troniche per sviluppare i propri
processi vitali.
Emerson Network Power par-
tita da queste considerazioni
per ideare la nuova gamma di
Ups Liebert Hipulse E, gruppi
di continuit che, con una po-
tenza tra gli 100 e i 4800 kVA, si
profilano come unefficace ri-
sposta allesigenza di protezio-
ne globale dalle inefficienze del-
la rete elettrica.
La serie Liebert Hipulse E
(www.liebert-hiross.com) si ca-
ratterizza per lalta affidabilit;
in particolare, tutte le soluzioni,
a doppia conversione online,
hanno una tolleranza pi ampia
sia della tensione dentrata (+/-
15%, in parallelo) sia della fre-
quenza dentrata (+/-5%). Le al-
tre caratteristiche sono: il con-
trollo automatico della batteria,
la regolazione manuale della sin-
cronizzazione del bypass, lele-
vata capacit di sovraccarico del
bypass statico, un unico modu-
lo inverter anche per Ups di ele-
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 119
Per lindustria ferroviaria
Weidmller (www.weidmueller.com) collabora con i pro-
duttori del settore ferroviario per rispondere alle esigen-
ze di movimentazione, mediante soluzioni innovative e
su misura per il cliente. Le richieste di mobilit e luso di
sistemi modulari stanno aumentando. Weidmller offre
una gamma completa di morsetti con collegamento a vite
(serie Sak e
serie W), a
molla autobloc-
cante (serie Z)
e Idc - tecnica a
perforazione
disolante
(serie I). Un
gran numero di
prodotti stato
sottoposto ai
test degli stan-
dard ferroviari
come EN 61373,
EN 50155, NF-F
16101, Astm-
E662/152.
WeiCos
(Weidmller
Connection
system) rappre-
senta la nuova
generazione di morsetti, che combina la tecnologia del
morsetto tradizionale con quella del connettore ad inne-
sto. Questa combinazione di diverse tecnologie consente
un cablaggio efficiente, modulare e flessibile, indipen-
dente dal produttore; ci significa che le unit funzionali
prefabbricate, come le lampade o i controlli porte, le pia-
stre di montaggio e i pannelli elettrici possono essere col-
legati alle installazioni esistenti, senza errori e in pochi
secondi - semplicemente inserendo il connettore ad inne-
sto nel terminale.
servizio lettori 144
Morsetti (in senso orario dallalto a sinistra) serie Z,
serie W, WeiCos, serie I
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
4
2
La nuova gamma di Ups Liebert
Hipulse E con una potenza
tra gli 100 e i 4800 kVA
www.serviziolettori.it
Per una risposta pi rapida,
potete usufruire anche del nostro Servizio
Lettori On-Line. Visitate il sito
vata potenza. Questo si traduce
nella capacit di sopportare ca-
richi con elevato fattore di cresta
e la totalit dei carichi non li-
neari e non equilibrati. Tra le
peculiarit della serie Hipulse
E vi , inoltre, la facile manute-
nibilit. Con il bypass di manu-
tenzione incorporato o esterno
(opzionale), gli Ups Liebert han-
no laccesso frontale per la so-
stituzione dei pezzi di ricambio
e la manutenzione preventiva. Si
possono collegare fino a 6 unit
della stessa potenza in paralle-
lo per raggiungere la ridondan-
za desiderata. La versatilit de-
gli Ups poi assicurata dalla
possibilit di
utilizzare qual-
siasi tipo di
batterie (a va-
so aperto, al
piombo erme-
tico e al nickel
cadmio), dalla
possibilit di
regolazione in campo della ten-
sione di fine scarica della batte-
ria e dallopzione di condividere
la stessa batteria da parte di
due Ups collegati in parallelo.
Un timer impostabile per incre-
mentare la durata di carica del-
la batteria e il display multilin-
gue a cristalli liquidi sono altri
due elementi che consentono
allutilizzatore di gestire il grup-
po di continuit con estrema
semplicit.
Alla serie Liebert Hipulse ab-
binato un ampio pacchetto di
soluzioni software per la comu-
nicazione: dal software di mo-
nitoraggio del gruppo di conti-
nuit (HiLink) a quello di spe-
gnimento di computer e server
(MultiLink), dallapplicazione
per il monitoraggio di tutto lim-
pianto (SiteScan) alle soluzioni
per il controllo della qualit del-
lalimentazione (HiView).
servizio lettori 145
Nuova luce in citt
Place linnovativo sistema di il-
luminazione per aree pubbliche
e residenziali presentato da
Gewiss (www.gewiss.com) ca-
ratterizzato da un esclusivo pa-
lo brevettato in alluminio estru-
so, dotato di sei guide verticali
nelle quali vengono inserite fino
a sei sfere, mediante appositi
bracci.
Le sfere possono essere inserite
sul palo a qualsiasi altezza e po-
sizione desiderata e possono es-
sere facilmente spostate anche
a prodotto gi collegato ed ope-
rante poich non esistono punti
di ancoraggio predefiniti, con-
sentendo la massima flessibilit
installativa.
La finitura estetica del palo com-
prende, come accessorio, una
base in alluminio tornito, che
conferisce allinstallazione un
aspetto gradevole e curato.
Tramite uno speciale accesso-
120
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NOVIT
Il display multilingue a cristalli liquidi
consente di gestire lUps con estrema
semplicit
Le fiere dell'innovazione
Fiera di Vicenza | 18-20 novembre 2004
Idee, strumenti e soluzioni in una mostra-convegno
dedicata al marketing ed alla comunicazione dimpresa
A.N.E.S. sar presente con lesposizione delle riviste associate
YOUR MARKETING COACH
A.N.E.S.
Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
8
0
2
@
Servizio lettori
Semplice e rapido:
registratevi al sito
www.serviziolettori.it
Vi sar assegnata una
password personalizzata
e riceverete direttamente
dalle aziende
le informazioni richieste.
UN AMICD FEDELE
Lince talia Srl - Via Mura dei Francesi, 26 - 00043 Ciampino, Roma, taly
Tel. +3906790331- info@linceitalia.it
Lince Nord talia srl - Via G. Garibaldi, 39 - 10090 San Giorgio C.se, Torino, taly
Tel. +390124325561 - informazioni@linceitalia.it
un cance||c autcmat|cc L|nce
sistomi di automaziono LNCE sono toonologioamonto
ahdabili o rosistonti nol tompo.
Lo nuovo linoo in bassa tonsiono pormottono di gostiro
olottronioamonto il movimonto dol oanoollo. L'onoodor
(oontagiri olottronioo), gostisoo la orza di spinta, il
rallontamonto sia in aportura ono in oniusura dol oanoollo
o l'invorsiono in oaso di ostaoolo. l tutto oon una grando
somplioit di installaziono o programmaziono.
PAD. 15 SALONE 2 - STAND B 52 - A 53
17-20 NOvEMBRE 2004
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
4
5
rio universale, possono essere
installati nelle guide del palo
vari complementi, quali cestini,
cartelli segnaletici e telecamere,
trasformando il palo in un vero e
proprio elemento di sostegno
universale.
Le sfere, realizzate in metacrilato
trasparente ad alto modulo per
garantire la massima traspa-
renza nel tempo, presentano
unottica schermata da unap-
posita gonnella paraluce e ri-
sultano perci rispondenti alle vi-
genti normative contro linqui-
namento luminoso. Particolare at-
tenzione stata posta alla faci-
lit di cablaggio delle stesse,
che pu essere realizzata velo-
cemente poich non necessa-
rio forare il palo: il cavo in dop-
pio isolamento viene fatto scor-
rere lungo la guida nel palo e
poi viene coperto e protetto da
un apposito profilo in gomma ri-
tagliabile a misura.
Ulteriori accessori ottici per-
mettono di convogliare la luce nel-
la direzione di interesse otte-
nendo cos la massima efficien-
za. La gamma dei pali, tutti con
diametro 125 mm, prevede tre al-
tezze fuori terra: 3, 4 e 5 metri;
sono forniti completi di asola
per lingresso di cavi interrati e
di morsettiera di derivazione e
portafusibile per ottimizzare i
tempi di cablaggio e successiva
ispezione.
Per incrementare la resistenza
agli agenti atmosferici e garan-
tire una maggiore durata nel
tempo, il palo viene sottoposto
ad un trattamento di cromata-
zione alodine 1200 prima della
verniciatura; inoltre, per lin-
stallazione in ambienti partico-
larmente aggressivi per la pre-
senza di sale, come ad esempio
ambienti marittimi o strade
montane sottoposte a spargi-
mento di sale in caso di neve,
previsto un ulteriore profilo di
protezione in materiale plasti-
co che viene calzato sopra il pa-
lo stesso, senza alterare larmo-
nia dellinstallazione.
Le composizioni multiple (da 1 a
6 globi) sono facili da realizzare
grazie alla disponibilit di kit
preconfigurati costituiti da palo
a pastorale, base cablata e rifa-
sata, agganci per palo, cavo di
alimentazione in doppio isola-
mento precablato da 8 metri,
frangiluce downlight, paraluce e
globo da 400mm di diametro a
scelta tra le tre finiture disponi-
bili, trasparente, opale e fum.
Per ottenere una composizione
multipla sufficiente ordinare
un kit per ogni globo che si vuo-
le installare e completare lor-
dine con il palo della altezza de-
siderata. Tutti i prodotti serie
Place sono a norma Cei En
60598-1 e Cei En 60598-2-3.
servizio lettori 146
122
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NOVIT
In che settore opera lazienda?
Che tipo di attivit svolge lazienda?
Quale mansione lei ha in azienda?
LEditore garantisce la riservatezza dei dati comunicati nel rispetto dei diritti previsti dallart. 13 della legge 675/96.
S, mi abbono!
Sconto 10% a chi
si abbona a pi riviste
CLIMATIZZAZIONE E REFRIGERAZIONE
Blu&Rosso
CDA - Condizionamento dellAria Riscaldamento e Refrigerazione
LInstallatore Italiano
Il Freddo
Progetto Hotel
Refrigeration World
Tecno Impianti
TIS - Il Corriere Termoidrosanitario
ELETTRICITA E ILLUMINOTECNICA
Commercio Elettrico
Il Giornale dellInstallatore Elettrico
Lighting - Design Collection
Progetto Hotel
MECCANICA, SUBFORNITURA E TESSILE
Controllo di Movimento
Il Giornale della Subfornitura
Industria Mercato
Tecnologie Meccaniche
Tecnologie Tessili
.IT Italian Technology Machine Tools
SERRAMENTI, VETRO E FACCIATE
Finestra International
Glass Today
Nuova Finestra
Progetto Hotel
Rivista del Vetro
ShowroomPorte&Finestre
Versamento sul c/c postale n. 33668666 intestato a Reed Business Information Spa, viale G. Richard 1/a - Milano
Assegno non trasferibile intestato a Reed Business Information SpA - Milano (da inviare in busta chiusa in allegato)
Carta di credito Master Card Carta S Visa Eurocard American Express
Numero Scadenza
Data Firma
S, DESIDERO DUE COPIE GRATIS. Se siete operatori del settore e vi interessa conoscere le altre nostre riviste, potete richiederne gratuitamente una copia saggio.
Scegliete le riviste di vostro interesse (massimo tre) tra quelle sotto elencate. Verranno soddisfatte solo le richieste di chi ha compilato i propri dati anagrafici e professionali.
Nome e Cognome
Azienda
Indirizzo dellazienda:
cap citt prov.
tel. fax
e-mail
MODALIT DI PAGAMENTO
DATI ANAGRAFICI E PROFESSIONALI
ARREDOBAGNO
Atelier Bagno
Blu&Rosso
Il Bagno Oggi e Domani
Progetto Hotel
AUTOMOTIVE
Il Giornale del Meccanico
L'Officina del Veicolo Industriale
Parts - componenti, ricambi, accessori
Parts Made in Italy
CHIMICA, PLASTICA E ALIMENTARE
ICP - Rivista dellindustria chimica
Plast
Tecnologie Alimentari
TC News - Tecnologie Chimiche
Tecno Plast
COME PAGARE
1) In posta: effettuare
il versamento sul c/c postale
n.33668666 intestato a
Reed Business Information SpA
viale G. Richard 1/a
20143 Milano.
Inviare copia della ricevuta insieme
al coupon compilato
2) Con assegno: inviare
in busta chiusa un assegno
non trasferibile intestato a
Reed Business Information SpA -
Milano
3) Con carta di credito: compilare
il coupon, firmarlo ed inviarlo
COME ABBONARSI
Se desiderate abbonarvi
alle nostre riviste compilate
questo modulo e inviatelo:
PER FAX
al numero 02/81830404
oppure
PER POSTA
Spedendolo in busta chiusa a:
Reed Business Information SpA
viale G. Richard 1/a
20143 Milano.
Oppure potete abbonarvi
collegandovi al nostro sito
INTERNET
www.reedbusiness.it
S
i
p
r
e
g
a
d
i
s
c
r
i
v
e
r
e
i
n
s
t
a
m
p
a
t
e
l
l
o
Italia Estero Nuovo Rinnovo
Commercio Elettrico (11 uscite) b 71.00 b/$ 107,00
Il Giornale dellInstallatore Elettrico (16 uscite) b 54,50 b/$ 82,00
Lighting Design Collection (5 uscite) b 63,00 b/$ 94,00
Progetto Hotel (4 uscite) b 44,40 b/$ 78,00
Tagliare e faxare o spedire per posta in busta chiusa
Informativa ai sensi dellart. 13, d. lgs 196/2003. I Suoi dati saranno
trattati, con modalit anche informatiche e senza particolari criteri di
elaborazione, da Reed Business Information S.p.A. per evadere la Sua richiesta
di abbonamento e svolgere le attivit a questa connesse. Il conferimento dei
dati relativi a qualifica e attivit azienda facoltativo e la mancata indicazione
non pregiudica il diritto di ottenere quanto richiesto. I Vostri dati personali
possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attivit strumentali
al predetto fine, quali gli istituti di credito e finanziari, gli uffici postali per i
pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica
informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi
eseguiti. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalit
suddette sono gli addetti allelaborazione dati e sistemi informativi, al
confezionamento e spedizione delle riviste e materiale informativo, al call
center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs
196/2003 pu esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.
Place il nuovo sistema
di illuminazione per aree pubbliche
e residenziali proposto da Gewiss
Il modo pi affidabile e vantaggioso per acquistare prodotti industriali in piccoli volumi
Per ricevere GRATUITAMENTE il catalogo RS
clicca su www.rs-components.it/catalogo
oppure chiama il numero 02.66.058.058
80.000 prodotti in un catalogo unico,
nessun quantitativo minimo dordine e
consegna in 24 ore in tutta Italia.
Tutto questo RS.
Ma non solo. RS in grado di offrire un
servizio pre e post vendita di altissimo
livello che aggiunge valore a tutti i tuoi
acquisti.
Fai anche tu come gli oltre 100.000 clienti
che ogni giorno si rivolgono a RS per
trovare prodotti e soluzioni immediate per
qualunque esigenza di lavoro.
Con il catalogo RS smetti di cercare e inizi
a trovare. Semplicemente inimitabile.
Inimitabile
ELETTRONICA - MECCANICA - IDRAULICA - ELETTROMECCANICA - OLEODINAMICA - TELEFONIA - UTENSILERIA - INFORMATICA
SICUREZZA - STRUMENTAZIONE - PRODOTTI PER LUFFICIO - EDITORIA TECNICA - AUDIO-VIDEO - TRASMISSIONE DATI
Come il catalogo RS
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
8
4
124
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NOVIT
A pulsanti, oltre che rotativi
Moeller (www.moeller.it) ha in-
tegrato gli interruttori protetto-
ri del nuovo sistema xStart con
contattori pi compatti e a bas-
so assorbimento, riducendo inol-
tre il numero di misure di corni-
ce. In aggiunta, tutti i componenti
delle partenze motore fino a 150
A del programma xStart sono
stati rinnovati ed ottimizzati.
Pkz riconosciuto nel mondo
come sinonimo di interruttori
protettori di alta qualit. Come
parte del suo nuovo sistema di
prodotti xStart, Moeller sta rein-
troducendo il sistema a pulsan-
te, che tanto successo ha ri-
scosso fra i clienti del Pkzm01 (fi-
no a 12 A). In caso demergenza
basta infatti premere il pulsan-
te! Vengono inoltre riproposti i
pulsanti di emergenza a fungo per
il montaggio sporgente sulle
macchine pi semplici. Le unit
Pkz possono essere utilizzate
allinterno dei quadri, installate
in una custodia per montaggio
sporgente oppure incassate nel-
lalloggiamento della macchina
o dellapparecchiatura grazie ad
unapposita piastra ad incasso.
Gli interruttori con comando ro-
tativo sono raccomandati allin-
terno di quadri elettrici, ed in
questarea Moeller sta aumen-
tando fino a 32 A il campo di
corrente per il Pkzm0. Dato che
gli utenti spesso combinano gli
interruttori protettori con i con-
tattori, lazienda sta standar-
dizzando ad una misura unifor-
me di 5 mm la larghezza di tut-
ti i suoi avviatori fino a 15 kW, 400
V. Questa dimensione offre una
serie di vantaggi nella proget-
tazione dei sistemi, sia per lin-
stallazione su guida din che per
il montaggio su adattatori per
sistemi sbarre. Gli interruttori
protettori Pkz trovano impiego
sempre pi spesso come inter-
ruttori generali o interruttori au-
tomatici demergenza per le ap-
parecchiature elettriche decen-
trate. Per queste applicazioni,
Moeller offre maniglie per co-
mando rinviato con bloccoporta,
destinate allinstallazione nei
quadri elettrici.
Queste unit sono semplici da
adattare a quadri elettrici di di-
versa profondit grazie alle pro-
lunghe per albero autocentran-
ti. Pkzm4 ora protegge motori
fino a 65 A e, in una nuova ver-
sione, i corrispondenti contat-
tori Dilm65 sono del 20% pi
stretti, per ottenere la stessa
larghezza dellinterruttore.
servizio lettori 148
Una gamma di Ups innovativa
Masterys lultimo Ups nato in
casa Socomec Si con Ups
(www.socomec.com), prodotto
innovativo frutto di un grande la-
voro di ricerca e sviluppo.
La nuova gamma di Ups ca-
ratterizzata dal design ricercato
ed stata studiata per un utilizzo
in tutte le aree critiche indu-
striali e informatiche, diventan-
do la protezione ideale per il bu-
siness aziendale. Masterys of-
fre un sistema modulare no sin-
gle point of failure, in
grado di assicurare
una disponibilit as-
soluta grazie alla com-
pleta ridondanza di
tutti i componenti.
Tutta la gamma ha
unarchitettura mul-
tiprocessore che ga-
rantisce velocit di
calcolo, potenza e af-
fidabilit.
La comunicazione di
Masterys, in caso di
anomalie o malfun-
zionamento, resa
possibile dalla pre-
senza della connes-
sione Lan integrata e
dai software di monitoraggio e
controllo disponibili. Attraver-
so di essi, lUps comunica in si-
multanea con lamministratore di
rete e il centro di assistenza au-
torizzato Socomec Sicon. Ma-
sterys conferma il costante im-
pegno dellazienda italo-france-
se per lambiente e per il ri-
sparmio energetico.
Infatti, lUps stato realizzato
con un numero ridotto di compo-
nenti, riciclabili per oltre il 70 per
cento (unanticipazione delle fu-
ture direttive Rohs e Weee).
Inoltre, la presenza del raddriz-
zatore Igbt, che riduce a un valore
<3% il tasso di distorsione armo-
nica verso la rete, e linnovativa
modalit di funzionamento Al-
ways-on-mode - il carico ali-
mentato dalla rete ausiliaria ma le
reiezioni armoniche, solitamen-
te provocate dai carichi distor-
centi, vengono comunque moni-
torate e corrette dallUps - ridu-
cono sensibilmente i costi ener-
getici di esercizio. Lofferta Ma-
sterys completa, da 8 a 90 kVA.
Le configurazioni sono compati-
bili con tutti i regimi di neutro (IT,
TT, TN), con ingresso/uscita mo-
nofase e trifase, per alimenta-
zione distribuita, centralizzata,
scalabile e ridondante.
Di facile installazione, i modelli del-
la gamma Masterys sono unici
per compattezza e dimensioni ri-
dotte; inoltre, le taglie fino a 30
kVA possono essere installate in
armadi rack 19 gi in uso pres-
so lutente.
servizio lettori 149
Alimentazione e Ups
in un solo prodotto
Lesigenza di poter usufruire di
alimentazione elettrica continua
e di qualit molto sentita da tut-
ti gli utenti, sia domestici che
prof essi onal i . Metasystem
(www.metasystem.it), per la pro-
tezione dei punti di accesso, di
storage delle informazioni, non-
ch della rete di trasmissione, ha
studiato Power strip, una striscia
di alimentazione composta da 6
prese Shuko/Italia, protetta da un
gruppo di continuit. Sempre
pi spesso, infatti, la produttivit
aziendale influenzata da pro-
blemi di natura elettrica che in-
terrompono operazioni critiche e
delicate come laccesso alle in-
formazioni aziendali, un patri-
monio sempre pi importante.
Power strip non solo un grup-
po di continuit, ma anche una
striscia di alimentazione idea-
le per armadi rack. Tutta la tec-
nologia di questo prodotto rac-
chiusa in una barra di alimen-
tazione innovativa, compatta,
potente ed economica, in gra-
do di garantire, in caso di emer-
genza, le tipiche prestazioni di un
gruppo di continuit elettrica.
conforme agli standard rack
19 e ha allinterno un gruppo
di continuit da 500VA e 6 prese
Shuko/Italia.
Grazie alla combinazione presa
shuko/gruppo di continui-
t, Power strip in grado
di sostituire la solita striscia
di alimentazione installata
negli armadi rack con una
striscia di alimentazione
protetta da un gruppo di
continuit. In questo modo
si ottimizza lo spazio e la
protezione della strumen-
tazione collegata. Punto
di forza la massima adat-
tabilit a tutti gli armadi
rack, ai quali garantisce mag-
gior sicurezza. Le dimensioni so-
no ridotte: alto solo 2 U e pro-
fondo 270 mm per inserirsi co-
modamente negli armadi muro,
spesso preferiti per motivi di in-
gombro.
Inoltre, Power strip un prodot-
to estremamente versatile, con-
traddistinto dalla formula plug
and play per un funzionamento
immediato e senza particolari
esigenze di manutenzione. Po-
wer strip nella funzione di Ups pre-
senta le seguenti caratteristiche:
- potenza nominale pari a 500
VA;
- tensione dingresso pari a 220
V (con un range 160V-280V) e
tensione duscita pari a 230V;
- tecnologia line interactive con
stabilizzatore Avr;
- display a led per lindicazione
La nuova gamma di Ups Masterys
Protezione selettiva
Con uno spessore di soli 12,5 mm,
il nuovo interruttore di protezione
automatico Ecp 3-6 di Phoenix Con-
tact (www.phoenixcontact.com) ge-
stisce tutti i circuiti di carico da 24
V dc. A questo provvede una com-
binazione tra limitazione della cor-
rente e tecnologia di protezione in-
clusa la separazione galvanica.
Linterruttore di protezione pu es-
sere applicato sulla presa Tmcp-
Socket-M, permettendo in tal modo
un montaggio rapido senza proble-
mi. Il settore dimpiego dellinter-
ruttore di protezione orbita nella-
rea degli alimentatori. Questi, in
caso di sovraccarico causato da un
guasto su unutenza, regolano ver-
so il basso la tensione duscita, so-
spendendo lalimentazione a tutto
il carico. Questo problema viene ri-
solto brillantemente dallinterruttore Ecp, il quale limita
costantemente la corrente massima possibile ad un valo-
re 1,8 volte la corrente nominale impostata. Grazie a que-
sta soluzione possibile inserire carichi capacitivi, laddo-
ve per la disinserzione prevista esclusivamente in ca-
so di cortocircuito o sovraccarico. Il range della corrente
nominale pu essere impostato mediante un interruttore
regolabile tra 3 A e 6 A. Un Led e i contatti ausiliari inte-
grati visualizzano lo stato desercizio e di errore.
servizio lettori 147
Interruttore automatico
Ecp 3-6
I nuovi interruttori protettori Pkz
di Moeller
Power Strip si adatta
a tutti gli armadi rack
|| I0t0ro
aocora Pa|azzo||
Troverai maggiori informazioni richiedendoIe a: PaIazzoIi S.p.A. - via F. PaIazzoIi, 31 - 25128 Brescia (ItaIy)
TeI. +39 030 2015.1 - Fax +39 030 2015.217 - Numero verde 800.700332 - marketing@paIazzoIi.it - www.paIazzeIi.it
P
R
O
M
O
T
l
O
N
P
L
U
S servizio lettori 1573
126
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
NOVIT
relativa allo stato di funziona-
mento;
- interruttore magnetotermico
resettabile.
Con la batteria fornita in bund-
le, Power strip al 50% del carico
garantisce 15 minuti di autono-
mia, mentre all80% del carico
in grado di arrivare fino a 9 mi-
nuti. Power strip si conferma
come il gruppo di continuit
ideale per garantire il buon fun-
zionamento di un centralino
aziendale e di altri dispositivi
di comunicazione, nonch per
le installazioni di networking,
sostituendo lutilizzo di appa-
recchiature spesso molto volu-
minose e ingombranti.
servizio lettori 150
Per applicazioni industriali
Mge Ups Systems (www.
mgeups.com), specialista nelle
soluzioni ad alta disponibilit di
energia, lancia Comet EX RT (7-
11 kVA), un apparecchio monofase
a doppia conversione con pre-
stazioni e caratteristiche gene-
ralmente proprie solo alla gamma
trifase.
Una vasta gamma di opzioni spe-
cifiche per gli ambienti industriali
lo rende la soluzione perfetta per
la protezione elettrica per ogni
tipo di applicazione.
Con una configurazione di rete
1 e 2 separate come caratteristi-
ca di serie, Comet EX RT pu es-
sere alimentato da due reti elet-
triche indipendenti. Fra le carat-
teristiche ricordiamo:
doppia tolleranza in situazioni
di guasto: per far fronte alle
situazioni pi critiche, due Ups
Comet EX RT possono essere
installati in ridondanza se-
quenziale;
by-pass manuale di serie. Tut-
ti i modelli della gamma sono
dotati di serie di questa fun-
zionalit che permette la so-
stituzione dellUps o delle bat-
terie senza interrompere i si-
stemi protetti;
progettato per lavorare con le
reti pi disturbate senza sol-
lecitare le batterie e senza al-
terare la qualit della tensione
in uscita: Comet EX RT fun-
ziona in modo normale da 120
a 280 Volt;
le batterie sono testate auto-
maticamente secondo para-
metri regolabili dallutilizza-
tore.
LUps progettato specialmen-
te per gli ambienti industriali.
Infatti:
pu funzionare fino a 8 ore a
una temperatura di 45 C sen-
za declassamenti;
per operazioni intuitive e im-
mediato monitoraggio locale
dello stato degli Ups, Comet EX
RT dotato di uno schermo
lcd multilingue, che offre unam-
pia gamma di parametri ed
capace di generare dei mes-
saggi di auto diagnostica;
con la scheda Jbus/Modbus e
6 contatti puliti di serie, si in-
serisce facilmente in tutti i si-
stemi di gestione tecnica del-
lazienda;
si adatta alle condizioni pi ri-
gide;
disponibile un trasformatore
in formato 6 U per modificare
il sistema di gestione del neu-
tro o gli isolamenti galvanici ne-
cessari a monte e a valle degli
Ups.
In pi, assicura facilit dinstal-
lazione sullhardware di qual-
siasi computer:
facile installazione in armadi ad
alta densit. Comet EX RT
disponibile in formato conver-
tibile Tower o Rack 19 non su-
perando le 6 U in altezza, in-
cluso il modulo delle batterie;
protezione ideale per gli ar-
madi di server e networking: fi-
no a 35 server (nella versione
7 kVA) e 55 server (11kVA);
tipiche applicazioni: reti per
aziende dipartimentali, sale
computer, sale di strumenta-
zione, Plc, pc industriali, scan-
ner di aeroporti, attrezzature
mediche...
servizio lettori 151
Protezione efficace
per reti e server
Liebert Psi il nuovo gruppo di
continuit line interactive di
Emerson Network Power (ups.in-
fo@liebert-hiross.com) ideato
per proteggere le reti e i server
dai danni causati dalle sovra-
tensioni e dai picchi di corrente.
LUps - nelle versioni rack e to-
wer - disponibile con una po-
tenza variabile da 1000 a 3000 VA.
I modelli della gamma Liebert
Psi forniscono energia pulita -
anche nelle condizioni pi estre-
me - senza ricorrere alle batterie,
grazie allampia tolleranza del-
le tensioni in ingresso e alla
stretta regolazione in uscita.
Questo sistema favorisce la
salvaguardia delle batterie
e la protezione dellinve-
stimento del cliente.
Liebert Psi ha come plus 4
unit opzionali di batteria
che, racchiuse in un box com-
patto di soli 2U di altezza, for-
niscono unautonomia extra di ol-
tre 3 ore a pieno carico.
avviabile a freddo in batteria
(black start), e - oltre ai 5 minuti
di back up per il salvataggio del
lavoro e lo shutdown e alle batterie
sostituibili a caldo dallutente in
caso di guasto - con un massimo
di 9 uscite protette da batteria, si
dimostra la soluzione ideale per le
applicazioni distribuite e non
presidiate, dove luptime un fat-
tore critico.
Dotato di porta seriale, usb,
scheda rel e di rete, anche dal
punto di vista delle comunicazioni
e dellinterfacciamento con i si-
stemi operativi e i software per
la gestione di rete, il Liebert Psi
un prodotto allavanguardia.
Grazie al Web Server integrato
nella scheda di rete, possibi-
le effettuare il monitoraggio del-
lUps da qualsiasi punto di una
rete Intranet o Internet.
Il software di gestione fornito a
corredo, MultiLink, permette in-
fine di controllare costantemente
il gruppo di continuit - an-
che in remoto - e, in caso di
blackout, di chiudere per tempo
le applicazioni salvando il lavo-
ro. Liebert Psi certificato da Mi-
crosoft, per lutilizzo con Win-
dows XP e 2000, e da Apple
Computer, per Macintosh OS X
(versione 10.2 e successive).
Inoltre la garanzia di due anni,
che assicura la riparazione o la
sostituzione gratuita dellUps
nel caso di guasto, un ulte-
riore servizio offerto da Emerson
Network Power per la protezio-
ne dellinvestimento dei propri
clienti.
servizio lettori 153
WWW WWW.ser .serviziolet viziolettori.it tori.it
WWW WWW.ser .serviziolet viziolettori.it tori.it
WWW WWW.ser .serviziolet viziolettori.it tori.it
Sensori dinclinazione Omron
Omron (www.eu.omron.com) presenta il nuovo senso-
re di inclinazione D7E-3, ideale per impiego come in-
terruttore di sicurezza in tutte le apparecchiature che
richiedono linibizione del funzionamento quando
non posizionati verticalmente.
Il nuovo Omron D7E-3 dotato di un angolo operativo
che varia da 50 a 80, caratteristica che riduce il ri-
schio di attivazione non desiderata a causa di vibra-
zioni o colpi accidentali; il sensore, una volta entrato
in funzione, si porta automaticamente in posizione di
riposo non appena raggiunge un angolo di inclinazio-
ne di 25; ci permette di riposizionare e riattivare
lapparecchiatura al quale collegato senza ulteriori
interventi. Il nuovo sensore ultracompatto D7E-3 mi-
sura solo 0,9 x 0,93 x 1,43 cm ed dotato di terminali
fast-on per una facile installazione.
Per linstallazione in spazi molto ristretti, Omron of-
fre invece il nuovo D6B, un sensore dinclinazione ul-
tra miniaturizzato a montaggio superficiale che misu-
ra solo 5,5 x 5,5 x 3,75 mm. Grazie agli innovativi pro-
cessi di produzione e sfruttando leffetto hall magne-
tico, stato possibile ottenere un eccezionale livello
di miniaturizzazione senza per alterare laffidabilit
di commutazione. Il D6B dispone di due uscite, ovve-
ro destra e sinistra, che rimangono in stato on (-0.5
Vc.c.) finch il sensore staziona in posizione di ripo-
so; una volta superato langolo di attivazione compre-
so tra 35 e 65, luscita commuta passando allo stato
off (+0.5 Vc.c.); langolo di reset invece compreso tra
60 e 30.
servizio lettori 152
Liebert Psi una soluzione flessibi-
le, capace di integrarsi ed interagire
in qualsiasi ambiente
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
9
6
Dichiarazione di conformit?
Basta un click
Dichiarazione di conformit?
Basta un click
Il Giornale dellInstallatore Elettrico, commercio
Elettrico e lo Studio Scapita hanno messo a
punto una soluzione veloce ed economica per
compilare automaticamente la Dichiarazione
di Conformit. Con questa iniziativa Il Giornale
dellInstallatore Elettrico intende offrire ai
propri lettori un utile strumento che consente
di velocizzare e semplificare il loro lavoro.
Dalla prima videata, che contiene il Modello
Ministeriale, sono raggiungibili tutte le finestre
che permettono di compilare e stampare gli
allegati in modo semplice e soprattutto veloce.
Dal Modello Ministeriale sono
selezionabili:
Elenco Tipologie Materiali
Schema dellImpianto realizzato
Schede dei Circuiti
Scheda delle Dotazioni/Ubicazioni
Denuncia dellImpianto di terra
Rapporto di Verifica
Dichiarazione Quadri (due differenti modelli)
Caratteristiche:
Inserimento in automatico di tutti i dati
ripetitivi
Gestione di tutte le informazioni
anagrafiche (clienti, fornitori, intestazione
stampe...)
Gestione Magazzino (171 marche - con
abbonamento al servizio)
Inserimento materiali nellElenco Tipologie
Materiali
Ogni allegato indipendente
e compilabile separatamente.
Funzione di copia/incolla per riutilizzare tutti
i documenti da una Dichiarazione allaltra
Unofferta per i lettori di Commercio Elettrico
e del Giornale dellInstallatore Elettrico:
il programma per la compilazione automatica
della Dichiarazione di Conformit
Ai lettori di Commercio Elettrico
e del Giornale dellInstallatore
Elettrico, il pacchetto -
che comprende Modulo Base,
Dichiarazione di Conformit
e la versione Demo del programma
Business - viene offerto
a condizioni agevolate: 140 + IVA.
Per ordinare il software o per ulteriori
informazioni sufficiente utilizzare
il servizio lettori on-line allindirizzo
www.serviziolettori.it/dichiarazione
oppure telefonare al numero
02-81830638
La Dichiarazione di Conformit si apre
con la videata principale, il Modello
ministeriale, che contiene le informa-
zioni identificative della Dichiarazione
(Numero, Cliente, Cantiere e data) e i
pulsanti per accedere a tutti gli allega-
ti. La compilazione velocissima poi-
ch tutti i dati della propria ditta e del
committente vengono inseriti in auto-
matico dal programma.
LElenco Tipologie Materiali lallegato principa-
le e pu essere compilato con 3 differenti moda-
lit: automatica, se agganciato aL Dettaglio
Lavori; semiautomatica, utilizzando le schede
Consultazione Magazzino e/o Consultazione
Tipologie dinstallazione per inserire codice,
descrizioni di articoli e tipologie dinstallazione;
manuale, scrivendo liberamente.
Il prospetto riassuntivo
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004
129
Norme & leggi
di Antonello Greco - gie@reedbusiness.it
Rubrica
di aggiornamento
normativo e legislativo
Lo scorso mese di giugno sono stati ristampa-
ti dal Cei i 7 fascicoli, pubblicati nel 2004, che
costituiscono la norma Cei 64-8, al fine di cor-
reggere le inesattezze contenute nei corri-
spondenti 7 fascicoli delledizione 2003 della
stessa norma ed inserire alcune modifiche.
Come per le precedenti edizioni, in aggiunta
alla tradizionale versione a fascicoli possi-
bile acquistare la norma rilegata in un unico
volume dal titolo Norma Cei 64-8 per im-
pianti elettrici utilizzatori - Criteri di applica-
bilit. Prescrizioni di progettazione ed esecu-
zione. Misure di protezione. Ambienti ed ap-
plicazioni particolari. Interpretazioni e com-
menti. Oltre al testo della norma Cei 64-8,
nel volume sono riportati i testi della Legge 5
marzo 1990, n. 46 e dei relativi decreti attua-
tivi, nonch gli articoli sulla sicurezza degli
impianti tecnici inseriti nel Dpr 380/2001 (Te-
sto Unico dellEdilizia). Allegato al volume
stato inserito un cd con le Schede funzionali
di impiantistica elettrica che forniscono un
utile supporto alla consultazione delle nor-
mative tecniche applicabili esistenti e per-
mettono di individuare immediatamente le
norme necessarie per lesecuzione delle varie
tipologie di impianti elettrici in conformit al-
la legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la si-
curezza degli impianti. Analogamente sta-
to pubblicato il secondo volume delle Nor-
me Cei per Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione che raccoglie le leggi,
i decreti, le direttive e le norme Cei riguar-
danti la classificazione dei luoghi con perico-
lo di esplosione e le prescrizioni per la pro-
gettazione ed esecuzione degli impianti elet-
trici in detti luoghi. Il volume costituisce lin-
tegrazione del volume I del 2001, dedicato al-
le Norme Cei per impianti elettrici nei luoghi
con pericolo di esplosione e contenente i te-
sti integrali delle norme Cei (comitato 31).
Completa il volume un capitolo dedicato a ri-
sposte sui principali quesiti posti dagli utiliz-
zatori delle norme relative ai luoghi con pre-
senza di atmosfera pericolosa.
PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
175 del 28 luglio 2004 - Supplemento Ordina-
rio n. 131, il Testo del decreto-legge 28 mag-
gio 2004, n. 136, coordinato con la legge di
conversione 27 luglio 2004, n. 186 recante:
Disposizioni urgenti per garantire la funzio-
nalit di taluni settori della pubblica ammini-
strazione. Disposizioni per la rideterminazio-
ne di deleghe legislative e altre disposizioni
connesse. In particolare larticolo 8-decies
proroga lentrata in vigore del regolamento sul pronto soccorso
aziendale, termine che altrimenti sarebbe scaduto lo scorso 3
agosto. Stando al rinvio, il regolamento dovrebbe entrare in vi-
gore il 3 febbraio 2005, a meno di ulteriori proroghe.
Si riporta di seguito il testo dellarticolo 8-decies:
ALCUNE MODIFICHE APPORTATE DAL CEI
Dalla ristampa della norma 64-8 ai sistemi di gestione della qualit
ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME CEI EMANATE
COM. NORMA DESCRIZIONE
Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione pubblica di bassa tensione
CEI EN 50365 Cei 11-73 Elmetti isolanti da utilizzare
su impianti di Categoria 0 e I
Cavi per energia
CEI 20-19/14 Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale
non superiore a 450/750V - Parte 14: Cavi per applicazioni
con requisiti di alta flessibilit
CEI 20-20/2 V1 Cavi con isolamento termoplastico con tensione
nominale non superiore a 450/750 V - Parte 2: Metodi
di prova
CEI EN 60702-1 Cei 20-39/1 Cavi per energia ad isolamento minerale
e loro terminazioni con tensione nominale
non superiore a 750 V - Parte 1: Cavi
CEI EN 60702-2 Cei 20-39/2 Cavi per energia ad isolamento minerale
e loro terminazioni con tensione nominale non
superiore a 750 V - Parte 2: Terminazioni
Materiali antideflagranti
CEI EN 50281 Cei 31-36 V1 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive
-1-2/A1 per la presenza di polvere combustibile - Parte 1-2:
Costruzioni elettriche protette da custodie -
Scelta, installazione e manutenzione
CEI EN 50281 Cei 31-37 V1 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive
-1-1/A1 per la presenza di polvere combustibile - Parte 1-1:
Costruzioni protette da custodie - Costruzioni e prove
Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)
CEI 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V
in corrente continua - Parte 1: Oggetto, scopo e principi
fondamentali
CEI 64-8/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua - Parte 2: Definizioni
CEI 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V
in corrente continua - Parte 3: Caratteristiche generali
CEI 64-8/4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua - Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza
CEI 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V
in corrente continua - Parte 5: Scelta ed installazione
dei componenti elettrici
CEI 64-8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V
in corrente continua - Parte 6: Verifiche
CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua - Parte 7: Ambienti
ed applicazioni particolari
Segue
11
20
31
64
NORME & LEGGI
Proroga di termine
1. Il termine indicato dallarticolo sei del regolamento di cui al de-
creto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, prorogato di sei
mesi.
SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALIT
stato pubblicato dallUni il nuovo cd-rom UniQualit - edizione
2004 - contenente le norme sulla certificazione Iso 9000:2000,
sul controllo statistico, sulla taratura degli strumenti di misura.
La nuova edizione dedica particolare attenzione ai temi della
misurazione (dalla gestione dei processi e delle apparecchiatu-
re, agli indicatori e alle rilevazioni della soddisfazione del clien-
te), del valore (dallanalisi alla gestione) e della manutenzione
(con le nuove norme europee).
Tra le principali novit si segnala:
Uni 11097: 2003 - Gestione per la qualit -
Indicatori e quadri di gestione della qualit
- Linee guida generali (pubblicata il
01/12/2003);
Uni 11098:2003 - Sistemi di gestione per la
qualit - Linee guida per la rilevazione della
soddisfazione del cliente e per la misurazio-
ne degli indicatori del relativo processo
(pubblicata il 01/12/2003);
Uni En Iso 10012: 2004 - Sistemi di gestione
della misurazione - Requisiti per i processi e
le apparecchiature di misurazione (pubbli-
cata il 01/04/2004);
Uni En 12973: 2003 - Gestione del valore
(pubblicata il 01/11/2003).
Oltre a ci sono presentati alcuni documenti originali Iso e
CEN:
- Iso Iec Dis 17011 - General Requirements for Bodies Providing
assessment and accreditation of conformity assessment bo-
dies;
- En Iso iec 17024 - Conformity assessment - General require-
ments for bodies operating certification of person;
- Iso 15161 - Guidelines on the application of Iso 9001:2000 for
the food and drink industry.
Contiene inoltre:
- la sezione Gestire il cambiamento;
- le informazioni sugli enti di normazione (nazionali, europei
ed internazionali), gli enti daccreditamento e gli organismi
di certificazione.
130
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME CEI EMANATE
COM. NORMA DESCRIZIONE
Esposizione umana ai campi elettromagnetici (ex CT 211)
106
CEI EN 50371 Cei 106-3 Esposizione umana ai campi elettromagnetici
(10 MHz - 300 GHz) - Norma generica per dimostrare
la conformit di apparecchi elettronici ed elettrici
di bassa potenza ai limiti di base fissati per la popolazione
Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione,
furto, sabotaggio e aggressione
CEI CLC/TS Cei 79-40 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione
50131-3 - Parte 3: Apparati di controllo e indicazione (Centrale
79 dallarme)
CEI CLC/TS Cei 79-41 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme
50131-7 intrusione - Parte 7: Guide di applicazione
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
5
8
6
Segue
IL VOSTRO PARTNER IDEALE
La Sonda ASPIS in fibra di vetro 3
V
http://www .it - E-mail: canfor@canfor.it
S
T
U
D
I
O
L
I
N
E
A
I
M
M
A
G
I
N
E
F
U
T
U
R
A
2
0
7
0
srl
dotazione
Questa sonda sperimentatissima e molto apprezzata dagli installatori, perch da la
possibilit di risolvere molti problemi nella posa a dimora dei conduttori elettrici.
Il vantaggio della sonda ASPIS in 3 : sottile, rigida e flessibile, regge la forza
di spinta, il superamento delle curve, le lunghe tratte e linfilaggio sia nei tubi piccoli
che grandi.
Questa sonda non sostituisce la ormai tradizionale in nylon Bayer-Perlon
ma la affianca in modo valido ed indispensabile.
Chi la usa non nel modo suggerito la pu rompere, per ovviare a questo incidente
di lavoro stata dotata del set di riparazione e delle istruzioni necessarie.
Per la sonda ASPIS in 3 si consiglia luso del contenitore (come per le sorelle
di diametri maggiori) che la salvaguarda da rotture accidentali, da ingarbugliamenti
ed sempre pronta alluso.
E prodotta nelle misure da 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 m. Il contenitore Art. 651/01
adatto a tutte le misure.
Art. 651/08 - The box Art. 161 - Sonda ASPIS 3
Art. 651/01
Art.622
Tirasonda
Art. 399/6 - Svolgitori ariane
Questa pagina suggerisce allinstallatore un sistema completo
e ordinato per lavorare bene ed in serenit.
Art. 623
Pinza
tirasonda
servizio lettori 1797
Uffici: via Tridentina 4 - 20157 Milano
Consegna e ritiro merce: via Bolivia 5 - 20157 Milano
Tel. ++39 02 38103446 - Fax ++39 02 33910990
http://www.canfor.it - E-mail: canfor@canfor.it
132
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
I veicoli da lavoro
Le soluzioni per
spostarsi e lavorare,
portando con s
tutto ci che occorre
di Thomas Saccani - gie@reedbusiness.it
Uno dei veicoli commerciali di punta della
Fiat , senza ombra di dubbio, linnovativo
Fiat Dobl Cargo. Presente sul mercato con
sei motorizzazioni (1.2 e 1.6 16v benzina, 1.6
16v Natural Power a benzina e metano, 1.9 D, 1.9 JTD e il nuo-
vo 1.3 Multijet 16v), il modello Dobl Cargo disponibile in
quattro versioni, base, SX, Combi e Combi sette posti e in una
gamma di 20 tipologie di carrozzeria: lastrato, vetrato, con una
o due porte laterali scorrevoli e porte posteriori a due battenti
(vetrate o lastrate) o portellone basculante.
La casa italiana, nella realizzazione del veicolo commerciale in
questione, ha dato molta importanza ai fattori comodit e ra-
zionalit.
Tutto, allinterno, a portata di mano: sotto il tetto cabina c
una mensola di notevole dimensione pensata per riporre og-
getti e documenti, la posizione di guida rialzata, per una per-
fetta visibilit, e il cambio sulla plancia, in posizione ergono-
mica.
Massima attenzione anche al lato sicurezza, con un veicolo che
ha superato i crash test pi impegnativi. Per non lasciare nulla
al caso, labitacolo vanta una struttura rigida indeformabile con
barre laterali an-
tintrusione nelle
porte e limpian-
to antincendio
Fps di serie.
Dobl Cargo in
versione Combi-
nato con para-
tia, con scocca interamente vetrata, offre 4 o 5 posti comodi,
portata da 250 a 360 kg, a seconda delle versioni, e omologa-
zione in categoria N1 con notevoli vantaggi fiscali.
Il massimo della portata di 3000 kg.
Ampia la lista degli allestimenti. Il Dobl Cargo si adegua ad
ogni tipo di richiesta, soprattutto se si parla di carichi non ec-
cessivamente pesanti. Perfetto per chi svolge attivit nella ri-
storazione o nellelettronica, viste le mille soluzione di inseri-
mento vano oggetti allinterno del veicolo.
Il prezzo detax di Fiat Dobl Cargo Bipower 1.6 SX di
13.667,00 euro, mentre il prezzo di Fiat Dobl Bipower 1.6 SX
di 16.100,00 euro (chiavi in mano).
Un altro veicolo commerciale di punta targato Opel il Mova-
no. Pensato per luso quotidiano, propone un vano di carico di
13,9 m cubici, con una capacit massima di 1600 kg di carico
(altezza media di 1,91 m).
Semplice la manovra di carico e scarico merci, grazie ad una
doppia porta posteriore di 180 o 270 (a richiesta) e alla por-
ta scorrevole larga 1,10 m e alta 1,80 m (a richiesta, seconda
porta laterale scorrevole).
Il Movano in formato furgone presente in 4 motorizzazioni:
1,9 Cdti turbo (82 cv), 2,5 Cdti turbo (100 cv), 2,5 Cdti turbo
(115 cv) e 3,0 Cdti turbo (136 cv).
Tanti gli equipaggiamenti di serie, tra cui lilluminazione al
vano di carico, rete portaoggetti e portadocumenti, diversi
vani portaoggetti.
Per una sicurezza al top, il Movano si basa su un sistema di
trazione anteriore che consente di controllare il mezzo anche
in situazioni di guida decisamente critiche.
Massima attenzione anche allimpianto frenante (Abs) e agli
airbag (lato guida di serie, lato passeggero a richiesta).
Perfetto per chi svolge attivit giornaliera, il veicolo targato
Opel permette linserimento di diversi allestimenti esterni, sia
di carattere elettrico sia tecnico. La maneggevolezza del veico-
lo consente di intervenire sul vano con inserimenti di ogni tipo-
logia. Tra gli accessori Opel sono presenti scala, portapacchi
da tetto, gancio traino e tanti altri accorgimenti per impianti
elettrici (prese, lampade, vani...).
Buona, in relazione al prezzo, la disponibilit di colori, con 10
tonalit sul mercato. Interessante anche il prezzo: il modello
furgone 1.9 Cdti 82 cv 5 marce passo corto (tetto normale)
in vendita, chiavi in mano, al prezzo di 22.567,00 euro (iva in-
clusa).
Tra le case automobilistiche che realizzano veicoli commerciali
non poteva certo mancare un colosso come Toyota. Tra le varie
proposte offerte dal marchio giapponese grande interesse su-
AMPIA SCELTA PER LUSO QUOTIDIANO
Quattro proposte che utilizzano al meglio lo spazio disponibile e assicurano
facilit di carico
scita il Toyota Hiace. Pensato per soddisfare le esigenze del
cliente europeo, il Toyota Hiace modello furgone dotato di tre
comodi posti e ben 6 m di spazio disponibile.
Il razionale utilizzo dello spazio disponibile unito ad un'eccezio-
nale facilit di carico, lo rendono un partner indispensabile nel
trasporto di merci di tutti i tipi.
Con il pianale ribassato e l'altezza da terra della soglia di cari-
co ridotta ad appena 520 mm, le operazioni di carico e scarico
sono estremamente facilitate. Inoltre il vano di carico facil-
mente accessibile grazie alle due porte di grandi dimensioni:
una laterale scorrevole e una posteriore basculante a doppia
estensione di apertura.
Il veicolo in questione ideale per chi deve svolgere lavori di
consegna merci; si adatta, infatti, ad ogni tipologia di carico,
senza problemi di peso o forma. Possibilit di inserimento di al-
lestimenti esterni senza eccessivi ostacoli, vista la grandezza
dello spazio a disposizione (6 metri).
Dotato di un motore Turbodiesel Common Rail D-4D da 120 cv
di 2,5 litri, il veicolo Toyota pu contare su una progettazione
accurata, con tanto di servosterzo con raggio di sterzata di 5,5
m e soglia minima di rollio in curva, in virt di un avanzato si-
stema di ammortizzamento e unampia carreggiata. Studiata
anche la linea, pensata per avere un basso coefficiente di aero-
dinamicit (0,36). Con una garanzia importante (3 anni o
100.000 km), il Toyota Hiace ha un prezzo, chiavi in mano, di
21.690,00 euro (iva inclusa). Possibilit di servizio Eurocare,
con assistenza 24 ore su 24.
Quinta versione per il modello Transporter, laffidabile veicolo
commerciale con marchio Volkswagen. La nuova edizione
punta sullo sviluppo in termini di prestazioni, versatilit ed
economicit.
Possibili sei motorizzazioni di lunga durata, con una coppia che
si sviluppa lungo un'ampia fascia di regimi. Il suo comporta-
mento su strada agile e al tempo stesso equilibrato. Grande
possibilit di risparmio offrono i quattro motori TDI r, progetta-
ti in base allo speciale know-how Volkswagen nel settore
diesel, con nuova tecnologia pompa-iniettore e consumo deci-
samente contenuto (a partire da 6,0 l/100 km, alla velocit co-
stante di 90 km/h).
Da non sottovalutare neppure lopzione 4Motion r, trazione in-
tegrale permanente che permette di lavorare anche nelle con-
dizioni climatiche pi avverse, grazie ad una presa sul terreno
perfetta anche con pioggia battente, neve o altri agenti atmo-
sferici sfavorevoli.
Il nuovo Transporter proposto in una vasta scelta di varian-
ti: Furgone o Kombi, Camioncino o Autotelaio a cabina singo-
la o doppia; con sei motorizzazioni, due passi, tre altezze di
tetto per Furgone e Kombi, quattro masse complessive am-
messe tra 2,6 e 3,2 t.
Insomma, un veicolo universale per tutti i tipi di impiego.
Il comfort di notevole livello con sedili ergonomici, piantone
dello sterzo regolabile, numerosi portaoggetti con tanto di pra-
tico portabicchieri. Sono fornibili a richiesta il climatizzatore
nonch il riscaldamento autonomo supplementare con tempo-
rizzatore e comando a distanza, che creano un'atmosfera gra-
devole nell'abitacolo.
Lampia gamma di allestimenti a disposizione permette di sod-
disfare ogni richiesta: canaline porta oggetti e fili, panche e
cassettoni, ogni necessit trova spazio nellampio volume in-
terno, con - nella versione Furgone - quattro masse comples-
sive ammesse di 2,6 t, 2,8 t, 3,0 t e 3,2 t, portate utili da circa
0,8 t, 1,0 t, 1,2 t a 1,4 t e volume di carico da circa 5,8 m
3
a
9,3 metri
3
.
Il prezzo? Il modello Furgone 2.0, 85/115 cv, disponibile, chia-
vi in mano, a 23.290,00 euro.
I VEICOLI DA LAVORO
Il Giornale dellInstallatore Elettrico
www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 133
134
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
Come funziona?
Rubrica
di approfondimento
tecnico-pratico
di Mario Giorgio Bartolo - gie@reedbusiness.it
Un rel (o relais) un apparecchio il cui com-
pito quello di aprire o chiudere una o pi
coppie di contatti in dipendenza da un se-
gnale elettrico di comando.
I contatti di un rel possono essere di tipo normalmente aperto
(indicati in italiano come N.A. ma in inglese come N.O. da nor-
maly open) oppure di tipo normalmente chiuso (N.C. sia in ita-
liano che in inglese) dipendentemente dallo stato che assumono
a riposo in assenza del segnale di comando. In generale quindi,
in assenza di comando, i contatti N.A. di un rel risultano aperti
mentre quelli N.C. chiusi.
In presenza di comando i contatti N.A. si chiudono e quelli N.C.
si aprono. Principalmente in funzione della corrente che sono in
grado di interrompere i rel possono assumere dimensioni e co-
sti molto variabili. I tipi di maggiore impiego negli impianti elet-
trici, ai quali sono limitate queste brevi note, vengono general-
mente costruiti con criteri di modularit che ne ottimizzano lin-
stallazione in quadro, e con un numero di contatti pari ad uno,
due o quattro. Molto utilizzati sono anche i rel a tre terminali di
contatto (o in numero multiplo di tre) i quali funzionano alla
stregua di un deviatore: un terminale comune risulta N.C. ri-
spetto a uno dei due rimanenti e N.A. rispetto allaltro.
Allapplicazione del segnale di comando si ha istantaneamente
lapertura del contatto N.C. e la chiusura di quello N.A. Una simi-
le terna di terminali detta scambio: pi comunemente uti-
lizzati sono i rel a semplice e doppio scambio. La figura 1 indica
la rappresentazione grafica di alcune comuni tipologie di rel.
TIPI DI REL
A seconda del fenomeno fisico che causa lapertura e la chiusu-
ra dei contatti, i rel possono essere di tipo elettromeccanico,
termico, elettronico. La figura 2A schematizza, in modo estre-
mamente essenziale, il principio di funzionamento di un rel di
tipo elettromeccanico (di gran lunga il pi utilizzato in applica-
zioni di impianti elettrici in bassa tensione).
In esso una delle due estremit di unancoretta mobile di mate-
riale ferromagnetico, libera solo di ruotare attorno al punto O,
viene attratta da una bobina (coil) quando questa percorsa da
corrente a seguito dellapplicazione del segnale di comando ai
terminali A1-A2.
Tale azione provoca lo spostamento della seconda estremit
dellancoretta munita del contatto 2 verso il contatto 1 (fisso) e
la conseguente chiusura del circuito 1-2 (nella figura schema-
tizzato un rel con contatto N.A.). Nei rel termici, lapertura o
la chiusura del contatto causata dallincurvamento di una la-
mina bimetallica riscaldata dal calore percorso dalla corrente
che la precorre (figura 2B). Tali rel sono per lo pi impiegati
quali rel di protezione aventi la funzione di aprirsi automatica-
mente quando la corrente raggiunge valori eccessivi. Da una
decina danni a questa parte, molto comuni sono diventati an-
che i rel elettronici non dotati di contatti veri e propri ma nei
quali lapertura o la chiusura di un circuito ottenuta mandan-
do rispettivamente in interdizione o in saturazione un dispositi-
vo elettronico a stato solido quale ad esempio un transistor, un
Scr o un tiristore.
Tali dispositivi sono dotati di tre terminali e possono comportar-
si come veri e propri circuiti aperti (condizione di interdizione) o
corto circuiti (condizione di saturazione) tra due di essi dipen-
dentemente dal segnale di controllo applicato sul terzo termina-
le (figura 2C).
Il principale vantaggio dei rel elettronici quello di non avere
parti in movimento il che consente di ottenere tempi di chiusura
estremamente rapidi e di eliminare radicalmente lusura mecca-
nica e la sensibilit alle vibrazioni (aspetto questo molto impor-
tante per rel destinati ad essere installati a bordo di veicoli o
treni). Lassenza di contatti metallici elimina anche i problemi le-
gati allossidazione degli stessi (aspetto importante per rel de-
stinati ad essere installati in locali ad alto inquinamento). Di
contro, i rel a stato solido non possono garantire lisolamento
galvanico tra parte di comando e parte comandata e sono pi
delicati dal punto di vista termico ed elettrico.
IMPIEGHI
I rel possono trovare impiego nei sistemi di telecomando e te-
lecontrollo per comandare a distanza lapertura o la chiusura di
circuiti percorsi da correnti relativamente intense; nellautoma-
zione industriale essi costituiscono il cuore della logica cablata
per il controllo di processi produttivi, ove necessario effettuare
lapertura o la chiusura di un circuito al verificarsi di assegnate
condizioni; nella protezione i rel sono infine impiegati con la
funzione di aprire automaticamente un circuito quando la cor-
rente in esso raggiunge valori eccessivi.
Il principale utilizzo dei rel nellimpiantistica elettrica invece
quello di controllare lalimentazione di carichi funzionanti a ten-
sione di rete (230Vac) mediante segnali di comando operanti a
IL REL
Principio di funzionamento, caratteristiche tecniche, le diverse tipologie
e le possibilit di utilizzo
Figura 1 - Rappresentazione grafica di alcune comuni tipologie di rel
Figura 2 - Principio di funzionamento dei principali tre tipi di rel
bassissima tensione di sicurezza (Selv, Pelv) o funzionale
(felv). La tensione di comando infatti generalmente di 12 o
24 V (dc o ac). In tal senso essi permettono di ottenere una
separazione galvanica e sicura tra circuito di comando e cir-
cuito comandato. La figura 3 illustra ad esempio come possa
avvenire, in linea di principio, il controllo on/off di un carico
funzionante a tensione di rete mediante pulsanti e segnali di
comando operanti a bassissima tensione (24V). Quando in un
impianto elettrico si utilizzano molti rel elettromeccanici oc-
corre prestare attenzione al dimensionamento del trasforma-
tore abbassatore utilizzato per lalimentazione delle bobine
dei rel.
In tale contesto assume notevole importanza il dato del co-
struttore di questi ultimi inerente lassorbimento di corrente a
regime (ed al transitorio) della singola bobina. da segnalare
comunque che, oltre ai rel con comando in bassissima ten-
sione di sicurezza, esistono anche rel il cui comando della
bobina avviene alla tensione di rete.
CARATTERISTICHE GENERALI DI UN REL
Tra le caratteristiche pi importanti che devono guidare nella
scelta a catalogo si ricordano:
- corrente nominale: la corrente che nominalmente pu attra-
versare i contatti chiusi del dispositivo;
- capacit di commutazione: la corrente che pu essere inter-
rotta mediante lapertura dei contatti; generalmente inferiore
alla corrente nominale;
- tempo di chiusura: il ritardo che intercorre tra listante in cui
si ha la presenza della tensione di comando alla bobina e quel-
lo in cui si ha la chiusura piena dei contatti; molto pronun-
ciato per alcuni rel elettromeccanici, praticamente nullo per
quelli a stato solido;
- tensione di comando della bobina;
- corrente assorbita dalla bobina a regime: dato utile per il di-
mensionamento dei trasformatori di alimentazione nel caso di
bobine operanti in bassissima tensione;
- numero e tipo di contatti;
- ingombro in unit modulari;
- frequenza di commutazione: esprime il massimo numero di
commutazioni ON/OFF sopportabili dal dispositivo per ogni
ora di funzionamento con carico nominale;
- possibilit di forzatura manuale dei contatti: una performan-
ce che torna molto utile in fase di test di un impianto.
MONTAGGIO
Normalmente i rel utilizzati negli impianti elettrici trovano al-
loggiamento nei quadri di controllo e sono allo scopo predisposti
in configurazioni modulari per il fissaggio su barra DIN. In tal ca-
so il loro ingombro normalizzato in unit modulari (u.m. nei
cataloghi dei costruttori) aventi larghezza standard di 18mm.
Rel unipolari e bipolari presentano generalmente ingombro pa-
ri ad una u.m. mentre rel a tre o quattro poli hanno ingombro
di due u.m.
La figura 4 illustra due rel della General Electric concepiti per
montaggio su guida din ad una e due u.m. Si noti lindicazione
della corrente nominale (16A), lo schema funzionale del disposi-
tivo e la levetta per la forzatura dei contatti.
Al fine di ottimizzare lingombro di quadro evitando linstallazio-
ne di rel con contatti non utilizzati, quasi tutti i costruttori for-
niscono la possibilit di agganciare al rel una unit di contatto
ausiliario avente larghezza pari a 0,5 u.m.
Tale unit renderebbe ad esempio a tre contatti un rel origina-
riamente dotato di due, contenendone lingombro in 1,5 u.m. ed
evitando linstallazione di un dispositivo a quattro contatti, uno
dei quali inutilizzato, con ingombro di due u.m.
Una tale filosofia consentirebbe un risparmio di mezza unit mo-
dulare (9 mm) per ogni rel installato con un contenimento di 9
cm ogni 10 rel. Si capisce bene come in quadri destinati a con-
tenere centinaia di rel i requisiti dingombro divengono assai
stringenti e considerazioni di tal genere si rendono quanto mai
preziose per lottimizzazione dellingombro complessivo. Per un
buon utilizzo di qualsiasi rel occorre infine tenere sempre pre-
sente la tipologia del carico.
Se questultimo destinato al funzionamento continuo, come
accade ad esempio nel caso di figura 3 dove il carico costituito
da una sorgente luminosa, ragionevole ipotizzare che la bobi-
na rimanga sottoposta alla tensione di eccitazione in maniera
continuativa per periodi di tempo prolungati.
In tal caso, a causa delleffetto Joule dovuto alla resistenza non
nulla dellavvolgimento, vi sar un non trascurabile sviluppo di
calore; se ci avviene su pi rel adiacenti luno allaltro, la pro-
babilit che gli stessi subiscano danni da surriscaldamento au-
menta notevolmente.
Per evitare ci molti costruttori mettono a disposizione op-
COME FUNZIONA?
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 135
Figura 3 - Utilizzo di rel per comandare un carico in on/off
Figura 4 - Vista frontale di due rel ad 1 u.m. e 2 u.m. predisposti per
montaggio su guida din (fonte: catalogo GE)
COME FUNZIONA?
portuni moduli distanziatori, da predisporre nel montaggio
tra un rel ed il successivo, appositamente concepiti per favori-
re lo smaltimento del calore.
VARIAZIONI SUL TEMA
Nellimpiantistica elettrica molto diffuso lutilizzo di alcuni
dispositivi costituiti essenzialmente da rel equipaggiati con
opportuni sistemi di comando (elettromeccanici o elettroni-
ci) concepiti allo scopo di estenderne enormemente le fun-
zionalit. Tali dispositivi, impropriamente indicati come rel
(essendone il rel vero e proprio solo una parte), sono fonda-
mentalmente distinguibili in tre tipi (almeno limitando lo
sguardo alle tipiche applicazioni dellimpiantistica elettrica):
- rel di priorit;
- rel passo passo;
- rel temporizzatori.
REL DI PRIORIT
Sono dispositivi utilizzati per controllare la corrente assorbita
a valle di un contatore di energia in maniera tale che al supe-
ramento di una soglia impostata (generalmente tramite un
trimmer posto sul fronte dellapparecchio), il dispositivo atti-
va un rel con un contatto NA o NC.
Mediante tale azione possibile sganciare dallalimentazione
carichi con priorit bassa limitando il prelievo di energia e
lintervento delle protezioni termiche. La regolazione della so-
glia pu generalmente avvenire tra 0 e 6kW dipendentemente
dal costruttore e dal modello.
Il ritardo di intervento normalmente dellordine di 0,5-1s e
lingombro rimane quasi sempre contenuto entro 2 u.m.
REL PASSO PASSO
Sono dispositivi sequenziali che effettuano la commutazione
tra due posizioni fisse ogni volta che un breve impulso di ten-
sione viene applicato ai morsetti di comando.
Nei tipi elettromeccanici ogni volta che alla bobina giunge un
impulso di comando avviene la rotazione, per un angolo op-
portuno, di un sistema di camme che chiudono o aprono i
contatti.
Ad ogni impulso il sistema di camme assume una posizione
fissa corrispondente a contatti aperti o chiusi.
Allimpulso successivo corrisponde una seconda posizione
nella quale i contatti chiusi si aprono e quelli aperti si chiu-
dono. Il sistema funziona cos in maniera sequenziale ad ogni
impulso di comando. Esistono rel passo passo cosiddetti
multicircuito che servono ad alimentare due diversi carichi
per mezzo di un unico pulsante.
Nei tipi elettronici i due stati corrispondenti alle posizioni fis-
se del tipo elettromeccanico sono ottenuti mediante un circui-
to bistabile che comanda un rel a stato solido integrato.
REL TEMPORIZZATI
Sono dispositivi che permettono di ottenere la chiusura e/o
lapertura dei contatti per una durata preimpostata e con un
ritardo anchesso preimpostato rispetto limpulso di comando.
Solo la fantasia pu limitare limpiego di tali dispositivi che
possono essere utilizzati ad esempio per aprire e chiudere au-
tomaticamente porte al passaggio di una persona (limpulso
di comando pu essere in questo caso fornito da un rilevatore
di presenza), far lampeggiare luci, comandare pompe con la
giusta isteresi, ecc
136
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
d 46,90
I.V.A. esclusa
d 59,80
(2 pezzi)
I.V.A. esclusa
ORBIS ITALIA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci 9/B
20060 Cassina de Pecci -Mi-
Tel.: 02 / 95 34 34 54 Fax: 02 / 95 20 046
Internet: www.orbisitalia.it info@orbisitalia.it sede produttiva certificata
Comunica al tuo rivenditore
di fiducia il codice del
cronotermostato che hai scelto
(NEO o ERA) e il codice del
regalo che desideri.
La Orbis Italia S.p.A. si riserva in qualsiasi momento di modificare le indicazioni
riportate nel presente stampato senza darne alcun preavviso. Promozione
valida sino ad esaurimento scorte.
Il cronotermostato elettromeccanico giornaliero ERA, ha come
caratteristica principale la facilit d'uso.
La regolazione elettronica della temperatura ambiente tramite 2
manopole, la possibilit di gestire due livelli di temperatura, un
orologio meccanico giornaliero a cavalieri imperdibili per
l'impostazione del tempo di funzionamento, rendono il
cronotermostato elettromeccanico ERA, semplice, intuitivo,
elementare ed utilizzabile da qualsiasi tipo di utente.
Programmazione giornaliera
Tempo minimo d' intervento: 15 minuti
Due livelli di temperatura: Comfort - Risparmio
Commutatore manuale: Comfort - Automatico -
Risparmio
Alimentazione: 2 pile stilo alcaline 1,5V AA
Montaggio: su scatola a 3 moduli o a parete
Il cronotermostato digitale settimanale NEO, ha come caratteristica
principale la sua facile programmazione. Il sistema consiste in un
men di programmazione basato su messaggi di testo che guidano
passo dopo passo lutente alla configurazione dei parametri. E
disponibile in tre differenti colori (Bianco - Antracite - Alluminio).
8 programmi indipendenti
Programmazione settimanale
Possibilit di programmare il Neo separatamente dalla base
3 livelli di temperatura programmabili:
Comfort - Risparmio - Antigelo
Tempo minimo di intervento: 30 minuti
Possibilit di blocco della tastiera
Possibilit di funzionamento manuale
Contatore del numero di ore di funzionamento del
riscaldamento e del condizionamento
Cambio automatico dellora legale
Programma vacanze - manutenzione - sicurezza
Alimentazione: 2 pile ministilo alcaline 1,5V AAA
Montaggio: su scatola a 3 moduli o a parete
* In unica soluzione
OBRT 0060 OBRT 0080 OBRT 0070 OBRT 0030 OBRT 0020 OBRT 0010 OBRT 0050 OBRT 0090 OBRT 0040
Isolamento 1000V certificato
OBRT 0100
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
8
3
HYUNDAI TAGLIA
I COSTI DEL LAVORO.
3.000,00 euro
di sconto
incondizionato
(IVA inclusa)
H-1Truck Cassone
H-1Van 6 posti Air
H-1Van 3 posti
* Listino in vigore dal 1/2/2004
Offerta dei Concessionari Hyundai
che aderiscono all'iniziativa, non
cumulabile con altre in corso. Valida
fino al 31/10/2004 per veicoli
disponibili in rete. Dettagli presso i Concessionari Hyundai Automobili Italia - Societ del Gruppo Koelliker SpA
w
w
w
.
h
y
u
n
d
a
i
-
a
u
t
o
.
i
t
Listino esclusa IVA, messa in strada e IPT
*
.
H-1 TDI Van 6 posti lungo Air 15.146,67
H-1 TDI Truck Telaio 13.688,33
H-1 TDI Truck Cassone 14.363,33
H-1 TDI Van 3 posti corto 12.471,67
H-1 TDI Van 3 posti corto Air 13.480,00
H-1 TDI Van 3 posti lungo 13.788,33
H-1 TDI Van 3 posti lungo Air 14.796,67
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
7
8
0
Il Giornale dellInstallatore Elettrico www.reedbusiness.it N. 13 10 Ottobre 2004 139
Libri & cataloghi
Che cosa leggere
per essere sempre
aggiornati
a cura di Fulvia Cattaneo - fulvia.cattaneo@reedbusiness.it
do le indicazioni del decreto legislativo 388/2003. Per rendere pi
efficace la formazione e facilitare il compito di medici e imprese,
Mega Italia Media ha rea-
lizzato, con la con-
s u l e n z a
s c i ent i f i c a
del Suem 118
(Servizio di ur-
genza ed emer-
genza medica) di
Brescia, il video-
corso Primo soc-
corso sul luogo di la-
voro. Disponibile su vhs, cd-rom o
in modalit e-learning (formazione a distanza), il corso illustra co-
me organizzare e formare un efficiente sistema di primo soccor-
so in azienda: il piano di emergenza, la comunicazione con il
118, le attrezzature e i dispositivi di protezione, i rischi connes-
si allintervento degli addetti.La parte principale del corso de-
stinata alla descrizione del comportamento in caso di infortunio:
dalla verifica e sostenimento delle funzioni vitali a come agire in
caso di arresto cardiorespiratorio, dalla movimentazione del-
linfortunato ai casi di soffocamento, dalle crisi asmatiche alle fe-
rite, dalle lesioni da corrente elettrica e da agenti chimici ai ca-
si di intossicazione. Con efficaci immagini e schede di sintesi lat-
tenzione dei partecipanti al corso viene mantenuta viva e ne
viene facilitato lapprendimento. Il pacchetto di formazione com-
prende anche un manuale e le schede di valutazione utilizzabili
per la verifica obbligatoria di fine corso.
servizio lettori 155
Stefano Bellintani
Manuale della domotica. Tecnologie ed evoluzione dellabitare
Ed Il Sole 24 Ore, Milano
Pagg. 341 - 40,00
Il volume si propone di dimostrare che oggi la domotica una realt
attuabile, affrontando le questioni che attengono alla cosiddetta ho-
Terasaki
Interruttori e
apparecchiature modulari
Per la nuova serie modulare
TemDin 2, comprendente inter-
ruttori magnetotermici da 4.5 a
15 kA, non automatici, magne-
totermici differenziali, differen-
ziali puri, blocchi differenziali,
contattori, teleruttori, pulsanti,
interruttori analogici e digitali,
strumenti di misura, trasforma-
tori e cassette in materiale iso-
lante, Terasaki ha realizzato un
nuovo catalogo in due versioni:
ledizione integrale e quella sin-
tetica, per una rapida consulta-
zione.
La prima, suddivisa in tre parti
(specifiche prodotti, informazio-
ni tecniche, dimensioni), racco-
glie in un unico catalogo tutti i
dati tecnici e gli approfondimenti
necessari per operare la scelta
migliore.
Nella prima parte, infatti, sono ri-
portate le specifiche fondamen-
tali di ciascun prodotto (potere di
interruzione, caratteristiche di
intervento, dati tecnici, applica-
zioni, codici e descrizione...); nel-
la seconda parte, insieme alle
informazioni relative alle condi-
zioni standard di funzionamento
ed installazione, trovano posto le
caratteristiche di intervento, le
curve I2t, le tabelle relative al-
linfluenza della temperatura
ambiente e dellaltitudine, ta-
belle di selettivit e back-up.
La terza parte, infine, espone
dettagliatamente le dimensioni
dei prodotti.
La guida rapida di consultazione,
invece, indica sinteticamente la
tipologia, le caratteristiche e i
codici dei prodotti, utilizzando
per ciascuna serie colori diversi
e foto a corredo.
servizio lettori 154
Mega Italia
Il primo soccorso
in un videocorso
Dal 3 agosto scorso, le aziende
non hanno pi la facolt di de-
cidere autonomamente le mo-
dalit di formazione degli ad-
detti della squadra del primo
soccorso aziendale, ma devono
affidarsi ad un medico che or-
ganizzer la formazione secon-
me automation e ponendo lac-
cento su esperienze e realizza-
zioni concrete. Inoltre, vengono
analizzati apparati e sistemi, ov-
vero la tecnologia che sta alla
base dellautomazione domesti-
ca. In particolare, lattenzione
viene concentrata sul valore ag-
giunto della domotica agli edi-
fici abitativi, cercando di descri-
vere lo stato dellarte e di prefi-
gurare gli sviluppi del mercato, in
termini sia di teleserviizi alla ca-
sa (citt cablata), sia di nuove
prospettive per il mercato im-
mobiliare della residenza.
servizio lettori 156
Ruggero Tumbiolo (a cura di)
Quaderni della rivista giuridica dell'ambiente, n 11
L'inquinamento elettromagnetico
Giuffr Editore, Milano
Pagg. 130 - 9,30
L'undecimo quaderno della rivista giuridica del-
l'ambiente dedicato all'inquinamento elettro-
magnetico che, come noto, tema oggi parti-
colarmente sentito da parte dell'opinione pub-
blica. Tale interesse venuto registrandosi a se-
guito soprattutto dell'ingente incremento di
impianti di antenne radio base per la telefonia
cellulare, nonch a seguito delle preoccupazio-
ni per la salute dei cittadini derivanti dalla espo-
sizione a sorgenti inquinanti.
Ci ha reso necessario sin dagli inizi il deciso in-
tervento della giurisprudenza, che ha presto
prodotto un vero e proprio complesso normati-
vo a cui si cercato di ovviare per mezzo del
d.lgs. 36/2001, ovverosia "Legge quadro sulla
protezione dall'esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici".
Obiettivo perseguito dall'autore stato ap-
punto quello di offrire al lettore un utile e pre-
zioso strumento di informazione giurispruden-
ziale relativo alla disciplina.
Il volume, infatti, comprendente il d.lgs 36/2001,
opportunamente commentato, delinea il pano-
rama normativo precedente la legge quadro:
dalle disposizioni in materia di elettrodotti alle
norme sulla compatibilit elettromagnetica del-
le apparecchiature; dall'istituzione dell'Auto-
rit per le garanzie nelle comunicazioni al d.m.
381/98 "Regolamento recante le norme per la de-
terminazione
dei tetti di ra-
diofrequenza
compat i bi l i
con la salute
umana".
Trova invece
una soddisfa-
cente e consi-
derevole trat-
tazione, oltre
alla parte de-
dicata alla nor-
mativa delle
singole regioni e delle province di Trento e Bol-
zano, emanate prima e dopo il suddetto decre-
to, anche il capitolo concernente la tutela pro-
cessuale che sia dal punto di vista penale che ci-
vile, non ultimo il contenzioso amministrativo,
di notevole ausilio a quanti operano nel settore.
Correda l'opera, in appendice, sia la rassegna del-
le principali fonti normative comunitarie, statali,
regionali e delle provincie autonome test esa-
minate, sia un'ampia rassegna bibliografica a cui
i lettori possono fare riferimento in occasione di
un approfondimento pi circostanziato ed esau-
stivo sull'argomento.
Armando Ferraioli
servizio lettori 157
Agenda
140
Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
FIERE, MOSTRE E CONVEGNI
CORSI E SEMINARI
Gli eventi
e gli appuntamenti
da non perdere
a cura di Elena Radice - elena.radice@reedbusiness.it
APPUNTAMENTO DOVE E QUANDO ORGANIZZATORE
Corso sulla normativa elettrica - Bologna, 18-19-20 ottobre 2004 TuttoNormel
L'impianto elettrico tel. 011-6611212 - fax 011-6618105
e la prevenzione incendi info@tne.it - www.tne.it
Corso di formazione "Tecniche Rozzano (MI), 19-20 ottobre, Control Techniques Spa
di programmazione Sypt - Sistema di 14-15 dicembre 2004 tel. 02-575751 - fax 02-57512858
sviluppo avanzato standard Iec 61131-3" www.controltech.it
Seminario tecnico per progettisti Cagliari, 20 ottobre; BTicino con la partecipazione del CEI
di impianti elettrici Milano, 18 novembre 2004 Per informazioni: call center servizio
clienti 199145145
Corso sulla normativa elettrica - Milano, 25-26-27 ottobre 2004 TuttoNormel
Legislazione e responsabilit tel. 011-6611212 - fax 011-6618105
nel settore elettrico info@tne.it - www.tne.it
Forum Energia e Sicurezza. Progettazione, Genova, 28 ottobre; Per informazioni:
esecuzione, manutenzione dei sistemi Udine, 11 novembre; www.forumenergiaesicurezza.it
per l'energia e la sicurezza Ancona, 25 novembre;
Parma, 2 dicembre 2004
Corso sulla normativa elettrica - Milano, 8-9-10 novembre 2004 TuttoNormel
Quadri elettrici di bassa tensione tel. 011-6611212 - fax 011-6618105
info@tne.it - www.tne.it
APPUNTAMENTO DOVE E QUANDO ORGANIZZATORE
Matelec Madrid (Spagna), 26 - 30 ottobre 2004 Ifema - tel. +34-91-7225174
Salone internazionale fax +34-91-7225793 - ifema@ifema.es
del materiale elettrico www.matelec.ifema.es
ed elettronico
Sinergy Rimini, 3 - 5 novembre 2004 Rimini Fiera Spa
Le reti tecnologiche in mostra tel. 0541-744292 - fax 0541-744204
www.sinergyexpo.com
Electronica 2004 Monaco di Baviera (Germania), Monacofiere Srl - tel. 045-8205843
Salone internazionale per componenti 9 - 12 novembre 2004 fax 045-8205886 - info@monacofiere.it
e assiemi elettronici www.monacofiere.it
Sicailux Pordenone, 10 - 13 novembre 2004 Business International Srl
Salone internazionale dei componenti tel. 02-876519 - fax 02-8052905
e accessori per l'illuminazione info@sicailux.it - www.sicailux.it
Sicurezza Milano, 17 - 20 novembre 2004 Fiera Milano Tech Spa
Mostra internazionale di apparecchiature, tel. 02-3264282 - fax 02-3264284
sistemi e servizi per la sicurezza integrata, fiere@fieramilanotech.it
l'automazione degli edifici e l'antincendio www.intelshow.com
Process 2005 Bologna, 16 - 18 febbraio 2005 BolognaFiere Spa
Mostra e convegno internazionale tel. 051-282399 - fax 051-6374014
sull'ingegneria, le tecnologie e la gestione process@bolognafiere.it
delle industrie di processo www.process.bolognafiere.it
ISH Francoforte sul Meno (Germania) Messe Frankfurt Italia Srl
Fiera internazionale della domotecnica, 15 - 19 marzo 2005 tel. 02-8807781 - fax 02-72008053
della tecnica energetica e mondo del bagno info@italy.messefrankfurt.com
Intel 2005 Milano, 17 - 21 maggio 2005 Fiera Milano Tech Spa
Internazionale di elettrotecnica, tel. 02-3264283 - fax 02-3264284
elettronica, illuminazione, automazione segreteria@fieramilanotech.it
e componentistica. 19 edizione www.intelshow.com
Medielettrica Palermo, 21 - 23 ottobre 2005 Promopalermo Srl
Mostra mediterranea del materiale tel. 091-6124368 - fax 091-6091695
elettrico, illuminotecnica ed elettronica www.medielettrica.it
La redazione declina ogni responsabilit circa variazioni o imprecisioni
s
e
r
v
i
z
i
o
l
e
t
t
o
r
i
1
6
4
7
142 Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 13 10 Ottobre 2004 www.reedbusiness.it
AZIENDE CITATE
AZIENDA PAGINA
Abb Sace Spa - Sesto San Giovanni MI 94
Aci Srl Farfisa Intercoms - Osimo AN 115
Aeco Srl - Inzago MI 30
AlHof di A. Hofmann Spa - Milano MI 113
Altecon Srl - Lissone MI 22
Amra Spa - Macherio MI 50
Arteleta International Srl - Cinisello Balsamo MI 82
Ats Elettronica Srl - Avellino AV 8
Belimo Servomotori Srl - Zanica BG 115
Bertoldo & C. Srl Div. Belt - Venaria Reale TO 110
Biffi Luce - Busnago MI 115
Bm Spa - Rozzano MI 32-33
Bticino Spa - Milano MI 58-59
Burster Italia Srl - Curno BG 93
Canfor Utensili Srl - Pero MI 131
Ceb Italia Srl - Usmate Velate MI 47
CGT - Carugate MI 114
Cia Trading Srl - Napoli NA 91
Codime Spa - Assago MI 49-51-53
Comelit Group Spa - S. Lorenzo di Rovetta BG manchette
Con.Trade Srl - Bergamo BG 75
Conchiglia Spa - Reggio Emilia RE 141
Datasensor Spa - Monte San Pietro BO 102
Ds Europe Srl - Milano MI 102
Ebo Systems Srl - Curno BG 113
Eisenbau Srl - Cornaredo MI 94
Elap Spa - Corsico MI 100
Elcam Sistemi Srl - Milano MI 93
Elcotronic Srl - Imola BO 118
Eldes Instruments Srl - Milano MI 98
Elicent Spa - Lonato BS 5
Esselte Spa - Gorgonzola MI 15
Eurage - Cologno Monzese MI 143
F Soft Srl - SantAmbrogio di Torino TO 36
F.lli Amos & C. Spa - Cologno Monzese MI 20
Faeber Lighting System Spa - Orio al Serio BG 12
AZIENDA PAGINA
Fanton Spa - Conselve PD 117
Fiera Milano Tech Spa - Milano MI 118
Flir Systems Italia Srl - Limbiate MI 97
Fluke Italia Srl - Brugherio MI 111
Fort Fibre Ottiche Srl - Curno BG 96
Fracarro Spa - Castelfranco Veneto TV 63-67
Gdt Elettroforniture Spa - Rozzano MI 100
GE Infrastructure Sensing / Druck Italia Srl - Rho MI 101
Gewiss Spa - Cenate Sotto BG IV cop.-21-23
25-27-29-120
Ghisalba Spa - Cascine Vica Rivoli TO 19
Gigieffe di Guerra Gian Franco - Lugo RA 24
Gramm Srl - Montemiletto AV 46
Grena Srl - Pedrengo BG 130
Hyundai Automobili Italia / Koelliker Spa - Milano MI 137
Icim Spa - Milano MI 114
Iess Sistemi Sicuri - Campodarsego PD 6
Ige-Xao Srl - Bergamo BG 115
Il Carbonio Spa - Milano MI 116
Imc Srl - Salerno SA 13
Inexport Italia Srl - Milano MI 62
Innovative Instruments Srl - Milano MI 100
K.E.R.T. Srl - Caerano S. Marco TV 69
La Filometallica Srl - Milano MI 52
La Triveneta Cavi Spa - Brendola VI 117
Legrand Spa - Zibido S. Giacomo MI patella-37-108-109
LEM Italy - Selvazzano Dentro PD 96
Leonardo Luce Italia Spa - Buccinasco MI 7
Liebert Hiross Italia - S. Giuliano Milanese MI 119-126
Lince Italia Srl - Ciampino RM 121
Lovato Electric Spa - Gorle BG 14
Mareco Luce Srl - Bertinoro FO 111
Masautomazione Srl - Segrate MI 98
Matsushita Electric Works It. Srl - Bussolengo VR 97-102
Messi & Paoloni Srl - Ancona AN II cop.
Meta System Spa - Reggio Emilia RE 124
AZIENDA PAGINA
Mge Italia Spa - Agrate Brianza MI 126
Micro Tek Srl - Rozzano MI 70
Moeller Electric Srl - Rodano MI 81-112-124
Multitecno Srl - Fossalta di Portogruaro VE 61
NBC Elettronica Srl - Delebio SO 93
Ntet Srl - Piano Tavola CT III cop.
Nuova Mizar Srl - Badoere di Morgano TV 35
Omron Electronics Spa - Milano MI 57-126
Orbis Italia Spa - Cassina de Pecchi MI 136
Palazzoli Spa - Brescia BS 114-125
Philips Spa Div. Lighting - Monza MI 107-116
Phoenix Contact Srl - Cusano Milanino MI 111-124
Picotronik Srl - Mirandola MO 98
Powertronix Spa - Grezzago MI 92
Prospecta Sas - Villa Cella RE 103
Qubix Networking Solutions - Padova PD 104
Riello UPS - S. Pietro di Legnago VR 119
Rockwell Automation Srl - Milano MI 101
Rs Components Spa - Cinisello Balsamo MI 123
Saip & Schyller Srl - Stezzano BG 112
Schneider Electric Spa - Agrate Brianza MI 111
SE Project di Domenico Sartore - San Pietro in Gu PD 102
Siemens Spa - Milano MI 105-112
Sirsen Srl - Monterusciello Pozzuoli NA 127
Sistem Air - Gravellona Lomellina PV 106
Socomec Sicon Ups - Villaverla VI 9-124
Stagnoli Srl - Desenzano del Garda BS 73
Tekkal - Milano MI 97
Teleco Automation Srl - Colle Umberto TV 77
Telestar Srl - Rovellasca CO 95
Tubifor di Antonio Fortunati - Buonabitacolo SA 10
Unahom Start Spa - Peschiera Borromeo MI 26
Urmet - Torino TO 11
Vega Italia Srl - Milano MI 93
Vemer Siber Group Spa - Brugherio MI 16-17
Vimar Spa - Marostica VI 99
Wago Elettronica Srl - S. Lazzaro di Savena BO 94
Weidmller Srl - Cinisello Balsamo MI 89-119
Wenglor Sensoric Italiana Srl - Vimodrone MI 102
Wika Italiana Srl - Rho MI 95
Zeca Spa - Feletto Canavese TO 65
Qui di seguito sono riportati i nominativi delle aziende citate in questo numero e la relativa pagina.
Le aziende inserzioniste sono evidenziate in blu. Se desiderate ricevere ulteriori informazioni sulle
notizie riportate nella rivista, potete utilizzare il nostro Servizio Lettori.
sufficiente compilare e inviare per fax (allo 02 36519123) la scheda pubblicata nell'ultima pagina,
citando il numero di riferimento associato a ciascuna notizia o pubblicit. Per una risposta pi ra-
pida potete utilizzare il nostro Servizio Lettori on-line all'indirizzo Internet www.serviziolettori.it.
I
l
m
o
n
d
o
E
U
R
A
G
E
Via A. Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (Milano)
Tel. 02 27301179 - Fax 02 70058476
e-mail: eurage@eurage.it - www.eurage.it
La nostra regola doro:
al servizio
del cliente!
PIEMONTE Tel. Fax
ELETTROFORNITURE
VERBANO S.r.l. Verbania VB (0323) 553195 (0323) 553377
LOMBARDIA
CEM COMMERCIALE S.r.l. Bresso MI (02) 26221428 (02) 2409778
C.E.M.E. S.p.A. Busto Arsizio VA (0331) 324000 (0331) 639436
C.M.E. S.r.l. Bovisio Masciago MI (0362) 559862 (0362) 559871
ELETTRA S.p.A. Cinisello Balsamo MI (02) 6607131 (02) 6181877
ELETTRICA EUROPA S.r.l. Palazzolo sullOglio BS (030) 7301411 (030) 7300355
GALMARINI EMILIO S.p.A. Gallarate VA (0331) 780900 (0331) 780910
GALMARINI EMILIO S.p.A. Gallarate VA (0331) 796350 (0331) 770800
GIARDINI CARLO S.r.l. Vigevano PV (0381) 346975 (0381) 346511
PIETRO PESENTI S.p.A. Pedrengo BG (035) 657530 (035) 657425
VENETO
MATEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Caselle di Selvazzano PD (049) 8739911 (049) 8739922
MATEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Silea TV (0422) 460668 (0422) 460658
MATEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Marghera VE (041) 937455 (041) 931520
LIGURIA
FO.EL. S.r.l. Sarzana SP (0187) 606413 (0187) 691090
S.M.A.E.S. S.r.l. Savona SV (019) 810591 (019) 810890
TOSCANA
FO.EL. S.r.l. Massa MS (0585) 791171 (0585) 790989
FO.EL. S.r.l. Pontremoli MS (0187) 832510
FO.EL. S.r.l. Querceta LU (0584) 769139 (0584) 742897
I.F.EL. S.r.l. Arezzo AR (0575) 357849 (0575) 323939
PIEMME S.r.l. Prato PO (0574) 433951 (0574) 433955
PIEMME S.r.l. Firenze FI (055) 351292 (055) 351295
LAZIO
M.E.T. S.r.l. Roma RM (06) 2382690 (06) 2389454
ABRUZZO
D.I.M.E. S.r.l. S.Giovanni Teatino CH (085) 4463759 (085) 4460568
D.I.M.E. S.r.l. Pescara PE (085) 4311134 (085) 4315867
D.I.M.E. S.r.l. Chieti Scalo CH (0871) 564099 (0871) 565047
D.I.M.E. S.r.l. Tortoreto TE (0861) 777081 (0861) 777168
ELETTROMARKET S.r.l. Castel di Sangro AQ (0864) 845338 (0864) 845338
FOGEME S.r.l. Avezzano AQ (0863) 49831 (0863) 4983206
FOGEME S.r.l. Avezzano AQ (0863) 25480 (0863) 20650
UMBRIA
BARBACCIA MARIO S.r.l. Terni TR (0744) 300291 (0744) 300943
DIS.M.E.P. S.r.l. S. Andrea / S. Sisto PG (075) 5289047 (075) 5270655
ELETTRA S.r.l. S.Eraclio di Foligno PG (0742) 391066 (0742) 391104
CAMPANIA
EUROELETTRA S.r.l. Arzano NA (081) 5734334 (081) 5734334
F.LLI BORRELLI & C. S.n.c. Aversa CE (081) 5038762 (081) 5046446
F.LLI BORRELLI & C. S.n.c. Aversa CE (081) 8902230
PUGLIA
CARLI ANGELO & C. S.a.s. Barletta BA (0883) 347595 (0883) 347965
CARLI ANGELO & C. S.a.s. Barletta BA (0883) 332084
F.A.P.E. S.r.l. Andria BA (0883) 557108 (0883) 557107
F.A.P.E. S.r.l. Corato BA (080) 8987113
FOREL S.r.l. Lecce LE (0832) 351975 (0832) 351573
FOREL S.r.l. Nard LE (0833) 572530 (0833) 572530
PAGE S.r.l. Foggia FG (0881) 724113 (0881) 771947
SICILIA
ELECTRIC GELA S.r.l. Gela CL (0933) 901919 (0933) 901163
ELECTRIC GELA
di Catania Giuseppa Gela CL (0933) 930809 (0933) 822785
OR.VE.ME. S.r.l. Canicatt AG (0922) 856015 (0922) 859767
ELETTOSUD S.p.A. Brolo ME (0941) 561296 (0941) 562155
ELETTROSUD S.p.A. Giardini Naxos ME (0942) 50238 (0942) 654398
ELETTROFORNITURE S.a.s. Saponara Marittima ME (090) 332473 (090) 3379250
ELETTROSUD S.p.A. Capo dOrlando ME (0941) 911120 (0941) 911120
ELETTROSUD S.p.A. S. Agata Militello ME (0941) 722529 (0941) 722529
ELETTROSUD S.p.A. Catania CT (095) 477481 (095) 472190
SARDEGNA
ELETTRICA INDUSTRIALE S.r.l. Quartu S. Elena CA (070) 83631 (070) 885956
ELETTRICA INDUSTRIALE S.r.l. Carbonia CA (0781) 665141 (0781) 665142
ELETTRICA INDUSTRIALE S.r.l. Cagliari CA (070) 20271 (070) 252087
ELETTRICA INDUSTRIALE S.r.l. Nuoro NU (0784) 295096 (0784) 295097
ELETTRICA INDUSTRIALE S.r.l. Oristano OR (0783) 358650 (0783) 358653
ELETTRICA INDUSTRIALE S.r.l. Sassari SS (079) 2639500 (079) 2639555
servizio lettori 1720
N. 14 2 Il Giornale dellInstallatore Elettrico N. 17 15 Ottobre 2002 www.reedbusiness.it
PERIODICO PER INSTALLATORI E OPERATORI DEL COMPARTO ELETTRICO
ORGANO DIRETTIVO NAZIONALE DI CONFARTIGIANATO - IMPIANTI
Anno 26 - Numero 13 - 10 Ottobre 2004
Direttore Editoriale: Giovanni Danielli - giovanni.danielli@reedbusiness.it; Caposervizio:
Fulvia Cattaneo - fulvia.cattaneo@reedbusiness.it; In redazione: Alessia Varalda - ales-
sia.varalda@reedbusiness.it; Segreteria di redazione: Elena Radice - elena.radice@reed-
business.it; Impaginazione e grafica: Design 3; Hanno collaborato a questo numero:
Angelo Baggini, Mario Giorgio Bartolo, Daniela Di Cola, Armando Ferraioli, Antonello Greco, Rober-
ta Leprotti, Alessandra Lucaccini, Paolo Micelotta, Giacomo Orlandi, Antonio Porro, Thomas Sacca-
ni, Pierfrancesco Sodini, Gabriele Tacchi, Alma Taddei
Reed Business Information SpA
Viale G. Richard, 1/a - 20143 Milano
Tel. 02/81830.1
www.reedbusiness.it
Amministratore Delegato: Alessandro Cederle; Direttore Circulation, Produzione e Affari
Generali: Cesare Rotondo; Publisher: Alberto Banal; Direttore Finanziario: Giuseppe Mauri
DIVISIONE ELETTRICO
Viale G. Richard, 1/a - 20143 Milano - Italia
Telefono Redazione: 02/81830629 - Telefax Redazione: 02/81830418
Telefax Pubblicit: 02/81830405 - http://www.reedbusiness.it
Direttore Vendite: Sergio Cirimbelli (sergio.cirimbelli@reedbusiness.it) - Servizio Traffico: Giuseppina Fusar (giusep-
pina.fusar@reedbusiness.it) - Servizi Vendite: Agostina Assandri (agostina.assandri@reedbusiness.it) - Foreign Sales
Advertising: Silvia Lusetti Tel. 02/81830246 (silvia.lusetti@reedbusiness.it)
Pubblicit a norma dellarticolo 2 comma 20/b legge 662/96.
Registrazione del Tribunale di Milano n. 285 del 2/8/1978.
Direttore Responsabile: Alberto Banal - Iscrizione al ROC n. 1136
Stampa: Roto 3 - Via Turbigo 11/B - 20022 Castano Primo (MI)
Una copia 3,40. I numeri arretrati il doppio. Abbonamento annuo Italia 54,50; Estero: $ 82,00; 82,00. Gli abbonamenti si rice-
vono a mezzo vaglia, assegno non trasferibile, mediante versamento sul conto corrente postale 33668666 intestato a Reed Business
Information SpA indicando chiaramente mittente e causale del versamento. Ancora via e-mail (abbonamenti@reedbusiness.it) telefono
(02/81830221) o fax (02/81830404). LIva sugli abbonamenti, nonch sulla vendita dei fascicoli separati, assolta dallEditore ai sensi
dellart. 74 primo comma lettera C del DPR 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto non pu essere rila-
sciata fattura. La rivista inviata ai soci della Confartigianato Impianti. Il prezzo dellabbonamento incluso nella quota associativa.
Tutti i diritti di riproduzione degli articoli e/o delle foto sono riservati.
Manoscritti, foto, disegni, quando non esplicitamente richiesti, non vengono restituiti.
Copyright Reed Business Information - Milano - Italia
Reed Business Information associato a:
Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformit al Regolamento
C.S.S.T. - Certificazione Stampa Specializzata Tecnica
Per il periodo 1/1/2003-31/12/2003 Certificato C.S.S.T. n. 2003-788 del 25/02/2004
Tiratura media n. 21.330 copie Societ di revisione: Italaudit spa
Diffusione media n. 20.970 copie Tiratura del presente numero: n. 20.000 copie
Informativa ai sensi dellart. 13, d. lgs 196/2003. I dati sono trattati, con modalit anche informatiche, per linvio della rivista e per svolgere le attivit a ci
connesse. Titolare del trattamento : Reed Business Information S.p.A. - Viale Giulio Richard, 1/A - 20143 Milano (MI). Le categorie di soggetti incaricati del trat-
tamento dei dati per le finalit suddette sono gli addetti alla registrazione, modifica, elaborazione dati e loro stampa, al confezionamento e spedizione delle riviste,
al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 possibile esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
aggiornare o cancellare i dati, nonch richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.
Informativa delleditore al pubblico ai sensi dellart. 13, d. lgs 196/2003. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e dellart. 2, comma 2 del
Codice deontologia relativo al trattamento dei dati personali nellesercizio dellattivit giornalistica, Reed Business Information S.p.A. - titolare del trattamento -
rende noto che presso i propri locali siti in Milano (MI), Vle Giulio Richard 1/A, vengono conservati gli archivi di dati personali e di immagini fotografiche cui i
giornalisti, praticanti, pubblicisti e altri soggetti (che occasionalmente redigono articoli o saggi) che collaborano con il predetto titolare attingono nello svolgimento
della propria attivit giornalistica per le finalit di informazione connesse allo svolgimento della stessa. I soggetti che possono conoscere i predetti dati sono esclu-
sivamente i predetti professionisti, nonch gli addetti preposti alla stampa ed alla realizzazione editoriale della testata. Ai sensi dellart. 7, d. lgs 196/2003 si pos-
sono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, rivolgendosi al predetto titolare. Si ricorda che, ai sensi
dellart. 138, d. lgs 196/2003, non esercitabile il diritto di conoscere lorigine dei dati personali ai sensi dellart. 7, comma 2, lettera a), d. lgs 196/2003, in virt
delle norme sul segreto professionale, limitatamente alla fonte della notizia.
Per la pubblicit sulle riviste Reed Business Information Spa contattare il:
tel. 02/81830655 - fax 02/81830405
SERVIZIO LETTORI
Volete ricevere ulteriori informazioni sui prodotti presentati dal Giornale dellInstallatore Elettrico?
Compilate questa cartolina in ogni sua parte, ritagliatela e inviatela via fax al numero: 02/36519123
Il servizio totalmente gratuito
Per una risposta pi rapida, potete usufruire anche del servizio lettori on-line. Visitate il sito www.serviziolettori.it
Segnare qui a fianco Servizio Lettori numero
il riferimento Servizio lettori ..................................................
riportato in calce alla notizia. ..................................................
possibile indicare anche ..................................................
pi riferimenti. ..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
Desidero ricevere maggiori informazioni
sui prodotti presentati nel:
Giornale dellInstallatore Elettrico numero
13
Riportate qui di seguito i vostri dati
e lindirizzo per linvio
delle informazioni
Nome ................................................................................
Cognome ..........................................................................
Societ ..............................................................................
Telefono ............................................................................
Fax ....................................................................................
E-mail ................................................................................
Via ....................................................................................
Cap ....................................................................................
Localit..............................................................................
Provincia ..........................................................................
Aiutateci a servirvi meglio!
Come ha avuto questa copia del Giornale
dellInstallatore Elettrico?
(barrare la casella corrispondente)
Lho ricevuta per posta ........................................................
Lho ritirata da un grossista di materiale elettrico ..
Altro ......................................................................................
Leditore si impegna a sottoporre gratuitamente alle aziende interessate tutte le
richieste provenienti dai lettori.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali
vostro diritto chiederne la modifica, la cancellazione od opporvi al loro futuro utiliz-
zo, scrivendo all'attenzione del Responsabile Dati di Reed Business Information Spa.
Il trattamento dei dati effettuato al fine di inviarvi, senza alcun impegno, le infor-
mazioni commerciali o promozionali da voi richieste con il presente modulo.
Nel caso non desideriate ricevere ulteriori informazioni, barrate questa casella:
Segnare qui a fianco
il numero della notizia
riportato in calce.
possibile indicare
anche pi riferimenti.
USPI -
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA
Potrebbero piacerti anche
- LED Penultima frontiera - PilloLED per Acquariofili IntraprendentiDa EverandLED Penultima frontiera - PilloLED per Acquariofili IntraprendentiNessuna valutazione finora
- GIE 2005 Num 01 TuttoDocumento104 pagineGIE 2005 Num 01 Tuttomax_ingNessuna valutazione finora
- Catalogo 300Documento100 pagineCatalogo 300robertoNessuna valutazione finora
- De 100Documento56 pagineDe 100Luca Singolo100% (4)
- Company Profile TQ (Ita)Documento9 pagineCompany Profile TQ (Ita)Lorenzo PellegrinoNessuna valutazione finora
- GIE 2005 Num 03 TuttoDocumento112 pagineGIE 2005 Num 03 Tuttomax_ingNessuna valutazione finora
- Catalogo 2005Documento120 pagineCatalogo 2005Веска БоневаNessuna valutazione finora
- ABB Electrical Installations Handbook I (Dispositivi Di Protezione e Control Lo)Documento119 pagineABB Electrical Installations Handbook I (Dispositivi Di Protezione e Control Lo)Marcello NavanteriNessuna valutazione finora
- Guida All'Impianto ElettricoDocumento200 pagineGuida All'Impianto ElettricoAndrea TomasselliNessuna valutazione finora
- Analisi Dei Prezzi in EdiliziaDocumento44 pagineAnalisi Dei Prezzi in EdiliziaGiovanni PolverinoNessuna valutazione finora
- Catalistino Faac Giugno 2011Documento276 pagineCatalistino Faac Giugno 2011Valentina GrecoNessuna valutazione finora
- Manuale Illustrato Per L'impianto Domotico 1-17Documento17 pagineManuale Illustrato Per L'impianto Domotico 1-17luc_ce67% (3)
- DOMOTICADocumento55 pagineDOMOTICACesar AugustoNessuna valutazione finora
- Catalogo Hvac 2015Documento348 pagineCatalogo Hvac 2015VisitOn.T.witte.rNessuna valutazione finora
- GIE 2004 Num 16 TuttoDocumento121 pagineGIE 2004 Num 16 Tuttomax_ingNessuna valutazione finora
- Catalogo Solar2012 WebDocumento162 pagineCatalogo Solar2012 WebSergio De Manuel GálvezNessuna valutazione finora
- Sanmarco EB1033 PreviewDocumento20 pagineSanmarco EB1033 PreviewAndrea CupponeNessuna valutazione finora
- PLC AblyDocumento72 paginePLC AblyRoberto EmmeNessuna valutazione finora
- Manuale Italiano 2.510900a - IT - MyCardioPadDocumento72 pagineManuale Italiano 2.510900a - IT - MyCardioPadRoberto FalconeNessuna valutazione finora
- Manuale Installatore Elettrico PDFDocumento98 pagineManuale Installatore Elettrico PDFAndreaNessuna valutazione finora
- CITY7Documento33 pagineCITY7ender.vs.melkorNessuna valutazione finora
- Il Collaudo Di Schede Elettroniche Per Il Settore AutomotiveDocumento79 pagineIl Collaudo Di Schede Elettroniche Per Il Settore AutomotiveGIUSEPPENessuna valutazione finora
- Ita Gate Tecnico SW v1-1Documento158 pagineIta Gate Tecnico SW v1-1Fabrizio TruglioNessuna valutazione finora
- Cordless PanasonicDocumento68 pagineCordless PanasonicMirko FlorioNessuna valutazione finora
- ASCENSORI - Guida Alla ProgettazioneDocumento148 pagineASCENSORI - Guida Alla Progettazionejasper_kikeNessuna valutazione finora
- 200quesiti OnlineDocumento233 pagine200quesiti OnlineXxxxxxxx XxxxxxxxNessuna valutazione finora
- MulticellDocumento56 pagineMulticelldabNessuna valutazione finora
- Liftvox Fitre.A5Documento64 pagineLiftvox Fitre.A5treeNessuna valutazione finora
- IMOLA User Guide PDFDocumento305 pagineIMOLA User Guide PDFAlberto CiaffardoniNessuna valutazione finora
- 1SDC010002D0901Documento255 pagine1SDC010002D0901generalclimaticNessuna valutazione finora
- Programmazione Centrali Di Allarme GuidaDocumento44 pagineProgrammazione Centrali Di Allarme Guidadem80Nessuna valutazione finora
- SchemariobticinoDocumento31 pagineSchemariobticinoapi-319942931Nessuna valutazione finora
- Schemario Impianti Elettrici Civili TradizionaliDocumento123 pagineSchemario Impianti Elettrici Civili Tradizionaliapi-319942931Nessuna valutazione finora
- Catalogo HIKMICRODocumento40 pagineCatalogo HIKMICRODaniele DeiNessuna valutazione finora
- Catalogo Generale Canali Russo PDFDocumento176 pagineCatalogo Generale Canali Russo PDFtinafalNessuna valutazione finora
- Manual MC Box 2Documento48 pagineManual MC Box 2Samy Vargas CastilloNessuna valutazione finora
- Sistemi Di Saldatura e Di Assemblaggio Per L'elettronica: WWW - Okinternational.it WWW - Metcal.itDocumento52 pagineSistemi Di Saldatura e Di Assemblaggio Per L'elettronica: WWW - Okinternational.it WWW - Metcal.itnabla1978Nessuna valutazione finora
- Gli Azionamenti Elettrici Nellindustria 4 0Documento23 pagineGli Azionamenti Elettrici Nellindustria 4 0Davide CoppolinoNessuna valutazione finora
- StecaGrid 1800 4200 Manual IT ES BGDocumento220 pagineStecaGrid 1800 4200 Manual IT ES BGFreddy EstallaNessuna valutazione finora
- 4g.evox ItDocumento40 pagine4g.evox Itj.agraitNessuna valutazione finora
- Panasonic KX-TG2511JT Wireless Telephone (User's Manual)Documento44 paginePanasonic KX-TG2511JT Wireless Telephone (User's Manual)Herc GrevNessuna valutazione finora
- Nuova Elettronica 246Documento132 pagineNuova Elettronica 246Henry RiosNessuna valutazione finora
- ChiusiniDocumento84 pagineChiusinikonboutNessuna valutazione finora
- ImolaUserGuide-28 0 7-ItaDocumento293 pagineImolaUserGuide-28 0 7-ItaDaniele RussoNessuna valutazione finora
- Fare Elettronica - FE 233 PDFDocumento113 pagineFare Elettronica - FE 233 PDFΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΜΙΣΙΟΣNessuna valutazione finora
- Manuel Evj800Documento50 pagineManuel Evj800IMB IndustrieNessuna valutazione finora
- Brazioli G. - Corso Di ElettronicaDocumento225 pagineBrazioli G. - Corso Di Elettronicazldz100% (4)
- Manuale Inverter PompaDocumento44 pagineManuale Inverter PompaGabriele LisiNessuna valutazione finora
- ABB Installazione 2013 - 2CSC600900D0901Documento386 pagineABB Installazione 2013 - 2CSC600900D0901Fabian100% (1)
- NT Collaudo Antenna UMTS SIEMENS Agg 18-10-05dDocumento53 pagineNT Collaudo Antenna UMTS SIEMENS Agg 18-10-05dspud_boy0% (1)
- Manuale PL60-90-120Documento28 pagineManuale PL60-90-120Stemate ViorelNessuna valutazione finora
- Elettrotec CatalogueDocumento15 pagineElettrotec CatalogueАлександър ПухлевNessuna valutazione finora
- 2CSC400002D0904 PDFDocumento652 pagine2CSC400002D0904 PDFinvolatoNessuna valutazione finora
- Prezzi Informativi Dell'Edilizia. Impianti Elettrici. 12021 - NodrmDocumento552 paginePrezzi Informativi Dell'Edilizia. Impianti Elettrici. 12021 - Nodrmmarco gassaniNessuna valutazione finora
- InimDocumento56 pagineInimcippalippa919Nessuna valutazione finora
- Le startup nell’Edilizia: Uno sguardo al panorama italiano, tra analogie e diversità, attraverso i casi studio Personal Factory e APR-InDa EverandLe startup nell’Edilizia: Uno sguardo al panorama italiano, tra analogie e diversità, attraverso i casi studio Personal Factory e APR-InNessuna valutazione finora
- Saldatura di circuiti elettronici: Guida per principianti e +Da EverandSaldatura di circuiti elettronici: Guida per principianti e +Nessuna valutazione finora
- Trasformatore A Stato Solido: Rivoluzionare la rete elettrica per la qualità dell'energia e l'efficienza energeticaDa EverandTrasformatore A Stato Solido: Rivoluzionare la rete elettrica per la qualità dell'energia e l'efficienza energeticaNessuna valutazione finora
- Progetti Arduino con Tinkercad | Parte 2: Progettazione di progetti elettronici avanzati basati su Arduino con TinkercadDa EverandProgetti Arduino con Tinkercad | Parte 2: Progettazione di progetti elettronici avanzati basati su Arduino con TinkercadNessuna valutazione finora
- TLB4 CE-M Omologato Per Uso Comm Manuale Utiliz ITDocumento60 pagineTLB4 CE-M Omologato Per Uso Comm Manuale Utiliz ITmax_ingNessuna valutazione finora
- Atv32 Installation Manual It S1a28689 01Documento52 pagineAtv32 Installation Manual It S1a28689 01max_ingNessuna valutazione finora
- Presentazione Inverter Serie 7300EVDocumento2 paginePresentazione Inverter Serie 7300EVmax_ingNessuna valutazione finora
- TLB4 CE-M Omologato Per Uso Comm Manuale Instal ITDocumento84 pagineTLB4 CE-M Omologato Per Uso Comm Manuale Instal ITmax_ingNessuna valutazione finora
- Atv32 Installation Manual It S1a28689 01Documento52 pagineAtv32 Installation Manual It S1a28689 01max_ingNessuna valutazione finora
- Altivar 320 - Manuale ProgrammazioneDocumento347 pagineAltivar 320 - Manuale Programmazionemax_ingNessuna valutazione finora
- Varispeed F7 DatasheetDocumento18 pagineVarispeed F7 Datasheetmax_ingNessuna valutazione finora
- 422 - Introduzione Alla Programmazione Dei PLC (G.ferrari)Documento15 pagine422 - Introduzione Alla Programmazione Dei PLC (G.ferrari)max_ingNessuna valutazione finora
- Resistenza Di Frenatura ATV320Documento1 paginaResistenza Di Frenatura ATV320max_ingNessuna valutazione finora
- Manuale PLC Software PDFDocumento65 pagineManuale PLC Software PDFmax_ingNessuna valutazione finora
- Modulo 1 - Principi Di Programmazione PLC S7-300 PDFDocumento46 pagineModulo 1 - Principi Di Programmazione PLC S7-300 PDFmax_ingNessuna valutazione finora
- W393-IT2-08 CJ1 OperManualDocumento708 pagineW393-IT2-08 CJ1 OperManualmax_ingNessuna valutazione finora
- Corso PLC Con EsercitazioniDocumento11 pagineCorso PLC Con Esercitazionimax_ingNessuna valutazione finora
- PLC Slides PDFDocumento96 paginePLC Slides PDFmax_ing100% (1)
- Corso PLC Con EsercitazioniDocumento11 pagineCorso PLC Con Esercitazionimax_ingNessuna valutazione finora
- (Trading Ebook Ita) Capire La Borsa PDFDocumento4 pagine(Trading Ebook Ita) Capire La Borsa PDFmax_ingNessuna valutazione finora
- Man Ita Mov11.4 TutorialDocumento56 pagineMan Ita Mov11.4 Tutorialmax_ingNessuna valutazione finora
- Man Ita Mov11.4 Guida IntroduttivaDocumento108 pagineMan Ita Mov11.4 Guida Introduttivamax_ingNessuna valutazione finora