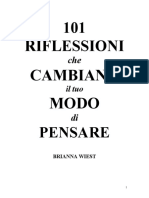Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
HEGEL Appunti
HEGEL Appunti
Caricato da
Francesca PrunedduTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
HEGEL Appunti
HEGEL Appunti
Caricato da
Francesca PrunedduCopyright:
Formati disponibili
HEGEL E LIDEALISMO ASSOLUTO
questi appunti riproducono sostanzialmente il capitolo su Hegel del manuale di iloso ia A!!agnano"#ornero$ %rotagonisti e testi della iloso ia& sono stati apportati alcuni tagli di parti marginali$ e inserite alcune parti 'estratte da altri testi$ di Trom!ino e di (eale"Antiseri) per spiegare meglio alcuni punti di icili*
Opere principali da ricordare: Fra gli scritti giovanili (1793-1800): Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino La prima espressione della iloso ia !matura" di #egel: La enomenologia dello $pirito (1807) %randi opere sistematic&e: La scien'a della logica (181(-181))* L+,nciclopedia delle scien'e iloso ic&e in compendio (1817)* Lineamenti di iloso ia del diritto (18(1) Le'ioni tenute da #egel all+-niversit. di /erlino* trascritte e pu00licate dai suoi discepoli dopo la sua morte: Le'ioni di iloso ia della storia * ,stetica * Le'ioni di iloso ia della religione * Le'ioni sulla storia della iloso ia 1
+* Il gio,ane Hegel '-) .* I /A%ISALDI DEL SISTEMA
2er poter seguire pro icuamente lo svolgimento del pensiero di #egel risulta indispensa0ile aver c&iare* sin dall+ini'io* le tesi di ondo del suo idealismo: a) la risolu'ione del inito nell+in inito3 0) l+identit. ra ragione e realt.3 c) la un'ione giusti icatrice della iloso ia1
a) Finito e infinito
Con la prima tesi #egel intende dire c&e la realt. non 4 un insieme di sostan'e autonome* ma un organismo unitario di cui tutto ci5 c&e esiste 4 parte o mani esta'ione1 6ale organismo* non avendo nulla al di uori di s7 e rappresentando la ragion d+essere di ogni realt.* coincide con lAssoluto e con lInfinito, mentre i vari enti del mondo* essendo mani esta'ioni di esso* coincidono con il finito. 8i conseguen'a* il inito* come tale, non esiste* perc&7 ci5 c&e noi c&iamiamo inito 4 nient+altro c&e un+espressione par'iale dell+9n inito1 9n atti* come la parte non pu5 esistere se non in connessione con il 6utto* in rapporto al :uale soltanto &a vita e senso* cos; il inito esiste unicamente nell+in inito e in virt dell+in inito1 Detto altrimenti: il finito, in quanto reale, non tale, ma lo stesso infinito. L+&egelismo si con igura :uindi come una orma di monismo panteistico: vale a dire teoria la :uale esiste un+unica realt. divina (monismo) di cui il mondo visi0ile costituisce la reali''a'ione o la mani esta'ione . (nella concezione cristiana invece Dio trascendente,c una distinzione ontologica fra il Creatore e il mondo creato . 6uttavia il panteismo di #egel si di eren'ia da :uello moderno (di %iordano /runo e di $pino'a) perc&7 per /runo e per $pino'a l+<ssoluto 4 una $ostan'a statica c&e coincide con la !atura, per l+idealista #egel invece l+<sssoluto si identi ica con un "oggetto spirituale in divenire, di cui tutto ci5 c&e esiste 4 un !momento" o una !tappa" di reali''a'ione1 9n atti* dire c&e la realt. non 4 !$ostan'a"* ma !$oggetto"* signi ica dire* secondo #egel* c&e essa non 4 :ualcosa di immuta0ile e di gi. dato* ma un processo di auto-produ'ione c&e soltanto alla fine, cio4 con l+uomo (= lo $pirito)* giunge a rivelarsi per :uello c&e 4 veramente: !9l vero - scrive #egel nella #refazione alla $enomenologia dello "pirito % 4 l+intero1 >a l+intero 4 soltanto l+essen'a c&e si completa mediante il suo sviluppo1 8ell+<ssoluto devesi dire c&e esso 4 essen'ialmente &isultato, c&e solo alla fine 4 ci5 c&e 4 in verit. 111"
b) Ragione e realt
9l $oggetto spirituale in inito c&e sta alla 0ase della realt. viene denominato da #egel con il termine di Idea o di &agione, intendendo con :ueste espressioni l+identit. di pensiero ed essere* o meglio* di ragione e realt.1 8a ci5 il noto a orisma* contenuto nella #refazione ai 'ineamenti di filosofia del diritto, in cui si riassume il senso stesso dell+&egelismo: Ci( c)e 4 razionale reale* e ci( c)e reale razionale . Con la prima parte della ormula* #egel intende dire c&e la ra'ionalit. non 4 pura idealit.* astra'ione* sc&ema* dover-essere* ma la orma stessa di ci5 c&e esiste* poic&7 la ragione !governa" il mondo e lo costituisce1 ?iceversa* con la seconda parte della ormula* #egel intende a ermare c&e la realt. non 4 una materia caotica* ma il dispiegarsi di una struttura ra'ionale (l+9dea o la @agione) c&e si mani esta in modo inconsapevole nella natura e in modo consapevole nell+uomo1 2er cui* con il suo a orisma* #egel non esprime la semplice possi0ilit. c&e la realt. sia penetrata o intesa dalla ragione* ma la necessaria* totale e sostan'iale identit. di realt. e ragione1 6ale identit. implica anc&e l+identit. ra essere e dover-essere* in :uanto ci5 c&e 4 risulta anc&e ci5 c&e ra'ionalmente deve essere1 6ant+4 vero c&e le opere di #egel sono costellate di osserva'ioni piene di ironia e di sc&erno a proposito dell+ !astratto" e
moralistico dover-essere c&e non 4* dell+ideale c&e non 4 reale1 , tutte :uante insistono sul atto c&e il mondo* in :uanto 4* e cos; com+4* 4 ra'ionalit. dispiegata* ovvero ragione reale e realt. ra'ionale - c&e si mani esta attraverso una serie di momenti necessari c&e non possono essere diversi da come sono1 9n atti* da :ualsiasi punto di vista guardiamo il mondo* troviamo ovun:ue* secondo #egel* una rete di connessioni necessarie e di !passaggi o00ligati" c&e costituiscono l+articola'ione vivente dell+unica 9dea o @agione1 9n altri termini* #egel* secondo uno sc&ema tipico della iloso ia romantica* ritiene c&e la realt. costituisca una totalit. processuale necessaria* ormata da una serie ascendente di !gradi" o !momenti"* c&e rappresentano* ognuno* il risultato di :uelli precedenti ed il presupposto di :uelli seguenti1
c) La funzione della filosofia
Coerentemente con il suo ori''onte teorico* ondato sulle categorie di totalit. e di necessit.* #egel ritiene c&e il compito della iloso ia consista nel prendere atto della realt. e nel comprendere le strutture ra'ionali c&e la costituiscono: !Comprendere ci( c)e 4 il compito della iloso ia* poic&7 ci( c)e 4 la ragione"1 < dire come dev+essere il mondo* la iloso ia arriva sempre troppo tardi3 giacc&7 sopraggiunge :uando la realt. &a compiuto il suo processo di orma'ione1 ,ssa* a erma #egel con un paragone amoso* 4 come la nottola di >inerva c&e ini'ia il suo volo sul ar del crepuscolo* cio4 :uando la realt. 4 gi. 0ell+e atta1 La iloso ia deve dun:ue !mantenersi in pace con la realt." e rinunciare alla pretesa assurda di determinarla e guidarla1 8eve soltanto portare nella orma del pensiero* cio4 ela0orare in concetti* il contenuto reale c&e l+esperien'a le o re* dimostrandone* con la ri lessione* l+intrinseca ra'ionalit.1 Auesti c&iarimenti delineano il tratto essen'iale della iloso ia e della personalit. di #egel1 L+autentico compito c&e #egel &a inteso attri0uire alla iloso ia (e &a cercato di reali''are con la sua iloso ia) 4 la giusti ica'ione ra'ionale della realt.* della presen'ialit.* del atto1 Auesto compito egli l+&a a rontato con maggiore energia proprio l. dove esso sem0ra piB risc&ioso: cio4 nei con ronti della realt. politica* dello $tato (infatti pu( sem+rare ovvio c)e il mondo naturale sia razionale, in quanto regolato da leggi necessarie, mentre pi difficile riconoscere c)e qualsiasi costruzione storica delluomo sia lespressione di una necessit, razionale, e c)e quindi de++a essere accettata coscom
d) il dibattito critico intorno al giustificazionismo hegeliano
#egel in un passo dell+,nciclopedia &a precisato c&e la sua iloso ia non pu5 essere scam0iata per una 0anale accetta'ione della realt. in tutti i suoi aspetti* perc&7 non vanno inclusi nel concetto di !realt." gli aspetti super iciali e accidentali dell+esisten'a (ma come possa esistere laccidentale in una realt, razionale e necessaria resta oscuro )1 < partire da :uesta precisa'ione taluni critici &anno negato il carattere giusti ica'ionista della iloso ia &egeliana: un ilone interpretativo c&e va da ,ngels a >arcuse (pensatori della !sinistra rivolu'ionaria")* pur ammettendo gli aspetti conservatori del pensiero &egeliano* &a tuttavia cercato di mostrare come esso possa venir letto in modo dinamico e rivolu'ionario1 9n atti secondo tali autori l+a orisma di #egel signi ic&ere00e in sostan'a c&e il reale 4 destinato a coincidere con il ra'ionale* mentre l+irra'ionale 4 destinato a perire (si trattere00e insomma dell+a erma'ione di un progresso necessario)1 Ora* :uesta lettura di #egel rappresenta* piB c&e un+interpreta'ione* una corre'ione di #egel alla luce degli ideali rivolu'ionari dei suoi autori1 9n conclusione ci sem0ra c&e i testi di #egel documentino in modo c&iaro e ine:uivoca0ile il suo atteggiamento ondamentalmente giusti ica'ionista nei con ronti della realt.1
1* Idea$ 2atura e Spirito*
Le parti della iloso ia
#egel ritiene c&e il arsi dinamico dell+<ssoluto passi attraverso i tre momenti dell+9dea !in s7" (tesi)* dell+9dea ! uori di s7 " (antitesi) e dell+9dea c&e !ritorna in s7 " (sintesi)1 6ant+4 vero c&e il disegno complessivo dellC,nciclopedia &egeliana 4 :uello di una grande triade dialettica1 L+9dea .in s/0 o 9dea !pura" 4 l+9dea considerata in se stessa* a prescindere dalla sua concreta reali''a'ione nel mondo1 8a :uesto angolo prospettico* l+9dea* secondo un noto paragone teologico di #egel* 4 assimila0ile a 8io !prima della crea'ione della natura e di uno spirito inito"* ovvero* in termini meno e:uivocanti (visto c&e lC<ssoluto &egeliano 4 un in inito immanente* c&e non crea il mondo* ma 4 il mondo) al programma o all+ossatura logico%razionale della realt.1 L+9dea ! uori di s7" o 9dea ! nel suo esser altro" 4 la Datura* cio4 l+estrinseca'ione o l+aliena'ione dell+9dea nelle realt. spa'io-temporali del mondo1 L+9dea c&e !ritorna in s7" 4 lo $pirito* cio4 l+9dea c&e dopo essersi atta natura torna !presso di s7" nell+uomo1 Ovviamente* :uesta triade non 4 da intendersi in senso cronologico* come se prima ci osse l+9dea in s7 e per s7* poi la Datura e infine lo $pirito* ma in senso ideale. Infatti ci5 c&e concretamente esiste nella realt. 4 lo $pirito (la sintesi)* il :uale &a come sua coeterna condi'ione la Datura (l+antitesi) e come suo coeterno presupposto il programma logico rappresentato dall+9dea pura (la tesi)1 < :uesti tre momenti strutturali dellC<ssoluto #egel a corrispondere le tre se'ioni in cui si divide il sapere iloso ico: 1) la logica* c&e 4 ! la scienza dellIdea in s/0* cio4 dell+9dea considerata nel suo essere implicito (= in s7) e nel suo graduale esplicarsi* ma a prescindere* come si 4 visto* dalla sua concreta reali''a'ione nella natura e nello spirito3 () la iloso ia della natura* c&e 4 ! la scien'a dell+9dea nel suo alienarsi da s70* 3) la iloso ia dello spirito, c&e 4 la scien'a dell+9dea* c&e dal suo alienamento ritorna in s7". ,cco un primo sc&ema generale (cui seguiranno altri piB analitici):
Logica
11 dottrina dellCessere (1 dottrina dellCessen'a 31 dottrina del concetto 11 soggettivo
#iloso ia della natura
a) antropologia 0) enomenologia c) psicologia a) diritto 0) moralit. c) eticit. a) arte 0) religione c) iloso ia
11 meccanica (1 isica 31 organica
#iloso ia dello Spirito
(1 oggettivo
31 assoluto
4* La Dialettica
Come si 4 visto* lC<ssoluto* per #egel* 4 ondamentalmente divenire. La legge c&e regola tale divenire 4 la dialettica* c&e rappresenta* al tempo stesso* la legge (ontologica) di sviluppo della realt. e la legge (logica) di comprensione della realt.1 #egel non &a o erto* della dialettica* una teoria sistematica* limitandosi* per lo piB* ad utili''arla nei vari settori della iloso ia1 Ci5 non esclude la possi0ilit. di issare :ualc&e tratto generale di essa1 Del par1 79 dellC,nciclopedia #egel distingue tre momenti o aspetti del pensiero: a) l1astratto o intellettuale* 0) ! il dialettico o negativo%razionale0* c . lo speculativo o positivo%razionale0. Il momento astratto o intellettuale consiste nel concepire l+esistente sotto orma di una molteplicit. di determina'ioni static)e e separate le une dalle altre1 9n altri termini* il momento intellettuale (c&e 4 il grado piB 0asso della ragione) 4 :uello per cui il pensiero si erma alle determina'ioni rigide della realt.* limitandosi a considerarle nelle loro differenze reciproc&e e secondo il principio di identit, e di non%contraddizione (secondo cui ogni cosa 4 se stessa ed 4 assolutamente diversa dalle altre)1 9l momento dialettico o negativo-ra'ionale consiste nel mostrare come le sopraccitate determina'ioni siano unilaterali ed esigano di essere messe in movimento* ovvero di essere relazionate con altre determina'ioni1 9n atti* poic&7 ogni a erma'ione sottintende una nega'ione* in :uanto per speci icare ci5 c&e una cosa 4 0isogna implicitamente c&iarire ci5 c&e essa non 4, risulta indispensa0ile procedere oltre il principio di identit. e mettere in rapporto le varie determina'ioni con le determina'ioni opposte (ad es1 il concetto di !uno"* non appena venga smosso dalla sua astratta rigide''a* ric&iama :uello di !molti" e mani esta uno stretto legame con esso1 , cos; dicasi di ogni altro concetto: il particolare ric&iama l+universale* l+uguale il disuguale* il 0ene il male ecc1)1 9l ter'o momento* :uello speculativo o positivo-ra'ionale* consiste invece nel cogliere l+unit. delle determina'ioni opposte* ossia nel rendersi conto c&e tali determina'ioni sono aspetti unilaterali di una realt. piB alta c&e li ri-comprende o sinteti''a entram0i (ad es1 si scopre c&e la realt. vera non 4 n7 l+unit. in astratto n7 la molteplicit. in astratto* 0ens; un+unit. c&e vive solo attraverso la molteplicit.)1 %lo0almente e sinteticamente considerata* la dialettica consiste :uindi: 1) nell+a erma'ione o posi'ione di un concetto !astratto e limitato"* c&e unge da tesi3 () nella nega'ione di :uesto concetto come alcunc&7 di limitato o di inito e nel passaggio ad un concetto opposto* c&e unge da antitesi3 3) nella unificazione della precedente a erma'ione e nega'ione in una sintesi positiva comprensiva di entram0e1 $intesi c&e si con igura come una ri-a erma'ione poten'iata dell+a erma'ione ini'iale (tesi)* ottenuta tramite la nega'ione della nega'ione intermedia (antitesi)1 @ia erma'ione c&e #egel ocali''a con il termine tecnico di Aufhebung il :uale esprime l+idea di un !superamento" c&e 4* al tempo stesso* un togliere (l+opposi'ione ra tesi ed antitesi) ed un conservare (la verit. della tesi* dell+antitesi e della loro lotta)1
4*0 %untualizzazioni circa la dialettica
l) Come si pu5 notare* la dialettica non comprende soltanto il secondo momento (:uello c&e #egel c&iama dialettico in senso stretto) ma la totalit, dei tre momenti elencati1 () La dialettica non a c&e illustrare il principio ondamentale della iloso ia &egeliana: la risolu'ione del inito nell+in inito1 9n atti essa ci mostra come ogni inito* cio4 ogni spicc&io di realt.* non possa esistere in se stesso (poic&7 in tal caso sare00e un <ssoluto* ovvero un in inito autosu iciente) ma solo in un contesto di rapporti1 9n atti* per porre se stesso il inito 4 o00ligato ad opporsi a :ualcos+altro* cio4 ad entrare in :uella trama di rela'ioni c&e orma la realt. e c&e coincide con il tutto in inito di cui esso 4 parte o mani esta'ione1 , poic&7 il tutto di cui parla #egel* ovvero l+9dea* 4 una entit. dinamica* la dialettica esprime appunto il processo mediante cui le varie parti o determina'ioni della realt. perdono la loro rigide''a* si fluidificano e diventano !momenti" di un+9dea unica ed in inita1 8etto
altrimenti* la dialettica rappresenta la crisi del inito e la sua risolu'ione necessaria nell+in inito: .ogni finito )a questo di proprio, c)e sopprime se medesimo. 'a dialettica forma, dunque, lanima motrice del progresso scientifico... in essa, soprattutto la vera, e non estrinseca elevazione sul finito0 1 3) La dialettica &a un signi icato glo0almente ottimistico, poic&7 essa &a il compito di uni icare il molteplice* conciliare le opposi'ioni* paci icare i con litti* ridurre ogni cosa all+ordine e alla per e'ione del 6utto1 >olteplicit.* opposi'ione* con litto sono sen'a du00io reali secondo #egel* ma solo come momenti di passaggio1 9n altri termini* il negativo* per #egel* sussiste solo come un momento del arsi del positivo e la tragedia* nella sua iloso ia* 4 solo l+aspetto super iciale e transeunte di una sostan'iale commedia (nel senso letterale di vicenda avente un epilogo positivo)1 E) <ppurato c&e pensare dialetticamente signi ica pensare la realt. come una totalit. processuale c&e procede secondo lo sc&ema triadico di tesi* antitesi e sintesi* ci si pu5 c&iedere se la dialettica &egeliana sia a sintesi aperta o a sintesi c)iusa. 9n atti* poic&7 ogni sintesi rappresenta a sua volta la tesi di un+altra antitesi* cui succede un+ulteriore sintesi e cos; via* sem0rere00e* a prima vista* c&e la dialettica esprima un processo costitutivamente aperto1 9n verit.* #egel pensa c&e in tal caso si avre00e il trion o della !cattiva in init." ossia un processo c&e* spostando inde initamente la meta da raggiungere* togliere00e allo spirito il pieno possesso di se medesimo1 8i conseguen'a* egli opta per una dialettica a sintesi inale c&iusa* cio4 per una dialettica c&e &a un 0en preciso punto di arrivo: .2entre nei gradi intermedi della dialettica prevale la rappresentazione della spirale, nella visione complessiva e finale del sistema prevale la rappresentazione del circolo c)iuso, c)e soffoca la vita dello spirito, dando al suo progresso un termine, al di l, del quale ogni attivit, creatrice si annulla, perc)/, avendo lo spirito realizzato pienamente se stesso, non gli resta c)e ripercorrere il cammino gi, fatto... 'impetuosa corrente sfocia in uno stagnante mare, e nellimmo+ile specc)io trema la vena delle acque c)e vi affluiscono ... 0 (%uido 8e @uggiero)1 F) , in e etti* tutti i iloso i c&e si sono ri atti in :ualc&e modo all+&egelismo (da ,ngels a Croce e ai neomarGisti) 5anno criticato l6idea di uno !stagnante epilogo" della storia del mondo* recuperando invece l+idea di un processo c&e risulta costitutivamente aperto1 9noltre* piB c&e sul momento della !concilia'ione" o !sintesi"* tali iloso i &anno insistito sul momento dell+ !opposi'ione" e della !contraddi'ione "* ossia su ci5 c&e #egel* nella $enomenologia, c&iama !il travaglio del negativo"1
7* La critica alle iloso ie precedenti
8opo aver de inito in positivo i capisaldi dell+&egelismo* 4 venuto il momento di illustrarli in negativo, ossia di vedere a :uali iloso ie esso storicamente si contrapponga.
a) Hegel e gli illuministi
La iloso ia di #egel implica un oggettivo ri iuto della maniera illuministica di rapportarsi al mondo1 9n atti gli illuministi* acendo dell+intelletto il giudice della storia* sono costretti a ritenere c&e il reale non 4 ra'ionale* dimenticando cos; c&e la vera ragione (= lo $pirito) 4 proprio :uella c&e prende corpo nella storia ed a0ita in tutti i momenti di essa1 9nvece la ragione degli illuministi esprime solo le esigen'e e le aspira 'ioni degli individui: 4 una ragione inita e par'iale* ovvero un !intelletto astratto"* c&e pretende di dare le'ione alla realt. e alla storia* sta0ilendo come dovre00e essere e non 4* mentre la realt. 4 sempre necessariamente ci5 c&e deve essere1 (111)
b) Hegel e Kant
Hant aveva voluto costruire una iloso ia del inito* e l+antitesi ra il enomeno e il noumeno* ra il dover essere e l+essere* tra la ragione e la realt.* a parte integrante di una tale iloso ia1 Del campo conoscitivo l+uomo 4 limitato alla s era dei enomeni* le idee della ragione sono soltanto ideali regolativi* c&e spingono la ricerca scienti ica all+in inito* verso una compiute''a c&e essa non pu5 raggiungere mai1 <nc&e nel dominio morale* la santit.* cio4 la per etta con ormit. della volont. alla legge della ragione* 4 il termine di un progresso all+in inito1 9n una parola* l+essere non si adegua mai al dover essere* la realt. alla ra'ionalit.1 $econdo #egel* invece* :uesta adegua'ione 4 in ogni caso possi0ile e necessaria (tutta la iloso ia di #egel costituisce una media'ione tra inito e in inito* cio4 un metodo per accedere* sia ra'ionalmente sia moralmente* all+<ssoluto)1 < Hant #egel rimprovera anc&e la pretesa di voler indagare la acolt. di conoscere prima di procedere a conoscere: pretesa c&e egli assimila all+assurdo proposito !di imparare a nuotare prima di entrare nell+ac:ua"1
c) Hegel e i romantici
9l dissenso di #egel nei con ronti dei romantici verte essen'ialmente su due punti1 9n primo luogo #egel contesta il primato del sentimento* dell+arte o della ede* sostenendo c&e la iloso ia* in :uanto scien'a dell+<ssoluto* non pu5 c&e essere una orma di sapere mediato e ra'ionale1 9n secondo luogo* #egel contesta gli atteggiamenti individualistici dei romantici (o* per meglio dire* di una parte dei romantici)* a ermando c&e l+intellettuale non deve narcisisticamente ripiegarsi sul proprio io* ma tener d+occ&io soprattutto l+oggettivo !corso del mondo"* cercando d+integrarsi nelle istitu'ioni socio-politic&e del proprio tempo1 9n realt. #egel* pur non rientrando nella !scuola romantica" in senso stretto* risulta pro ondamente partecipe del clima culturale romantico* del :uale oltre a numerosi motivi particolari (il concetto della creativit. dello $pirito* dello
sviluppo provviden'iale della storia* della spiritualit. incosciente della natura ecc1) condivide soprattutto il tema dell+in inito* anc&e se ritiene c&e ad esso si acceda speculativamente e non attraverso vie !immediate"1
d) Hegel e Fichte
(111) #egel accusa Fic&te di aver ridotto l+in inito a semplice meta ideale dell+io inito1 >a in tal modo il inito* per adeguarsi all+in inito e ricongiungersi con esso* 4 lanciato in un progresso all+in inito c&e non raggiunge mai il suo termine1 Ora :uesto progresso all+in inito 4* secondo #egel* il also o !cattivo in inito" o l+in inito negativo3 non supera veramente il inito perc&7 lo a continuamente risorgere* ed esprime soltanto l+esigen'a astratta del suo superamento1 8i conseguen'a* Fic&te si trovere00e ancora* dal punto di vista di #egel* in una iloso ia incapace di attingere :uella piena coinciden'a tra inito e in inito* ra'ionale e reale* essere e dover-essere* c&e costituisce la sostan'a dell+idealismo1
8* La #enomenologia dello Spirito
La Fenomenologia dello $pirito (1807) 4 la prima opera in cui #egel espone il suo pensiero !maturo"* :uel pensiero di cui a00iamo gi. presentato i ondamenti e il metodo (vedi sopra: i capisaldi del sistema e la dialettica)1 9l termine Fenomenologia (dalla parola greca p)ainomenon = ci5 c&e si mani esta* c&e appare) signi ica !$tudio delle mani esta'ioni" dello $pirito1 ($i tenga presente c&e il termine ! enomeno" in #egel non comporta una distin'ione Iantiana tra apparen'a e cosa in s7 inconosci0ile: in atti posta l+identit. tra pensiero e essere* tra ragione e realt.* nulla pu5 s uggire alla coscien'a)1 Della Fenomenologia dello $pirito #egel vuol descrivere il percorso della coscien'a verso il sapere assoluto* vale a dire l+itinerario dalla coscien'a comune alla piena coscien'a iloso ica1 !La coscien'a comune 4 la coscien'a dell+uomo c&e vede il mondo come un insieme di oggetti e soggetti indipendenti gli uni dagli altri sen'a rendersi conto c&e il mondo costituisce un+unit. e c&e anc&e la di eren'a tra il soggetto cosciente e le cose va compresa all+interno dell+unit. ra'ionale dell+<ssoluto1 La coscien'a iloso ica 4 invece :uella c&e vede le cose e gli eventi come la rammentaria mani esta'ione del 6utto* e considera una semplice illusione la possi0ilit. di identi icarle separatamente1 <lla coscien'a comune il mondo appare come un arcipelago composto da moltissime isole - gli uomini* gli oggetti* gli eventi - separate le une dalle altre1 La coscien'a iloso ica scopre invece c&e le isole sono le cime di monti sottomarini* c&e ormano un+unica catena montuosa c&e si eleva dal ondo del mare1 <llo sguardo del iloso o dietro la di eren'a compare la comune radice di ogni essere" 01 L+itinerario dalla coscien'a comune alla coscien'a iloso ica 4 segnato da una serie di tappe (c&e #egel c&iama igure) c&e costituiscono asi della storia dell+umanit.* asi c&e il singolo individuo deve ripercorrere (per elevarsi alla coscien'a iloso ica* al punto di vista dell+assoluto)1 >a :ueste tappe sono anc&e !mani esta'ioni dell+assoluto" perc&7* come a00iamo gi. detto* tutti gli eventi della storia non sono altro c&e momenti necessari del divenire dell+assoluto* della totalit. in inita1 Auindi la enomenologia descrive la via c&e conduce l+individuo al sapere assoluto (in :uesto senso la Fenomenologia dello $pirito pu5 essere intesa come un /ildungs@oman: un roman'o di orma'ione* nel :uale il protagonista* attraverso il duro tirocinio di un+esperien'a so erta* supera le originarie convin'ioni e giunge alla verit.)* ma descrive anc&e* e soprattutto* la via attraverso la :uale l+<ssoluto stesso giunge all+autocoscien'a (l+<ssoluto si autoconosce attraverso il iloso o) La Fenomenologia dello $pirito 4 costituita da ) tappe ondamentali: CO$C9,DJ< <-6OCO$C9,DJ< @<%9OD, $29@96O @,L9%9OD, $<2,@, <$$OL-6O Le prime tre tappe descrivono l+innal'amento dalla coscien'a individuale inita alla ragione come consapevole''a iloso ica1 Le successive tre tappe descrivono il dispiegarsi della coscien'a c&e &a con:uistato il punto di vista dell+<ssoluto1 $iccome lo svolgimento della iloso ia come !conoscen'a dal punto di vista dell+ <ssoluto" viene riproposto in modo piB sistematico nelle opere successive di #egel* prendiamo in considera'ione solo i primi tre momenti1 /OS/IE29A: Del primo momento della Coscien'a :uesta si rivolge a un oggetto c&e 4 considerato esterno rispetto ad essa1 AUTO/OS/IE29A: La seconda tappa dell+itinerario enomenologico 4 costituito dalla !autocoscien'a" c&e* attraverso i singoli momenti* impara a sapere c&e cosa essa sia propriamente1 L+autocoscien'a si mani esta* dapprima*
1
?edi >ario 6rom0ino* 8a Hant a #egel* vol1 (1( di Filoso ia testi - percorsi* 2oseidonia
come caratteri''ata dall+appetito e dal desiderio* ossia come tenden'a ad appropriarsi delle cose e a ar dipendere tutto da s7* a !togliere lalterit, c)e si presenta come vita indipendente "1 >a l+autocoscien'a necessita di altre autocoscien'e in grado di darle la certe''a di essere tale: l+uomo ac:uista coscien'a di s7* si a erma come autocoscien'a* solo se riesce a arsi riconoscere da altri uomini* da altre autocoscien'e (dice #egel: lautocoscienza raggiunge il suo a agamento solo in unaltra autocoscienza) L+uomo per5 non rispetta l+altro nella sua diversit.* ma vuole appropriarsene* vuole ridurlo a una cosa propria (perc&7* come a00iam detto* l+autocoscien'a si mani esta come tenden'a a ar dipendere tutto da s7) e di conseguen'a nasce in maniera necessaria una lotta tra i due uomini la cui posta in gioco 4 proprio il riconoscimento1 9l riconoscimento deve passare attraverso un con litto (e non attraverso l+amore c r1 pensiero giovanile di #egel)* solo attraverso !la lotta per la vita e per la morte" l+autocoscien'a pu5 reali''arsi1 >a poic&7 ogni autocoscien'a &a 0isogno strutturalmente dell+altra la lotta non deve aver come esito la morte di una delle due* ma il soggiogamento di una all+altra1 Dasce* cosK* la dialettica tra :padrone; e :ser,o; (c&e corrisponde* nella storia* alla civilt. antica)* c&e #egel descrive in pagine divenute amosissime* e c&e 4 e ettivamente ra le cose piB pro onde e piB 0elle della Fenomenologia1 9l !padrone" &a risc&iato nella lotta la sua vita e nella vittoria 4 diventato* di conseguen'a* padrone1 9l !servo" &a avuto timore della morte e* nella scon itta* per aver salva la vita isica* &a accettato la condi'ione di sc&iavitB ed 4 diventato come una !cosa" dipendente dal padrone1 9l padrone usa il servo e lo a lavorare per s7* limitandosi a !godere" delle cose c&e il servo a per lui1 >a* in :uesto tipo di rapporto* si sviluppa un movimento dialettico* c&e inir. col portare al rovesciamento delle parti1 9n atti il padrone inisce col diventare !dipendente dal servo"* perc&7 pu5 appropriarsi delle cose solo attraverso il lavoro del servo (il padrone rimane inerte)1 9l servo invece* per me''o del lavoro* inisce per diventare indipendente* perc&7 impara a dominare se stesso (autodisciplina) e impara a dominare le cose tras ormandole* imprimendo in esse una orma c&e 4 il ri lesso dell+autocoscien'a1 La igura della dialettica 2adrone-$ervo 4 stata appre''ata soprattutto dai marGisti* i :uali &anno visto in essa un+intui'ione dell+importan'a del lavoro e della dialettica della storia* nella :uale* gra'ie all+esperien'a della sottomissione* si generano le condi'ioni per la li0era'ione1 @esta tuttavia una di eren'a ondamentale tra >arG ed #egel: in atti la igura &egeliana non si conclude con una rivolu'ione sociale o politica* ma con la coscien'a dell+indipenden'a del servo nei con ronti delle cose e della dipenden'a del padrone nei con ronti del lavoro servile1 -n+altra igura cele0re dell+<utocoscien'a 4 :uella della /oscienza in elice$ c&e descrive la condi'ione della coscien'a tipica della religione e0raica e del Cristianesimo medievale1 La coscien'a in elice 4 la coscien'a c&e vive se stessa come coscien'a inita* mortale* c&e per esistere deve ancorarsi a una realt. assoluta* in inita* del tutto estranea alla coscien'a stessa ( = 8io trascendente)1 9n :uesta igura c+4 :uindi una pro onda scissione tra l+autocoscien'a dell+uomo ( inita * mutevole) e l+oggetto della coscien'a* la realt. vera* assoluta* in inita* a cui la coscien'a tende sen'a mai poterla raggiungere1 Della igura della Coscien'a in elice ogni accostamento dell+uomo alla 8ivinit. trascendente signi ica una morti ica'ione* un+umilia'ione* un sentire la propria nullit.* e da ci5 deriva appunto l+in elicit.1 Del Cristianesimo si cerca poi di rendere accessi0ile il 8io trascendente per me''o del 8io incarnato (%esB Cristo)3 tuttavia* secondo #egel* la pretesa di cogliere l+<ssoluto in una igura storica 4 destinata al allimento* perc&7 Cristo* vissuto in uno speci ico e irripeti0ile periodo storico* risulta pur sempre lontano* e :uindi per la coscien'a rimane separato* estraneo1 8i conseguen'a* anc&e con il cristianesimo* la coscien'a continua ad essere in elice e 8io continua a con igurarsi come un !irraggiungi+ile al di l, c)e sfugge"1 (AGIO2E& L+autocoscien'a era il momento in cui la coscien'a aveva preso se stessa come oggetto* ma il suo culmine nella coscien'a in elice mostra l+impossi0ilit. di comprendere se stessa restando entro i limiti di s71 La @agione nasce nel momento in cui la Coscien'a* a00andonato il vano s or'o di uni icarsi con 8io* si rende conto di essere lei stessa 8io* il $oggetto assoluto* in altri termini ac:uisisce !la certe''a di essere ogni realt."1 ,+ :uesta la posi'ione propria dell+idealismo: l+unit. di pensiero ed essere1 Auesta !certe''a di essere ogni realt." sorge nel @inascimento* si sviluppa durante l+et. moderna e &a il suo culmine nell+9dealismo1 9l !cammino"della @agione si conclude con il superamento del punto di vista individuale: la coscien'a comprende c&e ogni atto della vita individuale si situa dentro una realt. storico-sociale c&e lo onda e lo rende possi0ile* e :uindi la ragione si reali''a concretamente nelle istitu'ioni storico-politic&e di un popolo e dello $tato3 ma con :uesto entriamo nel mondo dello $pirito* per il :uale* come a00iam gi. detto* rimandiamo alla Filoso ia dello $pirito esposta nelle opere successive1
IL SISTEMA
Della 3nciclopedia delle scienze filosofic)e in compendio troviamo l+esposi'ione sistematica di tutti i momenti costitutivi dell+assoluto* nel loro ordine necessario1
La $enomenologia dello "pirito ci &a mostrato come la coscien'a empirica giunge al $apere assoluto1 9l sistema ci mostra l+<ssoluto visto da :uel punto di vista c&e la $enomenologia &a guadagnato1 $u :uesto piano 4 tolta ogni di eren'a tra certe''a (elemento soggettivo) e verit.1 L+esposi'ione segue il ritmo triadico di tesi (9dea in s7)* antitesi (9dea uori di s7* cio4 natura)* sintesi (9dea c&e ritorna in s7* cio4 $pirito) e si divide in Logica* Filoso ia della Datura* Filoso ia dello $pirito1
<* La Logica
9n :uanto !scien'a dell+idea pura* cio4 dell+9dea nell+elemento astratto del pensiero"* la Logica (alla :uale #egel &a dedicato l+opera !cienza della logica e la prima parte della "nciclo edia delle scienze filosofiche) prende in considera'ione la struttura programmatica o l+impalcatura originaria del mondo1 6ale !impalcatura" si speci ica in un organismo dinamico di concetti o di categorie i :uali* in virtB della identit. ra pensiero ed essere* costituiscono altrettante determina'ioni della realt.1 La logica di #egel :uindi 4 molto diversa dalla logica tradi'ionale* di deriva'ione aristotelica: in atti :uest+ultima veniva presentata come !organon"* puro strumento o metodo del pensiero* a cui era giustapposta la realt. esterna3 la logica di #egel invece esprime la realt. stessa nella sua essen'a1 2ertanto risulta evidente come la logica (= lo studio del pensiero) e la meta isica (= lo studio dell+essere) siano per #egel la stessa cosa (la posi'ione antimeta isica dell+9lluminismo e di Hant viene :uindi respinta da #egel) 1 #egel a erma anc&e c&e la logica 7 lesposizione di Dio, comegli nella sua eterna essenza prima della creazione della natura3 i termini 8io e crea'ione vanno per5 intesi diversamente rispetto a ci5 c&e essi signi icano nel contesto della dottrina cristiana: in atti la crea'ione per #egel 4 il processo in cui 8io stesso si tras orma e si arricc&isce* e il !8io dopo la crea'ione" (di cui si occuper. la iloso ia dello $pirito) 4 :ualcosa di superiore rispetto al !8io prima della crea'ione"1 L+9dea di cui tratta la Logica in ogni caso non 4 da concepire come una sorta di realt. unica e compatta* ma come $viluppo e 2rocesso dialettico1 9 concetti o categorie esposti nella Logica sono successive de ini'ioni dell+<ssoluto* progressivamente piB ricc&e* e l+9dea 4 la totalit. dei concetti determinati e dei nessi c&e li legano e il loro passare dall+uno all+altro in cerc&i sempre piB alti 1 La Logica &egeliana si articola dialetticamente in dottrina dell+essere* dottrina dell+essen'a e dottrina del concetto3 ognuna di :ueste articola'ioni presenta ulteriori triadi interne* c&e non 4 possi0ile trattare analiticamente1 2rendiamo :uindi in considera'ione solo l+incipit della Logica* la triade !,ssere* Dulla* 8ivenire": il punto di parten'a della logica 4 il concetto dell+essere* il concetto piB generale perc&7 assolutamente indeterminato* astratto* privo di ogni possi0ile contenuto1 >a appunto perc&7 privo di determina'ioni * l+essere ric&iama il suo opposto* il nulla* e a tutt+uno con esso1 La sintesi di :uesta prima opposi'ione * di essere e nulla* 4 il divenire: nel divenire in atti ci5 c&e non 4 viene ad essere e viceversa (gi. gli antic&i de inivano il divenire come passaggio dal nulla all+essere)1 9l divenire tuttavia non unisce l+essere e il nulla in un+identit. astratta ma in un rapporto dialettico* in cui ciascuno dei due passa nell+altro1 6utte le categorie della logica (sia della logica classica* sia della logica trascendentale Iantiana) vengono ricostruite con :uesto procedimento dialettico1 2er concludere prendiamo in esame la discussione (contenuta nella 8ottrina dell+essen'a) dei principi logici di identit. (A 4 A) e di non-contraddi'ione (A non non%A) di cui <ristotele aveva ornito la prima enuncia'ione: secondo #egel :uesti principi rappresentano il punto di vista dell+intelletto astratto e unilaterale* ma non il punto di vista della ragione* c&e 4 il solo punto di vista della verit.1 La vera identit.* secondo #egel* non 4 < = <* ma deve essere intesa !come identit. c&e include le di eren'e"* vale a dire come sintesi c&e dialetticamente si reali''a togliendo l+opposi'ione e conservando in s7 gli opposti1 Auanto al principio di non-contraddi'ione #egel o0ietta c&e la contraddi'ione inerisce necessariamente alla concrete''a e alla vita: Il muoversi non consiste se non in un esplicarsi e mostrarsi della contraddizione (... 5ualcosa dunque vitale solo in quanto contiene in s/ la contraddizione (tutto ci5 naturalmente rimanda alla 8ialettica)
0=* LA #ILOSO#IA DELLA 2ATU(A
9l testo ondamentale della iloso ia della natura di #egel 4 la seconda parte dell+ 3nciclopedia delle scienze filosofic)e in compendio1 Come a00iamo gi. detto (vedi sopra* a pag1 E * Le parti'ioni della iloso ia) la Datura 4 l+9dea ! uori di s7" o 9dea ! nel suo esser altro "* cio4 l+estrinseca'ione o l+aliena'ione dell+9dea nelle realt. spa'io-temporali del mondo1 9spirandosi a Fic&te* #egel a erma c&e anc&e la natura 4 9dea* cio4 :ualcosa c&e 4 compreso in :uella totalit. processuale (in divenire) c&e 4 l+<ssoluto3 non 4 una realt. estranea* irriduci0ile allo $pirito1 6uttavia la Datura 4 !l+idea nella orma dell+essere altro"* nella orma dell+esteriorit. c&e 4 inadeguata all+9dea1 2ertanto #egel insiste molto sul momento di negativit. costituito dalla Datura: ! 'a natura, considerata in s/, nellidea, divina* ma nel modo in cui essa , lessere suo non risponde al suo concetto: essa , anzi, la contraddizione insoluta. Il suo carattere proprio questo, di esser posta, di esser negazione* e gli antic)i )anno infatti concepito la materia in genere come un .non ens0. Cos- la natura stata anc)e definita come la decadenza
dellIdea da s/ stessa, poic)/ lIdea, in quella forma dellesteriorit,, inadeguata a se stessa. " #egel parla anc&e di una !impoten'a della natura" c&e pone dei limiti anc&e alla comprensione iloso ica della natura stessa1 Auindi #egel non condivide l+entusiasmo dei @inascimentali e soprattutto dei @omantici per la natura1 <lla tesi secondo cui in un piccolo evento naturale come in un iore o in una pagliu''a possono arsi conoscere la verit. e 8io* #egel contrappone la tesi secondo cui il piB piccolo evento dello $pirito ci a conoscere la verit. e 8io in modo incompara0ilmente superiore* e c&e per ino il male compiuto dall+uomo 4 addirittura in initamente superiore ai moti degli astri e alla innocen'a delle piante* in :uanto il male 4 un atto di li0ert.* la :uale costituisce l+essen'a dello $pirito1 La iloso ia della Datura si articola in: 1) meccanica* c&e studia lo spa'io* il tempo* la materia e il movimento3 () isica* ove dalla rigidit. dei corpi inerti si passa ai enomeni magnetici* elettrici e c&imici3 e 3) organica* c&e tratta della natura vegetale e animale1 Dell+esposi'ione della iloso ia della Datura #egel attinge alle conoscen'e della scien'a dei suoi tempi* tuttavia essa rappresenta un ritorno ad una conce'ione pre-galileiana della scien'a* alla persuasione di poter cogliere l+essen'a dei enomeni naturali* in orte polemica con la !ridu'ione al :uantitativo" attuata da %alileo* Cartesio e DeLton1
00* LA #ILOSO#IA DELLO S%I(ITO
La iloso ia dello $pirito 4 lo studio dell+9dea c&e* dopo essersi estraniata da s7* sparisce come natura* cio4 come esteriorit. e spa'ialit. per arsi puro spirito* autocoscien'a e li0ert.1 Lo $pirito 4 l+idea c&e ritorna a s7 dalla sua alterit.1 L+9dea* intesa come !impalcatura logica del mondo"* era una possi0ilit. astratta* lo $pirito 4 la vivente attuali''a'ione e autoconoscen'a dell+9dea1 Come momento dialetticamente conclusivo* ossia come risultato del processo dell+<ssoluto* lo $pirito 4 la piB alta mani esta'ione dell+<ssoluto1 $crive #egel: !'assoluto lo spirito: questa la pi alta definizione dellassoluto. 6rovare questa definizione e comprenderne il significato e il contenuto stata la tendenza di ogni cultura e di ogni filosofia* a questo punto )a mirato coi suoi sforzi ogni religione e ogni scienza* solo questo impulso spiega la storia del mondo"1 <nc&e la iloso ia dello $pirito 4 strutturata in maniera triadica* e :uindi divisa in tre momenti: 1) un primo in cui lo $pirito 4 sulla via della propria autoreali''a'ione e autoconoscen'a: $pirito soggettivo* () un secondo in cui lo $pirito si autoreali''a pienamente come li0ert.: $pirito oggettivo* 3) un ter'o in cui lo $pirito si autoconosce pienamente e si sa come principio e come verit. di tutto* ed 4 come 8io nella sua piene''a di vita e di conoscen'a: $pirito <ssoluto1
03* LO S%I(ITO SOGGETTI>O
Lo spirito soggettivo 4 lo spirito individuale (dell+uomo singolo* ancora legato alla initudine)* considerato nel suo lento e progressivo emergere dalla natura* attraverso un processo c&e va dalle orme piB elementari di vita psic&ica alle piB elevate attivit. conoscitive e pratic&e1 La iloso ia dello spirito soggettivo si divide in tre parti: antropologia* enomenologia e psicologia1 Della antropologia viene considerata :uella ase aurorale della vita cosciente c&e nell+uomo si mani esta come carattere* temperamento* disposi'ioni psico isic&e connesse all+et. e al sesso* a0itudini: la vita spirituale 4 ancora !invisc&iata" nella natura e ne conserva in gran parte la meccanicit.* la passivit.1 Della enomenologia viene riproposto il percorso !Coscien'a"* !<utocoscien'a"* !@agione" gi. visto nell+opera La enomenologia dello $pirito (c r1) Della psicologia vengono studiate le attivit. proprie dello spirito* cio4 la conoscen'a (attivit. teoretica)* l+attivit. pratica e il volere li0ero1 9l volere li0ero rappresenta il culmine dello $pirito soggettivo: l+anima dell+uomo aspira alla li0ert.* ma si scontra con il limite della propria inite''a* della propria individualit.1 2er essere li0ero* l+uomo deve superare la propria individualit. e inite''a* deve :uindi entrare in rela'ione con il mondo e gli altri uomini: per arlo non pu5 restare nella orma dello $pirito soggettivo1 $i passa :uindi allo $pirito oggettivo1
2recisa'ioni sul concetto di li0ert.1
9l momento dello $pirito oggettivo costituisce per #egel la reali''a'ione della li0ert. umana1 ,+ :uindi opportuno precisare c&e cosa intende #egel per li0ert.1 La li0ert. per #egel 4 la piena reali''a'ione dell+uomo* reali''a'ione c&e si ottiene :uando si raggiunge la consapevole''a di essere parte e mani esta'ione dello $pirito in inito1 Lo $pirito 4 li0ero perc&7 4 6otalit. in inita* e nulla gli 4 esteriore in modo da poterlo condi'ionare1 L+uomo 4 li0ero :uando comprende c&e nella sua vita individuale e inita si esprime lo $pirito in inito1 $i osservi c&e la no'ione di li0ert. c&e :ui utili''iamo non &a nulla a c&e vedere con la no'ione di li+ero ar+itrio, c&e presuppone la sostan'iale indipenden'a della persona umana dalla trama necessaria delle rela'ioni c&e costituiscono lCordine del mondo (ad esempio: &o la possi0ilit. di agire come voglio* nonostante le in luen'e c&e su0isco dal mondo
esterno)1 L+idea diametralmente opposta di #egel 4 c&e la persona 4 li0era :uando supera la propria inite''a e individualit. riconoscendo e accettando di appartenere a una trama necessaria di rela'ioni1
0+* LO S%I(ITO OGGETTI>O
2er oggettivit, dello "pirito #egel intende le istituzioni, esteriori all+individuo* nelle :uali l+uomo concretamente vive1 ,sse sono oggettive perc&7 si presentano al singolo uomo come una realt. data* come :ualcosa di concretamente esistente in modo oggettivo1 <d esempio* venendo al mondo* l+uomo si trova a ar parte di una amiglia* c&e 4 per lui :ualcosa di dato* un ente della realt.1 9n e etti si tratta di una orma molto particolare di oggettivit.* perc&7 la amiglia non &a alcuna esisten'a sen'a gli individui (soggetti* dun:ue) c&e la compongono1 L+oggettivit. dello $pirito 4 cos; ormata dallestraniazione degli stessi soggetti: le istitu'ioni* ad esempio la amiglia* sono l+oggettiva'ione dell+uomo stesso in una realt. c&e non &a piB i tratti soggettivi dellCuomo ma &a regole e caratteristic&e sue proprie1 Aueste istituzioni, in :uanto oggettive* si presentano all+uomo come dotate di caratteri c&e s uggono alla volont. del singolo: &anno letteralmente leggi oggettive* indipendenti dalla volont. dei soggetti* 0enc&7 siano costituite da soggetti1 Dicolai #artmann &a c&iarito molto 0ene la conce'ione &egeliana dello $pirito oggettivo in :uesta pagina c&e riportiamo: ! 'o "pirito oggettivo un elemento della vita in cui noi tutti ci troviamo e al di fuori del quale non a++iamo alcuna esistenza, per cos- dire laria spirituale in cui respiriamo. "i tratta della sfera spirituale in cui nascita, educazione e circostanza storica ci pongono e ci lasciano crescere: quel quid universale c)e nella cultura, nei costumi, nella lingua, nelle forme del pensiero, nei pregiudizi e nelle valutazioni predominanti conosciamo come potenza sopraindividuale e tuttavia reale, nei cui confronti il singolo si presenta quasi senza potere e senza difesa, poic)/ penetra, porta e caratterizza la sua essenza come quella di tutti gli altri. 3 facile divenirne storicamente coscienti (guardando indietro, dal punto di vista degli epigoni : noi parliamo di tendenza e correnti spirituali di un1epoca, dei suoi orientamenti, idee valori, della sua morale, scienza ed arte. Intendiamo questi fenomeni come qualcosa di storicamente reale, c)e )a il suo nascere e perire e dunque la sua vita nel tempo, non diversamente dagli individui. "iamo per( +en lontani dallattri+uire allindividuo storico come tale questi fenomeni, come se fossero soltanto i suoi. Concretamente li afferriamo certamente nel modo pi facile nelluno o nellaltro rappresentante dallo spiccato rilievo, ma sappiamo c)e si tratta solo di un rappresentante, c)e quella realt, c)e in lui si esprime spiritualmente non la sua e neppure oggettivamente si risolve in lui. !on meno noto lo spirito oggettivo nella vita del proprio presente. "i parla per esempio c)iaramente di un 7sapere del nostro tempo7. A questo sapere il singolo partecipa, imparando vi si orienta, ma tale sapere non si risolve mai nel sapere del singolo. Innumerevoli intelligenze vi colla+orano, ma nessuna lo dice certamente suo. 6uttavia qualcosa di totale, di comprensivo, di sviluppantesi unitariamente, una realt, con ordinamento e leggi proprie. !on )a spazio in nessuna coscienza singola* tuttavia si tratta di un elemento specificamente spirituale, essenzialmente differente da ogni dimensione cosale, materiale. 3 con ci( assolutamente reale, dotato di tutto quel c)e appartiene alla realt,: nascita nel tempo, crescita, sviluppo, culmine e decadenza. 8li individui sono i suoi portatori. 2a la sua realt, non quella degli individui, come la sua vita e la sua durata sono diverse dalla loro vita e durata. Continua a sussistere nellavvicendarsi degli individui, una realt, spirituale, un essere sui generis, spirito oggettivo "1 #egel distingue tre momenti della Filoso ia dello $pirito oggettivo* il diritto* la moralit. e l+eticit.1
IL DI(ITTO
9l soggetto trova dinan'i a s7 la legge* come istitu'ione esteriore c&e regola attraverso norme di comportamento le sue rela'ioni con il mondo1 La legge de inisce ci5 c&e 4 legittimo are da ci5 c&e non lo 4* e dun:ue inevita0ilmente limita l+assolute''a della volont. del singolo1 6uttavia nel concreto della vita il diritto permette di atto una maggiore li0ert. all+uomo* rendendo possi0ile la vita di rela'ione e dun:ue concretamente atti0ili cose c&e* altrimenti* sare00ero s; teoricamente possi0ili* ma nei atti del tutto irreali''a0ili (si pensi alla vita :uotidiana in assen'a di regole: un caos* non un+e ettiva li0ert.)1 >omento ini'iale del diritto 4 la propriet.1 La propriet. 4 il compimento dell+uomo (o* il c&e 4 lo stesso* la sua li0ert.) in una cosa esterna1 #egel dun:ue teori''a il diritto alla propriet. privata come una necessit. dello $pirito per la reali''a'ione della propria li0ert.1 ($i ponga atten'ione a :uesto punto* c&e >arG anali''er. accuratamente da una posi'ione ortemente critica1)1 8alla propriet. si passa al contratto (riconoscimento reciproco del diritto di propriet.) c&e pone l+uomo in rela'ione con altri uomini1 9l momento del diritto* tuttavia* permette solo una orma esteriore di li0ert. (una li0ert. nei comportamenti* non nella coscien'a dell+uomo)* e la legge 4 sempre vissuta come :ualcosa c&e dall+esterno si impone al singolo* se00ene ci5 accada per garantirgli una concreta li0ert. d+a'ione1 L+uomo non pu5 in atti pienamente identi icarsi con la legge* perc&7 essa 4 pur sempre esteriore alla sua coscien'a1 <lla legge manca :ualcosa* manca cio4 la possi0ilit. c&e l+uomo vi si identi ic&i: ci5 e:uivale a dire c&e la legge 4 esteriore* le manca l+interiorit.* le manca la moralit.1 >omenti dialettici del diritto sono la propriet. c&e pone l+uomo in rapporto con le cose (:uindi #egel a erma il diritto alla propriet.)* il contratto attraverso cui la propriet. viene riconosciuta dagli altri uomini* e c&e :uindi pone l+uomo in rapporto con gli altri uomini* il delitto* c&e 4 la nega'ione del diritto* e la pena* c&e rista0ilisce il diritto* reintegra il
<
colpevole nel diritto3 perc&7 la pena sia e icace occorre per5 c&e il colpevole non soltanto sconti la pena* ma riconosca interiormente la propria colpa* in tal modo per5 si passa dalla s era dell+esteriorit. a :uella dell+interiorit.* e si passa :uindi dal diritto alla moralit.1
LA MO(ALITA
La moralit. collega l+a'ione esteriore dell+uomo alla sua interiorit.1 Del momento della moralit. #egel studia il complesso delle leggi interiori della coscien'a1 L+am0ito della moralit. 4 del tutto diverso da :uello del diritto* perc&7 la onte di :uest+ultimo 4 un+autorit. istitu'ionale c&e regola solo l+aspetto esteriore dell+a'ione degli uomini sen'a occuparsi del loro mondo interiore1 2er la moralit. invece 4 essen'iale l+inten'ione con cui un+a'ione viene compiuta e il 0ene come valore morale 4 il suo ine1 La moralit. di #egel :uindi corrisponde all+etica Iantiana* c&e 4 ! ormale"* perc&7 d. importan'a solo all+inten'ione della volont.* non al contenuto* non alla reali''a'ione e ettiva1 6uttavia #egel considera ancora insu iciente la moralit. e critica l+etica Iantiana* rimproverandole di essere vuota e unilaterale* di ! c)iudere luomo nel suo interno"1 9 termini della :uestione sono :uesti1 >oralit. e diritto si contrappongono dialetticamente come legge esteriore e legge interiore1 D7 l+uno n7 l+altro dei due momenti* da solo* permette c&e nell+a'ione si esprima l+unit. della persona* cio4 lo $pirito nella sua integrit. e concrete''a1 2erc&7 :uesto accada 4 necessario il momento di sintesi tra diritto e moralit.* cio4 l+eticit.1
LETI/ITA
Dell+eticit. la volont. 0uona si reali''a concretamente* diventa :ualcosa di esistente1 Le norme esteriori del diritto e le norme interiori della moralit. sono conciliate nell+a'ione etica1 $i tenga presente c&e la distin'ione tra moralit. ed eticit. non 4 tradi'ionale* viene introdotta solo da #egel1 Col termine eticit. #egel intende ri erirsi a tutte :uelle istitu'ioni c&e permettono tanto una li0ert. esteriore :uanto una li0ert. interiore* istitu'ioni dun:ue nelle :uali l+uomo pu5 trovare piena soddis a'ione alle sue esigen'e di reali''a'ione e di li0ert.* perc&7 in esse pu5 identi icarsi: pu5 viverle come proprie* pur mantenendo esse il loro rigoroso carattere di oggettivit.1 Le istitu'ioni dell+eticit. cui si ri erisce #egel sono la amiglia* la societ. civile e lo $tato1
LA #AMIGLIA
La prima istitu'ione dell+eticit. 4 la amiglia* c&e permette la li0ert. per i suoi mem0ri nella s era della vita privata1 Della amiglia l+aspetto naturale (la !rela'ione dei sessi") viene elevato alla s era spirituale* in atti gli impulsi naturali vengono conciliati con i dettami ra'ionali e la volont. individuale viene conciliata con le leggi dello $tato (:uindi si reali''a la sintesi tra diritto e moralit.* in atti la amiglia 4 sintesi di un moto interiore* l+amore* c&e si reali''a esteriormente in una struttura giuridica* il matrimonio)1 L+elemento ondante della amiglia 4 l+amore* la amiglia poi si articola nei momenti del matrimonio* del patrimonio e dell+educazione dei figli1 L+a00andono della amiglia da parte dei igli costituisce la nega'ione della amiglia* da cui scaturisce la societ. civile1
LA SO/IETA /I>ILE
9l secondo momento dell+eticit. 4 la societ. civile* cio4 :uell+insieme di istitu'ioni nelle :uali l+individuo pu5 entrare in rela'ione con altri uomini sulla 0ase del proprio interesse (c&e 4 l+elemento ondante della societ.* come l+amore lo era della amiglia)1 Della societ. civile gli uomini trovano soddis a'ione ai propri 0isogni* pur restando estranei gli uni agli altri e pur essendo la societ. civile essen'ialmente antagonistica e con littuale1 La societ. civile svolge :uindi una un'ione di media'ione dei 0isogni e degli interessi contrapposti* permette cio4 c&e l+incontro-scontro di interessi individuali porti alla soddis a'ione dei 0isogni di tutti i soggetti sociali (per esempio il mercato permette c&e i 0isogni contrapposti dei venditori e dei compratori trovino soddis a'ione proprio incontrandosi)3 scrive #egel: Mlegoismo soggettivo si converte nel contri+uto allappagamento dei +isogni di tutti gli altri, % nella mediazione dellindividuo per mezzo delluniversale, in quanto movimento dialettico* cos- c)e, poic)/ ciascuno acquista, produce e gode per s/, appunto perci(, produce e acquista per il godimento degli altri 1N La societ. 4 costituita dai rapporti economico-sociali ma anc&e dal sistema giuridico-amministrativo c&e permette di coordinare le attivit. e gli interessi individuali1 #egel anali''a molti aspetti della vita sociale* :uali la divisione del lavoro e la divisione della popola'ione in classi sociali* l+amministra'ione della giusti'ia e il diritto pu00lico* la poli'ia e la sicure''a sociale* le corpora'ioni di mestiere1
LO STATO
La amiglia e la societ. civile sono entram0e istitu'ioni par'iali* c&e permettono la soddis a'ione del 0isogno etico dell+uomo solo in am0iti particolari (nella s era privata la amiglia* nella s era pu00lica* ma con littuale* la societ. civile)1 ,ntram0e non possono tuttavia sussistere come istitu'ioni se non all+interno dello $tato* c&e per #egel 4 la sintesi glo0ale dell+eticit.1
0=
Lo $tato in atti 4 una specie di ! amiglia in grande" in cui l+uomo pu5 reali''are pienamente la sua li0ert.1 Lo $tato in atti non si limita a coordinare gli interessi particolaristici (come avveniva nella societ. civile) ma pone un principio di unit. e di appartenen'a superiore* e perci5 convoglia tutti i particolarismi verso un 0ene collettivo3 in altri termini possiamo dire c&e lo $tato 4 l+istitu'ione in cui la li0ert. dell+uomo viene reali''ata non perc&7 l+uomo vi trova il soddis acimento dei propri 0isogni individuali ma perc&7 vi riconosce un valore superiore (l+et&os del popolo)* e condivide il riconoscimento di :uesto valore superiore con tutti i suoi concittadini1 Auesta conce'ione etica dello $tato* visto come incarna'ione suprema della moralit. sociale e del 0ene comune* si di eren'ia nettamente dalla teoria li0erale dello $tato (vedi LocIe) come strumento indiri''ato a garantire la sicure''a e i diritti degli individui1 9n atti per #egel una teoria di :uesto tipo comportere00e una con usione tra societ. civile e $tato* ovvero una ridu'ione dello $tato a semplice tutore degli interessi particolaristici della societ. civile1 Lo $tato di #egel si di eren'ia anc&e dal modello democratico* vale a dire dalla teoria della sovranit. popolare (vedi @ousseau)* in :uanto il popolo* al di uori dello $tato* 4 soltanto una moltitudine in orme1 < simili !astra'ioni"* #egel contrappone la teoria secondo cui la sovranit. dello $tato deriva dallo $tato medesimo* perc&7 lo $tato non 4 ondato sugli individui* ma sull+idea di $tato* ossia sul concetto di un 0ene universale: pertanto non sono gli individui a ondare lo $tato* ma lo $tato a ondare gli individui* sia dal punto di vista storico-temporale (lo $tato 4 !prima" degli individui* c&e nascono nell+am0ito di uno $tato gi. esistente)* sia dal punto di vista ideale* in :uanto lo $tato 4 superiore agli individui (cos; come il tutto 4 superiore alle parti c&e lo compongono3 in termini &egeliani lo $tato 4 una realt. !concreta" e la persona singola 4 una realt. !astratta")1 8etto :uesto* risulta c&iaro perc&7 #egel ri iuta anc&e la teoria contrattualistica (secondo cui la $tato derivere00e da un contratto scaturito dalla volont. degli individui)* e la teoria giusnaturalistica (secondo cui i diritti naturali esistere00ero prima e oltre lo $tato: per #egel il diritto esiste solo nello $tato e gra'ie allo $tato)1 Lo $tato &egeliano 4 assolutamente sovrano* ma non per :uesto 4 dispotico: in atti #egel ritiene c&e lo $tato de00a operare solo per me''o delle leggi* de00a essere* :uindi* uno $tato di diritto3 inoltre identi ica la !costitu'ione ra'ionale" dello $tato con la monarc&ia costitu'ionale moderna1 6uttavia #egel non intende costruire un modello politico di $tato* :uanto piuttosto rendere ragione della natura pro onda dello $tato* c&e resta tale indipendentemente dalle reali''a'ioni concrete degli $tati e dalle loro eventuali imper e'ioni e inadempien'e1 Leggiamo il testo di #egel: M'o "tato, in s/ e per s/, la totalit, etica, la realizzazione della li+ert,* ed finalit, assoluta della ragione, c)e la li+ert, sia reale. 'o "tato lo "pirito c)e sta nel mondo, e si realizza nel medesimo con coscienza, mentre, nella natura, esso si realizza soltanto in quanto altro da s/, in quanto spirito sopito. "olamente in quanto esistente nlla coscienza, in quanto consapevole di se stesso, come oggetto c)e esiste, esso lo "tato. (... 'ingresso di Dio nel mondo lo "tato* il suo fondamento la potenza della ragione c)e si realizza come volont,. !ellidea dello "tato non devono tenersi presenti "tati particolari, istituzioni particolari* anzi, si deve considerare per s/ lidea, questo Dio reale. 9gni "tato, lo si dic)iari anc)e cattivo secondo i principi c)e si professano, si riconosca questo o quel difetto, )a sempre in s/, specialmente se appartiene alla nostra epoca civile, i momenti essenziali della sua esistenza. 2a poic)/ molto pi facile scoprire un difetto, c)e intendere laffermativo, si cade facilmente nellerrore di dimenticare, al di sopra dei suoi singoli aspetti, lorganismo interiore dello "tato stesso. 'o "tato non unopera darte* esso sta nel mondo, e quindi nella cerc)ia dellar+itrio, dellaccidentalit, e dellerrore* un comportamento cattivo lo pu( svisare da molti lati. 2a luomo pi odioso, il reo, un ammalato e uno storpio, sono sempre ancora uomini viventi* laffermativo, la vita, esiste, malgrado il difetto* e questo affermativo importa, qui 1N ,merge da :uesta pagina una esplicita divini''a'ione dello $tato3 come vita divina c&e si reali''a nel mondo* lo $tato non pu5 trovare nelle leggi della morale un limite o un impedimento alla sua a'ione3 inoltre non pu5 esistere un organismo superiore allo $tato c&e possa giudicare le pretese degli $tati e regolare i rapporti tra gli $tati1 9l solo giudice o ar0itro ra gli $tati 4 lo $pirito universale* cio7 la $toria* la :uale &a come suo momento strutturale la guerra1 >uovendosi in un ori''onte di pensiero completamente diverso dal cosmopolitismo paci ista dell+9lluminismo* #egel attri0uisce alla guerra non solo un carattere di necessit. e inevita0ilit.* ma anc&e un alto valore morale1 9n atti come Mil movimento dei venti preserva il mare dalla putredine, nella quale sare++e ridotto da una quiete durevole N* cos; la guerra preserva i popoli dalla ossili''a'ione alla :uale li ridurre00e una pace perpetua1
0.* LA #ILOSO#IA DELLA STO(IA
$e lo $tato 4 la @agione c&e a il suo ingresso nel mondo* la $toria* c&e nasce dalla dialettica degli $tati* 4 il dispiegarsi di :uesta stessa @agione nel tempo3 nella storia si reali''a la coinciden'a ra reale e ra'ionale: tutto va come deve andare1 Certo dal punto di vista degli individui le cose spesso non vanno come dovre00ero* ma la iloso ia della storia non va pensata dal punto di vista degli individui 0ens; dell+assoluto* e allora si capisce c&e la storia si svolge secondo un disegno ra'ionale1 #egel dice c&e la ra'ionalit. della storia coincide con il concetto cristiano di 2rovviden'a* cio4 di un governo divino del mondo1 6uttavia la 2rovviden'a cristiana &a un+origine trascendente e non pu5 essere completamente deci rata e compresa dall+uomo1 9nvece la ra'ionalit. dello storia &egeliana 4 immanente e la ragione iloso ica pu5 comprenderne il ine e i me''i1
00
9l ine della storia del mondo 4 c&e Mlo spirito giunga al sapere di ci( c)e esso veramente, e oggettivi questo sapere, lo realizzi facendone un mondo esistente, manifesti oggettivamente se stesso N1 Auesto spirito c&e si mani esta e reali''a in un mondo esistente* cio4 nella realt. storica* 4 lo spirito del mondo c&e si incarna* si particolari''a negli spiriti dei popoli (e :uindi negli $tati) c&e si succedono all+avanguardia della storia1 9n atti nella competi'ione ra i popoli ottiene la vittoria :uel popolo (e :uello $tato) c&e &a concepito il piB alto concetto dello $pirito (come a00iamo detto sopra* il solo giudice o ar0itro ra gli $tati 4 lo $pirito universale* cio7 la $toria* la :uale &a come suo momento strutturale la guerra)1 <00iamo detto c&e lo $pirito oggettivo 4 la progressiva reali''a'ione della li0ert.1 Auesta li0ert. si reali''a nello $tato: :uindi il ine supremo della storia 4 una reali''a'ione sempre piB per etta della li0ert. per me''o dello $tato* reali''a'ione c&e avviene in tre momenti: 1) il mondo orientale* nel :uale uno solo 4 li0ero* () il mondo greco-romano* nel :uale alcuni sono li0eri* 3) il mondo cristiano-germanico* nel :uale tutti gli uomini sono li0eri 1 9 me''i della storia sono gli individui con le loro passioni: #egel ammette l+esisten'a di individui cosmico-storici o eroi* come <lessandro >agno* %iulio Cesare* Dapoleone* capaci di ! are la storia"* tuttavia :uesti uomini agiscono per ini particolari* ma c+4 un+ astu'ia della ragione c&e si serve delle loro passioni irra'ionali e particolari per reali''are un progresso universale: non loro &anno atto la storia* in realt.* ma in essi 4 vissuto lo $pirito e &a utili''ato la loro a'ione per il proprio o0iettivo universale (e :uando essi &anno reali''ato il loro compito* vengono !scartati" dallla storia: %iulio Cesare ucciso* Dapoleone esiliato a $ant+,lena ecc1) Commento: Lo storicismo per etto di #egel intende il divenire come un progresso continuo in cui la orma successiva 4 per or'a migliore di :uella precedente1 ,+ evidente c&e la storia cos; concepita diventa un !tri0unale" in cui c&i prevale &a sempre ragione3 col risultato di giusti icare ogni cosa: il male 4 cancellato* cos; come 4 cancellata la responsa0ilit. individuale1 , le lacrime e il sangue dei vintiO Finiscono* per usare un+espressione di Lenin* nella !pattumiera della storia"* come un momento dialettico necessario ma destinato ad essere superato dal potere vincente1 , il criterio di giudi'io storico non sar. il 0ene o il male* ma l+essere !contro la storia" o !nel senso della storia"* cio4 essere ultimamente dalla parte del vincitore1
01* LO S%I(ITO ASSOLUTO
Lo $tato 4 !l+ingresso di 8io nel mondo"* il culmine dello $prito oggettivo* ma esso rimane pur sempre un elemento par'iale* inito* del 6utto1 Occorre ancora giungere alla comprensione dello $pirito come 6otalit.1 Lo spirito assoluto 4 il momento il cui l+9dea giunge alla piena coscien'a della propria in init. o assolute''a (cio4 del atto c&e tutto 4 $pirito e c&e non vi 4 nulla al di uori dello $pirito)1 >a :uesto auto-sapersi dello $pirito non 4 un+intui'ione mistica* ma un processo dialettico rappresentato dall+arte* dalla religione e dalla iloso ia1 Aueste sono* dun:ue* tre attivit. attraverso le :uali noi conosciamo l+<ssoluto e l+<ssoluto conosce se stesso1 $ono per5 tre attivit. poste su livelli diversi1 9n atti soltanto la iloso ia pu5 am0ire al sapere assoluto* perc&7 essa sola utili''a lo strumento adeguato all+oggetto da conoscere: la ra'ionalit. dialettica1 L+arte e la religione &anno lo stesso contenuto della iloso ia* lo $pirito assoluto* ma lo presentano in orma inadeguate: l+arte nella orma dell+intui'ione sensi0ile e la religione nella orma della rappresenta'ione1
LA(TE
#egel attri0uisce all+arte una un'ione conoscitiva (come i @omantici)* l+arte permette in atti di arrivare* attraverso le orme sensi0ili* all+intui'ione dell+<ssoluto1 9n atti l+esperien'a estetica 4 l+esperien'a di un+unit. pro onda tra soggetto e oggetto3 pertanto l+arte* attraverso la media'ione di un elemento sensi0ile (:ualcosa di materiale* come una statua* un :uadro* un suono) coglie intuitivamente :uell+identit. tra $pirito e Datura c&e la iloso ia idealistica a erma concettualmente1 9l limite dell+arte consiste nel atto c&e la orma dell+intui'ione sensi0ile non 4 in grado di render conto del dispiegarsi dialettico dell+<ssoluto1 #egel dialetti''a la storia dell+arte in tre momenti: arte sim0olica* arte classica e arte romantica1 L+arte sim0olica (tipica dei popoli orientali) 4 caratteri''ata dallo s:uili0rio tra contenuto e orma* nel senso c&e la orma prevale sul contenuto1 L+arte classica 4 caratteri''ta da un arminco e:uili0rio tra contenuto spirituale e orme sensi0ili1 L+arte romantica 4 caratteri''ata da un nuovo s:uili0rio tra orma e contenuto* nel senso c&e il contenuto prevale sulla orma* :ualsiasi orma spirituale viene ormai avvertita come insu iciente a esprimere la ricc&e''a dello $pirito1 2er :uesto l+arte romantica prelude alla >orte dell+arte* cio4 all+a00andono dell+arte per trovare una piB adeguata espressione della spiritualit. nella religione e nella iloso ia3 la !morte dell+arte" non signi ica l+estin'ione di :ualsiasi attivit. artitica* ma il atto c&e per l+uomo moderno l+arte non costituisce piB il vertice della vita spirituale* non 4 piB (come invece era per gli antic&i) il 0isogno supremo dello spirito1
LA (ELIGIO2E
03
La religione 4 la seconda orma dello spirito assoluto* :uella in cui l+assoluto si mani esta nella orma della rappresenta'ione interiore* c&e 4 il modo tipicamente religioso di pensare 8io* e c&e sta a met. strada ra l+intui'ione sensi0ile dell+arte e il concetto ra'ionale della iloso ia (rappresenta'ione 4* per esempio* l+immagine di un 8io creatore* con cui la coscien'a religiosa esprime l+<ssoluto)1 <nc&e la religione &a uno sviluppo storico* dalle antic&e religioni naturali* in cui 8io 4 visto come or'a naturale* alle religioni dell+individualit. spirituale (giudaica* greca e romana)* in cui 8io appare in sem0ian'e umane* al Cristianesimo* in cui 8io appare come !puro spirito"1 2er #egel la religione cristiana 4 la !religione assoluta"* perc&7 essa esprime attraverso i suoi dogmi le stesse verit. della iloso ia: per esempio la 6rinit. esprime la triade dialettica di 9dea* Datura e $pirito* %esB Cristo uomo-8io esprime l+identit. di inito e in inito* ecc1 6uttavia anc&e il cristianesimo presenta i limiti di ogni religione* cio7 l+incapacit. della orma rappresentativa di esprimere adeguatamente l+<ssoluto1 9l limite della rappresenta'ione religiosa consiste nel atto c&e essa intende le sue determina'ioni come giustapposte* cio4 slegate* sconnesse1 2er esempio non c+4 un nesso logico (secondo #egel) tra la 6rinit. divina* la crea'ione* la provviden'a ecc1 9n altri termini* la religione non 4 in grado di pensare dialetticamente lo $pirito* vale a dire di cogliere la ricc&e''a e la necessit. delle sue articola'ioni: per la religione l+<ssoluto rimane misterioso1 2ertanto l+unico s0occo coerente della religione 4 la iloso ia* c&e ci parla anc&+essa dell+<ssoluto* ma nella orma inalmente adeguata del concetto1
LA #ILOSO#IA
Della iloso ia lo $pirito giunge alla piena e concettuale coscien'a di se stesso* c&iudendo il ciclo cosmico1 #egel ritiene c&e anc&e la iloso ia sia una orma'ione storica* ossia una totalit. processuale c&e si 4 sviluppata attraverso una serie di gradi o momenti concludentisi necessariamente nell+idealismo1 9n altre parole* la iloso ia 4 nient+altro c&e l+intera storia della iloso ia giunta inalmente a compimento con #egel1 8i conseguen'a* i vari sistemi iloso ici c&e si sono succeduti nel tempo non devono essere considerati come un insieme disordinato e accidentale di opinioni c&e si escludono a vicenda* in :uanto ognuno di essi costituisce una tappa necessaria del arsi della verit.1 M'a filosofia c)e ultima nel tempo insieme un risultato di tutte le precedentie deve contenere i principi di tutte: essa perci( la pi sviluppata, ricca e concretaN : l+ultima iloso ia 4 :uella di #egel P ,+ nella iloso ia di #egel c&e l+<ssoluto si autoconosce* totalmente e de initivamenteP
0+
Potrebbero piacerti anche
- De Bono, E., Il Pensiero LateraleDocumento70 pagineDe Bono, E., Il Pensiero LateraleClaudio Di Liddo100% (1)
- Appunti CartesioDocumento2 pagineAppunti Cartesiobla blaNessuna valutazione finora
- Riassunto Il Gioco Della Cultura Di S. Piccone Stella e L. SalmieriDocumento55 pagineRiassunto Il Gioco Della Cultura Di S. Piccone Stella e L. SalmieriPaolaNessuna valutazione finora
- James Frazer Il Ramo D'oroDocumento31 pagineJames Frazer Il Ramo D'oroKillerKattNessuna valutazione finora
- IT 101 Riflessioni Che Cambiano Il Tuo Modo Di Pensare Brianna WestDocumento249 pagineIT 101 Riflessioni Che Cambiano Il Tuo Modo Di Pensare Brianna WestSorin Yannick100% (1)
- CartesioDocumento16 pagineCartesioGian Luca VitaleNessuna valutazione finora
- Estetica Della Pittura Il Mulino 2007 PDFDocumento4 pagineEstetica Della Pittura Il Mulino 2007 PDFabundioarnaldoNessuna valutazione finora
- Ouroboros n.1Documento56 pagineOuroboros n.1belfagor42Nessuna valutazione finora
- Spinoza TIE MigniniDocumento25 pagineSpinoza TIE MigniniJosé PalmaSantyagoNessuna valutazione finora
- PLATONEDocumento5 paginePLATONENicolas Papalexis100% (1)
- Riassunto La Religione Entro I Limiti Della Sola RagioneDocumento12 pagineRiassunto La Religione Entro I Limiti Della Sola RagionePietro Angelo GangiNessuna valutazione finora
- AAS 50 (1958) - OcrDocumento1.130 pagineAAS 50 (1958) - OcrJosé Luis RiveraNessuna valutazione finora
- Learning How To LearnDocumento7 pagineLearning How To Learnarge_deianiraNessuna valutazione finora
- Le 7 Leggi UniversaliDocumento15 pagineLe 7 Leggi Universalihar58Nessuna valutazione finora
- La Filosofia Di Locke, Empirismo: RiassuntoDocumento2 pagineLa Filosofia Di Locke, Empirismo: RiassuntoGianfranco Marini100% (5)
- ARISTOTELEDocumento8 pagineARISTOTELEalice mareggiateNessuna valutazione finora
- Pulizia e Il Bilanciamento Dei ChakraDocumento21 paginePulizia e Il Bilanciamento Dei ChakraNina Ariel100% (1)
- Appunti PlatoneDocumento21 pagineAppunti PlatoneElenaNessuna valutazione finora
- Corso Di Filosofia Della Religione PDFDocumento18 pagineCorso Di Filosofia Della Religione PDFcuba esquivel amadeoNessuna valutazione finora
- Meditazioni MetafisicheDocumento4 pagineMeditazioni MetafisicheLuca Prudenzi100% (1)
- Introduzione A Manzoni, Scritti Filosofici e ReligiosiDocumento8 pagineIntroduzione A Manzoni, Scritti Filosofici e ReligiosiAndrea MorabitoNessuna valutazione finora
- Cusinato, La - Fenomenologia - e - Le - Affordances Espressive Dei Dati Di Fatto PuriDocumento15 pagineCusinato, La - Fenomenologia - e - Le - Affordances Espressive Dei Dati Di Fatto Puribrevi1Nessuna valutazione finora
- FF3300Documento119 pagineFF3300na9daNessuna valutazione finora
- Idea BelloriDocumento17 pagineIdea Bellorifran_rodríguez_2Nessuna valutazione finora
- Franco Venturi - Utopia e Riforma Nell'illuminismo (Riassunto)Documento14 pagineFranco Venturi - Utopia e Riforma Nell'illuminismo (Riassunto)fedeg94Nessuna valutazione finora
- eBook-Free-Il Genio - Robert DiltsDocumento39 pagineeBook-Free-Il Genio - Robert DiltsIsotta Dinzeo100% (1)
- La Cosmologia Di Massimo ConfessoreDocumento18 pagineLa Cosmologia Di Massimo ConfessorePiero PertusatiNessuna valutazione finora
- Carmignani - Teoria Delle Leggi Della Sicurezza SociaDocumento473 pagineCarmignani - Teoria Delle Leggi Della Sicurezza SociaSamanouskeNessuna valutazione finora
- Estratto Del Libro Diventa RiccoDocumento13 pagineEstratto Del Libro Diventa RiccoDomenico GeraceNessuna valutazione finora
- A. Benigni, Introduzione Generale Al Pensiero Di NietzscheDocumento196 pagineA. Benigni, Introduzione Generale Al Pensiero Di NietzscheGiovanni Gaetani100% (1)