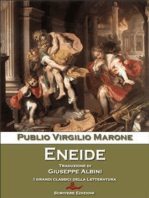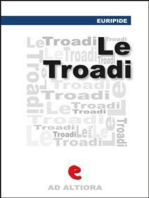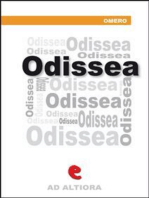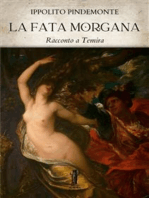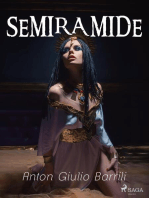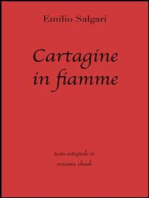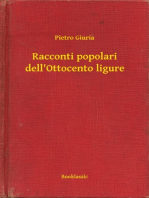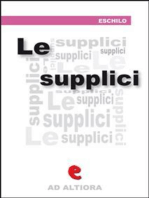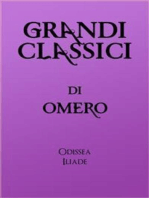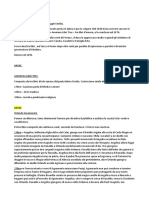Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
ENEIDE
Caricato da
AnnaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
ENEIDE
Caricato da
AnnaCopyright:
Formati disponibili
Virgilio, Eneide I
Arma virumque canō, Trōiae quī prīmus ab ōrīs
Ītaliam, fātō profugus, Lāvīniaque vēnit
lītora, multum ille et terrīs iactātus et altō
vī superum saevae memorem Iūnōnis ob īram;
multa quoque et bellō passus, dum conderet urbem, 5
inferretque deōs Latiō, genus unde Latīnum,
Albānīque patrēs, atque altae moenia Rōmae.
Mūsa, mihī causās memorā, quō nūmine laesō,
quidve dolēns, rēgīna deum tot volvere cāsūs
īnsīgnem pietāte virum, tot adīre labōrēs 10
impulerit. Tantaene animīs caelestibus īrae?
Virgilio, Eneide I, vv. 12-33
Città antica fu, la tennero coloni tirii,
Cartagine, lontano di fronte all'Italia e alla foce
del Tevere, ricca di mezzi, fortissima di ardore guerriero
che, sola, si dice Giunone prediligesse fra tutte
le terre, trascurata Samo; qui le sue armi,
qui il suo carro; che questa regni sui popoli,
se i fati permettano, la dea fin d'allora si prefigge e medita.
Tuttavia sapeva che sarebbe discesa da sangue troiano
una stirpe che un giorno abbatterebbe le rocche tirie;
di qui un popolo largamente sovrano e superbo in guerra
verrebbe a rovina della Libia: così filavano le Parche.
Temendo ciò la Saturnia, e memore della passata guerra
che aveva fatto per prima a Troia in favore della diletta
Argo - infatti non le erano ancora cadute dall'animo
le cause dell'ira e i crudeli dolori: rimane serrato
nel profondo del cuore il giudizio di Paride e l'offesa della spregiata
bellezza, e l'invisa stirpe, e gli onori a Ganimede rapito -,
adirata di queste cose teneva lontani dal Lazio,
travagliati per tutta la distesa delle acque, i Troiani, relitti
dei Danai e del feroce Achille; e già da molti anni
erravano, spinti dai fati, intorno a tutti i mari.
Tanto costava fondare la gente romana!
Virgilio, Eneide I, vv. 335-380
E allora Venere: “Io non sono degna di un simile onore;
hanno costume, le vergini tirie, di aver la faretra
e fino in alto fasciare le gambe in coturni purpurei.
Vedi qui i punici regni, i Tiri e le mura di Agènore.
Ma il territorio è dei Libici, gente non facile in guerra.
Regge il comando Didone. Partì dalla rocca dei Tiri
per fuggire al fratello. È una lunga vicenda di torti,
lunga e intricata; ma ne seguirò i principali momenti.
Era a lei sposo Sicheo, assai ricco di campi in Fenicia
e da lei sventurata diletto d’amore profondo,
cui il padre intatta l’aveva data, e congiunta coi primi
riti. Ma i regni di Tiro erano in mano al fratello
Pigmalione, innanzi a ogni altro efferato nel male.
Venne, fra loro, furore. E quello empiamente, alle are,
cieco di amore per l’oro, in segreto, col ferro sopprime
a tradimento Sicheo, non curando l’amore provato
dalla sorella; e a lungo nascose il misfatto, e, malvagio,
molto fingendo, ingannava con vana speranza l’amante
misera. Ma a lei, in un sogno, del suo marito insepolto
venne l’immagine, e il volto levò, esangue in modo mirabile:
mise a nudo le are crudeli e il petto trafitto
dal ferro, e tutto quel cieco delitto svelò del casato.
Poi la persuade a afferrare la fuga e lasciare la patria,
e come aiuto alla via le dischiude antichi tesori
di sottoterra, segreta abbondanza di argento e oro.
Scossa, Didone si dà a preparare la fuga e i compagni.
Viene a raccolta chi aveva un odio crudele al tiranno
o di lui aspro timore; navi per caso già pronte
prendono, colmano d’oro, e portano i beni dell’avido
Pigmalione via in mare. A condurre l’impresa è una donna.
Vennero ai luoghi in cui ora tu scorgi le mura imponenti
della nuova Cartagine, con la sua rocca nascente,
e acquistarono il suolo - dal fatto, il nome di Birsa -
quanto potessero cingerne con la pelle di un toro.
Ma voi, infine, chi siete, o da quali lidi veniste?
E dove vi dirigete?” E lui, al suo chiedere questo,
sospirando e traendo la voce dal fondo del petto:
“Se risalendo all’origine prima, o dea, rispondessi,
e tu potessi ascoltare gli annali del nostro penare,
Vespero prima, chiudendo l’Olimpo, verrebbe a riporre
il giorno. Noi dall’antica Troia – se a volte alle orechcie
vi giunse il nome di Troia –, per mari diversi portati,
una tempesta, a suo arbitrio, ai lidi di Libia sospinse.
Sono il pio Enea, che, strappati al nemico i Penati, li porto
su di una flotta con me, conosciuto per fama oltre l’etere.
Cerco per patria l’Italia, e del grande Giove la stirpe.
Virgilio, Eneide I, vv. 439-463
Viene avanti ravvolto, mirabile a dirsi, da nebbia,
stando fra gli altri, e alla gente si mischia, non visto da alcuno.
V’era nel cuore della città un bosco sacro, lietissimo
d’ombre; all’inizio, sbattuti da onde e tempesta, qui i Punici
disseppellirono il segno – una testa ardente di cavallo –
che indicò la regale Giunone: sarebbero stati
popolo prospero e in guerra eccellente nel corso dei secoli.
Qui la sidonia Didone a Giunone erigeva un grande tempio,
ricco di doni e del nume di lei. I gradini e le soglie
si levavano di bronzo, sul bronzo poggiavano le travi,
e ne stridevano i cardini sopra le porte di bronzo.
In questo bosco accadde un evento impensato e il timore
la prima volta lenì; qui Enea sperare salvezza
osa la prima volta, e fra i mali alimenta fiducia.
Mentre, in attesa della regina, considera infatti
ogni dettaglio nel tempio imponente, e ammira lo sfarzo
delle città, l’intreccio di apporti di artisti, e l’impegno
delle opere, vede in ordine gli scontri di Ilio,
e la guerra, per fama diffusa già in tutto il mondo:
Priamo e gli Atridi, e Achille, spietato per l’uno e per gli altri.
Si fermò, e in pianto disse: “Che luogo, oramai, sulla terra,
quale regione non è piena, Acate, del nostro penare?
Ecco Priamo. Anche qui trova il suo compenso il valore,
trovano lacrime i fatti, e le sorti mortali commuovono.
Sciogli i timori, avrai in simile fama una qualche salvezza”.
Virgilio, Eneide I, 561-636
Allora brevi parole Didone, chinato lo sguardo, proferisce: «Dissipate dal cuore il timore, o
Teucri, bandite gli affanni. Una condizione dura e la novità del mio regno mi costringono a
tali cautele, facendo vigilare per lungo tratto i confini da guardie. Chi la stirpe degli Eneadi,
chi la città di Troia ignora, il valore e i valorosi o l’immane incendio di quella guerra? Non
così duri abbiamo i cuori noi Punici, né così distante i suoi cavalli aggioga il Sole dalla città
dei Tiri. Sia che la grande Esperia e gli arabili campi di Saturno, o sia che la regione
dell’Erice e il re Aceste voi preferiate, col mio aiuto sicuri io vi congederò e dalle mie
ricchezze soccorsi. Volete anche qui, con me, alla pari stabilirvi nel mio regno? La città che
impianta è vostra; tirate a riva le navi. Troiani e Tiri da me senza alcuna distinzione saranno
trattati. E voglia il cielo che anche il re, sospinto dal medesimo scirocco, qui fosse, Enea!
Certo alle spiagge persone fidate invierò, la Libia ordinerò di perlustrare fino ai confini, se
mai rigettato dal mare per foreste o città vada errando».
Tutti tesi in cuor loro da queste parole, e il forte Acate e il padre Enea da tempo bramavano
erompere dalla nube. Per primo Acate interpella Enea: «O nato da una dea, quale ora il
pensiero che alla mente ti spunta? Tutto è salvo, lo vedi, flotta e compagni sono ritrovati. Uno
solo manca, che in mezzo ai flutti vedemmo noi stessi sommerso; il resto risponde alle parole
materne». Appena aveva proferito queste parole, che l’involucro d’un tratto si squarcia della
nube, e nell’etere aperto si purifica. Riapparve Enea e alla chiara luce rifulse, il volto e le
spalle simili a un dio. E invero la grazia nei capelli del suo nato la genitrice aveva infuso, e il
fulgore della giovinezza purpureo e limpida maestà negli occhi: così le mani dell’artista
aggiungono grazia all’avorio, o quando accade che l’argento o il marmo di Paro si avvolge
nel biondo dell’oro. Allora così alla regina si rivolge e, a tutti apparso all’improvviso, disse:
«Innanzi a te chi tu cerchi, eccomi: il troiano Enea, strappato alle onde della Libia. O tu, sola
delle indicibili sofferenze di Troia pietosa, che noi, superstiti ai Danai, che della terra e del
mare a tutti i travagli abbiamo dato fondo oramai, di tutto indigenti, nella tua città, nella tua
dimora quali alleati accogli: compensarti degnamente non è nei nostri mezzi, o Didone, né di
alcuno, dovunque, che sia della razza dardania nell’immensità dispersa dell’universo. Gli dèi,
se vi sono potenze rispettose dei pii, se qualcosa in qualche luogo è giustizia e coscienza del
bene, te premino degnamente. Quale così felice generazione ti portò sulla terra? quali così
insigni, quale sei, genitori ti procrearono? Ai golfi finché i fiumi correranno, finché sui monti
le ombre penetreranno negli anfratti, e il firmamento finché le stelle pascerà, sempre onori tu
avrai e lodi al tuo nome, qualunque terra mi chiami». Ciò detto, all’amico Ilioneo tende la
destra, la sinistra a Seresto, poi agli altri: al forte Gia e al forte Clonato. Rimase attonita
dapprima alla vista la sidonia Didone, alla sventura dell’uomo, immensa; e così con la sua
voce gli disse: «Quale sorte, o nato da una dea, fra così grandi pericoli t’incalza? quale potere
alla mostruosità ti spinge di queste rive? Tu quell’Enea, che al dardanio Anchise la
vivificante Venere in Frigia partorì, presso l’onda del Simoenta? E proprio Teucro io mi
rivedo a Sidone venire, cacciato dai lembi della patria, di un nuovo regno in cerca con l’aiuto
di Belo. Mio padre allora, Belo, l’opulenta terra devastava di Cipro e, vincitore, in suo potere
la teneva. Fin d’allora la caduta mi era nota della città troiana, e il tuo nome, e i re pelasgi.
Egli stesso, un nemico, i Teucri esaltava con lodi insigni, e disceso dall’antico ceppo dei
Teucri si presentava. Perciò avanzate, o giovani, entrate sotto i nostri tetti. Anche me per
molti simili travagli ha la fortuna sbattuto, e qui alla fine volle che mi stabilissi in terra. Non
ignara del male, imparo a soccorrere gli sventurati». Così va ricordando, e mentre Enea alla
reggia conduce, sotto i tetti, agli dèi nei templi indice sacrifici. Allo stesso modo, intanto, ai
suoi compagni sulla spiaggia invia venti tori, e grandi, dall’ispida schiena, cento suini, e
pingui, con le loro madri, cento agnelli, e il dono rallegrante per quella giornata.
Virgilio, Eneide II, vv. 1-9
Conticuere omnes intentique ora tenebant.
Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto:
Infandum, regina, iubes renovare dolorem,
Troianas ut opes et lamentabile regnum
eruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi 5
et quorum pars magna fui. quis talia fando
Myrmidonum Dolopumve aut duri miles Ulixi
temperet a lacrimis? et iam nox umida caelo
praecipitat suadentque cadentia sidera somnos.
Virgilio, Eneide II, vv. 10-81
Ma, se tanto è l’amore di apprendere i nostri rovesci
e di ascoltare in breve la prova estrema di Troia,
anche se l’animo trema al ricordo e a quel lutto rifugge,
inizierò. Dalla guerra spezzati, dai fati respinti,
i condottieri dei Danai, trascorsi oramai tanti anni,
plasmano simile a un monte, con l’arte divina di Pallade,
un cavallo, intessendo le costole in travi di abete:
fingono un voto per il ritorno, e la fama si sparge.
Qui corpi scelti di eroi, di nascosto, traendole a sorte,
chiudono nel cieco fianco, e a fondo ricolmano il grembo,
le sue imponenti caverne, di uomini armati a battaglia.
V’è là di fronte Tenedo, assai conosciuta per fama,
isola ricca e fiorente, finché resse il regno di Priamo,
ora non più che una baia e approdo mal fido alle chiglie.
Vengono qui con le navi, nascosti sul lido deserto.
Noi li crediamo partiti, diretti col vento a Micene.
Tutta la Teucria, dunque, da un lungo pianto si scoglie.
Si spalancan le porte; dà gioia spaziare, vedere
il campo dorico e i luoghi deserti e il lido lasciato.
“Qui le forze dei Dolopi, aveva qui Achille spietato
la tenda, qui era la flotta, qui usavano in guerra schierarsi”.
Parte stupisce del dono esiziale a Minerva illibata
e del cavallo ammira la mole; per primo Timete
dentro le mura esorta a portarlo, fin sopra la rocca,
o per inganno o perché ciò portava ormai il fato di Troia.
Ma Capi e quelli che avevano in mente un giudizio migliore
spingono o a precipitare in mare le insidie dei Danai,
e quel dono sospetto, e incendiandolo darlo alle fiamme,
o a trapassarne il cavo del ventre e esplorarne i recessi.
Si divide il popolo incerto in pareri contrari.
Primo davanti a tutti, fra grande corteggio a scortarlo,
Laocoonte, ardente, dall’alta rocca giù accorre
e da lontano: “Quale follia, o cittadini infelici?
Forse credete partiti i nemici? O che manchi di inganno
dono alcuno dei Danai? È così che Ulisse vi è noto?
O in questo legno gli Achei se ne stanno rinchiusi e nascosti,
o questa è macchina contro i nostri muri innalzata
per abbattersi sulla città, spiate le case,
o v’è altra insidia: nessuna fiducia, o Teucri, al cavallo!
Sia quel che sia, temo i Danai, anche se portano doni”
Detto che ebbe, un’asta impotente con vivo vigore
nel fianco della bestia scagliò, nel ricurvo fasciame
del ventre. E quella, confitta, vibrò, e dal grembo percosso
rimbombarono, cupe gemendo, le cave caverne.
E, a non avere sinistri i fati divini e la mente,
ci avrebbe spinto a straziare col ferro le argoliche tane,
Troia ora ritta sarebbe, e tu salda, alta rocca di Priamo.
Ecco frattanto i pastori dardanidi trarre, legate
dietro la schiena le mani, un giovane re, con clamore
grande. Da sé s’era offerto, ignoto, a chi incontro veniva,
e proprio questo tramava: aprire Troia agli Achivi.
Molto fidava nell’animo suo, pronto a entrambe le sorti:
o manovrare gli inganni, o soccombere a morte sicura.
Corrono i giovani teucri a vedere e d’intorno si affollano
da ogni dove, in contesa a chi più il prigioniero schernisca.
Ora ascolta le insidie dei Danai. E, da un solo delitto,
tutti apprendili.
E infatti quando al cospetto di tutti, insieme, turbato
si fermò, e sulle schiere frigie girò intorno gli occhi:
“Ah quale terra ora” disse, “che mari potranno mai accogliermi
o cosa infine rimane a me sventurato, che un posto
non avrò più presso i Danai, e che in più gli stessi Dardanidi
vogliono ostili punire con un castigo di sangue?”
A quel lamento mutarono gli animi e ogni aggressione
si arrestò. Lo esortiamo a dirci da che sangue è nato,
cosa ci porti, e con quali speranze si sia consegnato.
[Lui dice queste cose, deposto infine il timore:]
“Sia quel che sia, a te, o re, certo confesserò tutto”
disse, “il vero, e di argolica stirpe non negherò d’essere:
questo per primo; né, se la Fortuna ha plasmato Sinone
sventurato, anche falso potrà plasmarlo e mendace,
perfida.
[…]
Virgilio, Eneide II, vv. 108-144
“Spesso vollero i Danai, lasciata Troia, la fuga
preparare e, da lunga guerra spossati, partire.
E l’avessero fatto! Spesso li chiuse del mare
aspra tempesta, e già pronti a salpare, fu l’Austro a atterrirli.
Specie allorché si levava già questo cavallo, intessuto
con travi d’acero, in tutto l’etere i nembi tuonarono.
Preoccupati, inviamo Euripilo a interrogare
Febo e i suoi oracoli, e lui dal tempio riporta responsi
tristi: ‘placaste col sangue, e uccidendo una vergine, i venti
quanto dapprima veniste, o Danai, ai lidi di Ilio:
vanno cercati col sangue i ritorni e immolando un’argolica
vita’. E, come alle orecchie del popolo venne la voce,
si sgomentarono gli animi e gelido in fondo alle ossa
corse un tremore; a chi apprestino morte, chi Apollo richieda.
L’Itaco qui, con grande tumulto, trascina nel mezzo
il profeta Calcante: e lo spinge a svelar quali siano
quei voleri divini. E molti già a me predicevano
del frodatore l’imbroglio crudele, e il futuro vedevano
muti. Per dieci giorni egli tace e, rinchiuso, ricusa
di tradire qualcuno parlando, o di esporlo alla morte.
Spinto, alla fine, da grandi grida dell’Itaco, a stento
ruppe la voce secondo le trame, e destina me alle are.
Furono tutti d’accordo, accettando volgesse a rovina
di un solo sventurato ciò che per sé ognuno temeva.
Già si era al giorno nefando; si approntano il mio sacrificio
ed il farro salato e, attorno alle tempie, le bende:
mi strappai, lo confesso, alla morte e ruppi i legami
e in limacciosa laguna, oscuro fra l’erba palustre,
mi nascosi, di notte, finché le vele sciogliessero,
se mai salpassero. E ormai di vedere l’antica patria
più non spero, né i dolci figli o di mio padre anelato,
cui forse quelli faranno scontare la pena per questa
fuga, e espieranno, uccidendo quei miseri, questa mia colpa.
Per i Superi, dunque, e i numi coscienti del vero,
io ti prego e – se ancora in un luogo ne resta ai mortali -
per la lealtà intemerata: pietà di cotanti travagli,
abbi pietà di un cuore che, quanto subisce, non merita”.
Virgilio, Eneide II, vv. 163-224
Ogni speranza dei Danai, e fiducia in questa intrapresa
guerra, fu sempre l’aiuto di Pallade. Ma da che, invero,
l’empio Tidide e Ulisse, di scelleratezze inventore,
volti a strappare dal sacro tempio il fatale Palladio,
presero, uccise le guardie in cima alla rocca, la sacra
statua, e con mani lorde di sangue hanno osato toccare
della divinità le sacre bende virginee, da allora
via scivolò e dei Danai, caduta, fu tratta all’indietro
la speranza, e fiaccata ogni forza; e ora è avversa la dea.
E la Tritonia segni ne diede, con chiari prodigi.
Fu appena posta nel campo la statua, che fiamme corrusche
arsero nei suoi occhi innalzati, e un sudore salato
scorse sugli arti, e tre volte essa stessa (mirabile a dirsi)
sussultò sul suolo, con l’asta oscillante e lo scudo.
Subito svela Calcante che in fuga dobbiamo tentare
le acque, né le armi argoliche possono abbattere Pergamo,
se ad Argo non riprendano auspici e il nume riportino
che si rapirono via sul mare e con curve carene.
E se adesso col vento alla patria Micene si volgono,
armi preparano e dei favorevoli, e, in mare tornati,
qui non attesi verranno; così spiega i segni Calcante.
Per il Palladio e il nume violato, ammoniti, a compenso
questa effigie hanno eretto, a espiare l’infausto misfatto.
Ma questa mole immensa Calcante ordinò di innalzare
con un intreccio di travi, su fino al cielo elevandola,
che non potesse varcare le porte o entrare fra le mura
né proteggere il popolo sotto l’antico culto.
Se infatti il dono a Minerva la vostra mano violasse,
grande rovina allora – ma, prima, gli dei su di lui volgano
questo presagio! - verrebbe ai Frigi e al dominio di Priamo;
se invece, per mano vostra, alla vostra rocca salisse,
l’Asia, da sé, muoverebbe alle mura di Pelope in grande
guerra – un destino che andrebbe a spettare ai nostri nipoti”.
Per tali insidie, e per l’arte dello spergiuro Sinone,
fu creduto il racconto, e da inganni e da lacrime finte
preso un popolo che né il Tidide né Achille di Larissa,
non dieci anni di guerra, non mille carene domarono.
Qui un altro evento più grande, e molto più spaventoso,
coglie noi sventurati e sconvolge le menti già incaute.
Tratto per sorte ministro a Nettuno, alle debite are
Laocoonte a immolare un gran toro si stava accigendo.
Ecco però che da Tenedo, sopra le acque tranquille,
(e provo orrore a narrarlo) in immensi anelli due serpi
sul mare vengono a incombere, e in coppia si volgono al lido:
ritti i petti fra i flutti, svettano sopra le onde,
creste colore di sangue, il resto del corpo sul mare
striscia dietro ed inarca le immense terga in volute.
S’alza fragore sul gorgo schiumante, e già erano a terra,
e, con gli occhi ardenti, iniettati di sangue e di fuoco,
nel vibrare la lingua lambivan le fauci in un sibilo
Noi fuggiamo esangui alla vista. Ma quelle, sicure,
su Laocoonte si abbattono; e prima i piccoli corpi
dei due figli ciascuno dei due serpenti, avvinghiandoli,
stringe, e divora a morsi le misere membra; lui stesso,
poi, che accorreva in aiuto e brandiva le armi, ghermiscono,
e lo avvilupano in spire imponenti; e già per due volte
l’hanno serrato alla vita, due volte i dorsi squamosi
cingono al collo. Le teste e le alte cervici sovrastano.
Lui, le bende cosparse di bava e di fosco veleno,
con le mani a un tempo si sforza di sciogliere i nodi
e al contempo orribili grida leva alle stelle,
quale il toro muggiti, se fugge ferito dall’ara
dopo che dalla cervice ha scrollato la scure malcerta.
Virgilio, Eneide II, vv. 235-267
E i dragoni gemelli, strisciando ai templi più in alto,
fuggono e, volti alla rocca della spietata Tritonide,
ai piedi della dea, dello scudo nel disco svaniscono.
Ecco che allora un nuovo timore a tutti si insinua
nei cuori già sconvolti: pagò giustamente il delitto,
dicono, Laocoonte, che lese di cuspide il legno
sacro, la sua scellerata lancia sul dorso scagliandogli.
Va condotta ai templi l’effigie, e va supplicato,
gridano, della dea il nume.
E apriamo i muri di Troia, ne spalanchiamo le mura.
Tutti si accingono all’opera, rulli scorrevoli mettono
sotto gli zoccoli e tendono corde di canapa al collo;
quella fatale macchina ai muri dà la scalata,
gravida d’armi. Intorno fanciulli e fanciulle illibate
cantano inni sacri e stringono in festa la fune;
quella s’insinua in città, e minacciosa vi striscia nel cuore.
O patria, o Ilio, dimora di dei, e celebri in guerra
mura di Dardani! Quattro volte, alla soglia medesima
della porta impuntò, quattro volte nel ventre suonarono
le armi: ma noi insistiamo, incuranti per cieca follia,
e sulla sacra rocca poniamo quel mostro nefasto.
Anche Cassandra, allora, dischiude ai fati futuri
le labbra, per volere di un dio mai credute dai Teucri.
Noi sventurati, cui quello era l’ultimo giorno, i divini
templi veliamo, per la città, di fronde festive.
Ruota il cielo frattanto, e da Oceano irrompe la notte
avvolgendo nell’ombra sua vasta e la terra ed il cielo
e gli inganni mirmidoni. Tacquero i Teucri, distesi
per le mura. Il sopore abbraccia le membra spossate.
E già l’argiva falange a navi schierate veniva,
per la tacita luna e i suoi amici silenzi, da Tenedo
volta alle spiagge ben note, allorché leva fiamme la poppa
del re, e Sinone, difeso da fati divini a noi ostili
scioglie furtivo i serrami di pino e i Danai rinchiusi
nel ventre. Spalancato, li rende ai venti il cavallo
e, dal rovere cavo, fuori si traggono liti
Stenelo e Tassandro, capi, e Ulisse funesto,
scesi lungo una fune calata, e Acamante e Toante
e il Pelide Neottolemo e ancora, primo, Macaone
e Menelao e dell’ordigno lo stesso artefice, Epeo.
Entrano nella città, sepolta nel sonno e nel vino;
fanno strage di guardie, e, a porte aperte, ricevono
tutti i loro compagni, e le complici schiere congiungono.
Virgilio, Eneide II, vv. 268-295
Era il momento in cui il primo riposo ai mortali stremati
incomincia, e s’insinua, gratissimo dono divino:
ecco che in sogno mi parve presente davanti ai miei occhi
Ettore, molto afflitto e in larga effusione di pianto,
come quel giorno che il carro lo trasse, di sangue e di polvere
fosco, coi piedi rigonfi trafitti da cinghie di cuoio.
Ahi, qual era il suo aspetto! Quanto mutato da quello,
l’Ettore che ritorna indossando le spoglie di Achille
o che scaglia le fiamme frigie alle poppe dei Danai!
Con la barba incrostata, e con grumi cruenti ai capelli;
e le ferite mostrava, che molte ebbe attorno alle mura
della patria! Per primo, piangendo, io stesso sembravo
interpellare l’eroe ed effondere meste parole:
“O luce della Dardania, speranza fidata dei Teucri,
che grandi indugi ti tennero? Ettore, tu, l’agognato
da che regioni a noi vieni? In che stato, dopo le molte
morti dei tuoi, e il vario penare di Troia e degli uomini,
te vediamo, sfiniti! Che causa indegna ha straziato
del viso i tratti sereni? O perché scorgo queste ferite?”
Lui nulla, e non indugia sulle mie domande,
ma, traendo dal fondo del petto un gravoso lamento:
“Ah, fuggi, nato da dea” dice, “e strappa te a queste fiamme.
Il nemico è sui muri, dall’alto suo culmine Troia
crolla. Abbastanza si è dato a Priamo e alla patria: se Pergamo
destra potesse difendere, questa l’avrebbe difesa.
È a te che Troia affida le sue sacre cose e i Penati:
prendili al fato compagni, ricerca per loro le mura
grandi, che infine porrai, dopo aver molto errato sul mare”.
Virgilio, Eneide II, vv. 298-338
Nel frattempo, difforme lamento le mura rimescola
e di più e sempre di più, seppure appartato e nascosto
fosse il palazzo del padre Anchise, e protetto da alberi,
chiaro diviene il frastuono e l’orrore delle armi già incombe.
Io mi riscuoto dal sonno e salgo di corsa sul tetto,
sulla sua cima più alta, e attento mi tendo all’ascolto:
come allorché in una messe, sotto il furore degli Austri
piomba la fiamma, o un torrente, per le acque di monti violento,
prostra i campi, i lieti coltivi e dei buoi le fatiche
prostra, e trascina divelte le selve; ignaro stupisce
nell’avvertire il frastuono dall’alto di un picco, il pastore.
Ecco che allora il vero si fa manifesto, e si schiude
il raggiro dei Danai. Crollava già l’ampio palazzo
di Deifobo, che Vulcano soverchia, già arde
Ucalegonte, contiguo; estese rilucono al fuoco
le onde sigee. Grida d’uomini s’alzano, e strida di trombe.
Fuori di me, afferro le armi; né medito un piano per le armi,
ma mi arde l’animo di radunare una squadra a combattere
e coi compagni lanciarmi alla rocca; la mente trascinano
ira e furore, e avverto che è bello morire nelle armi.
Ecco che Panto, però, dai dardi Achivi sfuggito,
Panto l’Otriade, ministro del tempio di Apollo nella rocca,
le sacre cose e gli dèi sconfitti e il nipote piccino
trae di sua mano, e accorre, fuori di sé, alle mie soglie.
“Panto, che ne è di noi? Che rocca abbiam preso a difesa?”
Ciò avevo appena detto; e in un gemito questo rispose:
“Venne il giorno supermo e l’ineluttabile tempo
della Dardania. Fummo Troiani, fu Ilio, e l’immensa
gloria dei Teucri: tutto, crudele, Giove traspose
in Argo; nella città incendiata i Danai trionfano.
Alto, svettando in mezzo alle mura, armati riversa
il cavallo, e Sinone esultante rimescola incendi,
fra le insolenze. Altri stanno alle porte oramai spalancate,
quante migliaia ne vennero mai dalla grande Micene;
altri ad armi spianate hanno occupato gli angusti
vicoli; s’erge una schiera di ferro snudata in corrusche
punte, pronta alla strage; a stento, per prime, battaglie
tentan le guardie alle porte e con cieco Marte resistono”.
Per questi detti del figlio di Otri e volere divino
fra le fiamme e le armi mi scaglio, là dove richiamano
la triste Erinni, e il fremito, e grida levate su all’etere.
Virgilio, Eneide II, vv. 347-369
Quando li vidi riuniti e pronti a osare in battaglia,
di più li incito: “Giovani, cuori fortissimi invano,
se di seguirmi a tentare estreme difese nutrite
una brama sicura, che sorte vi sia lo vedete.
Tutti gli dèi su cui questo dominio poggiava, lasciati
àditi e are, svanirono; è una città fra le fiamme
che soccorrete: moriamo e gettiamoci in mezzo alle armi.
Sola salvezza, ai vinti, sperare in nessuna salvezza”.
Questo aggiunse furore al cuore dei giovani. E, come
lupi rapaci in fosca nebbia, che ciechi sospinse
rabbia maligna del ventre, e che i cuccioli, che hanno lasciato,
a fauci asciutte aspettano, andiamo fra i dardi e i nemici
a una morte non dubbia, e prendiamo la strada del cuore
della città; fosca notte con concava ombra ci è intorno.
Chi potrebbe spiegare a parole la strage, chi i lutti
di quella notte, o potrebbe col pianto uguagliarne la pena?
Crolla un’antica città, che fu sovrana tanti anni;
e per le vie si abbattono corpi indifesi in gran numero
per ogni dove, e dentro le case e lungo le soglie
sacre agli dèi. E non i Teucri soltanto pagano sangue;
capita che anche nei vinti ritorni ai precordi il valore
e, vincitori, cadano i Danai. Ovunque è crudele
lutto, ovunque terrore e, di morte, molteplice immagine.
Virgilio, Eneide II, vv. 386-412
E qui Corebo, esultante per il suo coraggio e il successo,
disse: “O compagni, là dove Fortuna dapprima ci mostra
via di salvezza, e là dove si offre benigna, seguiamola;
scudi scambiamo, e adattiamo a noi le divise dei Danai.
Chi indagherà in un nemico se questo sia inganno o valore?
Armi offriranno essi stessi”. E, detto che ha, mette addosso
l’elmo chiomato di Androgeo e lo scudo con arte adornato,
e si accomoda al fianco una spada argiva. Ugualmente
fanno Rifeo e lo stesso Dimante, e i giovani tutti,
di buon grado: ciascuno si arma di spoglie recenti.
E procediamo frammisti a Danai, con numi non nostri,
e, nella cieca notte assalendo, attacchiamo battaglie,
molte, e molti dei Danai facciamo discendere all’Orco.
Fuggono altri alle navi e cercano in corsa i sicuri
lidi: una parte di loro con turpe terrore risale
nell’imponente cavallo e nel noto ventre si cela.
Ahi, che nessuno può in nulla fidare, se ha avversi gli dèi!
Ecco, le chiome scomposte, era via trascinata la vergine
figlia di Priamo, Cassandra, dai penetrali del tempio
di Minerva, e al cielo tendeva invano gli ardenti
occhi; gli occhi: le tenere palme eran strette in legami.
Non tollerò questa vista Corebo, la mente infuriata,
e si gettò, pronto anche a morire, in mezzo alla schiera;
noi lo seguiamo compatti, e con armi serrate assaltiamo.
Qui innanzitutto, dall’alto tetto del tempio, travolti
siamo dai dardi dei nostri, e ne nasce amarissima strage
per l’aspetto delle armi e l’inganno dei greci cimieri.
Virgilio, Eneide II, vv. 431-468
Ceneri d’Ilio, e tu fiamma estrema dei miei, io vi invoco
per testimoni: nel vostro declino né dardi ho fuggito
né rischi, e avrei meritato il cadere per mano dei Danai,
se questi fossero stati i fati. Di lì ci strappiamo,
Ifito e Pelia con me (e, di loro, Ifito carico
d’anni oramai, Pelia anche attardato da un colpo di Ulisse),
dritti verso il palazzo di Priamo, chiamati da grida.
Qui v’era scontro imponente, come se altrove nessuna
guerra vi fosse, nessuno in tutte le mura morisse,
sì che scorgiamo un indomito Marte e i Danai piombare
verso i tetti, e, a testuggine, stringer d’assedio la soglia.
Alle pareti scale, e sotto gli stipiti stessi
sui gradini si accalcano, oppongono con la sinistra
gli scudi ai dardi, a difesa, e di destra alle falde si afferrano.
Contro, i Dardnidi svellono torri e tutte le cime
delle stanze – con questi dardi, intravista la fine,
già quasi dentro la morte, ad una difesa si apprestano –
e le travi dorate, quei fasti di antichi antenati,
scagliano giù; a spade sguainate presidiano in basso
altri le porte, e in serrata schiera vi stanno a tutela.
Si rinnova nel cuore la spinta a soccorrer la reggia,
a rinfrancarne quegli uomini, e aggiungere ai vinti vigore.
V’era un ingresso con porte invisibili, e stipiti posti
sul retro, in mezzo alle stanze di Piamo passaggio segreto,
grazie a cui l’infelice Andromaca spesso soleva
- fino a che il regno durava – recarsi dai suoceri senza
scorta alcuna e portare al nonno il fanciullo Astianatte.
Esco da lì sopra il tetto, sul culmine, donde di braccia,
gli sventurati Teucri scagliavano vani proiettili.
E una torre sospesa sul vuoto, e dal sommo del tetto
fin sotto gli astri elevata, da cui si soleva vedere
tutta Troia, e le navi dei Danai e l’acheo accampamento,
noi aggrediamo d’attorno col ferro, là dove le estreme
travi offrivano giunte più labili, e dalle alte sedi
la sradichiamo e spingiamo: crollando di colpo, trascina
con frastuono rovina, e sopra le schiere dei Danai
piomba distesa. Ma altri subentrano, né massi o altro
genere cessa, intanto, di dardi.
Virgilio, Eneide II, vv. 506-
Forse ti chiederai anche la sorte che Priamo abbia avuto.
Come vide cader la città catturata, e l’ingresso
dei tetti infranto, e nel cuore del suo palazzo il nemico
vecchio, invano circonda le spalle, tremanti per gli anni,
d’armi da tempo desuete, e si cinge un inutile ferro
e contro i fitti nemici si avanza, disposto a morire.
Sotto l’aperta volta dell’etere, in mezzo al palazzo,
v’era un’ara imponente, e, accanto, un vecchissimo alloro,
che si sporgeva sull’ara e avvolgeva con l’ombra i Penati.
Ecuba qui e le sue figlie invano intorno agli altari;
come colombe affannate all’arrivo di fosca tempesta,
stavano strette, e abbracciando le statue dei numi sedevano.
E come vide lui, Priamo, che aveva indossato le armi
sue giovanili, “Mio povero sposo” gli disse, “che insania
t’ha spinto a cingere questi armamenti? O dove ti scagli?
Non questo aiuto né tali difese richiede il momento,
no, neppure se fosse qui ora lo stesso mio Ettore.
Qui rifugiati, infine. Quest’ara difenderà tutti,
o morirai insieme a noi”. E questo dicendo lo trasse
verso di sé, accompagnandolo anziano in quel sacro riparo.
Ecco però che, sottrattosi a Pirro e alla strage, Polite,
uno dei figli di Priamo, fugge tra dardi e nemici,
nei lunghi porticati, e gli atri attraversa ferito
vuoti. Pirro lo insegue, ardendo di infliggergli il colpo,
già quasi riesce ad afferrarlo e già gli sta addosso con l’asta.
Come giunse, alla fine, agli occhi ed ai volti dei suoi,
cadde a terra, e con molto sangue effuse la vita.
Priamo qui, sebbene già in mezzo e in pugno alla morte,
non si trattenne però, né frenò la sua ira e la voce:
“Ma a te questo delitto” esclama “per simile ardire,
se una pietà v’è nei cieli, che tali vicende abbia in cuore,
paghino degni compensi gli dèi, e rendano i debiti
premi: a te, che mi hai fatto vedere davanti la morte
d’un figlio, e col suo cadavere violi lo sguardo del padre.
Ma non così quell’Achille, da cui generato ti menti,
si comportò con l’amico Priamo: arrossì per un supplice,
per la lealtà a lui dovuta, e i diritti; e il corpo di Ettore
rese al sepolcro, esangue, e me rimandò nei miei regni”.
Dice così il vecchio e senza vigore, innocua, la lancia
scaglia: e all’istante, con roco suono, il bronzo la ferma
e, vana resta lì appesa allo scudo, in cima all’umbone.
Pirro a lui: “Dirai questo, dunque, e ne andrai messaggero
al Pelide mio padre. A lui le mie ignobili imprese
riporterai, non scordarlo, e quanto traligna Neottolemo.
Ora muori!” E dicendo questo lo trasse, fra i tremiti,
che scivolava nel molto sangue del figlio, agli altari
stessi, afferrò di sinistra i capelli, e di destra la spada
prese corrusca, e la immerse a lui, fino all’elsa, nel fianco.
Virgilio, Eneide II, vv. 634- 650
Ma quando ormai sono giunto alle soglie
della casa paterna, alle nostre antiche dimore,
il mio genitore, che io desideravo di trarre per primo
verso le alte montagne e per primo cercavo, si rifiuta
di prolungare la sua vita dopo l’eccidio di Troia,
soffrendo l’esilio. “Voi, cui rimane integro per la vostra età
il sangue – disse – e intere nel loro vigore le forze,
voi affrettate la fuga. A me se gli abitatori del cielo
avessero voluto prolungare la vita, mi avrebbero conservato
questa sede. Basta, ed è troppo, aver assistito insieme
a un eccidio ed essere sopravvissuti all’assedio della città.
Così, oh così qual è adagiato date l’addio al mio corpo e partite.
Per me la mano della morte troverò: sarà pietoso il nemico
per l’avidità delle spoglie. Facile rinuncia quella del sepolcro.
Già da tempo malvisto dagli dèi, in inutili anni mi attardo,
da quando il Padre degli dèi ma re degli uomini mi sfiorò
col suo soffio folgorante e mi toccò col suo fuoco”.
Così persisteva a ripetere, irremovibile.
Mimnermo, frg 1 W
E quale vita, e quale gioia senza l'aurea Afrodite?
Vorrei essere morto quando a me non più questo importi,
l'amore clandestino e i dolci doni e il giaciglio,
che di giovinezza sono i fiori fuggevoli
per uomini e per donne; quando invece dolorosa sopraggiunge
la vecchiaia, che brutto e spregevole insieme rende l'uomo
sempre nell'animo tristi lo tormentano inquietudini,
né si rallegra al vedere i raggi del sole,
ma (è) inviso ai bambini e disprezzato dalle donne;
così dolorosa il dio ha fatto la vecchiaia!
Virgilio, Eneide II, vv. 675-678
“Se per morire te ne vai, anche noi porta via, a qualunque sorte,
con te; se invece per esperienza avuta qualche speranza poni
nelle armi indossate, questa dimora innanzitutto proteggi.
A chi il piccolo Iulo, a chi il padre e me, la sposa che
un tempo ero detta tua, vuoi lasciare?”
Virgilio, Eneide II, vv. 707 – 720.
“Dunque agisci, o caro padre, poniti sulla mia nuca;
io stesso ti sosterrò con le mie spalle e questa fatica
non mi sarà grave. Qualunque sarà la conclusione
di questi eventi, uno solo e comune il pericolo, una sola
per entrambi sarà la salvezza. Il piccolo Iulo mi sia compagno,
e da lontano segua le nostre orme la sposa. Voi, servitori,
attenti a capire ciò che dirò. C'è all’uscita della città un poggio
con un antico tempio di Cerere, abbandonato, e vicino un vecchio
cipresso dalla religiosità dei nostri padri venerato per molti anni.
Là da diverse vie ci riuniremo, là solo. Tu, genitore, prendi nella
tua mano gli oggetti sacri e i patri penati; per me, da così grande
guerra appena uscito e da un massacro recente, toccarli sarebbe
sacrilego, prima che nella viva corrente di un fiume mi sia lavato”.
Virgilio, Eneide IV, vv. 1-5
At regina gravi iamdudum saucia cura
vulnus alit venis et caeco carpitur igni.
multa viri virtus animo multusque recursat
gentis honos; haerent infixi pectore vultus
verbaque nec placidam membris dat cura quietem.
Virgilio, Eneide IV, vv. 6-61
Virgilio, Eneide IV, vv. 160-172
Sparsi, nei campi, i gruppi dei Tiri e i giovani tèucri
E il nipote dardanio di Venere vari rifugi
cercano per il timore. Rovinano fiumi dai monti.
A una medesima grotta Didone e il capo troiano giungono.
E per prima la Terra e Giunone, da pronuba,
danno il segnale: rifulsero folgori e l'ètere conscio
delle nozze, e dal sommo dei picchi le Ninfe ulularono
Quello fu il primo giorno di morte, il primo e la causa
po dei mali; infatti non bada a apparenze o a possibile fama,
né piú immagina ormai, Didone, un amore furtivo;
lo chiama unione nuziale, velando col nome la colpa.
Virgilio, Eneide IV, vv. 296-330
Ma la regina (chi potrebbe ingannare un amante?) presentì, per prima apprese gli avvenimenti
futuri temendo di tutto quello di cui era certa. La stessa empia Fama riportò a lei che era già
invasa dalla furia della follia,che veniva preparata la flotta e ci si apprestava alla partenza.
Priva di sé e furente, vaga correndo invasata per la città, come Tira evocata dai riti sacri,
quando, ascoltato Bacco, la eccitano le orge triennali e di notte il Citerone la chiama con il
frastuono. infine di sua iniziativa si rivolge ad Enea gridando così: “Hai sperato, o perfido, di
poter dissimulare una tale infamia, e senza dir nulla di allontanarti dalla mia terra? non ti
trattengono il nostro amore, né la mano che un giorno mi hai dato né Didone destinata ad una
morte crudele? Anzi, anche in inverno allestisci la flotta e ti affretti ad andare al largo in
mezzo agli Aquiloni, o crudele? E che? Se non cercassi terre straniere e dimore ignote e
rimanesse in piedi l’antica Troia, torneresti a Troia per il mare tempestoso? Ti allontani da
me? Ti prego per queste lacrime, per la tua promessa data, (poiché io stessa non lasciai
null’altro a me misera), per il nostro connubio, per i responsali che abbiamo iniziato, se ho
avuto qualche merito di te, se qualcosa di me ti è stato dolce, ti prego di abitare questa casa
che crolla e abbandona questa decisione se c’è ancora una possibilità per le mie preghiere.
Per te mi odiano i popoli libici e i tiranni dei Numidi, gli abitanti di Tiro mi sono ostili;
sempre per causa tua è venuto meno il pudore e la stima che avevo prima, solo per la quale
venivo elevata alle stelle. A chi mi abbandoni, ospite, solo questo nome da marito mi resta?
Perché indugio? Forse finché il fratello Pigmalione distrugga le mie mura o il gaetulo Iarba
mi faccia prigioniera? Se avessi avuto prole natami da te prima della partenza, se un piccolo
Enea giocasse con me/mi illudesse nella reggia, che nel volto mi richiamasse a te, allora non
mi vedrei dl tutto sorpresa e abbandonata.”
Virgilio, Eneide IV, v. 331-362
Così aveva parlato. Egli teneva i comandi immobili sui comandi di Giove e sforzandosi
premeva il dolore dentro il cuore. Infine dice queste poche cose: “Io non negherò, o regina,
che hai meriti, i maggiori che sei in grado di enumerare parlando, e non mi rincrescerà
ricordare Elissa, finché penserò a me stesso, finché il soffio vitale reggerà queste membra. Di
ciò parlerò poco. Non speravo di nascondere la fuga come un ladro, non credere, e non di
portare le fiaccole nuziali né ho mai stretto un simile patto. Se i fati permettessero di condurre
un’esistenza secondo i miei desideri e di governare a mio piacimento gli affanni, innanzitutto
abiterei la città di Troia e sarei presso le mie dolci reliquie, la reggia alta di Priamo sarebbe
ancora in piedi e con le mie mani avrei ricostruito per i vinti la rocca di Pergamo caduta due
volte. Ma ora Apollo grigneo e gli oracoli della Licia mi hanno ordinato di raggiungere;
questo è amore, questa è la mia patria. Se la rocca di Cartagine e la vista di una città libica
trattiene te che sei fenicia, quale invidia c’è per te che i teucri vadano a stabilirsi in terra
d’Ausonia (Italia)? Anche a noi è lecito cercare regni stranieri. Ogni volta che la notte copre
la terra con le sue umide ombre e ogni volta che sorgono gli astri infuocati il fantasma del
padre Anchise mi terrorizza e ammonisce in sogno; mi ammonisce anche il piccolo Ascanio e
l’offesa che reco al suo caro corpo, che defraudo del regno d’Esperia (Italia) e dei campi
fatali. Adesso lo stesso messaggero degli dei mandato dallo stesso Giove, lo giuro sul capo di
entrambi, mi porta ordini per l’aria veloce; io stesso vidi il dio in un chiarore lucente
penetrare nelle mura e io ne accolsi con questi orecchi la voce. Smetti di inasprire me e te con
i tuoi lamenti, cerco l’Italia non di mia volontà.”
DISPERAZIONE DELLA REGINA DIDONE Lei avversa guarda ostilmente lui che dice
queste cose ormai girando gli occhi di qua e di là e il suo sguardo vaga con gli occhi muti e,
infuocata, scoppia così a parlare: “Non ti fu madre una dea, né Dardano capostipite, o
perfido, ma ti ha generato l’orrido Caucaso dalle irte rocce e le tigri ircane (di Lucania) ti
hanno porto le loro mammelle (nutrito). Infatti perché fingere riservarmi ad ulteriori oltraggi?
Sei forse intenerito per il nostro pianto? Forse che mi ha guardato negli occhi? Forse che,
vinto, ha versato una lacrima o ha avuto pietà della sua amante? Cosa posso aspettarmi di
peggio? Ormai né la grande Giunone né il padre Saturno possono guardare qui con occhi
equi. La fedeltà non è più garantita: l’ho accolto buttato sulla riva e bisognoso di tutto e da
pazza gli ho dato parte del mio regno, gli ho salvato la flotta distrutta, ho sottratto i suoi
compagni dalla morte. Ah! Sono infiammata e trascinata dalle furie! Ora Apollo augure, ora i
responsi della Licia, ora il messaggero degli dei mandato dallo stesso Giove porta per l’aria i
comandi. Certamente questa è l’azione degli dei, la sollecitudine muove chi era fermo. Non ti
trattengo e non ti propongo altre
Potrebbero piacerti anche
- Traduzione Eneide Libro 4Documento16 pagineTraduzione Eneide Libro 4Laura AversaNessuna valutazione finora
- Cuore Deroe La Storia Di EneaDocumento110 pagineCuore Deroe La Storia Di EneaMyderizi ArtanNessuna valutazione finora
- Eneide III DefDocumento8 pagineEneide III DefSara CastelliNessuna valutazione finora
- Tutte le tragedie: Persiani, Sette contro Tebe, Supplici, Prometeo incatenato, Agamennone, Coefore, EumenidiDa EverandTutte le tragedie: Persiani, Sette contro Tebe, Supplici, Prometeo incatenato, Agamennone, Coefore, EumenidiNessuna valutazione finora
- Parafrasi EneideDocumento15 pagineParafrasi EneideMichele Guerrisi0% (1)
- Parafrasi EneideDocumento2 pagineParafrasi EneideSilvia NotiNessuna valutazione finora
- L'ombra del viandante: Elegia in memoria di Ceccardo Roccatagliata-CeccardiDa EverandL'ombra del viandante: Elegia in memoria di Ceccardo Roccatagliata-CeccardiNessuna valutazione finora
- 25 Inganno CavalloDocumento8 pagine25 Inganno CavalloGeorge OcneanuNessuna valutazione finora
- Testi VirgilioDocumento5 pagineTesti VirgilioFederica BossiNessuna valutazione finora
- Libro 4 Dell'EneideDocumento20 pagineLibro 4 Dell'EneideFrancesco De FilippiNessuna valutazione finora
- MeropeDocumento38 pagineMeropegiangi57Nessuna valutazione finora
- Euripide - TroianeDocumento25 pagineEuripide - TroianemaurocalifanoNessuna valutazione finora
- OdisseaDocumento301 pagineOdisseamanuel08.03.2008Nessuna valutazione finora
- Chioma Di Berenice - CallimacoDocumento7 pagineChioma Di Berenice - CallimacoMarika GalluccioNessuna valutazione finora
- Ramous - Eneide - TraduzioneDocumento9 pagineRamous - Eneide - Traduzioneman_in_a_box_Nessuna valutazione finora
- Orestea: Edizione Integrale. Agamennone - Coefore - EumenidiDa EverandOrestea: Edizione Integrale. Agamennone - Coefore - EumenidiNessuna valutazione finora
- Le confessioni di fra Gualberto: storia del secolo XIVDa EverandLe confessioni di fra Gualberto: storia del secolo XIVNessuna valutazione finora
- Riassunto Eneide Libri I-IVDocumento7 pagineRiassunto Eneide Libri I-IVFrancesco SaviozziNessuna valutazione finora
- EneideDocumento5 pagineEneideGiuseppe AlloccaNessuna valutazione finora
- EneideDocumento19 pagineEneideLuigi MarzoNessuna valutazione finora
- Proemio Dell'EneideDocumento1 paginaProemio Dell'EneideGiulia AllegriNessuna valutazione finora
- Pindaro - OlimpicheDocumento25 paginePindaro - OlimpichemaurocalifanoNessuna valutazione finora
- Odissea - Libro XIII - WikisourceDocumento12 pagineOdissea - Libro XIII - WikisourceSalvatore BellaviaNessuna valutazione finora
- Proemio Eneide - Spinnato Luca Faienza Gabriele 1Documento8 pagineProemio Eneide - Spinnato Luca Faienza Gabriele 1Luca SpiturrNessuna valutazione finora
- Eneide IXDocumento3 pagineEneide IXmatteo libertiNessuna valutazione finora
- ENEDE Ita LatDocumento189 pagineENEDE Ita Latyap1112Nessuna valutazione finora
- L'Ombra Delle Parole Rivista Letteraria InternazionaleDocumento14 pagineL'Ombra Delle Parole Rivista Letteraria InternazionaleTomasoNessuna valutazione finora
- Il SonettoDocumento5 pagineIl SonettoOana GeorgianaNessuna valutazione finora
- AlcmaneDocumento6 pagineAlcmaneApollo Sassy FeboNessuna valutazione finora
- Ho Sceso Dandoti Il BraccioDocumento6 pagineHo Sceso Dandoti Il BraccioSerena PrestinariNessuna valutazione finora
- ElementidiprosodiaeretoricaDISPENSALett IngleseiDocumento11 pagineElementidiprosodiaeretoricaDISPENSALett IngleseiSimone CavalloNessuna valutazione finora
- Campioni, Giuliano - Nietzsche. La Morale Dell'eroe (LDB) PDFDocumento158 pagineCampioni, Giuliano - Nietzsche. La Morale Dell'eroe (LDB) PDFMassimo Stella100% (1)
- Matteo Maria BoiardoDocumento2 pagineMatteo Maria BoiardoArabela MateescuNessuna valutazione finora
- 7° LezioneDocumento11 pagine7° LezionesunshineNessuna valutazione finora
- Eneide by Virgilio EdiscoDocumento605 pagineEneide by Virgilio EdiscoBeatrice Vacchi100% (1)
- Mu Allaqa Imru L-QaysDocumento8 pagineMu Allaqa Imru L-Qayszzz222222Nessuna valutazione finora
- Canto A Tenore - MadauDocumento114 pagineCanto A Tenore - MadauextravalgoNessuna valutazione finora
- Riepilogo Grammaticale - I Modi IndefinitiDocumento6 pagineRiepilogo Grammaticale - I Modi IndefinitiCristina MansillaNessuna valutazione finora
- Sodoma PDFDocumento19 pagineSodoma PDFnicodfNessuna valutazione finora
- Il Imito Come Strumento Di Scrittura Contemporanea Nei Romanzi Di Alain NadaudDocumento0 pagineIl Imito Come Strumento Di Scrittura Contemporanea Nei Romanzi Di Alain NadaudAngelNessuna valutazione finora
- WWW - Italianisticabl.eu - MaterialiDidatticiRob - Italijanska Književnost - 5 PDFDocumento2 pagineWWW - Italianisticabl.eu - MaterialiDidatticiRob - Italijanska Književnost - 5 PDFPedja SmajliNessuna valutazione finora
- Dolce Stil NovoDocumento17 pagineDolce Stil NovoGuillermoNessuna valutazione finora
- Agropoli Settembre Culturale 2011Documento25 pagineAgropoli Settembre Culturale 2011CilentoNotizie.itNessuna valutazione finora
- Accenti in Italiano + EsercizioDocumento4 pagineAccenti in Italiano + Eserciziomariacrisci2024Nessuna valutazione finora
- Letterautori Verde Volume2 Manzoni 5 MaggioDocumento7 pagineLetterautori Verde Volume2 Manzoni 5 MaggioLisa ManobanNessuna valutazione finora
- Tutti in Cerchio - Coro Parlato - L1786816673Documento13 pagineTutti in Cerchio - Coro Parlato - L1786816673Francesco VitaliNessuna valutazione finora
- Estratto MelanconiaDocumento16 pagineEstratto MelanconiaLaura Antonella PirasNessuna valutazione finora
- OmaggioaEzraPound Fabio Lamenti PDFDocumento101 pagineOmaggioaEzraPound Fabio Lamenti PDFAnonymous o0Eh6IzNessuna valutazione finora
- ElymiotiDocumento337 pagineElymiotiIacopo FontanaNessuna valutazione finora
- 4205416-Deutschlandlied Horst Wessel LiedDocumento2 pagine4205416-Deutschlandlied Horst Wessel LiedGeraldNessuna valutazione finora
- Discorso Intorno Alla Nostra LinguaDocumento21 pagineDiscorso Intorno Alla Nostra LinguaDiana BiaginiNessuna valutazione finora
- Antoniel - 2012 - Il Concetto Di Metafora in Black, Ricoeur e BlumenbergDocumento55 pagineAntoniel - 2012 - Il Concetto Di Metafora in Black, Ricoeur e BlumenbergceprunNessuna valutazione finora
- HeidiDocumento6 pagineHeidipizzaNessuna valutazione finora
- Sguardo Antropologico e Cinema Di Poesia Di PasoliniDocumento6 pagineSguardo Antropologico e Cinema Di Poesia Di PasolinipillamNessuna valutazione finora
- Petrarca NovecentoDocumento18 paginePetrarca NovecentoVeraNessuna valutazione finora
- Che Cosa Erano Il Volgare e Il Latino PDocumento32 pagineChe Cosa Erano Il Volgare e Il Latino PGaetano Previtera100% (1)