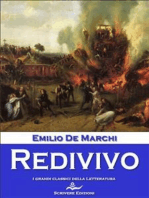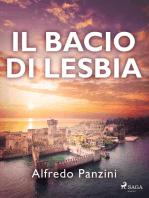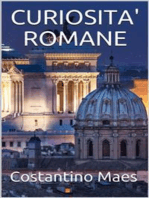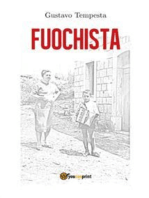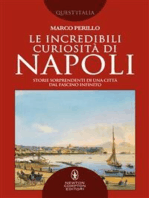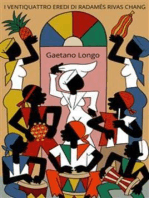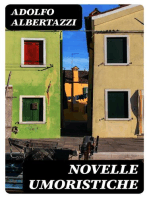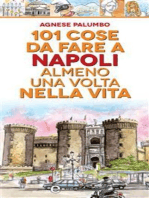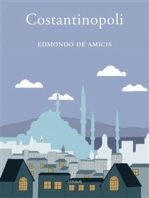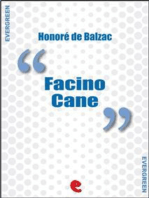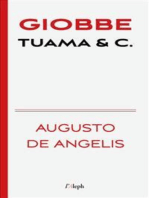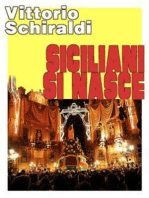Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Alberto Arbasino - Pensieri Selvaggi A Buenos Aires
Caricato da
Emilio0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
3 visualizzazioni99 pagineTitolo originale
Alberto Arbasino - Pensieri selvaggi a Buenos Aires
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
3 visualizzazioni99 pagineAlberto Arbasino - Pensieri Selvaggi A Buenos Aires
Caricato da
EmilioCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 99
GLI ADELPHI 418
Alberto Arbasino
PENSIERI SELVAGGI A BUENOS AIRES
© 2012 Adelphi edizioni spa Milano
www.adelphi.it
ISBN 978—88—459—2726—3
In copertina: Evita durante il suo viaggio in Europa nel 1947
© INIHEP–MUSEO EVITA
Presentazione
Tristi Tropici di Claude Lévi–Strauss raccontava
esplorazioni e scoperte — alla ricerca del ‘pensiero
selvaggio’ fra le tribù primitive e meste nel più profondo
Brasile. Contrapposte ai beati lussi nelle ricche metropoli
del dopoguerra, Buenos Aires e Rio de Janeiro, meta
agognatissima per generazioni di emigranti nostrani: «Dagli
Appennini e dalle Alpi alle Ande». I fasti argentini e
brasiliani abbagliarono la povera Italia affamata e distrutta,
fino al trionfo nella tournée europea della ‘presidenta’ Evita
Perón, bella giovane e brava attrice, con una memorabile
visita elegante e populista in Vaticano, e sostanziosi doni a
Pio XII. Ne derivò poi il successo planetario del musical
Evita. Frattanto, i libri di Lévi–Strauss diventavano classici
fondamentali nella voga strutturalista. Si tradussero le
opere di jorge Luis Borges, e anche lui venne a Roma, al
culmine della popolarità. E poi, tutta un’ondata di eccellente
narrativa latino–americana. Ma l’economia di quei paesi
andò incontro a crisi gravissime; e le racconta appunto
questo viaggio di rivisitazioni in Argentina, Brasile, Uruguay,
Perù. Dove tuttavia non mancheranno sorprese: il complesso
di Santa Rosa da Lima, ad esempio, si rivela «un caro nido di
memorie per gli antichi cultori delle più mitiche Sante
secondo quella leggendaria Compagnia D’Origlia–Palmi, o
Paolo Poli. Qui tutto par rivivere, intatto. Ah, quegli
indimenticati “Scignore scialvami, la carne è debbole!” di
Santa Rita, mentre Satana la tentava sotto forma di
fantasma dell'Amleto, ringhiando…».
Pensieri selvaggi a Buenos Aires
… Buenos Aires!… Montevideo!… Rio de Janeiro!… Sào
Paulo!… Lima!… Perù!… Iguazul!.
Giacché antico lettore e fan di Tristes Tropiques, il
centenario nel 2008 del “nacimiento” di Claude Lévi–
Strauss, “voyageur nostalgique”, mi sospinse a un vasto giro
estivo (e dunque là invernale, full season) nelle metropoli
dell’America Latina. Spesso, dunque, una rivisitazione. E
non già fra quelle tribù tropicali interne, che si possono
immaginare tuttora assai meste. (Altro che “malinconiosa
carne — dove una volta pullulò la gioia").
Ma proprio nelle stesse grandi capitali che traboccavano
di joie de vivre e di ricchezza, una volta. Ed esportavano
tutto un tripudio di luci e suoni e colori, lusso e voluttà,
antropologia culturale festosa e fastosa ed assai pittoresca,
basata sulle fortune svelte degli emigranti oltre che sugli
sfruttamenti amazzonici e andini.
Per noi bambini bastava anche poco, una volta. Bueno,
fuego, fuente, fuerte, puente, pueblo, puerto, puerta, la
vuelta buena.
Pochissimo o nada, bastava, per i piccini.
Pablo, Pablito, Pedro, Pedrito, Paco, Paquito e Paquita,
Benito, Rosita, Conchita, Carmencita, Pancho, Sancho, Rio
Rita. Caminito, pobrecito, cielito lindo… Evita!
E si era beati, da piccoli. Nomi come caramelle
Novecento: Arenal, Arsenal, Alcázar, Alcatraz, Amapola,
Pensacola, Capataz. Diablo. Retablo. Olé.
Saludos amigos, adiós muchachos, vamos a la playa,
compañeros, descamisados, descalzas, desnudas, barbudos,
guapas, gringos, niños, niñas, Mercedes, Dolores, Milagros,
Borges, Paraguayos, zarzuela, Consuelo, Piazzolla, Pilar,
Gardel, Trinidad, Soledad, Asunción, Concepción, corazón,
revolución, reacción, rebelión, represión, extenuación,
exteriorización, bodegón, salchichón, maricón, cospetón siór
parón… tan solo una canción…
… Hombre! Sangre! Dinero! Sombrero! Limón Limonero!
Bombero! Me muero! Te quiero! Todos caballeros! Toreador!
Mirador! Fundador! Parador! Guantanamera! Violetera!
Santander! Mercader! Escobar! Bolívar! Alvear! Miramar!
Minibar!
Quanti tanghi e fandanghi e consumazioni di sangria e
carioca e tequila con Django e Durango nei decenni
adolescenti, colmi di balere e boleri e bandoneón da
caballero stanco su un suo caballo bianco o bronco —
soprattutto in avanspettacoli “da bassa forza» di comiciattoli
sub–Macario o vice–Rascel con lazzi e scacazzi su patonze e
pecheronze e addante creola dalla bruna o turpe aureola…
Socchiudendo gli occhioni o gli occhietti, ai bei dì, fra tico–
tico e tuca–tuca e chupa–chupa e pago–pago in romantiche
rotonde sul mare con luna piena e ciff–ciaff d’ondate sulla
calda sabbia, e tutto un accompagnamento di maracas e
maracujas… Bésame mucho? …La pensée sauvage!
Tranquilli. Mantilla e cedilla. Eventualmente, seguidilla.
Hasta la vista, cuanto me gusta, mañana por la mañana,
Inti–Illimani, come coca boliviana son le donne dell’Avana,
ma a Copacabana la donna è regina, la donna è sovrana…
Come d’altronde a Ipanema… starring (ovviamente)
Irasema…
Calma.
Arriba y abajo. A las cinco de la tarde, la vida es sueño,
flores para los muertos, convidados de piedra, amado mió,
igualdad… No se puede, sin embargo, tampoco, también,
duende, llanto, cante hondo, corrida, movida, batucada,
calienta, pimienta, cabeza, fortaleza, fortín… Conga,
milonga, marimba, macumba, samba, caramba, carambola…
Alborada nueva? Adelante, adelante. El Relicario? Qué
garbo, qué rapto, qué éxtasis, qué écfrasis!
Un po’ per celia e un bel po’ sul serio, tra la raspa o la
salsa del Paraná, e qualche finca più o meno antigua piena
di popolari vecchietti non più “toreador en garde” e men
che meno “dragón d’Alcalá”, bensì alfine indignados di
neoavanguardia e neomutanderos postmoderni d’attualità…
Nella terza età!
Todos escandalizados y resentidos! Malcriados y
malhablados! Irriverentes, provocadores, transgresores y
provocantes! Claro? Maldonados? Malparados?
Malmandados? El Delicado… El Desdichado… El
Remendado…“Conga!”. (Rosalind Russell, Broadway, 1953).
Tutto un dopoguerra di sfrenati e spropositati gran lussi
rasserenanti e consolatori, sudamericani e coloratissimi:
Carmen Miranda, Katherine Dunham, Yma Sumac, Dolores
Del Rio, Dorothy Lamour, i leggendari “changement de
décor!” di Joséphine Baker, innumerevoli caratteristici
Peruviani e Uruguayani protagonisti sempre milionari e
vistosissimi e scatenati di operette e balletti e can–can da
Offenbach a Milhaud e Massine, Flying Down to Rio e Down
Argentine Way, con vistosi feticci d’ananas e banane da
Carnival in Costa Rica, tacchi e turbanti e baffetti nerissimi
e sarong e piumaggi sui sederi ‘en folie’ tra La Vie
Parisienne, Gaîté Parisienne, Ziegfeld Follies, Tropicana
Follies, le Folies Bergère, “Thank You South America”,
“Bahiana”, “Bandana Days”, “Minnie From Trinidad”,
l’epocale epopea di Evita Perón…
Ah, come facevano sognare le attualità cinematografiche
dei tardi anni Quaranta, col solenne e sontuoso ricevimento
in Vaticano della allora prestigiosissima Evita Perón in
perfetta toilette nera e soltanto l’Ordine di Isabella la
Cattolica (il più alto in Spagna) accanto alla figura
impeccabilmente ieratica di Pio XII con la nobiltà pontificia
in costumi di gran gala e nugoli di flabelli, e quella
indimenticabile benda nera all’occhio del principe
cerimoniere, giacché la presidenta argentina portava doni
alimentari cospicui dalle pampas e haciendas ai poveri
italiani affamati come in Sciuscià, Paisà, Ladri di biciclette.
E poco prima, con ampio gesto e gran signorilità panama
bianco, pizzetto berensoniano, abiti chiari da mezza
stagione — il Conte Sforza le additava il tramonto romano
dorato dalla Fiat scoperta, fatta opportunamente passare da
Ciampino per le magie e i sassi dell’Appia Antica, non certo
Nuova… E ancora prima, a Parigi, il Nunzio Roncalli la
accompagnava a Notre–Dame…
Guantini perfetti. Scarpine impeccabili. Signorilità a tutto
spiano. Quando non era ancora necessario citare un
calciatore o cantante locale per ingraziarsi le cronache…
Evita! Già le brevi attualità filmiche sulla sua celebrata
visita in Vaticano facevano sognare un grande musical sul
Duodecimo, con mirabili costumi bianchi e tanti flabelli di
piume e passerelle in sedia gestatoria e meravigliosi gesti
enigmatici in cima alle scale e sorrisi psichedelici durante le
visioni ultraterrene su “Oggi” fra gli agnellini nei
giardinetti…
E finalmente, la colossale processione funebre
culminante con la spettacolare esplosione notturna della
salma appena imbalsamata che sfonda tutti gli strati di
cellophane fra ecatombi di guardie svizzere che franano nel
tremendo odore invasivo per tutto San Pietro!
Tutto quel modestissimo dopoguerra — allora, invero —
albeggiava di esuberanti dovizie fra i grandi alberghi
romani. Quanta opulenza e allure nelle coppie miliardarie
argentine e brasiliane in lini bianchi e vaporosi volants
magnificamente stirati. Favolosi gioielli ostentati con
nonchalance anche in trattoria su puntarelle e rucole.
Sontuose cotonature a volute e cupole di vertiginose
madame. Bei signori alti e bruni con smisurate haciendas,
l’occhione accorato sotto le folte ciglia, i baffetti da
ambasciatore, e i ricciolini lucidissimi in fondo alla nuca, al
termine di ciocche nerissime cementate da gomine trendy
per gentlemen d’epoca…
Altro che quegli emiri e sceicchi molto più tardivi, povere
signore mie. O quei ‘codoni’ fluenti e sciolti sopra gli
arancioni fosforescenti dei successivi operatori stradali
“mondezzari chic”.
Dopo i benesseri, poi, «Hasta la vista siempre?».
Why not? Nuove lotte e marce praticamente continue e
generalmente di tendenza con tute e passamontagne e
giubbotti e jeans più o meno griffati e cartucciere e
mimetiche e desert boots di confine e frontiera e margine su
interminabili inesauribili sentieri di Ho Chi Minh, Phnom
Penh, Yucatán, Tucumán, Turkestan, Kurdistan, Kazakistan,
Astrakhan, Azerbaigian, Afghanistan, Pakistan, Iran,
Abadan, Abakan, Abidjan…
App… Sempiterna, scoraggiata, sempre più sconsolata
“tristeza tropical” (o addirittura “Continental”) non solo fra
quei primitivi Bororo e Nambikwara e Tupi–Kawahib così
deprimenti nei Tristes Tropiques di Lévi–Strauss?…
Anche nelle metropoli già mete agognatissime di tanti
poveri emigranti ai tempi ormai remoti di “Partono i
bastimenti” e «Santa Lucia luntana», con tanti bagagli di
nostalgie per casamenti casarecci…
… Mentre le più assortite e assordanti variabili
ideologiche spingevano i moderni migranti non troppo
nostalgici e famelici verso frontiere e provocazioni sempre
più impietose e scomode, lungo confini e margini
estremamente trasgressivi: un interminabile long drink di
trasgressioni conformisticamente corrette… Non più alla
moda giovane, però… Ormai, nemmeno quei bei
passamontagne e cappucci e sciarponi e guantoni
strapazzati e nostalgici, così comodi e pratici per gli agguati
e le guerriglie fra le viuzze e i vicoli delle città europee
invernali, con le relative foto, ma impensabili nei vasti spazi
e ‘campus’ dell’eterna estate californiana, tra le chitarre
hippie e le gonne spampanate dei Flower Children che
lungo le Prese di Coscienza nella Liberazione Sessuale
finirono per etichettare in ‘gender’ e specie i gai giovanotti
che specialmente in divisa facevano i ragazzotti senza badar
tanto alle identificazioni in qualche gruppo schedato e
archiviato nei cataloghi delle minoranze. Come quei
Nambikwara che spiegano a Lévi–Strauss: “Sono cugini e
cognati che fanno l’amore tra loro”.
Nidiate di vecchietti felici e fallici e «forever fuck you»
alle sfilate e alle manifestazioni e alle commemorazioni coi
loro antichi cuoi e anelli e catene dappertutto, così
controcorrente e irriverenti ai bei tempi…
Vecchi e giovani orsi truccati e abbigliati da Marilyn o
Marlene con bistri e parrucche o crestine verdi e viola…
… Scaricando marimbe e macumbe e tarante di ogni
tendenza e limite tra fiestas, mercados, bodegas, fazendas,
tende e brande interattive ‘in’ house, o lounge, o garage, o
rave, o rêve sostenibile… Contaminando e ibridando e
meticciando (o magari meriggiando?) matrix e remix e
rewind e replay e display con dj’s ethnic o multi–culti, post–
punk, hard–glam, metal, fusion, slogan, blog, must, cult,
cool…
Tristes Tropiques tempestivamente apparve come una
romantica avventura autobiografica, piena di scoperte
esotiche e indicazioni utilissime (quei Tropici sono
effettivamente tristissimi) soprattutto nell’euforica «Vie
Parisienne» strutturalista e semiotica degli anni fra
Cinquanta e Sessanta. Fasi di ghiotti entusiasmi dotti o
guitti, nella transizione post–esistenziale fra Bretón, Bataille,
Bérard, Buffet, Barthes, Brecht, il vecchio Picasso, i nuovi
‘op’ e ‘pop’, Lola Montez di Ophùls e A bout de soufflé di
Godard, Saussure e Clouzot e Brigitte Bardot e Juliette
Gréco e appunto Lévi—Strauss… Eccitazioni generali
smaccate o sorgive per qualunque sistema di segni, icone,
simboli, indici, totem, tabù, testi, campi, codici, semiosi,
segreti, marche, griffe, misteri, tatuaggi preferibilmente
occulti e iniziatici… «Kill that metaphor!» ingiungeva
inutilmente una rubrichetta apposita sul «New Yorker».
E H.M. Enzensberger storicizzò, in Mausoleum: “La sua
prima sortita, la sua prima fuga nella realtà: Tristi Tropici.
Ma i lebbrosi sotto la decrepita veranda lungo il Rio delle
Amazzoni non capivano ciò che diceva, e continuavano a
morire”. (A proposito del ‘Che’ Guevara, 1975).
In giro, tutto un tralalà o vol–au–vent metropolitano di
ceramiche e porcellane e maioliche misteriosofiche, vasi e
vasetti con beccucci criptici, sculture lignee
parapsicologiche, fibrille sciamaniche, gioiellini esoterici,
archi e dardi e astucci penici finemente zoomorfi e volentieri
ermetici da appendere sulle pareti di ogni studio
surrealistico e primitivistico sulle pendici di Montmartre, fra
maschere enigmatiche ed ermetiche acconciature con
onerosi graffiti facciali e corporali da fissare on thè spot
prima di ogni potlatch di chincaglierie e piume in testa e
penne e pennarelli e modelli di piercing in ogni area del
volto e dello scroto… Disseminazioni e decostruzioni con
tensioni e fermenti di culto locale e tribale, ostentatamente
‘vanitas’ e ‘dépense’ da sfoggiare al Casino de Paris o al
Palais de Chaillot o nelle più esclusive toilettes delle Grandi
Scuole di élite e di griffe.
“Mythèmes”, si sorrideva volentieri, durante la moda
strutturalistica, quando ci si compiaceva di ridurre a un solo
organismo di soddisfazione o alienazione convenzionale
sistemica tanti o tutti i miti e riti e vestiti e bolliti e canditi e
pantriti anche se un po’ troppo triti o sdati, coi loro prototipi,
archetipi, stereotipi, fra codici e termini e gerghi e lessici…
Burlador, campeador, goleador, defensor, redentor,
soñador, rubacuor, ora fra i ninnoli e i balocchi e i nuovi culti
delle nuove culture e della nouvelle critique: rotture formali,
transazioni verbali, densità grammaticali, concisioni e
contrazioni, ideologismi e sillogismi anche eversivi,
suggestive parafrasi e metastasi tra il Dono selvatico dei
nativi e il Tombeau poetico per lirici simbolisti… E le favorite
opposizioni tra Natura e Cultura, caldo e freddo, crudo e
cotto, duro e molle, grande e piccolo, frigo e forno, zucchero
e caffè, macchiato o no, e anche contrasti e incongruenze
fra parentadi tradizionali, unioni libere e belle, sessi più o
meno riscaldati o tiepidi, tabù costanti o variabili circa il “si
fa ma non si dice” nelle società più aperte o chiuse,
disciplinate da forme, pregiudizi, spontaneità, consuetudini,
regole, segreti delle alcove (o dei guanciali, dei lenzuoli,
delle trapunte, delle federe, delle fodere) lungo le sempre
meno ‘sfiziose’ vie della Seta, delle Spezie, della Mirra…
Ah, pensare per ossimori paradossali, frammenti
dissacranti di performance tragica, densità spontanee,
smarrimenti ontologici, incertezze e balbuzie apodittiche,
ierofantiche…
… Esprimersi mediante paratassi disarmoniche, aforismi
di contro–retorica, filosofia in T–shirt sull’invenzione della
melodia quale supremo mistero dell’uomo e sulle
significanze della linea retta in contesti storicamente
barocchi…
… Livelli…
Alto? Di élite, ovviamente.
Basso? Di massa, claro.
Midcult? Di consumo borghese e piccolo–borghese, ga va
sans dire, of course. Ma fino a quando?
Insomma, ci si era abbastanza preparati, in teoria, prima
di sbarcare o approdare nella Buenos Aires di Borges e di
Evita, nella Montevideo di Lautréamont, nel Brasile più o
meno ‘magato’ e cioè fatato o stregato, nel Perù dei viceré e
di Santa Rosa da Lima, da non confondere con l’omonima di
Viterbo, e coi suoi cento ‘facchini’ che ogni 3 settembre
portano in processione una ‘macchina’ di 50 quintali e 28
metri d’altezza.
Palme tropicali e palme accademiche, feluche e peluches,
potiches, babbucce, fettucce, feticci, fornelli a legna sotto i
baobab creativi. O «chez Salvatore’s». Pizze, tortillas.
Zattere e zatteroni e jeep, infradito e amuleti di
modernariato improvvisamente costosissimi, anelli al naso e
all’uccello come emblemi di status e sprezzatura portatile. E
pregiate decorazioni: un ‘ruban’ pour le chevalier, une
‘rosette’ pour Vofficier… Et pour le commandeur? Une
‘rosette sur canapé’! (Anche ai Tristi Tropici vige la rosette e
sono Immortels, les Académiciens?). Volentieri, in quelle
ormai remote beate epoche, si assisteva a tutto un eccitante
sbocciare e sgorgare e scaturire di alternative e opposizioni
e contraddizioni per lo più tremendissime, in seno a chissà
quante convergenze o connivenze o divergenze della
peggiore specie, tra complicità e correità, contaminazioni
controverse, false o simulate analogie…
Connotazioni e denotazioni croniche, sincronie e sinergie
o diacronie e discronie cicliche… Soggetti/oggetti fra natura
e cultura in esterni/interni crudi o bolliti o arrostiti secondo
la stagione, al dente o al sale o à la coque nelle società
primitive come negli alti studi e anche al restaurant…
Tutto un in–and–out di crudités e stracotti, sul menu,
quindi, con gelatine e galantine, sformati e stufati, salamini
e salatini, surgelati e soufflés, nonché tipiche vivande
amazzoniche: coda di caimano alla griglia, colibrì e
pappagallo arrostiti e flambés al whisky, salmi e arrosti di
uccello–cane con frutti di palma, ragù di tacchino con salsa
untuosa di noci tritate; e una sostanza biancastra e
grassoccia, delicata come un burro profumato di latte di
cocco, forse un’escrescenza di larve dai tronchi putrescenti,
in un diffuso odore di tisana calda al cioccolato… Ah, laggiù
nell’Amazzonia… Terra di sogni e di chimere…
Rammento — oh, se rammento — quei primi anni
Sessanta… Con vero interesse, nelle varie città, il pubblico
non solo torinese dell’Associazione Culturale Italiana delle
sorelle Antonetto commentava i grafici di Lévi–Strauss sulla
struttura sociale apparente e quella reale nei villaggi
Bororo, che mostravo in ogni ‘lectio’. Istituzioni tribali fallaci
per sudditi–vittime inconsapevoli: apparentemente, una
comunità paritaria giacché circolare e assembleare. Ma in
realtà, tre gruppi sociali (superiore, medio, inferiore) ove le
relazioni sociali si riproducono all’interno di ogni clan. Mi
parevano tavole utili per illustrare le strutture della nostra
società letteraria: si era appena entrati nel postneorealismo.
Ma già gli abbonati dell’A.C.I. osservavano che quei grafici
ricavati nel più primordiale Mato Grosso si potevano bene
applicare alla società italiana nel suo complesso. Non
pareva una singolare scoperta. Intanto, oltre ad Artaud e ai
suoi primitivi, stava arrivando Borges con fior di labirinti
fantastici; e poi tutta la grande ondata sudamericana.
Dunque, tutti: Porto Alegre! Belo Horizonte!
Meticciati anche assai trasgressivi, e digressivi, invero,
con tanti migranti multi–culti tra confini e frontiere da
abbattere. Mitemi e rituali sempre più impietosi e più
scomodi. Mancanze di rispetto sistematiche. Irriverenze
arrampicatrici e carrieristiche, provocazioni teppistiche e
dissacrazioni vandaliche, anarchie e anamorfosi
metropolitane, libere associazioni creative soprattutto nei
rackets…
In jeans Levi Strauss, oltre tutto: quel ‘501’ con vita alta e
culetti strettissimi, alla moda quando si era tutti più magri e
più snelli. (Anche avendo mangiato poco, durante la guerra
e in seguito). Modellavano chiappe ‘giuste’, col taglio
calzante, anche a chi non le possedeva per natura o cultura.
E un lusinghiero ‘pacco’ sul davanti, sotto addominali
ancora piatti, come le calzemaglie nelle pitture
rinascimentali: mentre la più occhiuta Antropologia
Strutturale e una Pensée Sauvage anche più occhialuta
servivano a fornire bagagli intellettuali in più, a livelli di
borghesie di massa sempre più su, o più giù. Mode giovani,
intanto, variabili ideologiche sempre più assortite e
assordanti, aggiornate migrazioni verso confini e margini
sempre più trasgressivi ed esclusivi: un bel frullato
omologato di provocazioni controcorrente ma
conformisticamente ok… Tutto a posto! Musiche e canti di
rivolta, sommossa, ammutinamento, insurrezione,
contestazione consensuale…
E i piccoli fans ideologici, gettandosi a frotte su
qualunque pretesto di fil rouge con tavole rotonde e
convegni e dibattiti: ah, ipotizzare un qualche progetto o
prospetto di struttura teorica secondo un’ottica non già
asfittica e labirintica e magari eclettica, giacché pluralistica.
Ma sempre e ovunque progressista: non meramente
globale, benché assai multiculturale.
Con particolare riguardo alle varie etnie, genie, allogenie,
allopatie, allergie. Naturalmente, politically correct. Gente
che va, gente che viene, come in ogni Grand o Piccolo Hotel?
'Fashion' e 'fusion' già notevolmente contaminate e
meticciate fra i Nambikwara di Lévi–Strauss e i Tarahumara
di Antonin Artaud. Gaie epifanie mistiche e multimediali
meditazioni erotiche di antiche 'divine' effervescenti uso
Tropicana Follies anche indoorientali e occiduo–
sciamaniche, fra Bataille, Balthus, la dea Kalì, qualche
Kamasutra a Katmandu. Vasti 'chàteaux' in Spagna o
Baviera, 'peyotl', allucinazioni, abbagli, miraggi accademici
o 'live' di frontiere e confini volanti da contaminare su
balconi come trampolini a un terzo o quarto piano… Dopo
ricette di funghi e funghetti, radici e tuberi inediti, e magari
un dash di rizomi populistici, alla portata di tutti…
Giù sul territorio, fra i leggendari festival in New Mexico,
a Santa Fe e dintorni ci si andava chiedendo quale drink
all'Artaud avesse mai sorseggiato la baronessa vedova
germanica di D.H. Lawrence, quando obliò sul trenino l'urna
con le ceneri del consorte, portata dalla Francia meridionale
col nuovo compagno bersagliere Angiolino appositamente
per inumarla in un cimiterino naif e non ancora turistico a
Taos fra i pueblos. «E Lawrence d'Arabia, con quel notorio
accidente a Deraa?».
«Ignoranti. Finitela».
Però, tuttora, quella perenne melanconia gravante non
solo tra i primordiali Nambikwara e Tupi–Kawahib già
depressivi nei Tristes Tropiques, con tutti quei loro sistemi
di segni e segreti, fenomeni fisici o simbolici, emblemi o
blasoni poco leggibili e non molto piacevoli… Scarsi
buonumori, e probabilmente troppa fatica, anche al favoloso
paese dei Tarahumara secondo Artaud, quando le stesse
sostanze iniziatiche ormai si spacciano senza cerimonie e
birignao in ogni crocicchio. Basta pagare cash. E quella sua
favoleggiata Bali, in pochi decenni, eccola diventata un
ricovero per vecchi hippies; e poi, tutta un autonoleggio con
lavaggio. In quanto all’erotismo, del resto, eccolo ridotto a
non molte migliaia di pagine di Georges Bataille su zombi e
vudu e tatuaggi e Sante Terese e graffiti rupestri, senza
neanche un backroom teorico nrf. Che tristezze? Di massa?
Purtroppo, anche nelle megalopoli già meta agognata (e qui
Rascel interrompeva: “la cognata”) di tanti emigranti, e poi
di mondanucci attratti da mojito e merengue a basso prezzo.
Cheap (una volta), ogni dono e baratto o acquisto di
‘coloniali’… E non solo fra le ottocentesche signore
droghiere che in cattedra o pulpito e nero lungo e brillanti e
perle ripetono con trillo argentino alla cassa le pesature dei
vari commessi in camice chiaro, “mezz’etto di spezie, un etto
di aromi, una presa–omaggio d’oppio e dragoncello”… E le
mentalità primitive degli indigeni più o meno ‘decolonizzati’
e ‘civilizzati’ o ‘selvaggi’ nei rapporti più o meno storici o
moderni o eccentrici fra l’uomo e la natura e la cultura e la
società e l’ambiente sostenibile… E ancora il fardello esotico
dei vari eccitanti o antipatici interdetti circa la
masturbazione single o l’omosessualità collegiale o il
sacrilegio intellettuale o l’incesto spirituale o l’ateismo
confidenziale, esistenziale, professionale, o recondito, o più
o meno in estrinseco…
… Mentre già l’esistenzialismo svoltava nello
strutturalismo, lasciandosi indietro le infinite formichine
della ‘longue durée’…
“Comprendre” coloniali, artifizi, analisi, linguistica
generale, semiotica, peyotl. Geometrie e strutture storiche e
descrittive, con incensi e dosi e chiodini di garofano e voli
dal balcone come offerte e simboli, fra interdetti e
intermezzi di sviluppo o decrescita, violenze e voluttà
statiche o effimere. Sincronie e/o diacronie ove si agitano e
sbattono memorie lontane di donazioni infantili di stagnole e
francobolli gelosamente accumulati da anni per missionari
che invece di redimere i morettini poi finivano cucinati in
pentoloni da allegri indigeni tipo Douanier Rousseau, per la
gioia dei bimbi cresciuti coi programmi radio di Nizza and
Morbelli.
E macché hully gully, hula hula, hula hoop per farsi
benvolere dai colonizzati o colonizzandi… Anche con Artaud
e la Crudeltà, nel Duemila, non si può né si deve esagerare
tra le fiere o esposizioni coloniali che nemmeno esistono
più?
Ma in quei tristissimi Tropici di Lévi–Strauss soprattutto
impressionano certe analogie underground con la
suggestiva prosa onirica di Freud. Affine perizia
nell’attrarre il lettore anche accidentale entro i melanconici
recessi dell’Inconscio, primordiale o no. Poi, lì, a seconda
degli Istituti, mesti e mogi tabù istintuali di passaggio fra
una Natura di meno o più nobili selvaggi primitivisti e una
sofisticata Cultura accademica di cattedratici logocentrici
magari omologhi circa le strutture e i funzionamenti di un
Immaginario forse ereditario. Tra infrazioni e immagini
indubbiamente impresse, non senza lasciti, e non sempre
alla portata dei più qualificati esperti ed interpreti. Ḉa
arrive….»
In quei Tropici, forse una ineguaglianza fra i sessi come
nelle rivoluzioni arabe e nei campionati di calcio? Miti e
modi e mode e anche parecchio McLuhan, nelle culture à la
belle étoile o alla brace, come nelle poco puntuali relative
dialettiche fra ‘media’ d’arte più o meno varia?
Diversità screanzate o affinità impertinenti, per colpa di
qualche psicanalisi selvaggia analoga a volgari esorcismi di
sciamani cafoni?
Disseminazioni diligenti e decostruzioni intelligenti del
cool e del cult — nonché dei vaffancool e vaffancult —
secondo il deplorevole linguaggio dei giovani con belle e
garbate maniere nel porgere in chimono da Butterfly un
pacchetto economico agghindato e vuoto come la cerimonia
del tè? O del caffè? In tazza grande? O — meglio — un
revival del cocktail bar, con barman e file di bottiglie dietro il
bancone. E Martini, Negroni, Americano, Alexander,
Manhattan, un dash d’Angostura qui, e Tabasco là, non solo
birre, e meno che meno tè, fra le coppette di mandorline e
pistacchi forse più graditi agli habitués dei trips?
Totò: “Bada che ti mangio, dice l’Uomo alla Natura, con la
faccia scura, e un pranzo al restaurant!”.
«Pensée Sauvage»… In un fascicolo speciale di «Sciences
Humaines», «en partenariat avec le Courrier de l’Unesco»,
tre bimbi Cashinauas analfabeti del Perù appaiono “immersi
nella lettura di Tristes Tropiques”, nella foto ridicola di un
professore antropologo americano. E poche pagine prima,
Lévi–Strauss medesimo indica “l’algèbre ensembliste” come
principale strumento della sua analisi strutturale. Nonché
Wagner quale “innegabile iniziatore dell’analisi strutturale
del Mito”. Mito e Musica, del resto, quali “macchine per la
soppressione del Tempo”. Dotate, dunque, di un potere
praticamente occulto. (Chissà i piccini?).
Ci si era preparati anche troppo, in tutt’altre epoche. Fin
dall’”Adelante Pedro” scolastico, e dalle ataviche leggende
familiari sulle prosapie iberiche, a causa di ufficiali ispanici
localmente attardati nell’Oltrepò.
Una prozia ottocentesca “aveva bellissimi mobili e
suonava il piano senza toccare i tasti”. “E si sentiva?”. “No,
ma le signore applaudivano”. (Un anticipo dijohn Cage?).
Un’altra, più recente, «ogni mattina alle undici prendeva il
suo zabaglioncino, fatto con un uovo d’oca». “In amaca?”.
“Certo, fra le sue ortensie. Sul lato in ombra della villa”.
Muri molto bianchi e vesti molto nere, da foto neorealiste
di culto, si riportavano con meste sensazioni ed eccelse
citazioni dai primi caratteristici giri giovanili nella tipica
Spagna pienamente franchista ai tetri inizi degli anni
Cinquanta. Taverne evidentemente intatte da secoli, con
bevitori ‘a garganella’ da tradizionali zucche piene di vino
rosso poco turistico. Lustri copricapi da Guardia Civil,
pittoreschi e costanti come nelle messinscene di routine.
Rifornimenti poetici — oltre ai Lorca, Jiménez, Machado, già
editi da Guanda — più à la page che i Blasco Ibáñez o Pérez
Galdós nelle librerie degli zii, il paso doble ai circoli, o
Sangue e arena al cinema.
Sotto sotto, ovviamente, covavano e stagionavano
transizioni più o meno occulte di fermenti tra Buñuel e Dalí,
con gli sputtanamenti delle non più giovani Rosite nubili, già
nervosissime alla fine della dittatura moralistica. E si
pregustavano chissà quali nuovi “conigli dal cilindro”, alla
cessazione dei conformismi imperanti: poeti andalusi, stilisti
catalani, chefs baschi, letterati e registi dissacranti e
trasgressivi…
Però, ancora, sotto i peggiori bastión di Siviglia e in pieno
orrido regime del Caudillo, tra miserabili focherelli e
ammantellati affamati in grotte pezzenti (“tutto un Goya,
happy now?”, “macché, María Candelaria con Dolores Del
Rio, Mexico 1944!”), cupi ceffi proponevano una racchia
anziana e nana che faceva numeri con un cagnolino triste
davanti a una coperta stesa per riparare una numerosa
famiglia di vecchi digiuni immobili intorno a un braciere
spento, nella loro spelonca; «El perrito, trabajando,
trabajando…».
“Madre mia, qué horror! Madre mia, qué horror!”
ripetevano invece insieme, in una tabaccheria–chincaglieria
a Malaga, una vecchia altera dama in veletta fatta
accomodare in poltrona, con una sua duena arcigna dietro
in piedi, ad ogni prezzo decrescente per una medaglietta in
regalo a una nipotina lì sempre più tetra. (Come certe
antiche cuoche nostrane inorridite davanti alle prime pizze.
“A’ sarì mia matt! Uma mai fatt inscì!”.
“Mira mira que picho que el tien”, era piuttosto un refrain
a mezza voce su e giù per i turbolenti e succulenti oscuri
cammini sotto burberi alcázar da Toledo a Segovia, poi
finalmente esternandosi come ‘low camp’ in qualche
festivalino off–off. Del resto, i già leggendari Dirty Dicks Bar
a Gibilterra come a Malta e a Hong Kong erano diventati
noiosi e inutili before our time. E perfino a Macao, antica
colonia d’oltremare, un piccolissimo parà in mimetica da
sierra o savana, solleticato con un sommario gratta–e–vinci
fieramente proclama “No tengo voluntad de orinar” con le
manine sui fianchi come le Mirandoline delle vecchie
compagnie venete. E come replicava un cuochino a un
grosso regista che gli gemeva addosso “vero che ti aiuto
tanto in cucina?”. Dispettosetto: “sì, a fare confusión!”. Così,
col classico “madre mía qué horror”, “voluntad” e
“confusión” divennero signorili répliques alle più
sfacciatelle avances nei locali ancora guardinghi, prima di
qualunque movida.
Ma nei posti madrileni migliori si ritrovava sempre
affabile e prodigo di sé “l’uomo più bello del mondo”
(secondo Tennessee Williams e altri) che lavorava per
Samuel Bronston nella produzione di kolossal come Il Re dei
Re o El Cid con la coppia Heston–Loren. Ex–stuntman,
ospitava in un magnifico attico «l’unico autentico Mr Norris
di Christopher Isherwood», vecchissimo e tremendissimo e
lasciato a casa la sera, intento (mentiva lui) a una sua folly
intitolata Braganza–Extravaganza.
Le prime volte a Rio, tanti Capodanni fa (con voli ancora a
tappe), si andavano ricercando le sopravvivenze originarie
di un Kitsch o camp nativo e storico, detto ‘cursi’. Chicche
per chi ‘sapeva’ (Chichita Calvino, Severo Sarduy, Manuel
Puig…), e non ancora in preda a sfruttamenti mediatici o
accademici.
Ecco allora memorabile il museo delle reliquie di Carmen
Miranda: icone e cimeli e lasciti tutti–frutti di un iper–
arcimboldismo autoctono e fantastico, dai turbanti sfrenati
alle scarpette con tacchi deliranti. Orecchini e borsette in
colori esaltati, spropositati, fanatici. Ananas parossistici…
Forse più anacronistico, si visitava allora anche il Museu
de Imagens do Inconsciente (cioè dell’Inconscio, magari non
esiste più?), poveramente e pulitamente allestito all’interno
del manicomio principale. Molti lavori di ricoverati in terapia
evidentemente coloristica: trasfigurare il disturbo mentale
in un’opera eventualmente d’arte. E risultati mediamente
più fantasmagorici delle più celebrate produzioni cliniche
austriache e svizzere. Come sensazione indimenticabile, il
greve scorrere e richiudersi di cancelli massicci terribili
davanti e alle spalle del visitatore.
Perseguendo quel medesimo filone ‘cursi’, ecco il
leggendario Cinema Iris, mitico relitto franante e sfavillante
del più spropositato ‘camp’ nel primo Novecento. E non più
sede usuale di spettacoli svenevoli e frivoli sul palcoscenico,
bensì abituale dimora di ininterrotte strabilianti discese
dalle slabbrate scalee Art Déco di agghindatissime e
numerose “divine” o “povere pazze” vecchie e giovani e
assai casarecce e generalmente miserrime. Fuori,
sbaraccata e smandrappata da molti anni, l’ormai desolata
Praga Tiradentes, praticamente periferia interna derelitta,
ma un tempo centro di vita mondana, con eccellenti teatri
musicali ed eleganti confetterie liberty. Infine, mentre le
‘fatalone’ scendevano e ‘incedevano’, in toilettes da
avanspettacolo poveristico, tra le gallerie e i palchi e gli
spettacolari cessi tanti giovanotti ‘si sfogavano’ con
prestanze multiple (per il Vecchio Continente) inaudite.
Movide di tendenza?
Poco più in là, nei monumentali cessi della enorme
stazione per le cittadine coloniali di Minas Gerais Belo
Horizonte, Ouro Prèto, Lavras Novas, Diamantina,
Caratinga, Caxambu, Caparaó… — decine di indios mineiros
anche anziani e corpulenti se lo menavano furiosamente e
reciprocamente con energia (per noi antichi decadenti)
forse spropositata. Il momento migliore era quando
periodicamente irrompevano squadracce di poliziotti
prepotenti intimando “In alto le mani!”. E allora il turista
poteva scorgere uccelloni eretti di inusitata grossezza. Ma
neanche una risata o un sorriso. «Tristezze» andine o
cariocas, se non del Mato Grosso? Bororo minerarie,
magari? Mah. In seguito, «per meglio osservare gli uccelli
da vicino» le guide per giovani suggeriscono piuttosto i
percorsi ecologici nei parchi nazionali dove la flora e la
fauna sono protette nel loro habitat sostenibile. Si sono poi
visti crescere, nei principali capoluoghi di regione, i vari
musei obbedienti alla voga effimera dei brutalismi
architettonici rozzi: parafrasi degli scheletri cementizi
incompiuti dei condomini e viadotti interrotti per mancanza
di soldi e calcestruzzi in paesi poco emergenti. O ecomostri
abusivi in attesa di tritoli e dinamiti civiche per l’entusiasmo
dei paesaggisti ecocompatibili.
I prototipi risalgono per tutti alla trista South Bank
londinese negli anni Sessanta: la lungaggine costruttiva del
National Theatre e della sinistra Hayward Gallery con
dislivelli e scalette e cenciose moquettes a ‘wishful’ prova di
angry young men e teddy boys e altre figurette di teppistelli
urbani non ancora giunti allo spaccio e allo spray segnalante
smercio ma tutto sommato fermi, anche per i vandalismi, ai
tirasassi o estintori dei troppo proverbiali ragazzi di
Portoria, quegli intrepidi Balilla già giganti nella Storia con
fez e fiocco e foulard con medaglione del Duce, e giberne di
cartone. Magari fissati (una volta) sui “W la f…” e “Lazio
merda” tracciati con gessi e carboni infantili, per le
ispirazioni dei giovani Twombly. E quivi, l’industre scuola de
«L’ornamento è delitto» aveva già imboccato le due viacce
sudamericane dei sottoprodotti semplificati con materiali
scadenti. La disadorna superficie fascista di soli mattoni o
solo travertino, in ignara attesa della disgrazia ambientale
futura: i graffiti–delitto anche sui casolari più remoti. O le
facciate razionali di vetro verdino o fumé, con ingenti ma
prevedibili spese di pulizie frequenti, a causa dell’aspetto
spesso laido. Vetrate spesso infangate dagli acquazzoni. Per
i post–neorealisti più cinici, ottimo il cementaccio da
sottopassaggio, reso presto lurido dalla pollution e dai
focherelli degli homeless. Non si può peggiorare. Non
richiede manutenzione. E i più bruti benevoli: con gli
allestimenti di detriti e rifiuti si viene incontro ai giovani che
amano e cantano il degrado come protesta verso il sistema
in cui vivono, e beati nel disagio adorano idoli miliardari
sempre più stracciati e zozzi e pieni di ‘fuck’ e ‘shit’ di
successo. (Ritorno aggiornato del gusto delle rovine per i
milordi del Grand Tour?). Grandi provocazioni e
trasgressioni: tracciare ovunque cazzi e vaffa ripetendo
interminabilmente vaffa e maccheccazzo. Prediligendo le
devastazioni, con eventuali abiezioni. Quindi, mai offrire o
imporre treni o cessi o cieli o culi o mondezzai o giardinetti
risciacquati e puliti, disagi smacchiati o detersi, mosaici e
stucchi Art Nouveau o Art Déco, discariche spic & span.
Invece, piuttosto, si vada incontro ai gradimenti, secondo gli
indizi e gli indici. “Ancora un po’ di degrado, per gradire?”.
“E il disagio, bruttezza”. E si risparmia, oltre tutto. Anche
negli allestimenti dei melodrammi più tradizionali, all’Opera.
A Copacabana e Ipanema, nelle ferie natalizie fini d’altri
tempi ormai lontani, di Capodanno in Capodanno si
constatava il ere scere e infittirsi di inferriate robuste e
vigilantes armatissimi sugli ingressi marmorei delle
abitazioni panoramiche. E si sconsigliavano ormai le discese
dalle sofisticate e sempre più fortificate coberturas per
attraversare la via lì davanti nei tradizionali abiti bianchi e
bagnarsi ritualmente mani e piedi nel mare fra le
innumerevoli macumbere candelarie accovacciate in
spiaggia. Ivi solevano, di giorno e di notte, i pittoreschi
monelli di strada e favela, a frotte, siringare getti di cacca
sulle scarpe, bianche o no. E subito poi, approfittando
dell’attimo di schifo per saltare addosso in parecchi alla
ricerca di soldi ovviamente inesistenti. Anche perquisendo
un eventuale cadavere.
“Rubòòò?” allibivano ancora certe signore pomeridiane,
all’ora del tè, davanti ai grandi alberghi.
Sempre lì a Rio, sopra Lapa o Glòria, in un più che
decoroso pianterreno, la caratteristica possessiva mammona
di Manuel Puig, forse emigrata dal Piemonte da piccola e
ora esule dall’Argentina, perseguitata ma fan di film cursi e
trash (come lui), con le manone sui fianchi esortava i
visitatori del figlio convivente in ciabattine a biasimarlo
perché vivevano “en està ratonera”.
(Mentre il vecchio babbo in canottiera bofonchiava
tacendo).
E se l’ornamento fosse un diritto?
Ma poi, così per gioco, sarebbe più di tendenza una
movida in Patagonia? O in Amazzonia, invece che ad
Ansedonia? E quali cascate? Victoria, Niagara, o Iguazu così
raggiungibile dall’Argentina come dal Brasile? («I’ve never
sailed the Amazon, — I’ve never reached Brazil — I’ve never
seen a Jaguar, — Nor yet an Armadil» verseggiava Rudyard
Kipling).
«El poniente implacable en esplendores… El poniente de
pie como un Arcángel… La clara muchedumbre de un
poniente… Siempre es conmovedor el ocaso… Penumbra de
la paloma.,. En busca de la tarde… La tarde calla o canta…
Afuera hay un ocaso, alhaja oscura… Enternecidas de
penumbra y de ocaso… Desde el banco de sombra…». Così
cantava ai suoi bei dì Borges nella «numerosa Buenos
Aires», benché taluno sostenesse che i tramonti sono
migliori a Montevideo. Comunque, dopo tante albe in India
— a causa degli orari disumani dei voli aerei —, a sorpresa,
l’aurora più bella venne osservata davanti al Palatino, nel
taxi dall’aeroporto.
Il primo convito post–Borges a Baires venne organizzato
dal Grinzane–Cavour piemontese, ospitando Giulio Einaudi
in fase allora periclitante.
In nome del «criollismo urbano», si costituiva una specie
di “tertulia ultraista” in giro fra il brutalismo cementizio di
una nuova Biblioteca Nazionale intitolata appunto a Borges
ma piena di targhe memoriali per Evita, e la vecchia
biblioteca smessa dove lui fu direttore cieco. E simile,
questa, a storici istituti tecnici per elettricisti milanesi
d’antan: Ettore Conti, Feltrinelli. (Ci sarà venuto, Gadda?).
Nei pressi, un Senato a cupola fra la Grand Central Station a
New York e il Kunsthistorisches Museum a Vienna. Un
grattacielo vetrato del potere militare uso Cortemaggiore,
Alitalia, Snam. Una apparente Chase Manhattan Bank, che è
una anagrafe. E la celebrata Casa Rosada sembrava evocare
“Arrivi” e “Partenze” e «Partire è come un po’ morire»,
piuttosto che Evita e Perón. Ma anche inalazioni, irrigazioni,
talassoterapie.
Giù giù, lungofiumi e lungomari davanti a docks e
ferrovie, condomini residenziali e ministeriali con balconate
analoghe e piante verdi identiche, sobborghi abitativi di
speculazioni con trame e televisori e misteri forse affini a
enigmi immobiliari e fiscali dietro le facciate dei viali Paridi
e Buozzi a Roma..: Disordinati partenoni di cupolette pre–
peronistiche doriche e ioniche sopra grandiose strutture da
grands boulevards e grandes brasseries fine–secolo, con
viveurs e golfini da ville d’eau… Mito di Parigi nelle vetrine
fini, tra marciapiedi rotti e autobus vuoti a prezzi bassissimi,
e ambulanti meramente locali… Ma grinte oligarchiche
ineluttabilmente accigliate e arcigne: DNA della cupaggine,
fra la megera bien e i nobili di più o meno antico stampo,
nemicissimi vitalizi di “quella zoccola” (Evita)…
“La imaginada urbe”… Il quartiere tanto signorile e fine
della Recoleta pareva ancora la nostra via Condotti d’altri
tempi, quando (secondo i vecchi gentiluomini) «ci si faceva
lucidare le scarpe prima di entrare»: fra baretti d’aperitivi,
camicerie e calzolerie su misura, librerie d’arte e
cioccolaterie e cravatterie e gioiellerie con una sede unica e
storica, non ancora le merci del lusso di massa identiche in
ogni aeroporto e outlet e center. O file e comitive di
mutande e zainetti fra marciapiedi a pezzi e ambulanze con
moribondi e accattoni mutilati dei racket, davanti alle
liquidazioni di borse e ciabatte griffate dalla pubblicità
globale. Si può ricordare, nelle vie più parigine d’Argentina,
un passeggio orgogliosamente anacronistico di anziane
signore in tailleur e cappellino e borsina da rue de la Paix, e
anziani signori in finissimi “prince de Galles” ormai cessati e
storici da noi, cravatte e pochettes da Place Vendóme, e
scarpette ovviamente fulgide, fra le vetrine (non ancora da
discount) nei pressi del fastoso e tradizionalmente ‘mitico’
Hotel Alvear. E lì subito accanto, uno sfavillante Harry’s Bar
(Cipriani autentico) che quanto prima avrebbe chiuso. Né
arriveranno più i giornali italiani, neanche sportivi, e
malgrado i milioni di nostri emigrati?
Dove saranno finiti i proverbiali galanti giovani che
offrivano il braccio alle eleganti ereditiere anche nane per
attraversare la strada lì davanti? Forse qualche marginale
antica dama qui risale o ridiscende dai mitici tempi facoltosi
e mecenateschi delle Ocampo ed altre patrone celebri della
modernità “entre deux guerres», in saloni e Trianon con
high teas molto highbrow (altro che i populismi di Evita) e
riviste di lusso e probabili emolumenti per Eliot e Valéry e
Tagore e Saint–John Perse, con Bioy Casares e Borges ‘di
casa’ e assolutamente anti–Evita fra i canapés e i pasticcini
e le Rebecche o Maddalene pentite e al pozzo sui
pianerottoli, e i tanti Santi cogitabondi in vari stili per
defunti magnati anche cileni collezionisti di impressionisti e
rococò in navate gotiche entro villone Liberty gremite di
pale d’altare e ninnoli di Rodin. Quando le ricchissime doti
nuziali americane ‘indoravano’ blasoni europei e romani
ormai parecchio impoveriti. E correntemente, magari, le più
facoltose ereditiere usavano festeggiare il proprio
compleanno contemporaneamente nelle parecchie
residenze intorno al mondo, dalle Hawaii a Marrakech.
Soli soli al Teatro Colón, spettacoloso e gigantesco antro
degradato e fatiscente che una volta rivaleggiava col
Metropolitan di New York nel remunerare Toscanini e
Caruso e la Callas e quant’ altri, che così viaggiando per
mare univano al guadagno coloniale il riposo dell’ugola. In
questo leggendario Kitsch moribondo, si aggirano come
nella Classe morta di Kantor e nelle allucinazioni
surrealistiche alla Magritte decine di simil–Borges molto
distinti e in ordine: capelli bianchi a posto, completo chiaro,
occhiali scuri, bastoncini d’appoggio, accompagnatrici di
sostegno.
Un evento per anziani. Si celebra il defunto compositore
Alberto Ginastera, antica gloria locale e autore di Bomarzo,
opera decadente e diligente sui drammi alchemici e magici
degli Orsini in quel Parco dei Mostri presso Viterbo. (Ebbi in
sorte di vederlo al Coliseum londinese, da giovane, verso il
1976, e non è vero che fosse “Porno in Belcanto”, come fu
scritto. «Una concentrazione di violenze, come in Verdi»,
piuttosto. E naturalmente «un incubo erotico forse disceso
dagli Etruschi, con statue di satiri e ninfe rimescolate fra
Vicino Orsini e Giulia Farnese e i mostri del parco»…). Sulla
scena, biondissima e disinvoltissima, la violoncellista vedova
di Ginastera suona Schumann come a un cocktail con
l’orchestra. E una Fata Confetto ricoperta di paillettes
turchine, molto festeggiata dai finti Borges. Ma qui le
strutture già opulente non paiono più in grado di produrre la
solita routine operistica. Da anni e anni.
Come solo godimento, ecco esposti ai vari livelli dei
costumi storici particolarmente sfarzosi: decenni e decine di
Leonore e Traviate e Tosche e Gilde più provocanti delle
Carmen e Preziosille, in velluti da poltrone e broccati da
tendaggi. Parsifal e Lohengrin e Radamès scollati, con
corsetti ortopedici color carne per fingere muscoloso
addome. Qui fu impresaria di successo la famosa Adelina
Agostinelli, bergamasca e debuttante a Treviglio, vedova dei
tenori Quiroli e Tabanelli, nonché originaria Marschallin alla
‘prima’ del Rosenkavalier alla Scala, contristata da
manifestini futuristi, in presenza dell’Autore, 1911. Sarà mai
stato qui il Gadda delle Adalgise faraònidi al Fossati, “con
lodoleschi trilli e occhi da ex–vipera”? Violette nei capelli!…
Maddalena zero in condotta!… Ore nove lezione di chimica!
… Bei musini di ragazze e ragazzi, bei gestini d’altri tempi,
camicette candide impeccabili… Tutta una grazia italiana
démodée, una carineria spontanea nell’atteggiarsi, uno
schietto garbo da telefoni bianchi (né cazzeggi né
paraculaggini, natura e cultura ovviamente anacronistiche?)
a un liceo italiano, benché gli ospiti del Grinzane–Cavour
non fossero propriamente bocconcini? Tristissimi Tropici?…
Ancora?
Tristezas Tropicales ormai metropolitane inevitabilmente
affliggono e contristano gran parte delle emozioni umane e
civili, e gli sconfortati sentimenti, soprattutto nei quartieri
più centrali e storici di Montevideo… Tutt’attorno, le casette
basse costruite dai vecchi emigranti, evidentemente a mano
con mezzi poverissimi; poi crollate e implose dentro, per
mancanza d’ogni manutenzione sul tetto–soffitto; e quindi
neanche occupabili da squatters ancora più miseri. Vi
cresce molta vegetazione tropicale, dentro. A Montevideo,
dall’unico roof garden alberghiero, tutto un Mondrian
monocromo di tetti piatti in sfacelo. Neanche un quadratino
verde. Giù in strada, appaiono impressionanti le
facciatefantasma già assai facoltose e pretenziose con due o
tre piani di colonne e balconi ottocenteschi, portoni e
cornicioni elaborati, grate di pretesa. Già, evidentemente,
casse di risparmio e compagnie commerciali e dimore nobili:
come gli analoghi e coetanei palazzetti di Voghera coi vecchi
saloni degli sportelli delle ‘banchette’ agricole, vecchi uffici
ereditari d’avvocati della Curia, antichi letti ove dormirono a
turno Pio VI e Pio VII e Napoleone. Decrepiti salotti con «bei
mobili», non ancora modernizzati: mogani, palissandri, noce,
bois de rose, broccati e damaschi spenti, intarsi, bronzi
dorati, ritratti di vecchi…
Buon business nel lungo periodo, forse, per i nostrani
mediatori e costruttori locali, con edificazione di ‘casermoni’
condominiali al posto dei distrutti giardini atavici, in centro,
o intorno a ville con torrette estive e camere da letto al
primo piano? Qua, invece, dagli scatafasci e tracolli
nell’antico centro benestante e franante stanno erompendo
radici violente come in Cambogia. Ed Era una destinazione
così sospirata dagli emigranti, dagli Appennini o dalle Alpi
alle Ande. In queste capitali già fiorenti e ora misere,
l’ambiente e i contesti si presentano come disgrazie urbane
e tristezze civili.
Non solo a Buenos Aires si sono costruite per decenni le
irrimediabili fette di decine di piani per tre porte–finestre, e
un loro ballatoio spesso diviso in due con filo spinato e
piantine secche, sopra avenidas spropositatamente
larghissime. E fianchi non molto profondi (come ci staranno
le scale?) sopra sfasci e baracche. Con effetti da «articolo
il», come dicevano certi nostri vecchi per le coppie nano–
gigantessa. (Tema o mito d’altronde trattato anche chez
Lévi–Strauss).
Ancora si possono leggere, a fianco dei portoncini
bullonati, le firme e sigle degli architetti ormai remoti che
negli anni della prosperità incoraggiata hanno edificato
«Eclecticismo historicista» e «Neoclasicismo italo–
hispánico» e «Arquitectura moderna heterodoxa» e
“Inspirado en el Plateresco» o «Neoclasicismo y
Modernismo español y francés» o «Expresionismo
holandés».
E le facciate razionaliste in tutto vetro verdastro o
marroncino, che agli inizi impressionavano per i fanghi
spessi lasciati dai temporali tropicali come sulle automobili,
e per le coperte miserrime portate da casa e stese dagli
impiegati contro il sole battente a 40°. Oggi, invece,
parecchi enormi sottoprodotti del Bauhaus si sono rivestiti
di innumerevoli condizionatori esterni asimmetrici non certo
previsti da un’estetica di Mies van der Rohe. Fanno questo
insolente Mondrian in rilievo, piuttosto, o smisurato
caravanserraglio alla Mecca, fra una Casa del Vino o de
Garibaldi e poi una del Virrey e l’Arzobispado e il Cine Rex e
il Banco Inglés e la Catedral Metropolitana vuota a tutte le
ore. E deserta non solo a Montevideo, malgrado le folle che
passano. Ma continuando a guardar giù dai torracchioni più
eclettici, mai un solo vasetto o qualche tentativo di aiuola,
sulla distesa sconfinata dei tetti: così come neanche una
cassetta di gerani sui balconi guardati dalla strada.
E se a Sào Paulo si va ad ammirare il più mitico palazzone
ondulato di Oscar Niemeyer, lo si trova scrostato peggio di
Cecilia Metella. Trattandosi di abitazioni vissute e trafficate,
verrà spontaneo domandarsi: come ripartire le più urgenti
spese extra? La vita uruguayana abbiente sembra piuttosto
vistosamente spostata altrove, lasciando perdere queste
piazze che un secolo fa sontuosamente rimescolavano il più
turrito Medio Evo col Secondo Impero e la Terza Repubblica
alberghiera di Parigi e Cannes.
Fra neoclassicismi e storicismi poliedrici e versatili, e
larghe avenidas intitolate a date storiche, per lo più in
maggio e luglio, fino alle nuove sfilate dei condomini di lusso
più aggiornati e recenti. Ma senza più un vero centro,
neppure quale shopping center: i multimercati sono molto
economici. Clientela senza loghi o griffe, da inflazione al
25%.
Tipiche "Torri Littorie" come a Genova, con fianchi
curvilinei. Banche perfettamente palladiane del Trenta.
Cupole e cupolette assolutamente eclettiche, torrette,
pinnacoletti, altane, loggiati, bovindi. Beaux Arts e Torri
Velasche, Cordusi e Coppedè e Càriplo, stucchi e rilievi e
festoni e telamoni e cariatidi ove ogni ornamento è
volutamente delittuoso, nonché voluttuario e quindi
voluttuoso, ma se non ci fosse sarebbe comunque peggio.
Abolire qualche ornato nelle acconciature amazzoniche, nei
folklori andini con ori e penne, fra i barococò inca o
benedettini o gesuitici? Introdurre o imporre minimalismi da
sushi e geishe fra gli indios e i peones? Questi Tropici
giustamente giudicati tristi da Lévi–Strauss diventerebbero
magari più allegri, con un po’ di Bauhaus nel Mato Grosso e
in città?
Ecco qui improbabili réclames di fragranze maschili
‘sauvages’ per barbudos hirsutos nei vari pubblicizzati e
prestigiosi Chiapas, e per i popolari chicos di strada nelle
giungle metropolitane in mimetiche global o no–global, e le
caratteristiche magliette d’altrettanto prestigiose università
americane (Harvard, Yale, ecc.), come già i lustrascarpe in
India. Con qualche refuso nel lettering. Tipo descamisados
peludos brianzoli e ciociari, eredi populisti di Evita e del Che
in chissà quali favolose favelas fra Novara e Matera.
Falchetti e yuppetti con pizzetti alla Italo Balbo o Conte
Sforza e magliette di «Renegados», «Revoltosos»,
«Subversivos», «Turbulentos», «Transgresores»,
«Irreverentes», «Irritantes», sacri cuori di Gesù come sulle
T–shirts di «I Love NY», in viacce slabbrate che si chiamano
ancora “Misiones” o “Mercedes” o (dietro il cimitero)
“Petrarca”. Ma loro diventeranno almeno «Atractivos» o
«Atrayentes» (come asseriscono le canottiere «cómplices»)
nelle discoteche o discariche di bocca buona?
“Fascistissimo” sarebbe naturalmente per noi questo
Palacio Municipal di Montevideo, fratellone coetaneo di
Littoria e Sabaudia, classificato quale esemplare di
“Arquitectura moderna heterodoxa” sulle guide, e con un
gran David di Michelangelo in bronzo (del 1931)
sull’ingresso.
Subito davanti, come alla famosa Plaza de Mayo con tante
celebri Madri e Nonne, bivacchi e tendaggi di manifestanti,
molto di tendenza, con parecchi striscioni e molte
rivendicazioni. «Tras la derogación!». «Movilidad de
jubilaciones!». «Firma aca contra la impunidad!». «Todo
cambia, y el poder judicial que?». «Escala salarial!» per tutti
gli impiegati. Si oppure no alle municipalizzazioni, fra tanghi
atavici a tutto volume, fasce e frange etniche, gualdrappe e
sombreros di innumerevoli tribù sistematicamente vittime di
tradizionali soprusi e rivoltanti violenze.
Appena sotto, nel deserto Museo de Historia del Arte, fra
varie riproduzioni in gesso di celebri sculture classiche,
«Tradiciones en tránsito»: un allestimento di bottigliette
vuote di bibite, su un tappetino. Poco dopo, all’aeroporto,
una installazione molto più bella: un contenitore di vetro
pieno di accendini multicolori che vengono gettati prima
dell’imbarco.
E poi, come da noi, di tre voli ne fanno uno. Dopo pratiche
e moduli e timbri e sportelli e tasse più complesse tra
Uruguay e Argentina che tra le due Berlino nella Guerra
fredda. Comunque, soprattutto nei telegiornali della
nomenklatura sovietica e a certi funerali nel più profondo
Sud si potevano vedere altrettanti bacioni e baciozzi così
obesi e osceni tra anziani baffuti e ‘distinti’, qui al check–in.
E così, nel triste Ferragosto invernale di questo tristissimo
emisfero australe, al colmo della cosiddetta ‘season’ il
turista sempre più mogio e mesto finirà per giungere di cult
in cult tipo Lourdes o Caravaggio o Fatima o altre sedi
miracolose di Madonne residenziali celebri finalmente alla
famigerata o addolorata Plaza de Mayo. Tumultuante e
debordante come la Plaza Independencia a Montevideo,
però priva di Madri o Nonne abituali, stavolta. E neanche
Babbi o Nonni o Vedove in giro, se mai ve ne furono.
Qui davanti alla malandata Casa Rosada, icona malfamata
del Potere e dei Bonds argentini, in zona vietata al traffico si
accampano e ‘spalmano’ sul territorio pedonale parecchi
ormai incalcolabili bivacchi rivendicativi di protesta e
denuncia con tende e ombrelli e innumerevoli bambini etnici
e bancarelle di collane e cartelloni con illimitati ritratti di
vittime fra altoparlanti al massimo dei decibel con violenti
dissensi circa massacri e stragi in epoche e località
praticamente incontrollabili. Quante carneficine! Troppe!
Che casino e che macello! Tutto intorno, infinite proposte di
tanghi indimenticabili in romantici localini abbastanza
prevedibili. Trionfi del Pop Camp! Ah, poter avere ancora
qui Manuel o Saverio, mentre fra samba e caramba e tatatà–
tatango in competizione fragorosa coi classici alla Carlos
Gardel passano e ripassano camioncini con scritte uso
“Pettoruti & Bigotti” o «Dándolo y Primi», slogan di «El
Bianco està de Moda» sui fianchi degli autobus, la pubblicità
elegante dei prodotti contro l’unghia incarnata e le ascelle
che puzzano.
Sulle bustine dello zucchero, come marca, «La Pasiva». E
una popolare bodega si chiama «La Graffigna». Le guidine
per giovani, oltre a consigliare qualche «Giramondo» e
«Como en Casa», segnalano un barrio particolarmente
franante abitato da artisti molto bohémiens e un museo
carcerario per anarchici impenitenti con ricostruzione di
una cella peculiarmente mefitica. Sulle luminose insegne dei
multicinema, soprattutto Horror e Terror. Sulle porte della
Catedral Metropolitana, foglietti e manifestini di tutto un
sincretismo panamericano di chiese e comunità e missioni
cristiane, evangeliche, variamente bibliche e carismatiche.
Dentro, una eccellente Via Crucis dell’artista Domenighini,
molto affine al G.A. Sartorio del fregio di Montecitorio. Con
qualche ammicco anche al F.P. Michetti della Figlia di lorio.
Lì davanti, sui banchetti, tutta una smisurata campionatura
dell’etno–cheap che si ritroverà nei chioschi delle capitali e
stazioni del Subcontinente.
“No al paro”. “No al terror”.
«El Sur reclama comunidades y pueblos».
«Organizar su movimiento autònomo».
«Complotar contra el monstruo».
«Dirigentes nativos romper diálogo con el Gobierno».
«No, sr Alcalde!».
«Protesteremos!». E nelle strade vicine, graffiti con gli
stessi slogan, tutti politici e in vernice nera. Mentre dalle
edicole sventolano giornali con “Caos vehicular”, «Atentado
con muertos», «Bomberos marcharán desnudos». (E
appaiono anche in TV i pompieri e le pompiere scioperanti
che minacciano di sfilar desnudos in Plaza de Mayo: ma
sono panzoni e ciccione metropolitane di mezza età, altro
che descamisados bonazos da boscaglia o guerriglia). E gli
altoparlanti dei bivacchi sparano tanghi ossessivi a pieno
volume, mentre sui taxi “Don’t Cry For Me Argentina” pare
più frequente che «Roma nun fa’ la stupida stasera» a
Trastevere. «Triste, solitario y final» ripetono i quotidiani.
Mentre i soliti crocchi di venditori etnici accoccolati ai
margini espongono i ninnoli andini sui tappetini, e magliette
con icone sempreverdi quali Che Guevara, Evita Perón,
Carmen Miranda, Cristo incoronato di spine, Village Eat, La
Bestia Pop, Los Brutos, Los Fabulosos Cadillacs, e perfino
ancora Dorothy Lamour.
“Expiación y pecado”. “La dulzura puede cambiar el
mundo”. “El libro de las simpatías”. “Terapia espiritual del
Amor”. “Casos imposibles”. «La banda de los pedófilos».
«Reunión de la Prosperidad».
«American gangsters», «Combustible espiritual». Trattati
di logica referenziale per qualunque esame breve. Filosofia
cerebrale e teosofia occultistica e spiritualismo spiritistico
ad ogni livello. Società segrete. «Libera lotta in libero
Stato». Corsi accelerati e biennali di “aritmetica e fisica e
ragionamento” nei parcheggi presso i Palazzi di Giustizia.
(Anche molto a Rio). Manualetti e DVD su outing, footing,
preparare dolci portentosi, sistemare il bagno, maturare la
mente, partecipare a concorsi e prodigi e miracoli. Altro che
gli estri dei narratori fantastici. E Borges, e i suoi colleghi
chimerici, surreali, fiabeschi, fantasmatici?…
Ma come gestire sin embargo una decadencia che si
prolunga e protrae sine die, se non c’è un minimo sentore di
“gaia apocalisse” e i bonds risultano truffaldini? Arrivederci
a Key West o a Miami, South Beach?
Paragonabile forse ai migliori santuari ellenistici e indù, il
Museo Evita a Buenos Aires probabilmente condensa più
magie e venerazioni sudamericane che i siti inca a tremila
metri o le reliquie di Santa Rosa a Lima. Questo Mito
carismatico e mediatico e Kitsch lascia opportunamente
perdere l'insulso partner Perón (marginale come un San
Giuseppe nei culti della Madonna), e risiede in un bel villino
o castelletto medioeval–plateresco del primo Novecento:
tipo un Coppedè coloniale con ricchi ornamenti, in un agiato
quartiere alto–borghese oggi interamente moderno, con
balconate e verande sui dodici–quindici piani accanto al
Giardino Botanico e a quello Zoologico. Era, al tempo di
Evita, un suo centro di accoglienza e assistenza per i poveri;
e attualmente, al pianterreno, una caffetteria e ristorante di
successo, con gran frequenza di donne. Dopo una cassiera
quasi impressionante — perché forse volutamente identica a
un'Evita invecchiata — si dispiega la leggenda per due piani
curati e accuditi con grande attenzione anche tecnologica al
mito.
Evidentemente si è conservata o ricostruita gran parte
del guardaroba, perché le foto sono molte, e accanto a
ciascuna c’è una teca col medesimo abito, da mattina o da
sera. E complessivamente, uno spaccato storico esemplare
sugli aspetti grandi e piccoli di un’intera fase argentina.
Storia politica, sociale, del costume, del gusto… Con corsi e
ricorsi, fra populismi e oligarchie. “Una niña inquieta”,
naturalmente di umile famiglia: ecco la macchina da cucire
e gli occhiali della mamma sartina. Eva Duarte negli anni
Trenta diventa una Carla Del Poggio o Irasema Dilian dei
“telefoni bianchi” argentini: in teatro, nel cinema, alla radio.
Con cappelli di paglia, mazzolin di fiori e titoli paragonabili
ai nostri La moglie in castigo, o Due cuori sotto sequestro o
Catene invisibili: “Una sposa nei guai”, “La cavalcata del
circo”, “La carica dei valorosi”. E programmi radiofonici su
Elisabetta I e Caterina II e Madame Chiang Kai–shek. Tante
popolari copertine a colori su “Cine Argentino”, “Antena”,
“Damas y Damitas”, “Sintonia”, “Radiolandia” (quando era
ancora bruna, e coi capelli talora sciolti). Presto,
definitivamente bionda e con le caratteristiche acconciature
a doppia banana, appare soltanto su «Mundo Peronista» e
nelle foto ufficiali sulle prime pagine dei quotidiani: sia nei
modesti vestitucci a pois per le continue attività benefiche
tra i poveri, sia nelle fastose toilettes da gran gala concepite
come realizzazioni del più bel sogno per qualsiasi donna e
‘fan’. Quindi, nessuna via di mezzo (tipo ‘tailleurini’ borghesi
di Chanel), evidentemente fuori da ogni immaginario o
entusiasmo di massa e dell’epoca. Ecco allora qui subito i
pezzetti di cinegiornali che tanto impressionarono tutta
quell’Italia affamata nel 1947 in occasione della trionfale
tournée europea di Evita senza il marito, per portare i lauti
aiuti economici dell’allora ricca Argentina al povero Vecchio
Continente disastrato dalla guerra. E quelle indimenticabili
immagini in Vaticano, in mirabile abito nero accanto alla
sensazionale benda nera sull’occhio del Principe Ruspoli, fra
innumerevoli porpore di eminentissimi, porgendo le
sovvenzioni delle pampas a Papa Pacelli, dopo le riprese
parigine col futuro Papa Buono a Notre–Dame…
Magnificenza e ‘allure’ impeccabile in ogni capitale e
cerimonia e celebrazione e circostanza e convenevolo, con
la ‘pietas’ giusta fra i baraccati europei bisognosi di cibo
argentino. Performer completa, come poi forse soltanto
Reagan, in tutt’altri contesti più informali e bonari. E magari
Kennedy, figlio di un importante produttore cinematografico.
(«Joseph Kennedy presents Gloria Swanson» si leggeva nei
titoli di testa, quando ancora i film muti venivano ripescati
nei cavernosi teatri provvisti di un gigantesco organo
Hammond. E magari con la Swanson stessa come sfavillante
presentatrice per cause benefiche).
Dietro il grand chic — che diventa presto un high camp di
massa, senza molti paragoni democratici e laici — l’attivismo
dittatoriale e sociale appare assillante e quotidiano come il
non–stop cineteatrale e radiofonico di Evita inappuntabile
attrice full time. Muore di cancro a 33 anni, nel 1952, fra le
esultanze (“Evviva i tumori!”) di varie élites oligarchiche e
con un annuncio documentato raccapricciante, perché la si
vede ‘live’ moribonda: “Rinuncio a tutti gli onori, non
rinuncio al lavoro e alla lotta”. E poi, variamente esecrata o
madonnificata, benché sui telegiornali il presidente della
Bolivia d’oggi si rivolga alle sue masse con identici archetipi
oratori, o forse praxis sudamericana di routine. Come già
per i nostri piccoli balilla e avanguardisti e piccole italiane e
giovani fasciste e aspiranti–sotto–capi–manipolo (A.S.C.M.) e
ciechi o vedove di guerra con veli neri sventolanti (tutto un
‘garrire’) nella casareccia Piazza Venezia: ben più piccina
picciò rispetto a qualunque Avenida o Prospettiva de Mayo o
Julio o Nevskij strapiena di testoline e fiaccole ‘oceaniche’ a
milioni e milioni osannanti nelle inquadrature e campi lunghi
epici e costruttivisti dei cloni argentini di Ejzenstejn o Leni
Riefenstahl. Donde, per associazioni più o meno libere, si
può addivenire ai ninnoli e retaggi tipici nel familiare design
del Regime nostrano.
Anni e anni dopo, non più affamati e laceri sotto le
bombe, ancorché “da secoli, calpesti e derisi”, secondo lo
‘scalognato’ Inno Nazionale (e il Divino Poeta Nazionale:
“ahi, serva Italia, di dolore ostello, non donna di province ma
bordello!”, altro che «suoni la tromba, e intrepido, io
pugnerò da forte!”), qui al Museo Evita si possono
riconoscere parecchi analoghi ruralismi razionalistici «verso
il popolo» nel nostro Agro Pontino e nella Cirenaica.
Nell’Argentina allora ricchissima — piena di carne bovina a
buon mercato e di miliardari assai chic, e con una
popolazione poco numerosa — provvedimenti imponenti e
un attivismo addirittura folle. ‘Populismo’ di destra o
sinistra, contro i salotti e le cricche o i clan che non
perdonano?
Installazioni per l’assistenza medica gratuita. Soccorso ai
vecchi indigenti. Il turismo delle vacanze infantili. I cessi
moderni e i letti puliti nei dormitori. Le ricette per le pappe
infantili rustiche. I tavoli agresti su cui pasticciare le ricette
della nonna. I giocattoli educativi con legnetti colorati
combinabili. Le cucine regolate con le etichette per i risi e le
paste su ogni cassetto e sportello. Adunate e fiaccolate
assolutamente spontanee. Funerali e commozioni di massa.
Infiniti busti e bustini in vari materiali post mortem.
Innumerevoli graffiti e lapidi da tifo e da stadio con “Evita
vive”, e invece è morta. Sempre più malata, con la voce
rotta, morente giovane senza ovviamente qualche ‘vanitas’
circa un futuro così ‘camp’, al di là delle serate di gala e
rappresentanza da ‘icona cult’ tutta Rochas e Lanvin e
volants impeccabili nelle grandiose apparizioni al Teatro
Colón (ormai malandato, anche lui), dalla gran
documentazione giornalistica e filmica risulta impazzare
tutto un assistenzialismo altamente compulsivo, animato e
spinto da quelle vaste masse incrollabili ma storicamente
volubili che anche a Roma imperversano, compatte ed
eterodirette, in Piazza Venezia e a San Giovanni e a San
Pietro o al Circo Massimo, e per ogni ‘derby cittadino’ o
concerto cult di icone rock. Documenti strazianti, disperati,
avendo tempi e voglie di riflettere sulle Teorie delle Masse, i
corsi & ricorsi storici e i caratteri antropologici magari
demagogici che le accompagnano e seguono, strutturali ed
etnici. Forse anche di élite?
Enormi campagne, epocali battaglie per la parità
femminile e il conseguente voto alle donne. Però, non in
linea con le suffragette signorili all’inglese che lo esigevano
come diritto istituzionale accordato da un governo
democraticamente eletto, e non militare e quindi
maschilista. Dunque, rifiuto di un Partito Peronista
Femminista, creato da Evita, da parte delle élites e dei
salotti.
E d’altronde, da parte di Evita, una repulsione totale e
sincera (e molto reciprocata) per qualunque specie di
intellettuali salottieri.
Nemmeno “ex–fascistoidi” come nella solita “serva Italia”
del tribolato dopoguerra, con stuoli e caterve di zeli e
solerzie e prontezze e instant–tessere di voltafaccia tra fame
e macerie e Sciuscià e Paisà subito dopo l’impegno littoriale.
Fra gli amorosi cimeli, le immense foto del “Dia de la
Lealtad” e le biciclettine per i bambini poveri, le cinque
impronte digitali per la Presidenza, un ricostruito “Patio
Andaluz” con certe caratteristiche mattonelle, e le pentole
per le suore dell’Ayuda Social, qualche Don Chisciotte
dipinto o graffito dai bimbi, la Dichiarazione dei Diritti dei
Lavoratori con la Riforma della Costituzione, il treno
elettorale “E1 Descamisado”, il libro di Evita La razón de mi
vida, le immagini della sua tomba al Cimitero Maggiore di
Milano, a lungo anonima per evitare altre empietà dopo una
profanazione del cadavere. (E dopo i casi del corpo del
Duce).
Una quantità di cappellini, tipo apparizioni di Mina in TV.
‘Chanellini’ da passeggio o shopping parigino, però, mai.
Rieccoci insomma così nel viejo y ilimitado Palermo,
tradizionale territorio di Borges, attualmente in gran parte
cadente e morto, poiché anche qui si sono sfasciate dentro
— per mancanza di manutenzione sui materiali andanti — le
già pittoresche casette degli emigrati con pianterreno solo e
tutt’al più un pianetto, e un loro giardinetto. Fino a non
troppo fa, ripittate e accudite. Ma dopo le frane di tetti e
pareti senza speranze, come nelle cascine che cascano da
noi presso le autostrade, evidentemente è diventato
antieconomico alzare edifici su lotti così piccoli. Anche sulle
prestigiose avenidas intristiscono irriducibili i soliti moderni
e malconci casamenti di molti piani sull’immutabile fronte
delle tre finestre in proprietà suddivise, senza lati profondi
sugli ex–ortini ora depositi e scarichi. E la solita pena
logistica: dove potrebbero stare gli eventuali ascensori, e gli
attuali cessi? Anni fa se ne ricavavano impressioni
complessivamente tristi, ma prive di miti o misteri. Casette a
un piano, scrostate, da vecchi ferrovieri. Cortiletti e angolini
dove non ci sta neanche una piccola cilindrata, né un’aiuola
di verdure. Giardinetti pubblici con panchine e alberelli
piuttosto squallidi. Un vetusto garage disoccupato. Uno
scivolo arrugginito per bimbi poveri con la nonna.
Addirittura una nonna gobba (ma lo fanno apposta?) fra le
vecchine e donnette da borghi nelle bonifiche pontine: forse
vengono dalle stesse emigrazioni romagnole e venete, come
a Ostia Antica. Affacciandosi sul Moderno, “Café IN”, “Pizza
IN”, “El fútbol cinco”, «El cine seiscientos». Ora, qui, in un
Palermo non siciliano e non bombardato, ma pieno di cavi
annodati fra macerie e voragini, fanno evidentemente
impressione soprattutto gli scheletri di cemento male
armato e abbandonato, già luridi: come nei sottosviluppi dei
Terzi e Quarti Mondi indebitati, e nei male invecchiati
brutalismi architettonici imposti nei decenni scorsi ai trucidi
musei e svaghi progressivi da cui nei Tristi Tropici i
probabili utenti rifuggono. Mentre nei multipiani razionalisti
vetrosi gli infelici e impotenti indigeni tentano di ripararsi
dal sole tropicale con le coperte e ‘mantas’ andine e
illimane, non disponendo più di frasche e palme affastellate
come nelle classiche foto antropologiche delle tribù
primordiali depresse.
«Palermo Hollywood», «Palermo Soho», indicano le
mappe. Ma su tante ‘incompiute’ cementizie e scheletriche,
ad ogni piano spiccano adesso grandi cartelli di VENDESI,
forse ormai inutili per tirare avanti, però ineliminabili: ogni
quartiere ricco o povero inalbera da anni una quantità di
avvisi identici. E di sera, veramente “una prece”, nella
vastità desolata e defunta, fra crolli e VENDESI e arbusti e
macerie e gatti. Un isolotto di tendenze?
Ecco improvvise vetrine, come citazioni familiari di moda
europea, italiana. Tutto un logo, un brand, un cult nostrano.
Icone di rappresentanza, abituali nelle vie di shopping e
negli aeroporti, non nella cimiterialità sterminata di questo
‘Palermo’. Due o tre incroci, in tutto: Armenia, Malabia,
Salvador… Tra i negozi di lusso internazionale,
aggiornatissimi, soprattutto parecchi ristoranti molto ‘in’,
molto più ben messi e buoni che i nostri analoghi. Non
affollatissimi, però squisiti. E non certo indicati per “dare
una sbirciata” fra gossipisti mutanderos e indignati
infraditos in cerca di lofts alternativos y centros
transgresivos. O fra rimembranze di lini bianchi, doppipetti,
gessati, smeraldi, Saint–Laurent d’alta moda e altre
anacronistiche epoche.
Macché «oggi il mio cuore è pieno di nostalgia».
Sembrano un nuovo dominio delle giovani donne in
business, in gruppi o famiglie o coppie manageriali,
chiaramente abituate a lavorare e dirigere in grandi uffici,
ma con innate eleganze di basso profilo e bon ton
manageriale, gestionale e chic. Donne e ragazze ‘in
carriera’, allegre e abbienti, in un’economia così
preoccupante. Che differenza col vecchio ‘machismo’
sudamericano, tutto baffoni e doppipetti d’antan accanto
alle pettinature architettoniche, oppure tutine mimetiche da
‘full attack’ urbano e grottesco in selve ecologicamente
minacciate e protette. E che oltranza taciturna in quegli
occhioni profondi, come afflitti da inguaribili melanconie
australi vitalizie, fra ciglia abbondanti, anche mentre
mangiano spiedoni di carne al sangue o ‘pomiciano’ con la
loro muchacha. Contraddizioni, parecchie. Ai margini del
classico territorio borgesiano, più o meno smunto, ora ‘Alto
Palermo’ è un immenso shopping center su molti piani e
parecchie scale mobili. Ascensori panoramici sulle ‘Torri
Portofino’ di trenta o quaranta piani residenziali sopra file di
condomini e impianti ginnastici a schiera, succursali
colossali di Mickey Mouse, palloncini colorati, scolaresche
smisurate, pletore di frugolini rock che si specchiano e
bitriforcano tra le infinite scaffalature dei Musimundo
Megastore… Labirinti di compact, paninoteche di
computers, sconfinate babeli di videogames… Altro che
quelle care vecchie Biblioteche di Babele ‘cartacee’…
Forse (chissà), qua o là, in qualche antico localino proprio
sin empacho, sopravvivono tradizioni popolari di
abominevoli lazzi cursi e camp magari lascivi o lavativi su
conghe e milonghe, donde poi bande di scatenati Argentins
de Paris travestiti e frocissimi trionfarono sin embarazo tra
Montparnasse e Montmartre dagli anni Cinquanta in poi,
mentre i neo Lévi–Strauss emergenti passavano piuttosto a
osservare le «coppie maschili sterili» di newyorkesi
metropolitani che ai tempi di Auden–Kallman e poi Capote e
tanti grandi sarti e coreografi di Broadway si rilassavano e
rimbambivano a Fire Island portandosi a casa le provviste e
i fiori e il ghiaccio coi trolleys (allora mai visti) dal
supermarket a Cherry Grove, ancora senza elettricità. E
nella notte, dopo le bibite, tutti al Meat Rack. Su passerelle
lignee etnologicamente (e poi anche ecologicamente)
‘rimarcabili’, giacché forse ataviche sulle tante selvagge
dune del New England. Ove d’altronde ‘Nantucket’, già
scalo di baleniere per Moby Dick, presto divenne brand
commerciale per quei pantaloni maschili già definiti ‘couleur
puce’.
E saranno definitivamente trapassati anche i più illustri
classici moderni, qua dove una rua J.L. Borges sbuca in una
Plaza Cortázar, tra Palermo Hollywood e Palermo Soho?…
Un momento o memento di libere associazioni (o «recuerdo
encubridor», qui) rinvia a taluni messaggi “sono lì che
aspettano all’angolo Vittorini–Quasimodo!” sui radiotaxi
nostrani.
Nella nostra antica Roma Capitale, sin embargo dopo
l’espantoso Spinaceto e fin verso la olvidada Cecchignola,
un triplice cartello espectral di «colle parnaso» e “strada
senza uscita” e «via camus» davanti a una rebosante
perenne montagnetta di detriti dirige direttamente alle
viette gide e proust e mauriac, generalmente con iniziale
minuscola, senza nomi o iniziali di anagrafe o indicazioni di
nazionalità. E tutte strette, cieche, a cul–de–sac, senza
comunicazioni reciproche, come le attigue viuzze gatto,
guareschi, gogol, melville, kafka, lorca, saponaro, provenzal,
lanza, fenoglio, drigo, giuliotti, marotta, buzzi, lisi, woolf,
joyce, vergani, folgore, balzac. (Certuni, però, come a.
moravia, fruiscono dell’iniziale del nome).
Lì addosso, immensi immobili come caricature di
aeroporti. Asiatici? Pronti per qualche film noir molto cult?
Nomadismi underground tutti horror e squallor e rave di
sovrappassi arrugginiti e cadenti dopo napalm e missili
metropolitani? Spray per la droga eseguiti evidentemente
da acrobati sopra budelli e crepacci fra enormi triangoli di
mattoncini–giocattolo molto più alti e fitti che negli
agglomerati adiacenti sulle attigue vie dei fucilieri, avieri,
autieri, genieri, bersaglieri, carristi, pelosi, acqua acetosa
ostiense, tor pagnotta. Un campetto di calcetti teppistelli
dopo un trucido vicolo baudelaire.
Allucinanti moltiplicazioni e contaminazioni di ziggurat
piramidali a gradoni ove tutto appare sfalsato negli assi
orizzontali e verticali e asimmetrici: ecco la via carlo emilio
gadda. Con gli effetti ambientali e acustici già contemplati
da quel sommo ingegnere, quando sugli spurghi degli
sciacquoni ancora non si aggravavano gli scarichi degli
stereo nei cartongessi. Altro cul–de–sac, con accesso in
comune al piazzale e. morante (tipo vasto e deserto
parcheggio camion) dalla rotatoria e. montale recintata e
diffidata archeologicamente da una sovrintendenza come
l’attigua piazza g. piovene, fra i viali c. levi e f.t. marinetti
con «opere di urbanizzazione primaria» abbandonate.
Sotto il parallelo e civettuolo vialetto guido da verona
improvvisamente sovrastante al vasto e ramificato viale i.
silone che fra pratolini e pea si spinge fra molte empietà
paesistiche fin quasi alla città militare. Zona uffici, in largo
ungaretti. Deposito di cassonetti in larghetto Buzzati.
Palazzoni su c. linati e c. sbarbaro ostendono targhe
aziendali con “pericolo di morte”. Dequalificati appaiono
campana e brancati e bontempelli, accomunati nei vicoletti a
j.keats, e risicati spazi tra le facciate e fiancate e i ponteggi
per ogni manovrina d’auto come nei litigiosi garages
condominiali.
Ma cessati i casermoni da incubo, ecco lunghi tortuosi
serpentoni tagliati da doppie corsie attraverso le coltivazioni
dirette e le cascine frananti, nella solita campagna laziale,
tra vastità inopinate nel vialone di pavese, nelle curve di
quasimodo e tomasi di lampedusa, nel rettilineo ancora di c.
levi per cui si rientra finalmente nella c. colombo.
Tuttora qui a Buenos Aires, nella stagione dei famigerati
bonds argentini, l’emblematico Teatro Colón è sempre
chiuso per degrado e restauri. (E ancora, chissà se Gadda ci
sarà mai venuto, nei suoi anni qui per la Compañía General
de Fósforos?). Ma le stesse disgrazie attualmente si
verificano in queste varie excapitali della lirica
oltreoceanica, già leggendarie per le stagioni sfarzose, i
cantanti illustri, i compensi da favola, il relax e la durata
delle voci prima dei cambi veloci fra climi e aeroporti.
A Rio de Janeiro, al magnifico Teatro Municipal con
facciata che compete con l’Opéra Garnier a Parigi, e un
insigne passato, la season offre solo una Giselle con il
proprio balletto. A Montevideo, un Trovatore e una Butterfly
con artisti locali al Teatro Solis, tutto un lindo colonnato in
stile termale Salsomaggiore/Montecatini. Foto dei nonni col
bicchierone purgativo al Tettuccio… Alle spalle, in un tristo
slargo Ciudadela/Reconquista, una cupa fontanella dedicata
a Lautréamont e Laforgue glorie locali affonda come le
facciate ‘parigine’ intorno, appena ottocentesche e già
frananti. (Ma non era nato a Montevideo anche il poeta
surrealista Supervielle?).
A Lima, già fastoso vicereame con ori e tesori degli Inca
nonché la Carrozza d’Oro, o del SS. Sacramento, della
celebrata sciantosa Périchole, animatrice di romanzetti e
operette e commedie e film, da Mérimée a Offenbach a
Thornton Wilder a Lord Berners… Fino ajean Renoir con
Anna Magnani in un technicolor da dopoguerra, e non già in
questo Barrio Palermo di Borges, bensì in una nostrana
Palermo sicula e barocca ricostruita stralunata a Cinecittà a
causa dei pali e fili elettrici spuntati nella sicilianità più
autentica dopo i sopraluoghi della Panaria o Trinacria Film
degli Alliata e Avanzo…
Ma sarà stato veramente vicereale, questo modestissimo
teatro di Lima, in un degrado e crollo di viuzze e viottoli
senza possibilità neanche di carrozzelle o carrettini, e in
programma soltanto una Bayadère? Però, con un Ballet
Folclòrico addirittura Nacional?
E allora, sarà stato proprio questo?
Solo a Sào Paulo, invece, almeno una parvenza di
stagione lirica: con Arianna a Nasso, Sansone e Dalila, e un
‘doppio’ Puccini–Menotti, Le Villi e Amelia al ballo. Ma senza
un movimento visibile accanto, nelle sere di botteghino e
spettacolo. «Per stasera, abbiamo ogni ordine di prezzi».
Prima di ogni Internet e delle semantiche descrittive o
comparative, i chioschi argentini erano pieni di giornaletti
con annunci gremiti di espressività linguistica. «Boca golosa
y culo vicioso buscan chicos copados y muy cariñosos para
realizar nuestras fantasías con mucha onda y mucho morbo.
Si son más de uno, mejor, para hacer cosas de hombres y
destrozar camas sin histeria ni traumas. Bienvenidos los
gordos y los monstruos».
E da Córdoba, da Rosario, da Tucumán, luoghi
indimenticabili “dagli Appennini alle Ande” (e forse con
emigrazione di Votini o di Franti?), “Busco culito caliente y
delgadito… Busco macho hasta 40 que le guste que le
rompen el orto… Busco seriamente verdadero esclavo, serás
entrenado, castigado y ingeniosamente torturado… Busco
màster muy dominante y immoral que me esclavice y
humilie a su antojo, y si es preciso utilice las manos…”
Me gustaría tenerte ya entre mis manos para darle un
toque personal a tu entrenamiento y enseñarte cual es la
mejor manera…”. Buscaría, gustaría, me encanta, el erótico
fruncir de cada orificio… Altro che le coppie in crisi e gli
intellettuali in crisi e le affettuose nostalgie da bestseller
nostrano per gli antichi sapori della nonna e gli odori della
zia?…
Ecco insomma perché le varie letterature sudamericane
partono così avvantaggiate nella resa espressiva? Pôle
position e degré zéro in qualunque object lesson di stilistica
minimale, le variabili più basiche del Desiderio popolare e
naïf: fierrero, fiestrero, franelero, fachero, mimoso,
temeroso, velloso, cosquilloso, enamoradizo, limpio, arisco,
altivo, lampiño, libriano, gordito, morchito, morocho,
morrudo, malenito, tiernito, grandote, divertido, delgado,
candado, calentón, recalentón, pintón, varonil… Quanti
istintivi realismi più o meno magici. E chissà quanti refusi di
stampa spinti verso Espressionismi o Scapigliature di micro–
violenze gergali e corporee, con le relative rendite di
posizione, allora. Ma adesso, chissà quanti siti di «culitos
calientes», per gli internettisti impenitenti.
“La Nación” spiega che il governo venezuelano e
petroliero di Chàvez compra i bonds argentini «a mille
milioni di dollari per volta» per accrescere la vulnerabilità di
uno Stato che non riuscirà mai a ripagarli. «Riesgosa
deuda»: debito pericoloso. Ma i vari media non spiegano
come fa il Venezuela, con undici milioni d’abitanti di cui due
milioni a Caracas, ad acquistare strumenti musicali e
insegnanti e locali per duecento o trecentomila ragazzi di
strada senza dar fastidio ai vicini con le finestre aperte. E
poi, chi compra i biglietti per ascoltarli in moltitudini di
concerti? Le agenzie?
E piove. Tristes Tropiques più Pensée Sauvage. Afflizioni
anche generalistiche contristano gran parte delle emozioni
metropolitane, soprattutto nei quartieri principali e storici di
tutta questa Capitale: benché destinazione marittima tanto
vagheggiata, evidentemente Buenos Aires ha sempre voltato
le spalle all’Oceano, come per rimirare soltanto il proprio
Centro.
Triste e solitario e forse anacronistico, il magnifico
albergo Alvear si conserva emblematico praticamente nel
nulla, in questa demoralizzata season 2008, col suo
stupendo irreale breakfast che riunisce adesso due diversi
pubblici. Tavole di businessmen in completi neri e camicie
bianchissime a spese di una Borsa che va malissimo.
Famigliacce abbienti e ordinarie con bambini che trafficano
fra computer e pennarelli e rifiutano i cibi ottimi. Sui
margini, più o meno spaesata e imbarazzata, qualche
caratteristica dama démodée evidentemente superstite dei
mitici fasti di una modernità finanziera e facoltosa.
Ivi appunto si alloggia. Ma ripercorrendo queste superbe
vie già residenziali della Recoleta, che facevano tanto Ville
Lumière, quante finestre spente con cartelli di vendite e
svendite. Marciapiedi già malridotti come a Roma. Negozi
deserti malgrado le liquidazioni pazzesche. Molti,
addirittura già chiusi.
E i caratteristici mercatini delle tazzine rotte mostrano
delle miserie da piangere. Una vastissima piccolissima
borghesia evidentemente poverrima. Forse addirittura un
Walter Benjamin si scoraggerebbe in questi passages dove
non si vendono merci, neanche piccole, e c’è ben poco da
flanare, lungo i viali ‘de Mayo’ dove miserande vecchiette
protendono le mani sotto la pioggia «para corner»… Altro
che (sempre con Walter Benjamin) «Passeggiando per
Milano — camminando piano piano — quante cose puoi
vedere — quante cose puoi sapere. — Molta gente per la via
— molta gente in Galleria»… “Oh, bella piscinina — che
passi ogni mattina” rimpiangerà poi Saul Steinberg.
In nuovi decenni e diverse sponsorizzazioni di tendenza,
prevarranno i pennarelli o le tastierine dei frugolini
spontanei? Anatomie del pensiero mitologico più complesso
in semplificazioni parlate e non scritte, paradisi involontari
di oralità schiettissima, bontà naturale umanamente ovvia,
soluzioni anche provvisorie di contraddizioni altrimenti
intrattabili entro le strettoie logiche e cartacee ormai anche
professionalmente sostituibili? Sostenibili? Passano tanti
autobus con “Destino Palermo”.
Praticamente, poi, cosa e come post–decostruire negli
eventuali riciclaggi dell’habitat, dopo i franamenti delle
costruzioni sul territorio a causa dei materiali eco–scadenti
e della mancanza di eco–manutenzione, in assiemi e
complessi dove ogni modo o mood di facciata e struttura e
progetto fa a pugni col look di vicini e contesti più o meno
pacchiani o cool…
Tutte colpe delle gran crisi attuali? Fanno davvero una
grave impressione, queste metropoli tropicali già
leggendarie, e ora così deprimenti e depresse, ricordando
quel loro vistoso dopoguerra di eccedenze e dovizie…
Tristi come quelle sventurate tribù primitive
dell’Amazzonia, si ripete guardandosi in giro. “Destino
Palermo”? “Destino Retiro”?
Giù per l’Avenida de Mayo, la gente fa ancora la fila sul
marciapiede accanto allo storico e sbrigativo Café Tortoni,
anche per poi dire “ci siamo stati”, come i gruppi di turisti
alla sala da tè Angelina, in rue de Rivoli.
E sono ottime, le frittatine e tartine di Tortoni, in un
tremendo bric–à–brac di mensole, ceramiche, vetrerie,
cimeli, elisir antichi, ciaffi e carabattole di tanghi Art Déco,
volute serpentine e turistiche di tavolini e abat–jour tipo
aspidi o cobra di ghisa.
Leggere o rileggere Le cru et le cuit o L’origine des
manières de table, qui? Lungo questi viali ‘de Mayo’, le
povere vecchiette continuano a tendere le mani sotto la
pioggia. Ripassano i soliti autobus «Palermo Lugano»,
«Palermo Toscanini», «Palermo Wilson», fra i marciapiedi
piovosi e i taxi vuoti.
Con questo brutto tempo, per utenti di culto, sarebbe più
in «Destino Palermo» o “Destino Evita”?
Lì accanto, un’immensa libreria dell’usato espone un (mai
visto) Tam–Tam del cugino Tillo: cioè Attilio Gatti, figlio della
zia Virginia detta Gina (sorella di mio nonno materno
Alfredo) e del generale Annibale Gatti, nonché fratello di
Mario, maggiore di cavalleria caduto nell'ultima guerra e
cugino e sposo (con le dovute dispense) della zia Giulia,
sorella della mia mamma, altra Gina.
Era un avventuroso esploratore incontentabile dell’Africa
allora più esoterica, con spedizioni tutte sue e
probabilmente rovinose ai tempi del suo collega Duca degli
Abruzzi. Tillo scriveva per il “National Geographic” e il
mercato americano, da bambini ci regalavano il suo Saranga
il Pigmeo, una fiaba in grande formato edita da Garzanti.
(Che pubblicava anche Vita di chirurgo e Nostalgie fra le
rovine del primario ospedaliero Andrea Majocchi, cugino
della nonna paterna e forse ispirato da Axel Munthe).
Tam–Tam è la vecchia traduzione spagnola (Editorial
Labor) di un Tom–Tom originale inglese, rivista da un
direttore del Museo Etnològico di Barcellona. Tante foto di
cercopitechi, gnu, pigmei, zulù, cobra, antilopi, ippopotami,
gorilla, capanne e baracche con miti e riti esotericissimi in
arcani sacrari pieni di stregoni e santoni fantasiosi fra
animali eccentrici e aggeggi iniziatici. Sempre lì in attesa di
sbandati viaggiatori a cui minacciare enigmi, rivelare
misteri, incutere incognite in tempi lunghissimi.
Ma nonostante qualche elefante e dromedario, per noi
incompetenti, questi scatti fotografici nell’Africa più
misteriosa e profonda sembrano piuttosto simili ai successivi
di Lévi–Strauss nel suo altrettanto profondo Mato Grosso.
Sottotitolo “La llamada de la selva», comunque.
E certo, leggere Tillo a Buenos Aires…
Si inizia il 27 gennaio del 1920, ma la narrazione sembra
spesso pendere verso il più paranormale e imminente
Artaud. Già nella prima pagina, alle dieci della mattina ma a
due o tre mesi di cammino da Addis Abeba, Tillo ammazza
un leopardo che sta assalendo «una corpulenta dama con
holgada capa de seda negra» su una mula imbizzarrita, e
con «improperios a los cobardes leprosos de su escolta»,
che «se hallaba recogiendo frutos silvestres para aplacar la
sed de su señora». Una Regina! Così il consorte, il Ras di
Amhara, gli offre una gran festa con cibi atroci e il dono di
un pugnale appartenuto a un Negus di almeno mezzo
millennio prima. Nella camera mortuaria di un’altra
enigmatica regina (Candace, conquistatrice di pezzi
d’Egitto, ma nel 700 a.C. circa), dopo «la sucesión de
corredores, rampas, cámaras, hornacinas, maravillas de
ladrillos esmaltados, frescos, estatuas y esculturas» per cui
occorrerebbe una iconologia “de que no dispongo en
absoluto”, un raggio di sole al tramonto penetra
esattamente in un cubo di 6 metri di lato scavato nella
roccia viva, e fa danzare come grandi vipere sei lampade di
bronzo identiche. Mentre il sapiente e misterioso Ali el–
Bahuri accresce i misteri, come in aspettativa di qualche
Indiana Jones. E Tillo, che ha interpellato dei vecchi saggi
(taluni conosciuti e rispettati, lì, altri meno), preferisce
intrattenersi sul problema se ‘Candace’ sia un nome proprio,
o un aggettivo che significava «regina», e dunque
applicabile a qualunque sovrana. E inoltre, quale opinione
risulta scientificamente corroborata?
Ma intanto, «lo struzzo a sei zampe» appare formato da
tre boscimani coperti di piume che si appostano agitando un
falso collo per cacciare le struzze.
Poi, misteriosi segnali di fuochi fra «torres y crestas de
montaña monolíticas con forma de gigantescos monstruos
prehistóricos, perdidos en un mundo ciclópeo». Qui, chi si
avvicina viene bombardato con «gran cantidad de enormes
piedras» dai terribili uomini bianchi primordiali che «ningún
ojo puede ver»; e le tribù terrorizzate della pianura
mostrano infatti una «espantosa criatura», già gran capo dei
«tarotes» che si era avventurato fra quelle piramidi
granitiche, ma catturato da quei tremendi «blancos» era
stato condannato da una loro spietata regina tirannica al
taglio di mani e lingua e orecchie, e allo strappo degli occhi,
come orribile esempio vivente delle sevizie per chi violava il
‘Musungo’. Ecco dunque le foto delle rocce ciclopiche, e
della «roca protectora bajo la cual Gatti y el profesor
buscaron refugio de las piedras que contra ellos hacían
rodar los hombres blancos de las montanas». E accanto, foto
affascinanti di una «danza secreta de la pitón» iniziatica
(nessun maschio zulù può contemplarla) per stupende
vergini cariche di collanine e treccioline impregnate di
grasso animale. Sennò, i soliti accampamenti e canneti e
camion insabbiati fra giungle e savane molto selvagge e
tribù estremamente primitive. Pitoni, gorilla, curiosi
coccodrilli nei fiumi da attraversare immersi fino al collo,
benché completamente vestiti con sahariane ed elmetti e
tutto. Queste foto di Tillo e Lévi–Strauss mostrano formali e
sostanziali analogie nell’Africa profonda come
nell’altrettanto profondo Brasile, fra le capanne e baracche,
i ranghi tribali, le danze di guerra e di pace, i riti ovviamente
esotericissimi, i sacrari sempre arcani e pieni di stregoni e
santoni carichi di pelli d’animali bizzarri e aggeggi esoterici
e piume in testa come alle Folies Bergère d’una volta, su
facce inceronate e pitturate come i soliti Kandinskij o Klee
seriali, piercing di labbra e nasi e orecchie e sopracciglia
tipo logo–Artaud di massa… Certi torinesi di una volta
consigliavano piuttosto le ricerche scientifiche sui Bororo di
un loro Padre Colbacchini, ai primi del Novecento.
Arenili molto desolati, leoni appostati, foreste bruttissime,
indigeni più o meno inospitali, barche con rematori
generalmente noiosi, chiappe con scadenti maquillages
astrattisti… Fotografandosi volentieri durante gli incendi
delle barriere circolari di sterpi intorno ai villaggi degli zulù
ostili, e nei trasbordi sotto Mogadiscio o sul Mar Rosso in
vecchie “carrette del mare” con strampalati compagni
affetti dal medesimo «mal d’Africa». Un dottor De Croci
conoscitore dei dialetti nativi; un Trubetzky polacco sempre
ubriaco e bestemmiatore antimaomettano; un saturnino
Conte Vitaloni diretto a Yedda per sposare in un
inenarrabile labirinto dopo una coincidenza di sogni
telepatici una principessa locale Delia Matahouie in toilettes
parigine ma troppo somigliante a una Miss Biologia Marina
già incontrata su un fetido cargo in avaria e specialista in
protoplasmi di profondità… Ma quando Tillo fotografa
Vitaloni su una chaise–longue entro un volo d’uccelli
verdazzurri, a bordo, la lastra poi sviluppata (e qui
pubblicata) mostrerà «il sogno del Conte» circondato e
infastidito da una danza di arabi mediocrissimi. (E i
narratori fantastici, giungeranno dopo?).
A Sào Paulo, sull’incasinatissima Avenida Paulista, il
centenario Manoel de Oliveira, festeggiato coetaneo ‘cult’ di
Lévi–Strauss, ha testé girato uno spottino subito applaudito
a Venezia, con due imbranati da barzelletta che insistono a
parlarsi coi telefonini, tipici coglioni metropolitani fianco a
fianco in mezzo al traffico, senza potersi sentire, invece di
far qualche passo giù nelle calme vie del lusso, ove si
inanellano e spalmano le più celebri griffe, gomito a gomito.
E i più eleganti alberghi minimalisti, con «caviar and
champagne bar» e poltrone di cordami annodati (design)
per costose birrette fra siciliani giovani e vecchi con
mazzette di banconote da spartirsi, tipo Caraibi. Ecco qui i
quartieri esclusivi e alternativi di tendenza, ormai in ogni
città, dove le mappe zainettistiche spingono i cloni e zombi
cool a bocca aperta e bottiglietta in mano per «sbirciare lo
shopping dei ricchi, esplorare i ritrovi di artisti bohémiens,
sorseggiare una consumazione in locali di movida fuori dal
coro, con intellettuali e comici irriverenti, stilisti appartati e
schivi, rockstars di passaggio e impietosi complessini
scomodi e trendy».
Davanti all’étalage delle liquidazioni e svendite, nei meno
opulenti passages, fra titoli con “Rebelión” e “Represión”
strillati dai giornalai, torna in mente il “Bombardieri” di
Voghera, così chiamato perché urlava appunto «Bombe!
Bombe! Bombardieri!» per vendere i giornali della sera,
verso il 1942.
Magari istintivamente si ricercheranno boutiques di
«Rebelión & Represión» o «Represión & Rebelión». Ma
“Decadencia y resistencia, ciau ciau” pare el saludo più cool,
tra i flâneurs davvero in.
Così i più depressi o perplessi alunni melanconici e
saturnini dei Panofsky e Klibansky, forse devoti australi
peripatetici o solo patetici e periferici, intorno alle mode tipo
Derrida e Foucault, magari erratici flemmatici o lunatici tra
caipirinha fusion e bling–bling mojito e batidas multi–etno,
forse qui andranno chiedendosi se in tutta esta fatal tristeza
tropical bisognerà ordinare qualche rap o reggae
Paraguayo, rave Uruguayo, fusion Nabunimbwa o
Nambikwara, progressive Guanabara, hardcore
Tarahumara, dancefloor Mundunku, heavy metal Musungo,
Puerto Deseado blues o punk o funk o blog o lounge o
garage o brut?
Su per questa trafficata avenida può anche far paura il
terribile e irreparabile ma importante Museu de Arte
(MASP), che vuole adattare la brutalità cementizia della
costruzione al gusto civettuolo delle opere donate da
collezionisti molto convenzionali e soft. Tanti salotti adatti
per un Settecento francese da nèi e cicisbei, con arredi fra
le boutiques e senior suites «ovattate e felpate» e gli stand
domenicali dei «rigattieri per gioco».
Quindi, un frequente riciclo delle collezioni permanenti
con titolazioni «intriganti» suggerite dagli accostamenti
tematici. Dunque, per lo più, mitologici e galanti. Così, lungo
tramezze e transenne ondulate e sbieche in vari vivaci verdi
e rossi e blu, tra fili e cavi e tubi sospesi, come nei primi
ristoranti milanesi di design snob che ‘evidenziavano’ le
condutture dell’aria condizionata e dei cessi, la “superficie
delle cose esistenti” evoca soprattutto lusso e calma e
voluttà e ‘Setteciuento’ per madame, con qualche dormeuse
e abatjour. Mitologie, mitomanie, impressionismi, rococò.
Arianne più o meno abbandonate, Maddalene pentite (o
impenitenti), Pompadour pastorali e citeree, Cupidi
trionfanti o castigati anche in porcellane e ricami, paesaggi
e nature morte o fioritissime in esterni/interni di tendaggi e
arazzetti e cuscini, fra schiere di Santi puniti (Gerolamo,
Sebastiano, Rocco, Antonio, ecc.) e Madonne botticelliane
noncuranti e festini di Priapo e Poussin e culone di Renoir.
Gran frullati o pannoloni extra–morbidi per grandi e piccini
d’ogni età. Euridici e Lucrezie più o meno addolorate, Mosè
e Adamo e Atteone abbastanza rincresciuti, fra Mantegna e
Modigliani e bronzetti, Cézanne e Magnasco e Picasso, un
ottimo Giampietrino, un ambiguissimo Perugino,
un’elaborata macchinosa “Resurrezione” di Raffaello, un
Rembrandt con collana d’oro,‘poteries’ e Boldini e Van
Gogh. E vari eccellenti veneti con opere anche «di seconda».
Nonché un ritratto poco somigliante di Gianfranco Contini
(1928) di De Pisis. Chissà se è conosciuto, da noi.
Mi torna in mente una involontaria ‘scoperta’. A Bombay,
dopo aver rivisto le sculture al pianterreno e le miniature al
primo piano, una volta si sale al secondo ove tra molti
ordinari Canal Grandi e Piazze Navone cheap della
Collezione Tata ci sono evidentemente sempre stati un
Bonifacio Veronese vero e un autentico Dosso Dossi («Arrivo
di Bacco a Nasso») già creduto scomparso.
E può tornare in mente che davanti al guardaroba del
Palace di Sankt Moritz tanti anni fa pendeva una copia forse
ottocentesca del «Bacco e Arianna» di Tiziano, analogo
perché proveniente dal medesimo «camerino d’alabastro» di
Alfonso I d’Este. Nella grande e naturale prevalenza degli
italiani, qui a Sào Paulo, molti moderni inviati dalla
Farnesina: egregi Melotti, Pomodoro, Consagra. Ah, poter
tornar bambini, con lo sguardo dell’infanzia privo di
pregiudizi cronologici o metaforici; e ammirare con
sincronia cool priva di déjà vu le variazioni locali sul
cubismo e «Guernica», il surrealismo naif, gli impegni di
lotta, i muralismi da campesinos messicani.
E se un eventuale frugolino in passeggino rompe
fragorosamente le palle e protesta perché forse non gli
piacciono un Candido Portinari o un Piero di Cosimo, quale
paparino o mammina si permetterebbe di redarguirlo — “ma
sono bambiiini!” — lì davanti ai mini–Goya degli
ambasciatori e ai commessi degli ascensori in costume?
Soprattutto a Sào Paulo e a Rio, ormai abbondano i
monumenti esterni voluminosi e vistosi, ma estremamente
economici e praticamente indistruttibili.
Infatti, ammiccando furbamente e saggiamente agli
‘allestimenti’ e ‘installazioni’ nelle grandi mostre e fiere
internazionali e aste ‘da capogiro’, basta evidentemente
scaricare una quantità di lastroni, pietroni, roccioni grezzi o
semilavorati, magari griffati con un «by» come jeans o
profumi di moda, in mezzo ad aiuole morte o morenti,
davanti a siti di performance e loft controcorrente. Molti
quadratoni di ciottoloni levigati, sempre sostituibili come i
sampietrini. Avanzi e rifiuti siderurgici tinteggiati. Tuguri
graffittati e dichiarati artistici con expertise dei galleristi
che li hanno prodotti. Cementi armati con gli scoli da
sottopassaggio–latrina e le branchie rugginose che
sporgono come per impiccagioni senza complimenti.
Definitivi e démodés, inattuali e irreparabili come cantieri
lasciati a metà su territori mafiosi, i grossi musei edificati
nel dopoguerra danaroso oggidì somigliano alle tante
impalcature di cemento disarmato e deteriorato con gli
ossessivi VENDESI SU ogni piano fra le putrelle sporgenti. E
davanti al Museo d’Arte Moderna di Rio, così cementizio e
metallurgico, ci si domanda come diavolo andò a fuoco anni
fa, distruggendo il 90% delle collezioni. Peggio che un coro
ligneo? Lo si ricorda appunto costruito (com’è tuttora) in
materiali da ponti e strade o stazioni, solitamente
ininfiammabili. E con un ristorante sotterraneo, benché
davanti a una vista mirabile: dunque detto «il bunker di
Hitler». Ai vari piani, invece, tuttora, per dare aria, sempre
più d’una vetrata aperta, con rischi atmosferici per certi
surrealisti e cubisti.
Ma del resto, neanche tanti anni fa, in una prestigiosa
mostra dei tesori dell’Ermitage a New Delhi, i migliori
Botticelli e Raffaello e Correggio e Tiziano e Pontormo e
Lotto e Domenichino e Guercino e Reni di San Pietroburgo,
anche su tavola, erano esposti ai monsoni da tutte le finestre
spalancate. Altro che microteche e climatizzazioni
individuali.
Ora il vecchio scheletro disastrato ospita la grafica di
Mimmo Paladino, la retrospettiva di una vecchia paesaggista
locale, la collezione fotografica di un anziano diplomatico.
Ma gli spazi cavernosi non sembrano attirare la stessa
utenza giovanile che fa le code per gli hangar e capannoni
dismessi nell’archeologia industriale europea. E i giardinetti
lì davanti, del rinomato Roberto Burle Marx, consistono
adesso in alcuni riquadri di vecchio cemento con acqua
ferma e sporca, tuttora pieni di ciottoli tondi. La classica
“minestra di sassi” nelle isole greche: ben muschiosi.
Ivi pochi antichi barboni dormono o muoiono fra i cartoni.
Neanche un saccopelista. Le guide informano che la
“bohemia carioca” si è spostata altrove. Ma anche al
grandioso e tradizionale Museo Nazionale delle Belle Arti,
accanto al pomposo teatro dell’Opera che quest’anno dà
solo Giselle, sulla fondamentale Avenida Rio Branco, alle
spalle della popolare Cinelàndia, sono aperte soltanto le
stanze delle avanguardie brasiliane ormai storiche, a metà
del Novecento.
Almeno, l’analogo Museo Nazionale di Buenos Aires
(MNBA) tiene aperte benissimo le sale delle collezioni
epocali, con opere illustri, e un ottimo catalogo storico e
pedagogico. Fior di barocchi, fiamminghi, impressionisti e
avanguardisti popolari o pompiers, con paesaggi sconfinati,
scoperte della luce e dell’ombra, aggiornamenti sulle
tendenze, idilli creoli, pescatori al tramonto, polluzioni
dilaganti, precolombiani andini, intimismi cinetici, arti
povere o disagiate, sogni e fantasie di gauchos e salons.
Rubens, Rembrandt, Tintoretto, El Greco, Goya, Manet,
Courbet, Redon, Guardi, Pettoruti, Bugiardini, Brughetti,
Bigatti, Grippo, Guttero, Sivori, accanto agli sviluppi
realistici e astratti e neofigurativi e concettuali e pop e op e
tradizionali e geometrici di Córdoba e Tucumàn e Mendoza
e La Piata e ballerine di Degas eccellenti per qualunque
scolaresca, dopo tante secessioni e trasgressioni omologate
o irriferibili. Appena lì fuori, però, una terribile Facoltà di
Legge più nazi di qualunque Haus der Kunst. Benché
identici a sé medesimi in tutt’Europa, dalla Pomerania al
Cilento, i graffiti sono qui generalmente politici e leggibili,
con risentimenti etnici e rivendicazioni corporative e livori
estremi, in vernici per lo più nerissime ma non
emblematiche, e senza sperdersi a marcare i territori di
bande o di stronzi, o a segnalare in linee curve lo spaccio
più prossimo. E specialmente a Rio, nel centro, intorno ai
tribunali trafficatissimi, ogni obelisco liscio o grezzo già
carico di sbaffi porta slogan strafatti uso “Basta con la
repressione!” o “Abbasso la dittatura delle toghe!”, con
qualche colore in più. Striscioni consueti fra i gazebi di
protesta. Attendamenti abituali per commemorazioni di
genocidi. Mambi e sambe che strillano “pobrecitos y
pobrecitas” fra esposizioni di frequenti «Tendencia e
Discrepancia», «Aspirafòes e Sonhos», «Movimento Arte»,
«Novembro Arte Contemporanea”, “Novissimos 2008”,
“Amarelonegro Arte”, lofts, sprays, performances, siti
alternativi esclusivi.
Fra slarghi e spiazzi e viadotti e vialoni centripeti e
popolosissimi, intitolati con lapidi sfregiate a innumerevoli e
fondamentali date patriottiche, santi e statisti e navigatori e
generali ‘carioca’, sopra smisurati banchetti di chincaglie e
manicaretti con ingredienti orecchiabili, fin troppo:
carapulca, chiclayana, peclunga, mondongo, culandro,
choclo, huacacacatay.
Conghe e milonghe itineranti e intriganti come bossenove
e macumbe e fiaccolate mozzafiato, outlets di sambe e
carambe e sambodromi multi–brand, tanghi e manghi tra
disagi d’élite e garbagi radical–chic…
«Allacciamoci nel fango — belle pupe cuor d’orango»
canticchiavano i gagà d’epoca nelle rotonde sul mare, o in
qualche chalet di mezza montagna, mentre gli alunni
nostrani di Cole Porter pasticciavano con “tropic” ed
“exotic” e “neurotic” fra un “In Love For Love” e un “I’m an
Indian Too”.
«Està samba brasileira», par di rammentare che cantasse
la bella Katherine Dunham, ammiccando fra amache e
ventagli. Memorie involontarie?
«Cachaga», che sarà mai? E una «Cidade Eclética»?
Ma dove saranno i ‘crooners’ d’antan?
“Dalle da bere dell’acqua ossigenata, “poiché l’ingrata —
spietata fu con me!”.
Fra navate e sambodromi, forse qui si potrebbe far
sorridere, un pochino, con qualche sofisma o arzigogolo
molto teoretico circa il corpo, il dono, i valori e lavori e
plusvalori dei sottoprodotti di sfruttamenti anche epidermici
e casual, fra scambi e rendite, capitali e interessi…
… Nell’afa provinciale degli Stati Uniti sudisti, sarà stato
regolare (prima dell’Aids) che il sabato sera i camion
dell’esercito portassero le accaldate reclute in qualche
ranch molto sportivo for men and boys nel deserto, dove nei
cortili dietro o nei backrooms i sottufficiali si limitavano a
osservare l’andazzo, finché veniva l’ora mattutina di
ricaricarli spossati sui camion e ricacciarli sulle brande nelle
barracks…
… E in seguito, smaltita la routine militare, nelle comunità
delle industrie spaziali che in Texas (presso Houston)
ingaggiavano migliaia di giovanotti lavoratori ancora single,
ogni settimana i più avvenenti “nuovi arrivi in città” si
presentano ai già integrati in gigantesche discoteche ben
provviste dei più tecnologici proiettori e sound systems dove
le più tradizionali e matronali glam–trans sovraccariche di
piume e lamé e paillettes e cicce impongono alle polpose
matricole uno strip–tease il più ruffiano possibile.
Concretamente valutato in base alla quantità di dollari
imbucati nelle mutande e nei calzettoni dai pretendenti
apprendisti. E alla fine, via coi camioncini dei nuovi amici,
per lo più trucks di teams di gay carpenters, electricians,
bricklayers, reclute in analoghi laboratori spaziali…
Nella più antica Ferrara mitica e tipica, intanto,
proverbiale territorio di ‘busoni’ padani e segnacoli
metafisici, un’alta ciminiera dechirichiana si ergeva fra gli
arbusti e cespugli (‘broussaille’, ‘maquis’) sulle macerie
bombardate presso la stazione. E segnalava anche ai
viaggiatori dopo il crepuscolo i vasti spazi per gli sfoghi
reciproci, senza problemi tecnici e senza ricorrere a parchi,
giardini, bastioni, mura merlate, prode complici o cinema
galeotti, a Ferrara. Altro che “camerini”. D’alabastro, o
meno.
Alle cascate di Iguazu (o Iguagu) scattano subito i
paragoni con quelle africane di Victoria, meno molteplici ma
forse più impressionanti per la caduta possente e massiccia.
Un albergo di lusso coloniale inglese là, sullo Zambesi, fra
Zimbabwe e Zambia. Qui invece tipicamente americano,
dalla parte argentina.
Scenari spettacolari di cataratte e rapide e vortici
sfrangiati e multipli, tra i vari fianchi e versanti. Fragori
acquatici ovviamente “del Diablo”. Giammai “de la Virgen” o
“de la Cultura” o “de la Cruz”. Forse meglio che sul
Niagara? Qui, “Aventuras” organizzatissime, con tempi e
partenze e prezzi di gran tassatività: nella giungla, fra le
rapide, intorno e sotto le cataratte, nell’ecologia ogni 15
minuti, ‘nautical’ ogni 20. Circuiti superiori e inferiori,
trenini. E si arriva dopo colazione, per ammirare il tramonto
e le sue fasi. A letto presto, naturalmente. Levata mattutina
per l’alba e poi le ‘avventure’. Viste splendide. Nel
pomeriggio, ritorno a Buenos Aires o a Rio. Fine della
vacanza? Macché.
Forse paradossalmente il più sgangherato Barocco
religioso si ritrova nella terribile Cattedrale modernissima di
Rio, simile a una piramide sacrificale o a una centrale
nucleare — Yucatán, Chernobyl — in cemento recintato e
deserto entro e sotto un pesantissimo traffico di viadotti,
tangenziali, code, bretelle, svincoli. E chissà quali
imprecazioni motoristiche. Sull’entrata, né Madonne né
Santi, ma un gran cartello: «Energia eficiente, Iluminagao
inteligente».
Dentro, un buio sinistro di vetrate cupe. Minacciose.
Macché trasparenze solari gotiche tipo cinema favolistico
e didascalico per illuminare le anime medioevali più semplici
in tutta chiarezza e letizia. Come le miniature sui codici, o il
bianco–e–oro e i cieli squillanti delle vecchie magnificenze
ripulite. “Culi di bicchieri colorati”, piuttosto: come avanzi di
quei servizi da tavola al mare cheap e autarchici ma non
volgari nei supermercati dell’altroieri. Poi riusati in vari
cancelletti molto artistici, a Venezia e a Roma. E pomeriggio,
i credenti non si fanno vivi, e noi fedeli turisti ci avviamo
all’unico taxi in attesa. «Tranquilli. Potete chiudere».
In Brasile, come del resto anche a monte, nell’atavica e
melanconica “Lisboa antigua” (e non solo fra i mesti
aborigeni Nambikwara e Bororo), ovviamente echeggia tutta
una saudade generalista e tristeza full time in concert e
tour. Lutti continui e rituali 24—ore anche dispendiosi, con
tutto quel caduveo e candomblé fra “La casa portuguesa” e
il Mato Grosso e le favelas e il sertào. “Bachianas
Brasileiras” e «Suadades do Brasil». Magari il fado funebre
della perenne Amalia Rodrigues, e l’altrettanto imperitura
Juliette Gréco, con «Je suis seule (o seul) ce soir, avec ma
peine» e parecchi “jadis” e “c’est fini” assai lamentosi sui
walkie–talkie di poco allegri accampamenti… E
naturalmente, «depressào anaclitica» e “posigào
depressiva”, secondo le autorevoli diagnosi delle scuole
freudiane poliglotte e dei fondi monetari internazionali, a
proposito dei bonds–spazzatura.
Su un colle o cocuzzolo, nell’impervio monastero di Sào
Bento, tutto racchiuso in una sua tenebrosità molto legnosa
e un po’ navale, iperdorata benché benedettina e non
gesuitica, e contraria ad ogni ‘vista’ a dispetto della
stupenda posizione panoramica da “petit hotel de charme”
su una delle baie più belle. Nessun credente, malgrado gli
ascensori che perforano la salita.
Tre coppie di turisti, con tre taxi fuori.
Ma almeno un grazioso numero: un pretino o fraticello
che insegna a un altro fraticello o pretino innumerevoli
evoluzioni e inchinetti davanti a un gran numero di altari,
altarini, Vergini e monache sante, con reverenzine e turiboli
e pissidi. Come si ammiravano a Salisburgo, tanti anni fa, le
concordate cerimonie dei camerierini austriaci perfetti che
levavano contemporaneamente i coperchi argentei dai pesci
o bolliti d’ogni commensale a tavola. Si ritrova lo stesso
addestramento sullo scomodo volo antelucano da Rio a
Lima: una hostess insegna a versare il caffè a una novizia
spaesata e peciona.
A Lima, altro che Immaginazione al Potere, nei giardini
del Palacio de Gobierno. Un vastissimo ‘pavillon’ di fattura
quasi squisita, nel gusto parigino della Gare d’Orsay e delle
cancellate del Pare Monceau, benché assai più moderno.
Come d’altronde il vicino Arcivescovado, tutto un merletto di
stucchi e trafori post–coloniali nuovi e post–Liberty
recentissimi. E a fianco, la Cattedrale tutta linda e ‘neo’
dopo tanti terremoti e restauri.
E la “Fiesta de la Juventud”: lo si legge su tante
magliette. Dunque, tra le inferriate del Gobierno spalancate
sulla vecchia Plaza de Armas, un gran palco di rock in
concert con giganteschi amplificatori. E migliaia di alunni,
nelle divise delle scuole evidentemente meritocratiche, per
élites vastissime. Ragazze in giubbotti rossi e bianchi come
la bandiera nazionale. Scolaresche miste in abiti verdi e blu.
Maschietti in nero e camicia bianca, tutti orgogliosi in
cravatta. Altri in costumi ricchissimi di velluto azzurro con
ricami dorati e sonagli ai polpacci. Truppe e cadetti inca e
tupamaros molto folk. Ma senza turisti. Tutto per uso
interno. Jeeps, caschi, elmetti, camionette di «Emergencia»,
«Asalto», pronti soccorsi di «Ambulancias Roma” e
“Bombeiros Sanitarios” abbondanti e attendenti, sotto i
dum–dum–dum del rock. Aiuole di fiori perfetti, su tutta la
Plaza de Armas. E in tutta la città, sfasciata e smisurata,
neanche una cicca per terra, giardinetti accuditi, poliziotti
armati ad ogni incrocio. Sarà una dittatura autoritaria? Un
patriottismo o nazionalismo inca, andino, illimano,
amazzonico, meticcio, mulatto, creolo?
Gli animatori sembrano piuttosto agitatori. Ma le piccole
fans appaiono irreggimentate, disciplinatissime, e
soddisfatte. Anche i piccini. Un populismo autentico, verace?
E1 Presidente e i ministri e le ministre fanno discorsi di
«Viva la Gioventù» con appelli e auspici molto facinorosi e
tumultuosi al Cambiamento e contro lo Sfruttamento. Tutto
un sindacalismo governativo in forma di opposizione e
provocazione populista e aggressiva, per le varie categorie:
neo–avvocati spremuti negli studi legali, neo–dottori
spompati con turni impossibili fra ospedali e cliniche. (Par di
riascoltare Marcuse, che ai suoi bei tempi venne tanto
applaudito all’Eliseo romano, per l’Associazione Culturale
Italiana delle sorelle Antonetto, perché non appena sul palco
si tolse la giacca con un gesto plateale senza precedenti fra i
docenti nostrani, generalmente privi anche di una camicia
bianca tanto impeccabile. Ma poi dovette uscire tra i fischi e
i buuu, perché scaduto il tempo una vociaccia urlò “er
professò deve annà a pranzo da Luisa Spagnoli!”, e scattò
una contestazione goliardica tipicamente di massa
pecoreccia).
Scoppiano invece qui le rivendicazioni nazionali e
governative sul Rinnovamento, per un orgoglio peruviano
anche ministeriale che andrà a decidere le riforme e magari
il riarmo con gran fede nei destini e talenti del suo Paese
amazzonico e andino. Con un suo evidente ‘Pride’
patriottico: né vendite né immondizie, sui marciapiedi in
strada. E tanti immancabili ‘sbirri’ anche nelle periferie più
disastrate e deserte.
Il complesso di Santa Rosa da Lima, a Lima, appare molto
più trafficato del popolare Corso Buenos Aires a Milano al
culmine delle liquidazioni. E anche un caro nido di memorie
per gli antichi cultori delle più mitiche Sante secondo quella
leggendaria Compagnia D’Origlia–Palmi, o Paolo Poli. Qui
tutto par rivivere, intatto. Ah, quegli indimenticati «Scignore
scialvami, la carne è debbole!» di Santa Rita, mentre Satana
la tentava sotto forma di fantasma dell'Amleto, ringhiando, a
Cascia e a Cortona e a Viterbo. E la sera dopo, untuoso, con
lo stesso copriletto, Polonio alla Regina: «Madamigella
Ofelia vuol vedervi». E Sua Maestà: “Uffa, quella noiosa,
ditele che non ci sono”. E lui: “Ma è pazza”. E lei: “Quand’è
così…”, allargando le braccia. Allora entrava la figlia,
squittendo: «Rosmarino rosmarino!».
Dopo quel “rosemary, that’s for remembrance”, qualche
Ofelia preraffaellita offre «pansies, that’s for thoughts»,
come si ritrova anche nel risvoltino inglese della Pensée
Sauvage di Lévi–Strauss, mantenendo il civettuolo doppio
senso di “viola del pensiero” e «pensiero». Come d’altronde
certe nostre canzoni della Belle Epoque declamavano
appunto “Pansé pansé, vuol dir pensate a me”. Mentre ai
tempi d’Oscar Wilde “pansies” erano certi vistosetti nella
buona società britannica. E magari “davano da pensare” alle
famiglie.
Sempre per gioco, Marlene Dietrich in calze a rete nel
saloon di Destry Rides Again canticchiava ammiccante
ironica «See What the Boys in the Backroom Will Have».
(Secondo Lord Beaverbrook, opera d’arte più grande di ogni
Venere di Milo). E più tardi Frank Sinatra, dopo “Star Dust”
come réclame per la coca, con “Strangers in the Night”
portava alle stelle i bar del racket dove nella più tarda notte
sconosciuti fino allora estranei si scambiano «glances and
advances, until the night is through». Occhiate anche al
buio, in backrooms? “Ma questo è il nostro inno!” si esultava
nei locali. Presto, però, i ‘movimenti’ avrebbero classificato e
sputtanato con etichette derogatorie i boys e i backrooms e
la cosa in sé. Ancora qua a Lima, nello storico e
affollatissimo habitat di Santa Rosa — ovvero Tacna, atroce
rione di botteghine per credenti e chiese commerciali e
mucho tráfico — “nel pozzo del giardino, va, Spoletta!”,
intimerebbe l’abominevole Scarpia della Tosca. Nel pozzo
del giardino, infatti, la Santa gettò le chiavi del suo cilicio.
Altro che «Mutande pazze!». Trionfi di pre–camp tropicale
già un po’ ‘cursi’? Ma nel giardino, ecco bassissima e
pendente anche la celletta in muratura uso nanetti da
giardinetto ove la Santa amava rinchiudersi piegata in due o
tre per giorni e notti di meditazione o fantasy. Così, qui
riappaiono le storiche leggende macabre di un genere
altrettanto ‘maudit’ sulle atroci ‘segrete’ piene di cacche e
scarafaggi dove i tiranni tipo Ezzelino da Romano o Bernabò
Visconti sopprimevano tanti poveracci fra innumerevoli
tormenti e cachinni.
Ed ivi ovviamente ritornano gli incubi infantili causati dai
film horror dei “telefoni bianchi”, tipo Il Leone di Damasco o
Pia de’ Tolomei ove Ghino di Tacco e Osvaldo Valenti o Carlo
Ninchi rinchiudevano Carla Candiani o Germana Paolieri e
altre infelici vittime legate come salami a un palo mentre
l’acqua sporca saliva fino al naso e i carcerieri ghignanti si
divertivano intanto a infilzare i detenuti urlanti come polli
nelle stie. Mentre gli attori alzavano il viso e si
preoccupavano sul serio, e secondo il Divino Poeta il
popolaccio gridava come alla partita: “Pisa! Vituperio delle
genti!”, “Lucca, pilucca, gentucca!”, “Siena mi fé, disfecemi
Maremma!”, “Pistoia degna tana di bestie!”. E il supremo
Totò, dopo vari «Ahi Pipì, ahi Pipì, ahi Pipìsa», a una
soubrettina che gli si presentava con “Certo non sono
Francesca! Sono più bella e più fresca! Sono più esotica e
strana!”, subito ribatteva:
«Ho capito! Sei Taide, la mondana!». Mentre la divina
Wanda Osiris, da parte sua: «Renzo intanto piano piano,
s’incammina per Milano, cià la testa che gli ronza, ma
s’attacca al tram per Monza, onza–onzaonzazzà». Nonché:
“Quale è il nome della suora? Chi non l’ha capito ancora? E
la Monaca di Monza, onzaonza–onzazzà!”. Ma intanto, “I
fratelli hanno ucciso i fratelli!”, «A lancia e spada, il
Barbarossa in campo!», «I fuochi della Lega rispondon da
Tortona!», «Il popol grida: l’esterminio a Como!»… E non
solo per vezzo e metafora, in campo o in lizza, come quando
sbadatamente si menzionano Oltreoceano il guanto di sfida
o spezzare una lancia levando gli scudi ai ferri corti… E un
fiume carsico, Oltreconfine?… Altro che le galanti ‘stufette’
cardinalizie con Veneri e Diane e Grazie in toilette da bagno
a gamba tesa.
Ma almeno allora ci si poteva divertire a buttar via il
bambino con l’acqua sporca, dalle finestre sulla via…
Forse potrebbe riuscire interessante e curiosa, per
qualche specialista di mythologiques, una ricerca teorica e
magari sul campo circa le ripetitive ricorrenze di fantasmi
Cines nell’Immaginazione religiosa e tirannica al potere fra
il Perù vicereale e quel Medioevo cattivissimo non solo fra
guelfi e ghibellini o Bianchi e Neri e leggendari Capuleti o
Montecchi, ma anche in centri piccoli come Parabiago: non
ancora calzaturiero ma in lotte fratricide tra un Lodrisio e
un Luchino Visconti. Con vari sottoprodotti di Generalcine e
Fonoroma e Manderfilm, a proposito di cene delle beffe,
disfide, corsari rossi e verdi, Fanfulla da Lodi, Lorenzino de’
Medici, Ettore Fieramosca, «Nel castello c’è un fantasma
originale! quando suona mezzanotte lui compare!», ma sarà
una macchinazione di nipoti ereditieri anni Trenta per far
venire un colpo a un cardiaco… Più popolarmente, qui la
Santa provoca abietti cumuli di bondieuseries in vendita
presso questi incessanti botteghini tra gli infiniti cinema su
Tacna. Strapieni anche di candele in vari calibri
(palesemente pornofallici) di consumo per le continue
fiaccolate di culto pop sotto le icone locali da album DVD
con zazzere zozze invariabili, cappellucci o cernecchi
immutabili, inalterabili smandrappate canottiere fra palme e
grattacieli da fiction, format, fantasy.
Nemmeno un accenno, invece, qui, all’omonima e
possibile ‘concorrente’ Santa Rosa da Viterbo, più popolare
certo fra noi e tuttora festeggiatissima con quell’immensa e
gravosissima ‘macchina’, nella sua ricorrenza e nella sua
città, e fragorose acclamazioni dei credenti locali. Carissima
(ancora!) nelle attempate memorie dei più devoti a quelle
solite pie rappresentazioni sotterranee vaticane, ove
appunto la religiosissima Rosa viterbese veniva
continuamente insidiata dalla pessima Strega di Vi
torchiano. Quando ancora la sua emula o antagonista
Margherita da Cortona andava menando vita purtroppo
galante, a Cortona. In questi assembramenti di religiosità
smisurata, ad ogni passo, rieccole! Contìnuamente ritornano
dal Rimosso, e attualmente rivivono! Qui a Lima, anche una
tradizione di Santi locali molto tìpici: abbigliati e addobbati
come i manichini in costume di scena ai musei operistici.
Talvolta con quegli occhioni sbarrati delle volpi argentate in
auge fra le signore negli anni Trenta. San Martin de Porres,
patrono dei parrucchieri dal Seicento a tutt’oggi, però, è
stato canonizzato da Giovanni XXIII soltanto nel 1962, dopo
aver sanato un paio di cancrene e occlusioni intestinali nei
passati anni Quaranta e Cinquanta, con illustrazioni tipo
“Domenica del Corriere” dell’epoca. Altro che “Fiesta de
lajuventud”.
Questi monasteri smisurati e intriganti almeno dal
Settecento si presentano adesso come principali curiosità
metropolitane, con tutto un tango o fandango di attrazioni,
chiostri e refettori e necropoli e cappelle e biblioteche e
catacombe e retablos che sommano Kitsch barocco
spagnolo con nativo Kitsch inca, mulatto, metìccio, creolo,
anche già camp e punk. E lì, fra Santo Domingo e San
Agustín e San Francisco e San Pedro e Santa Rosa e Las
Nazarenas e Los Descalzos e La Merced e i ritratti dei
vescovi e le pitture sacre dei naïfs di Cuzco e le reliquie
imbarazzanti e le donazioni ragguardevoli e i tesoretti in
metalli molto massicci, le teche e bacheche con reliquie
strapiene di suppliche si affiancano ai cartelli che
ammoniscono di non scrivere sui muri perché «è mancanza
di educazione». Nei sotterranei di San Francisco, con una
quantità di crani e femori sono stati composti degli artìstici
rosoni pavimentali, secondo le consuetudini cappuccine
mortuarie. Nel sottosuolo dell’Inquisizione, poi, sono
ricostruite con manichini e strumenti veristici le più efferate
torture, con soddisfazioni evidentemente malsane dei
visitatori che si fotografano con gesti allusivi accanto ai
corpi incatenati e fustigati sconciamente divaricati come in
quegli effimeri backrooms fin troppo esagerati negli anni
Sessanta.
Memorie sanfranciscane e newyorkesi d’epoca, per
anziani sopravvissuti alle epidemie: ah, the waterfront area,
ah that meatpacking district… E i pentolini che bollivano per
la cera sui corpi, tra le flagellazioni e fustigazioni e le
sculacciate e le cinture chiodate, e le vasche delle deiezioni
per le mortificazioni, fra violentazioni e altre punizioni che
evidentemente sopravvivono solo nella pittura sacra, in
qualche parrocchia fuorimano, su Internet… Nessuno
tuttavia pare voglioso di spingersi fino al dimenticato
convento dei Descalzos, olim fiorente in fondo a un
quartiere di giardinetti già pomposetti e ora abbandonati.
Ma i rustici strumenti in mostra accanto ai dipinti sacri
servivano solo a curare i malati e a fare il vino. Nella loro
rozzezza, niente di utilizzabile per assaporare il retrogusto
di qualche Tropicana o Trinidad o South American Way, o
approfondire lo stile e le opere di Carmen Miranda.
A Voghera, prima della guerra, quando le signore
portavano ancora i cappellini, la modista più pregiata era la
Descalzo, al pianterreno di casa nostra, sulla via Emilia.
Siccome era sempre spettinata, veniva soprannominata “la
Scavión”. Déjà vu, qua Tutte queste arti sacre vengono
prodigalmente incontro ai pii entusiasmi anti–igienici (e
prediletti dalle devote nubili) davanti ai ‘fioretti’ e ‘sacrifizi’
delle sante e beate che per far piacere al Signore e alla
Madonna o anyway avevano fatto voto di mai detergersi gli
orifizi dopo i bisogni e mai cambiar biancheria per decenni.
Suscitando interrogativi soprattutto clinici per le mancate
puliture dopo le escrezioni fisiologiche e patologiche
ovviamente presso Santa Rosa ma soprattutto negli ospedali
e lazzaretti con degenti infettivi in cura presso buone sorelle
così zozze e luride. Altro che cacce agli untori e Colonne
Infami per i manzoniani in erba.
O i lavacri igienici del Dottor Semmelweis almeno per le
mani di medici e infermiere e pazienti, secondo i più
diligenti lettori del Dottor Céline.
Quante tradizionali canzonacce goliardiche e ataviche,
piuttosto, tra i futuri professionisti e primari ospedalieri
nelle medesime famiglie e culture delle anziane credenti
puzzolenti. E quali cheap e deplorevoli distici, ancora con le
ditate, nelle ritirate studentesche, a proposito di “pezze” di
Sant’Agnese, o prodezze falloidi con binari e spilli dei Santi
Ilario o Cirillo. Magari, secondo pulsioni di una sudicioneria
originariamente innata e devota, benché negli idiomi e
ambienti più dabbene «una sporcacciona» emani giudizi e
fetori tutt’altro che educativi, in fondo.
Ai bravi bambini d’una volta, le care ziette
raccomandavano: per fare un piacerino a Gesù e alla
Madonna (che chissà come saranno contenti) fai il fioretto di
rinunciare alle primizie che preferisci. Però il fioretto o voto
non valeva se il piccino rinunciava agli odiati cavolfiori.
Oggi, poi, le primizie non esistono più perché la macedonia
e la vignarola si trovano identiche e pronte ai supermarket
per tutto l’anno. Ma allora (chiedeva lo sciocco bimbo),
perché voi non andate in giro col brutto tempo senza scarpe
tipo Scalzi e Scalze? A me d’estate piacerebbe, con i
contadinelli e i tirasassi, ma se poi mi sgridano perché
sporco il vestitino? Così, per i cattivi bambini d’una volta, il
colmo veniva raggiunto con la barzelletta dell’ingordo maso
che chiede al tremendo sado: “bacchettami! sferzami!
flagellami!”. E il vero sado, con un ghigno malefico: “NO”.
Ma intanto, mai un Santo Padre celebrato perché (come
le più venerate monache sante) non si cambiava la
biancheria sotto la bianca veste. O un bimbo lodato dalla sua
mamma come esempio perché non si pulisce il culito e non
mette a lavare le mutande sporche. (A Voghera, le vecchie
cameriere spiavano verso mezzogiorno la Marchesa Cacca,
detta così perché venendo dalla sua campagna a far
mercato in città, alla sua ora allargando le gambe in piedi
presso la fontanella di San Sebastiano faceva pipì simulando
una distrazione, poco importandole di venir sogguardata da
classi inferiori).
Pensierini devotissimi in una cattedrale deserta: se un
credente o un laico o un fedele musulmano o luterano o
confuciano o israelita o indù insiste nel maltrattarsi e
malmenarsi — o se giornalisti e politici giornalmente si
bacchettano e sferzano sui media, sibilando e ringhiando
spesso — a chi farebbe piacere soprattutto? A Giove e
Giunone, ad Abramo o Isacco, a Bacco, a Brahma, a Buddha,
a Gambrinus, a Cranach, a Dùrer, a qualche Papa o Santo o
Martire?
Alle Tre Grazie? Alle Nove Muse? A Mosè, o ad Aronne?
Alle Tre Madonne?
E se un frugolino più o meno grandicello prova un
normale dolore prima e un normale piacere poi (dovendolo
accidentalmente prendere dietro), a chi dovrebbe offrire
senza alcun secondo fine l’uno o l’altro o ambedue? Sarebbe
più contenta Giuditta o Salome o Dalila, fra le solite? O
qualsiasi Santa generalista?
O qualche specifica Beata locale?
Talvolta, in qualche cattedrale spopolata, a fianco
dell’altar maggiore si vede un Gesù di cartongesso o legno
dipinto nella tradizionale posa della Melanconia, di Dùrer e
tanti altri. Trauermusik o Trauerspiel boreale, nel più
profondo e triste Nord. Come si vide in una celebrata
mostra di Malinconie al Grand Palais, piena di Böcklin e
Fùssli e Sergel e Hopper, col sottotitolo di «Génie et Folie en
Occident». Senza ricorrere ai Tropici, tristi o allegri, o così
così. Con guance perplesse poggiate sull’avambraccio
stanco. Sovente, qua, in grandezza naturale e intenti
veristici: come nei migliori iperrealismi degli anni Sessanta
(D. Hanson, J. De Andrea…) cui taluni Italians rivolgevano
garbati “how do you do” nelle magioni di Park Avenue. Altri
Gesù postmoderni siedono in cheap T–shirts e posa
buddhista a palme aperte con o senza piaghe, come
prendendo il sole sul Machu Picchu, e lo stesso Sacro Cuore
delle solite magliette con “I love Jesus” (da discoteca
devota?). Immagini dolenti in vendita con la loro candelina
elettrica e ostensori raggianti sopra plaids scozzesi,
all’insegna di “Santa Maria de Cervellón”. Ah, la Scavión?
“Che macello!” e “che casino!” ridacchiano i ragazzini
che non hanno mai visto animali squartati o giovanotti in
camera, con le pensionanti della quindicina, in qualche
casino o macello ‘live’. «Che via crucis e che calvario!» si
arrabbiano i turisti del weekend. E mezza giornata in un
paio d’uffici sarà ovviamente un’odissea. Ma non solo nella
Turandot pucciniana, i gran dignitari Ping e Pang e Pong:
“Ha inizio la cerimonia! Andiamo a goderci l’ennesimo
supplizio!”, su libretto di G. Adami e R. Simoni. Durante le
guerre, e soprattutto l’ultima, in ogni città e paese ordinari e
amorfi burocrati si sono trasformati in capibanda di
torturatori inventivi.
Come piacciono sempre ohimè i tormenti, le sevizie, gli
strazi, evidentemente. I patimenti attraggono, anche fine a
se stessi. Quali elevazioni, ed erezioni, e magari deiezioni,
davanti a qualunque disgrazia e macello, o anche a una sua
buona rappresentazione. Palesemente, insegnano la Carne e
la Morte e il Diavolo (anche fuori dai migliori testi), ecco una
forte e diffusa costante caratteriale dell’animo umano? Fin
troppo umano.
Già con transfert delle proprie pulsioni a qualche
supposto ente sovrumano che nelle sue chiese dovrebbe
provare e mostrare lo stesso piacere degli spettatori
malvagi amanti delle rappresentazioni di sciagure e
massacri, fans anche a pagamento di stragi grandi e piccole,
antiche e moderne, etniche o sstoriche o geografiche o
geologiche o ideologiche o politiche. Crolli, naufragi,
incendi, eruzioni, inondazioni, polluzioni, eccidi e carneficine
abbondanti, al sangue.
«Fanno un po’ senso», allora, tutti questi immensi duomi,
spesso lindi e rifatti a causa dei terremoti, con tutta una
popolazione molteplice che passa davanti e non entra. E
anche il turismo credente difetta. Magari i fedeli nuovi
preferiscono le stragi vere in diretta, e i presentatori
televisivi ai predicatori che cercano di emularli con lazzi dal
pulpito nei dialetti locali?
A lungo ci si può aggirare, in queste capitali barocche, fra
navate lignee e nere altissime, cavernose, piene di Cristi
martoriati e morenti o già deceduti senza secondi fini
artistici o turistici. Molteplici Madonne in varie dimensioni e
altezze sopra altari multipli, orazioni e oblazioni richieste
per la beatificazione di frati del Settecento poco
riconosciuti. Innumerevoli cappelle e santuarietti laterali di
un “baroccoccodè” scrupolosamente sovraccarico.
Già da Carnevale al sambodromo? Sempre San
Sebastiano in gara camp con le Divine del Varietà? E ancora
Longhi: “I manichini ancheggianti del Perugino”. Chissà se
riferendosi a quel San Sebastiano ‘morbinoso’ del Museo di
Sào Paulo, già da gran carro per sfilata di Gay Pride. Come
se la copiosità dell’ornamento accrescesse la devozione, ai
Gai Tropici?
Ma quali ancestrali imbarazzi e impacci, nel
rappresentare le Tentazioni. Mostriciattoli bruttissimi che
‘tentano’ poveri vecchietti scarni nelle peggiori solitudini, e
non sono neanche interessanti… Mai una gioventù carina
con tentazioni reciproche. “Che schifo” borbotterebbe una
necessaria Tina Pica. D’altronde, in quelle memorande sacre
rappresentazioni nelle Caves du Vatican, qui rammentate e
commemorate con gusto praticamente a ogni passo, fra
analogie e coincidenze… Quel povero vecchietto a quattro
zampe, con una sconcia trapunta sulle spalle, faceva solo
“grrr grrr” alle anime belle di Cascia e Cortona che
eroicamente gli resistono. E poi diventano Sante del
calendario, con cappelle e venerazioni anche in Perù. Bella
forza.
Peraltro, anche l’accattonaggio molesto suscita rifiuti
automatici magari per le vecchie mendicanti musulmane
piazzate dai rackets sui gradini delle chiese cattoliche, in
Italia. E lì, con loro, invocare un’Ave Maria? Dentro, poi,
soprattutto qui, si ritrovano gli esempi nelle venerande pale
d’altare: pani e pesci una tantum, mica spesso. Ma dove
sono finiti, intanto, quei Miracoli rustici — delle Forbici,
dell’Imbuto, del Secchiello, del Setaccio, del Lettuccio con le
Piccine — già tanto frequenti negli affreschi di tutti i nostri
chiostri di conventi e monasteri, prima del Barocco? E
magari poco felici, nel messaggio e nel look, a causa di
bubboni e pustole gotiche. San Rocco sarà stato contagioso?
Nel Lazzaretto?
Ah, la Flagellazione. Che fissazione. Come piace sempre a
tutti, ai ricchi epuloni nonché ai poveri disgraziati, sia alle
massime divinità sia al grosso pubblico di massa. Che
successo costante, ad ogni livello, se non soltanto col solito
cliché mediático si fustigano i costumi pessimi e gli
avversari politici e sportivi, ma proprio fisicamente si
staffilano senza ironia i corpi soprattutto sul dietro con
autentico sangue e quei tremendi dolori che dànno sempre
un gran piacere a tanti sommi numi e devoti fedeli credenti
coinvolti a loro agio nelle varie belle arti e negli spettacoli
malvagi e in ogni sorta di fiction o Internet. Perfino nelle
fattispecie più intimistiche di “do–it–yourself ” come il cilicio,
gli aghi, gli spilli, le spine, i chiodi spietati.
Meglio che niente, sostengono le anime più belle.
Pazienza? «Tétlathi dé, kradie…Frenati cuore mio, ben altro
di più cane hai già dovuto sopportare», ci si insegnava,
traducendo Omero).
Sempre trovarobati sferzanti, bellissima roba, per
l’intrigante connaisseur come per il dilettante voyeur o per
l’eventuale “mascalzón latino” in preda a istinti pessimi.
Eternamente, evidentemente, sia per la religiosità spinta
come per la porcata spintissima, la solita turpe e copiosa
attrezzeria di fruste, sferze, staffili, scudisci, nerbi, verghe,
bacchette, ‘ferulae’ latine, ‘knut’ russi, gatti medioevali a
nove e più code, flagelli anche di Dio, da ringraziare o
aborrire in preghiera… Ed evidenti soddisfazioni, ‘live’ o in
differita o nelle arti anche minori: schiene e cosce e natiche
già striate in partenza da perfidi cilici, abbondanti cicatrici
da calvari, martiri, tormenti, strazi!…
Carnefici impietosi e soddisfatti di sbieco su corpi
sanguinolenti e purulenti! E chissà che parolacce! Castighi e
spasimi orrendissimi in affreschi, dipinti, polaroid, sculture,
filmini da pornoshop, autopunizioni tipo happening davanti
al grande pubblico o nella più stretta privacy con o senza
specchi o sound o rebound o replay o display… Anche fra
vecchietti purtroppo repellenti, in siti e portali ahimè
deplorevoli. Vergogna? Uffa?
Che imbarazzi, piuttosto. Non dovrebbero stare in un
Paradiso succulento, secondo tutta l’iconografia chiesastica
educativa e didattica, i vari castigati e puniti che Dante
colloca nell’Inferno?… «A la man destra vidi nova pietà, —
novo tormento e novi frustatori, — di che la prima bolgia era
repleta. — Nel fondo erano ignudi i peccatori… — Di qua, di
là, su per lo sasso tetro — vidi demon cornuti con gran ferze,
— che li battien crudelmente di retro…».
Ma i “cornuti” non erano oggetto di barzellette salaci e
cheap, una volta? E non dovrebbero essere tutti santi e beati
martiri, questi disgraziati vittime di pene fisiche identiche ai
tormenti e tormentoni impartiti con le stesse sferze e ferule
fornite ad analoghi frustatori della solita attrezzeria di nerbi
e flagelli d’uso e consumo religioso e pittorico?… «E io, che
posto son con loro in croce, — Iacopo Rusticucci fui, e certo
– la fiera moglie più ch’altro mi nuoce». Questa, poi!
(Inferno, XVI, 43—45).
Infatti, in tanti nostri dipinti rinascimentali, per lo più i
frustatori ostendono muscolose chiappe piuttosto pastose, in
faccia al pubblico.
Ed Elena Giusti cantava, in rivista: “Risparmia i tuoi colpi
— o mio bel tirator — come piccole volpi — son le donne e
l’amooor!”. Avanti, Grùnewald? Indimenticabile! La Passion
selon Sade, di Sylvano Bussotti, con la suprema Cathy
Berberian a un Festival musicale palermitano negli anni
Sessanta, consisteva in fulgidi vocalizzi su un bric–à–brac di
fruste e flagelli e cerchi uncinati alle tempia di tenori vari,
usando come strumenti musicali quei vari arnesi di tortura,
provenienti dal regolare trovarobato operistico del locale
Teatro Massimo. E nulla più.
Quante spiacevoli e cheap memorie infantili adesso
involontariamente recuperate dalla Terza Età più fisiologica,
davanti alle immagini più o meno visionarie di codesto
Inconscio cattolico latino–americano…
Brrr. Quelle vecchiette immancabili a ogni Prima Messa,
che facevano la Comunione ogni mattina, dopo aver
proclamato ad alta voce di aver grandemente peccato per
loro massima colpa… E prima della televisione, ci si
domandava quali peccati commettessero nei loro abbaini,
fra il latte e il gatto. Vanterie? Megalomanie? Antiche
assatanate nubili piamente entusiaste circa i fioretti e
sacrifizi delle migliori Sante e Beate, per far piacere a loro e
al Signore e alla Madonna facevano voto di cambiarsi poco e
mangiare pochissimo…
Così intanto risparmiavano. Bingo? Si soffre molto e
volentieri, facendo economia, intanto. Provocanti o
imbarazzanti Ritorni di tanti Rimossi, per pochi soldi nelle
apposite fessure sacre e profane sulle torture più
innominabili, anche di anziani, e talvolta gratis… Godimenti
psicosomatici stuzzicanti e magari seducenti per artisti
religiosi e pie devote con ormoni analogamente in
subbuglio, a queste latitudini, davanti alle flagellazioni e ai
supplizi così graditi agli Onnipotenti ispano–obsoleti molto
più tropicalsplatter ai Tropici che in Lituania o Lapponia…
Tantissimi artisti anonimi, in questo vicereame peruviano,
erano evidentemente «nati sotto Saturno», più che altrove.
Cioè, secondo Rudolf e Margot Wittkower, solitari, tribolati,
complessati, introversi, problematici, ossessivi, stravaganti,
eccessivi, evasivi, compulsivi, eccentrici… E dunque
propensi alla posizione classica della Melanconia: un look
molto desolato. Né Juventud né Fiesta. Sarà allora curioso o
scomodo contemplarne gli indiscreti eccessi o esiti, in
mancanza di meglio o di ecstasy?
Ecco insomma una quantità di Santi e Martiri più o meno
esotici e naïfs mentre si fanno più o meno grossolanamente
o scientemente turlupinare da qualche ovvio e scontato
Maligno che gli promette chissà quale Paradiso di
monsignori e cardinali e arcivescovi e arpe e angelotti
culotti se si fanno frustare e torturare da aguzzini bellocci e
cattivissimi per la gioia di un pessimo pubblico sadomaso
che ovviamente adora sempre le stragi e piaghe con tanto
sangue, ed esige fiaccolate notturne da tregenda circa gli
eccidi più eccitanti, ove non bastino gli accidenti stradali
anche diurni per saziare le foto degli astanti coi telefonini.
Mah, rieccoci infine qui davanti a televisori gremiti di
gruppi turistici anelanti e ansanti al Machu Picchu, peggio
che al Colosseo o a Pompei. Ma i viaggi più o meno
affascinanti fra le bellezze nell’antropologia culturale di
questi tropici peruviani tristissimi sembrano per lo più
diramarsi attraverso qualche ricco museo o luogo storico e
archeologico. Già residenze signorili importanti: quindi con
eccellente savoir faire nella distribuzione e nel taglio degli
spazi. Sale e saloni bene esposti e accoglienti, con
vegetazione confortevole in giro. E ricostruzioni con plastici
intorno ai relitti dei siti migliori. Per il gusto delle rovine, v’è
un’ottima Ciudad Sagrada, dopo le periferie di Lima, a
Pachakamaq o Pachacamac. Fornisce ‘thè best’ in materia di
mura e rampe e fondamenta e rimanenze ed ex–opulenze di
templi del Sole e almeno quindici piramidi provviste di idoli
e palacios e tutto — culture Wari e Ishmay e Inca e Lima,
con Oráculo, Adobitos, Caminos Epimurales, Plazas de los
Peregrinos, eccetera — senza le folle e le foto e gli spintoni e
i disturbi a tremila metri. Allestimenti piacevoli di collezioni
ricchissime soprattutto di ceramiche e terraglie e maioliche,
e tutto un mondo di morti animatissimi in aldilà fantastici,
sulle scaffalature ordinate e abbondanti al prospero Museo
Larco Herrera, nel distretto Pueblo Libre. Oltretomba
didascalici come nei nostri migliori schemi scolastici per i
cerchi e i gironi della Divina Commedia. Intriganti vasi
antropomorfi bruni con doppie cannelle o triple vaselle
come inquietanti incroci fra teiere cinesi e nanetti da
giardino. Che cazzoni, però.
Quanti stili squisiti. Epoche Formative, Imperiali,
Transitorie, Fluorescenti, Fusionali. Culture e necropoli
Chimú—Inca, Chancay–Inca, Chincha–Inca, Pukina–Inca,
Huarpa–Huari, Pukara, Paracas, Cupisnique, Pacopampa,
Chanapata, Chirica, Curayacu, e tante altre, fra il periodo
pre–ceramico e quello coloniale… E tutti questi cazzi
enormi, di gnomi senza collo, nelle bolge molto festive dei
lussuriosi Inca, in una sezione per adulti con fellatio
naturalistica, muertos mas turbándose, tocando vulvas
desmeduradas, coito anal frequente e insistente, fra nanetti
bassissimi con gambotte assai brevi.
Gli ori e gli argenti sono invece soltanto cerimoniali, come
le acconciature di piume di gala. Per la quotidianità,
piercing in tutta la faccia, con ossetti evidentemente cheap;
e tessuti elaboratissimi, pazientissimi, quando il lavoro sarà
costato poco o niente. La sera, crostacei turistici in rotonde
sui moli del tenebroso Oceano Pacifico. O manicaretti andini
tipici «a la parmesana» con tante patate, fra Strutture e
Decostruzioni che magari fanno confusión.
Piuttosto triste e solitario, nonché praticamente ‘final’,
nelle sterminate periferie di Lima, fra highways e
demolizioni e baracche più interminabili e selvagge che in
California o in Florida, lo spropositato Museo de la Nación
appare come un gigantesco meticciamento fra cubismi e
brutalismi tropicali in scatoloni cementizi scorticati. Più
kolossal e greve di Bilbao, ma con lo stesso protagonismo
della Struttura padronale verso i ‘segni’ ivi contenuti,
trattati come ninnoli ceramici e tessili secondo le mode
etniche di turno.
Così, in arredi tipo Banche di Stato saccheggiate e Palazzi
del Governo dopo i bombardamenti, ecco foto e
testimonianze e ritagli e volantini e video e trafiletti di lotte
armate con stragi e violenze e vittime, Inca e Túpac Amaros
antichi e moderni, Senderos Luminosos contro la
Modernidad Global, comunità e università in armi, depositi e
necropoli di kalashnikov e martiri, controffensive
autoritarie, eccidi ed eccessi delle truppe, traffico di droga e
corruzioni dilaganti, guerriglie maoiste con atentados y
muertos, università e lauree letteralmente sotto il tallone di
vari oppressori, crisi estreme su un sì o un no al terrorismo,
responsabilità comprovate dei poteri su conflitti con
massacri, lutti e commemorazioni sempre. Come nei
peggiori dopoguerra europei, con guerriglie e stragi
sistematiche. Quante strategie e tattiche della tensione. E
visitatori tra il coinvolgimento e l’allestimento: bandane e
cuffie e calzerotti da evento, shatush di lana di lama che
sarebbero altrove regali di Natale.
A un altro piano, una mostra sulla patata nazionale quale
fonte di ispirazione per gli artisti: sale e sale di ceramiche,
installazioni, pitture, arazzi, video, marmi e bronzi e presepi
e poster con poesie e canzoni di cosmovisione andina sullo
spirito antico e moderno e naïf e pop nelle varie
caratteristiche specie e sottospecie del popolare e
alimentare tubero, dei suoi fiori e foglie e bacche e corimbi
e fecole e simboli. E tutta una iconologia non solo profana
ma perfino sacra, allegorica anche per l’Oltretomba, con
addirittura un Cristo Crocefisso sopra una patata. Fra
teatrini, proiezioni, sceneggiate, mitologie, significanti e
significati e metafore ed epistemi ed ermeneutiche, con
ascensori titanici, e addetti a questi lavori in tuniche di
design.
Però, senza cenni alle conseguenze dell’arrivo e ricezione
delle Kartoffeln nella Germania affamata di Madre
Coraggio. O della casalinga “crème Parmentier” nel vitto
padano, magari “a la parmesana”, prima dell’associazione
automatica dei ‘chips’ con la televisione e il cinema. (Mentre
visitando i murales di Rivera nei palazzi del potere
messicano, ci si domanda come tiravano avanti nel
Napoletano prima del pomodoro, nel Veneto prima della
polenta, a Torino e in Svizzera prima del cacao. Né si
trascuri il tacchino. O lo spirito di patata, egualmente ignoto
agli avi Latini).
Dialogo con Borges
A. Borges è forse l’ultimo dei grandi scrittori…
B. No, no, non sono d’accordo…
A. Ma il nostro è stato un secolo di grandi scrittori, e lei è
davvero uno degli ultimi, e come se non bastasse anche il
più illustre rappresentante della Letteratura Fantastica…
Del resto, secondo lei che cosa possiamo intendere come
Letteratura Fantastica?
B. Direi soltanto che la letteratura è sempre stata
fantastica, è cominciata con le cosmogonie, con le mitologie,
con i racconti di dèi e di mostri… Nessuno scrittore ha mai
sognato di essere un proprio contemporaneo: questo forse è
cominciato soltanto nel diciannovesimo secolo… Prima si
parlava sempre di altri secoli e di altri paesi, ed era la cosa
più naturale…
A. Già; ma nei nostri tempi?
B. Bisogna ritornare a questa tradizione fantastica che è
la vera grande tradizione, la tradizione principale della
letteratura; il resto è piuttosto giornalismo, sarà anche
storia, ma non è letteratura.
A. E il Realismo?
B. Il Realismo è un episodio, solo un momento nella storia
della letteratura. La grande letteratura non è mai stata
realista. Anche in un libro che si crede realista, il Don
Chisciotte, libro che mi piace molto, ci sono sempre i due
elementi, il realistico e il fantastico, ma quello che domina è
l’elemento fantastico perché Cervantes è dalla parte di Don
Chisciotte e non dalla parte dei contadini o degli altri di
buon senso. Anche il lettore è sempre dalla parte di Don
Chisciotte: così il libro è in equilibrio fra i due elementi, però
il più importante è il fantastico, e prevale sempre. La follia
dell’ hidalgo è molto più importante dello squallore della
realtà spagnola contemporanea che lo circonda, e che è
evidentemente disprezzata da Cervantes. Egli ama piuttosto
il mondo fantastico della Bretagna, della Francia
cavalleresca e di Roma. Questo c’è anche in Ariosto: cioè
l’amare un qualcosa e prenderlo un po’ in giro. E ciò che si
sente continuamente nell’ Orlando Furioso, dove si tratta di
questo cavaliere, e intanto lo si canzona, però
delicatamente, non troppo. E questo si ritrova in Cervantes,
che certamente aveva letto l’Ariosto, gli piaceva molto e ne
parla a più riprese… Quando faccio della letteratura
fantastica, non faccio un qualcosa di nuovo, ma una cosa
che si è sempre fatta, tranne che per un brevissimo periodo
di tempo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, e
continua ancora nell’America del Nord, e anche
nell’America del Sud…
A. Ma continua anche in Europa.
B. Sì, sì. Io non sono davvero un innovatore, e quando ho
fatto della letteratura fantastica non ho fatto altro che
continuare quello che facevano gli arabi, che hanno
inventato le Mille e una notte, quello che faceva
Shakespeare, e d’altra parte quello che faceva anche Dante.
A. Già, ma nel Dugento.
B. Letteratura tutta fantastica, comunque. Mai realismo.
La Divina Commedia non è certo un libro realistico.
A. Certamente.
B. E un’allucinazione… E… E… Una contraddizione di
tutte le letterature dell’oggettività…
A. Già. Ma intanto da molte parti si privilegia oggi nella
letteratura quella specie di realismo che «rispecchia le cose,
riflette la realtà». Sono slogan correnti: mentre
l’immaginazione, compresa l’immaginazione al potere, non
sembra ben vista nella letteratura.
B. No. Lo scrittore deve sapere essere fedele alla propria
immaginazione: e se è fedele a ciò che immagina, se sogna
sinceramente, ecco, è questa la sua sincerità. E io cerco di
sognare sinceramente. Credo cioè che sia un errore il
pensare che la letteratura sia fatta di parole. No, non è fatta
di parole; cioè, è fatta anche di parole, ma è fatta
soprattutto di immagini, di sogni.
A. E di libri, di citazioni…
B. E di citazioni di libri. Ma i libri sono poi la memoria
dell’umanità, sono il passato… e il passato è anche un
sogno…
A. E allora, la letteratura non ha a che fare con le cose ma
con la letteratura medesima…
B. Ma certamente!
A. La Letteratura come Biblioteca, grande metafora della
sua opera…
B. Qui ha ragione, però credo che sia stato Henry James
uno dei primi a scrivere sulla letteratura come vita
letteraria, ed è molto interessante, perché era proprio
James…
A. Ma secondo lei, nella letteratura «creativa», quale è
l’importanza del sogno, e quanta invece è la rilevanza degli
aspetti “tecnici”? Forse che il sogno coincide con
l’Ispirazione, quella tale Musa che visita il Poeta?… O non
sarà qualche altra cosa?
B. Sì. Io credo che si incominci sempre con il Sogno, si
incomincia con la Musa, si incomincia con lo Spirito Santo,
con il Re, con Dio, per gli Ebrei della Bibbia, e poi si
lavorano questi materiali. Mi ricordo di un caso famoso:
Stevenson ha sognato la scena centrale in cui il Dr Jekyll
diventa Mr Hyde; e poi ha dovuto inventare tutto il resto. Ed
è la sua ragione, evidentemente, che ha fatto tutto. Ma… la
scena centrale è stata un regalo del sogno. Anch’io
parecchie volte ho sognato delle storie in modo un po’ vago,
e successivamente ho dovuto inventare i dettagli, le
“circostanze” che la nostra epoca esige.
A. Ma per esempio, come…
B. Si incomincia sempre dal sogno e dall’immaginazione,
che è la stessa cosa. Sognare: e non è importante che uno
sia sveglio o addormentato, no!
A. Ecco… ci sono, per esempio, degli scrittori come Julien
Green…
B. Ah,Julien Green?…
A. Lui dice che incomincia sempre un romanzo con un
sogno; e il suo principio, m’ha raccontato, è così: “Quando
scrivo la prima pagina di un nuovo romanzo, ho
un’immagine, per esempio, un ragazzo dai capelli rossi, che
forse è un assassino, e a un certo momento esce di casa, e io
non so assolutamente che cosa succederà alla pagina due,
alla pagina tre… e allora mi lascio andare seguendo questa
immagine…”.
B. E molto coraggioso… Io no. Io conosco sempre l’inizio e
la fine dei miei racconti e delle mie poesie, e di qualunque
cosa io scriva. Non so quello che succede “in mezzo”, tra le
due parti, e allora devo scoprirlo.
Come se fosse un’isola, e io vedessi, diciamo, quello che
c’è su un capo dell’isola, poi c’è tutta questa lunga isola in
mezzo, e poi vedo l’altro capo; ma bisogna che io trovi o che
inventi quello che c’è fra i due.
A. Ma quali sono il peso e l’importanza della tecnica
letteraria nella realizzazione dell’opera… quello che
possiamo chiamare l’assemblaggio delle strutture formali?
B. Evidentemente non ci si deve pensare… Non credo che
Poe credesse che la poesia è un’operazione
dell’intelligenza… rovesciare l’intelligenza
sull’immaginazione, sul sogno… Chiaramente, io cerco di
essere il più semplice possibile; cerco di evitare di essere
oscuro; molte volte mi hanno accusato di essere oscuro, ma
io cerco di non esserlo. Bisogna sempre che ci siano i due
elementi: c’è prima l’immaginazione, il sogno, l’immagine —
quell’immagine di cui parlava Julien Green — e poi bisogna
che la ragione lavori. Bisogna che collaborino, non sono dei
nemici.
A. Lei accetta la frequente definizione di Arte Barocca per
la letteratura fantastica? Non c’è, secondo lei, nell’arte
fantastica e nella letteratura fantastica un forte elemento
barocco?
B. Ma il Barocco è molto artificiale, è molto self–
conscious, diciamo autocosciente; e la letteratura fantastica
non lo è affatto.
A. Non è molto artificiale?
B. No, non credo proprio che sia artificiale: è molto
naturale… E il Barocco che è artificiale… Il Barocco è
l’arte…
A. E lei crede che la letteratura fantastica sia così
naturale?
B. Senza dubbio.
A. E non ha a che fare con artifici, menzogne, sogni,
illusioni, parvenze, chimere…
B. Sì, ma i sogni sono reali, come lo stato di veglia; i sogni
sono reali, e le fantasticherie sono reali; il mio passato è
reale, il mio passato e la memoria, la storia è reale, e la
storia è un sogno per noi, proprio come diceva Joyce: “La
storia è un incubo da cui cerco di svegliarmi”. La storia è un
incubo, un sogno, tutto è un sogno. O, come diceva bene
Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, il Mondo
come Volontà e Rappresentazione: la nostra volontà e il
sogno sono la stessa cosa. Vorstellung si può tradurre con
sogno, con immagine: il mondo come volontà e come
immagine. Si può tradurre in tanti modi, Vorstellung…
A. Allora, sogno. Però, anche Biblioteca: cioè questa sua
grande metafora del mondo come biblioteca sconfinata,
indefinita, infinita, piena di libri che rimandano ad altri libri,
forse reali, o forse immaginari e illusori come in quell’altra
sua grande metafora del labirinto di specchi…
B. La Biblioteca è una specie di sogno; e anche uno spazio
di sogno; ma non ho più scritto altre storie di biblioteche e
di specchi. Più recentemente ho scritto storie più semplici.
Ne ho un po’ abbastanza, di labirinti e di specchi.
A. Ne ha abbastanza ora?
B. Sì, assomigliano un po’ troppo a Borges, non mi piace
Borges…
A. Non le piace Borges?
B. No, non mi piace, è uno scrittore mediocre… ma devo
convivere con lui ed è una cosa un po’ noiosa, soprattutto
quando si hanno settantasette anni e si vorrebbe avere altri
interlocutori, per esempio lei. E molto più piacevole parlare
con lei che con Borges.
A. Ah sì? Grazie, ma vorrei farle altre domande: lei
preferisce il racconto molto breve, evidentemente non le
piace il romanzo. Ma perché?
B. Non mi piace il romanzo perché è troppo artificiale!
A. Lo trova molto artificiale?
B. I racconti invece sono sempre delle vere storie, e gli
uomini hanno sempre amato raccontare e ascoltare storie:
per questo amo tanto Kipling, uno dei più grandi scrittori del
suo tempo, e non solo per le sue poesie, anche per i suoi
racconti dove ha messo tante cose… Giacché siamo a Roma,
ricordo che ci sono tanti racconti di Kipling nei quali parla
dell’Impero Britannico, ma lo fa con la metafora di Roma… E
molto strano… Credeva che la Storia non fosse che una sola,
che tutta la Storia fosse una Storia dell’Impero Romano, e
che questa cambiasse di nome, di razza, di indirizzo, ma…
A. … che fosse sempre la stessa?…
B. … sempre lo stesso impero. Lo stesso impero anche
per Stevenson, questo grande scrittore che mi piace tanto,
questo grande scozzese arrivato nel Far West, in
California… e lì diceva: «Sono alla frontiera della cultura
occidentale, o se preferite dell’Impero Romano».
A. Ma allora, quelle decadenze e cadute di imperi, e
anche dell’Impero Romano…
B. E la decadenza e caduta per noi dell’Occidente.
A. E non è una storia di affondamento o di crollo?
B. Sì, è vero. Ma allora vorrà dire che non c’è stato altro
che l’Impero Romano, e la prova è che noi stiamo parlando
ora in francese che è un dialetto del latino, lei parla italiano
che è un altro dialetto del latino… e io naturalmente parlo e
scrivo in spagnolo…
A. Ma io volevo chiederle ancora: nella ricchezza del
romanzo, anzi di certe grandi costruzioni romanzesche,
come quelle di Proust e di Musil, ci sono delle tali feste
dell’immaginazione, tali trionfi delle possibilità della
letteratura…
B. Sì, sì, e anche in Joyce.
A. Sì, ma io preferisco Proust e Musil a Joyce… Perché le
piace poco questa grande costruzione che è possibile nel
romanzo?
B. Perché è una costruzione; so che io non posso farla;
posso fare soltanto dei racconti. E poi, dato che io non sono
un lettore di romanzi, perché dovrei scriverne? Io non li
leggo, all’infuori di Conrad… Conrad mi piace molto…
A. E le piace più degli altri?
B. Sì, ma tutti l’hanno dimenticato. Eppure Conrad ha
salvato quello che c’è di epico nel romanzo, e gli altri non
l’hanno fatto.
A. E il più grande romanziere, per lei?
B. Per me sì.
A. Più grande di Henryjames?
B. Come romanziere, sì, forse. Come narratore, no. Ma io
preferisco sempre Conrad. Ha delle cose così… così dirette,
così semplici, così perentorie, così coraggiose, Conrad! E il
coraggio mi piace molto. Forse perché non ne ho. Sono
piuttosto un tranquillo… Tutta la mia famiglia era di militari,
sono persone che hanno combattuto, che si sono fatte
uccidere, che sono andate in esilio… La nostra storia è molto
violenta: la storia argentina, uruguayana, piena di
peripezie… Mi piace molto Conrad; e poi non capisco perché
lo hanno dimenticato. Forse perché in Inghilterra è
considerato un po’ come uno straniero, era un polacco e non
si può concepire che il più grande romanziere inglese sia
nato in Polonia. Queste cose però capitano, è un regalo che
la Polonia ha fatto all’Inghilterra.
A. Ma per esempio, tra i grandi narratori inglesi
dell’Ottocento, come Dickens?…
B. Ah, mi interessa molto, Dickens, ma fa parte della
letteratura fantastica…
A. Sì, infatti…
B. Quando si legge Dickens non si ha affatto una
impressione di realtà; e se lei prendesse le vecchie edizioni
di Dickens, vedrebbe che le illustrazioni sono delle
caricature…
A. Letteratura onirica?…
B. Sì, sì, Oliver Twist, la notte, i ladri che si confondono
con i sogni della notte, sono letteratura onirica… Poi c’è
l’aspetto del meraviglioso: Alice nel Paese delle Meraviglie,
Attraverso lo Specchio, di Lewis Carroll, sono perfettamente
onirici…
A. Ma per esempio, tra i grandi russi, nella vecchia
disputa fra i partigiani di Tolstoj e di Dostoevskij, lei da che
parte si sente? da quella di Dostoevskij?
B. No, no, assolutamente, io sono per Tolstoj.
A. Ma Tolstoj è un realista, non è un visionario! E allora lei
perché sta per Tolstoj? Lo trova forse un fantastico? O non è
Dostoevskij, il vero fantastico?
B. Se fosse mai vero, noi dovremmo rispondere con
un’altra domanda: noi non sappiamo se l’universo è
realistico oppure onirico; se l’universo è onirico, allora
anche Tolstoj è onirico, però non ne sappiamo nulla. Forse il
mondo è un sogno, l’abbiamo detto anche poco fa — Die
Welt als Vorstellung — il mondo come rappresentazione, il
mondo come sogno. Ma no, mentre rispondevo alla sua
domanda ho pensato a un tratto che provo molto più piacere
a leggere Tolstoj, un’emozione più forte che a leggere
Dostoevskij. È tutto qua. Io non sono un teorico, non ho idee
astratte, sono incapace di pensare, posso immaginare,
sognare… posso, a rigore, scrivere… ma non so se posso o
no ragionare…
A. Ah no? Ma come?… Per esempio…
B. Non sono un intellettuale. Sono un naif.
A. Ma allora, in questo vecchio gioco della torre o jeu de
massacre che si può sempre fare, chi le piace di più tra
Balzac e Flaubert, per esempio?
B. Non mi piace affatto Balzac, e mi piace Flaubert. Ma
mi piace soprattutto La tentazione di Sant’Antonio.
A. Non Madame Bovary?
B. No, Madame Bovary non ho mai potuto leggerla, non è
mai riuscita a interessarmi; e i Tre racconti sono assai
fiacchi.
A. E Bouvard e Pécuchet, allora?
B. Bouvard e Pécuchet sì: è un gran libro del
diciannovesimo secolo e non soltanto di quel secolo.
A. Noi discorriamo abbastanza di letteratura e fantasia,
letteratura e ispirazione, letteratura e tecnica letteraria, ma
nel nostro tempo continua sempre quel gran discorso di
letteratura e ideologia, e una gran parte dei letterati
subordina la letteratura appunto all’ideologia…
B. Io credo che sia un errore. Le opinioni sono quello che
c’è di più superficiale; e le opinioni di uno scrittore non
contano. Mi ricordo di un testo di Kipling, che mi piace
molto, e dove si dice che “è permesso a uno scrittore di
inventare una favola, ma non di sapere se è vera”… Dunque,
la moralità della favola…
A. La moralità, perché?
B. Ma questa non si sa. Ed è molto curioso, perché Kipling
parla prevalentemente dell’uomo bianco e del suo impero…
A. Il famoso “fardello dell’uomo bianco”…
B. Sì, proprio il fardello… Eppure sono sempre quelli dove
l’uomo bianco non è davvero il più simpatico. Per esempio,
Kim è un grande libro, ma lì si pensa più all’anima che non a
Kim. L’anima mi sembra molto più reale di Kim, ed è molto
più importante di Kim; e anche per Kipling è così. Insomma,
aveva le sue opinioni; ma se era fedele alla sua
immaginazione, allora, quando si legge il libro, non si è
affatto convinti delle sue opinioni, anche perché non
contano poi troppo… Insomma, io credo che sia molto
pericoloso giudicare uno scrittore dalle sue opinioni; ed è
per questo che io, che non sono cattolico ma non sono
nemmeno pazzo, dico che la più grande opera di tutta la
letteratura è la Divina Commedia. Questo non vuole affatto
dire che io sia credente, o che creda all’Inferno e al
Purgatorio e al Paradiso. Questo non c’entra niente. Sono
delle opinioni di Dante, queste, o forse delle metafore,
immagini che ha preso chissà dove, e dove le ha prese non
m’interessa. Quello che mi interessa sono i sogni di Dante, e
i personaggi che ha inventato, che ha creato e ricreato… In
generale si giudica uno scrittore dalle sue opinioni. Io, per
esempio, ammiro molto Whitman ma non ammiro la
democrazia che era necessaria a Whitman per scrivere
poesia. Però questo è affar suo, non mio. A me importa
soltanto la poesia di Whitman, quello che ha scritto con le
sue idee sulla democrazia, che non mi interessano affatto.
A. Ma lei è davvero un vecchio anarchico, o è altre cose?
B. Sì, un vecchio anarchico. Anzi, un vecchio spenceriano
individualista. Cioè non sono fascista, non sono comunista,
non sono nazionalista, detesto il nazionalismo. Non sono mai
stato peronista o nazista, detesto tutto questo. Sono un
vecchio anarchico, un vecchio anarchico pacifico, un vecchio
signore anarchico individualista, un vecchio lettore di
quell’Herbert Spencer che ha scritto L’uomo contro lo Stato,
ma intanto abbiamo lo Stato dappertutto, il nazionalismo
dappertutto.
A. Si osserva spesso nei più importanti scrittori del nostro
secolo che quanto più sono stati rivoluzionari e sperimentali
nella loro opera, tanto più hanno avuto opinioni politiche
conservatrici; e non parliamo solo dei soliti Céline o Pound,
e nemmeno di Marinetti o D’Annunzio…
B. Non credo che Marinetti sia uno scrittore importante,
no?
A. Ne parliamo perché siamo in Italia. Tutti quei loro
entusiasmi per la guerra… Marinetti cantava la modernità e
la guerra, e poi è diventato fascista; e D’Annunzio cantava il
grande passato italiano e la guerra, ed è diventato
abbastanza fascista anche lui…
B. Vorrei dire una cosa: c’è un libro che mi piace molto,
ed è la storia della letteratura italiana di Momigliano. Ma lì
non si parla affatto di Marinetti.
A. Non se ne parla?
B. No. Lo si omette, e basta.
A. Eppure il futurismo ha avuto una grande notorietà e
una grande influenza, no?… Ma io volevo parlare di scrittori
come Valéry, Mann, Benn, Eliot, Pirandello, Montale, Svevo,
Rilke, e tanti austriaci: i grandi poeti e i grandi narratori del
nostro secolo avevano idee politiche praticamente
reazionarie ed erano invece dei rivoluzionari autentici nella
loro opera… no?
B. Non lo so, nel mio caso non mi intendo molto di politica
e non ne parlo mai; sono un uomo etico, io. Io ero contro il
peronismo per un motivo etico, soprattutto; e per ragioni
intellettuali.
A. Anche estetiche?
B. Sì, anche estetiche. Perón era una grande canaglia, era
una figura sporca e poco intelligente, e le persone perbene
gli credevano ben poco.
A. Lei ha sofferto molto sotto il peronismo?
B. È una faccenda privata…
A. E privata?
B. Mia madre è stata messa in prigione, e anche mia
sorella e mia nipote. Mi attaccavano attraverso le persone
che amavo.
A. Sono cose tipiche delle dittature.
B. Sì, era tutto così abominevole… Non voglio più
ricordarmi di quel periodo.
A. No.
B. Finché sono a Roma non voglio più pensare a quei fatti
passati.
A. D’accordo: mai nessun rapporto fra vita vissuta e
creazione letteraria. Ma allora, per esempio, nel lavoro di
uno scrittore, di un poeta… escludendo naturalmente la vita
e l’esperienza, che cosa crede sia necessario per compiere
la sua opera? Insomma, che cosa è veramente necessario
per uno scrittore?
B. Bene, vorrei ricordare ciò che mi disse mio padre più di
un mezzo secolo fa. Mi disse: «Bisogna leggere molto,
bisogna scrivere molto, ma non bisogna pubblicare, oppure
bisogna pubblicare molto tardi». Mi ha dato questo
consiglio: leggere, scrivere, e poi stracciare ciò che si è
scritto. Pubblicare solo quando si è maturi, ma comunque
non è questa la cosa importante.
A. Molto tardi, allora?
B. Sì, molto tardi; ma questo non è stato possibile, per
me. Io ho cominciato troppo giovane; avevo ventiquattro
anni quando ho fatto pubblicare, nel ’23, a Buenos Aires, il
mio primo libro. Non ho inviato esemplari ai giornali, alle
librerie, agli scrittori, niente. Ho regalato solo agli amici il
mio libro. Erano trecento copie.
A. Ma allora quali crede che possano essere oggi i
maggiori pericoli per la letteratura? I veri nemici
dell’esercizio della letteratura, voglio dire.
B. Credo che attualmente il grande pericolo sia la politica,
di qualunque segno. Io appartenevo a un partito
conservatore, ma poi mi sono ritirato perché spesso ero già
d’accordo in anticipo con opinioni diverse altrui. Credo che
sia ridicolo appartenere a un partito politico. Per me è molto
singolare: i comunisti mi considerano un fascista, i fascisti
mi considerano un comunista, dunque non sono da nessuna
parte, sono un vecchio individualista.
A. Non le piace fare dichiarazioni politiche, vero?
B. No; però, a parte questo, credo che noi abbiamo ora il
miglior governo possibile per il nostro paese; ma questo non
è importante in Italia.
A. E non sente pericoli, disagi, minacce? Per l’Italia, ad
esempio, questo è un momento di crisi. Lei non crede che in
Argentina ci siano delle ombre nell’awenire del paese, come
del resto ce ne sono nei paesi vostri vicini?
B. Abbiamo passato un periodo anarchico in cui si era
governati dalla canaglia. Poi sono venuti soprattutto uomini
di amministrazione, che non sono certo gran cosa, ma
almeno non sono dei gangster.
A. Chi sono o chi erano i gangster?
B. Perón, naturalmente; e sua moglie; e la sua vedova.
Tutte queste persone erano veramente delle canaglie, vere
canaglie al potere.
A. Vorrei domandarle un’altra cosa, sulla sua formazione
intellettuale. Quando lei ha incominciato a scrivere, ed era
molto giovane, nel suo ambiente culturale si era già
nell’epoca di Pound, nell’epoca di Eliot, oppure era prima?
B. No, no, io non li conoscevo affatto, a quell’epoca.
Leggevo soltanto i classici.
A. Ma quando era ragazzo, e cominciava a scrivere, a
quali autori della sua epoca faceva riferimento? Insomma,
per lei, quella era l’epoca di chi? Di quale scrittore?
B. Era l’epoca di Shaw, l’epoca di Wells.
A. Ma erano importanti per lei?
B. Molto importanti. È l’epoca in Spagna di Unamuno,
l’epoca di Paul Groussac a Buenos Aires. Quanto a Ezra
Pound, l’ho conosciuto più tardi e come scrittore non mi
piace affatto. Eliot è diverso. Eliot è molto più fine di Pound.
Ma non è un poeta che mi piaccia, scrive cose molto fredde.
A. Eliot?
B. Eliot, sì.
A. E come critico?
B. Come critico non me ne importa niente. Vorrei che un
critico fosse anche un po’ creatore, come De Sanctis o
Coleridge, tipi che sanno anche riscrivere i propri testi,
mentre in Eliot non c’è critica, c’è una discussione assai
meschina, e sempre una certa pedanteria… Non mi piace la
prosa di Eliot; ma ciò non toglie che ci siano alcune sue
poesie molto belle… Eppure per me Eliot non è un grande
poeta inglese. Potrei citare una cinquantina di nomi prima di
arrivare a Eliot.
A. E quali sono i primi?
B. Per esempio Frost, e Yeats. Prendiamo il caso di Yeats.
Yeats era un nazionalista.
A. Ah, me l’ero dimenticato, nella lista dei rivoluzionari
reazionari.
B. Eppure Yeats era un grande poeta malgrado le sue
opinioni, malgrado quel suo sistema mistico che è una
ridicolaggine… Yeats, sì, è un grandissimo poeta che ha
fatto della lingua inglese uno strumento espressivo
straordinario.
Certi versi non si possono né spiegare né tradurre, ma
sono bellissimi al di là di ogni loro significato.
A. Ma come persona, come idee?…
B. Come persona, no, era nazionalista, era un irlandese
professionale. Non come Shaw, che era anche irlandese, ma
non sempre se ne ricordava. Però questo non c’entra
niente… Poteva essere esecrabile come amico, e amabile e
ammirabile come poeta. Il poeta resta e l’uomo sparisce, del
resto; ed è molto più importante essere ammirabile come
amico dell’anima. E più o meno il caso di Croce, forse io non
sono d’accordo con Croce, ma io lo amo, lo sento come un
amico.
A. Ma per esempio, la posizione di Croce sulla poesia
francese del diciannovesimo secolo… Non gli piaceva
Baudelaire…
B. E aveva ragione.
A. Non gli piaceva Mallarmé…
B. E aveva ragione.
A. Aveva ragione? Anche a lei non piacciono né Mallarmé
né Baudelaire?
B. No, non mi piacciono; ma mi piace per esempio
Verlaine, anche se non è un grande poeta, un poeta per
sempre, direi. Mi piace molto Hugo, si trovano delle cose
splendide in Hugo, per esempio quando dice «L’hydre
Univers tordantson corps écaillé d’astres…», è pura
bellezza.
A. Baudelaire allora no. Ma Apollinaire almeno sì?
B. Apollinaire era un poeta, mentre Baudelaire era
piuttosto qualcuno di costruito, uno che costruiva poesia con
fatica. E molto maldestro… almeno secondo me. Trovo che
ha sempre delle… Come dire… E poi non mi piace il suo
gusto, non mi piacciono i pipistrelli, non mi piacciono i
mobili, non mi piacciono i divani…
A. Ma non le piace questa specie di Grand Mauvais Goût,
questa specie di Kitsch che c’è in parecchi poeti
dell’Ottocento, soprattutto francesi?
B. Sì, ma in loro lo detesto. Nel caso di Verlaine, non c’è
questo senso del Kitsch; e c’è invece in Oscar Wilde, che
chiaramente non è un grande poeta, c’è questo Kitsch, ma
con un sorriso, lo prende un po’ in giro… mentre Baudelaire
prendeva i suoi demoni e i suoi pipistrelli e le sue prostitute
e le sue mulatte, tutto, fin troppo seriamente…
A. Ma in quell’enorme magazzino, in quell’immenso
deposito centrale del Kitsch intellettuale che è il Bouvard e
Pécuchet… lì si tratta di un vero monumento… e non è il
trionfo del Kitsch?
B. Già; ma Flaubert faceva dell’ironia; e invece
Baudelaire lo prendeva sul serio, lo amava!
A. È vero?
B. Sì, c’è questa sola differenza, ma è una differenza
grandissima.
A. Ma volevo domandarle ancora, quando lei era molto
giovane a Buenos Aires…
B. Da giovane a Buenos Aires leggevo solo libri inglesi, mi
pare; o delle traduzioni in inglese.
A. Ma della letteratura francese, tedesca, italiana?…
C’erano nella sua biblioteca giovanile dei nomi, dei titoli, dei
libri… c’era qualcosa che l’ha colpita più fortemente in
quella fase?…
B. Sono stato avviato alla letteratura tedesca da Carlyle
che mi ha mostrato cos’è la Germania. Poi ho studiato il
tedesco da solo per poter leggere Schopenhauer in lingua
originale. Ho incominciato con le poesie di Heine, che sono
molto belle e molto semplici…
A. … e che lei preferisce a Goethe?
B. Oh, certamente: Heine era ebreo e quindi molto più
intelligente di Goethe. Naturalmente questa è una battuta di
spirito. Mi piace molto la lingua tedesca, che è anche più
bella di ciò che si scrive in tedesco.
Mentre nel caso del francese, la lingua è brutta ma la
letteratura è bella.
A. E nel caso dell’inglese?
B. Mi piace sia la lingua sia la letteratura. Invece in
spagnolo non si è scritto quasi niente.
A. Quasi niente?
B. Sì, c’è il Don Chisciotte.
A. E la poesia?
B. La poesia, sì: Góngora, San Juan de la Cruz. Poi c’è il
diciottesimo secolo che è povero come il diciannovesimo. E
dopo questi non c’è molto.
A. E il Novecento?
B. Il Novecento è un po’ il riflusso dell’America Latina…
A. Con tutti i romanzi sudamericani di questi anni?…
B. Ah, quelli? Veramente non li conosco molto.
A. E non è curioso di conoscerli?
B. Ho letto García Márquez e lo trovo buono. Gli altri che
ho letto non mi sono piaciuti. Si tratta di esperienze che
appartengono al genere Faulkner: si gioca col tempo.
Nemmeno Faulkner mi piace poi molto.
A. Non le piace come Faulkner gioca col tempo?
B. Sì, talvolta lo faccio anch’io e lo fanno molti. E stato
Conrad l’iniziatore di questo genere.
A. E naturalmente resta il più grande…
B. Certo che resta il più grande! E proprio Conrad che ha
iniziato uno dei suoi romanzi, non ricordo il titolo, con una
scena dove ci sono due amici che si incontrano e parlano di
un terzo amico, e attraverso la loro conversazione si
ricostruisce tutta la realtà di questo terzo amico… Uno dei
due dice di aver visto una scena, l’altro afferma di essere
arrivato prima e tutto diventa estremamente complicato…
Solo verso la fine si capisce di chi parlavano.
A. Ma Faulkner, per esempio…
B. Sì, la medesima cosa, Faulkner l’ha fatta circa
vent’anni dopo Conrad, che è stato il primo.
A. (alpubblico televisivo) Vorrei adesso ringraziare tanto
Borges per essere venuto qui, per essersi trattenuto con noi
venendo poi così da lontano, venendo dall’Ottocento. Come
dice lui: “Io sono un uomo dell’Ottocento”. Venendo non
soltanto da luoghi così lontani nella geografia, come Buenos
Aires, ma così lontani nella immaginazione e nell’invenzione
come le sue biblioteche sconfinate e immaginarie. Vorrei
ringraziarlo di essere venuto. Grazie.
B. Tocca a me ringraziare e poi sono a Roma…
A. E contento di essere a Roma?
B. Molto contento. E il centro, è l’Europa, è l’Italia, è
Roma. Roma è sempre l’Impero Romano, che continua sotto
altri nomi.
A. Ma lei si aspetta qualche cosa dall’Europa?
B. Mi aspetto tutto dall’Europa. Cosa ci si può aspettare
dalla periferia? Periferia sono anche America e Russia. E
dalle periferie, cosa ci si aspetta?
A. Lei non si aspetta niente?
B. No, no; tocca a voi salvarci.
A. E lei crede proprio…
B. Io spero che alla fine tutto l’Occidente abbia qualche
cosa da voi. Noi facciamo del nostro meglio per aiutarvi.
Spero che tutto l’Occidente sia un po’ uno specchio, uno
specchio eterno dell’Europa: uno specchio fedele; o che
cerca di essere fedele. E noi faremo del nostro meglio.
Tocca a voi salvarvi, e salvarci anche. Ve lo dice un buon
argentino. Io adoro la vostra patria.
Roma, San Gregorio al Celio, maggio 1977
Evita in musical
Altro che il greve Vicario di Rolf Hochhuth nel retro della
Libreria Feltrinelli, o l’arguta Evita Perón di Copi sotto un
tendoncino da circo. Si sa — e si ripete — che molti
desidererebbero soprattutto un grande musical su Pio XII,
con coreografie di flabelli e passerelle in sedia gestatoria.
Broadway! Mirabili gesti in cima alle scale, sorrisetti
misterici durante le sacre visioni con gli agnellini nei
migliori giardini vaticani, e nel finalissimo le smisurate
esequie con la sensazionale esplosione della salma tra gli
Svizzeri che stramazzano… Al Vicario avevo invitato alcune
pronipoti di recenti Pontefici: una venne con entusiasmo,
pregustando la sorpresa della Polizia davanti all’ostensione
del passaporto; un’altra osservò soltanto «non mi pare il
caso».
Particolarmente ‘electrifying’ risulta invece il mirabolante
debutto di Evita, di Andrew Lloyd Webber, nell’immenso
Prince Edward Theatre londinese già Cinerama, e a cura del
mirifico regista Harold Prince. Già artefice di Follies,
trionfale evocazione cadaverica della Broadway perenta
nella fatiscente basilica Del Winter Garden, e riproposta
ancora a Broadway quarant’anni dopo, nel 2011. Non più
con Alexis Smith e Yvonne De Carlo e Dorothy Collins ma
con Bernadette Peters e l’ottantaduenne Rosalind Elias.
Sempre fantasmi di se stesse celebri antiche star tanti anni
fa. Tipo Sunset Boulevard: una ruggente cascata di vecchie
strappate agli ospizi e aggrappate agli stucchi ragnatelosi,
fra paillettes e claquettes, traboccanti di vitalità e vivacità
da terza età davanti a spettatori fra l’inorridito e
l’imbarazzatissimo.
Per questa Evita, la scena appare circonfusa da quei
murales che specialmente in Messico rappresentano e
significano lavoro nazional–popolare fra Rivoluzione e
Governo e Università e grandi alberghi per comitive
‘inclusive’ e oscure storie di delitti politici d’altri tempi con
vittima (ovviamente) Trotzkij. Pubblico, qui, di
un’effervescenza, una turbolenza, una stravaganza, una
volgarità, piuttosto straordinarie. Tute d’oro e torsi nudi e
scarpe fluorescenti come in quelle migliaia di monumenti ai
caduti che scorrazzano per tutta Roma dopo le partite di
tipo sudamericano, con una minuscola base formata da una
Cinquecento rossa che si espande in numerosi combattenti
e reduci sudati e sormontati da tricolori sventolanti nelle
dimensioni della facciata di Montecitorio. Ecco lì un enorme
schermo con un orrendo western sentimentale molto
argentino, e lei eroina di mèlo per una platea di stravaccati
subitamente sbigottiti per un annuncio radio molto ufficiale:
“Evita Perón è entrata or ora nell’immortalità”. Qui si
sviluppa un doppio funerale sublime: sul megaschermo, le
vere esequie di Evita, cine–documentate e assolutamente
sensazionali; e sulla scena, un corteo funebre quasi
altrettanto grandioso e interamente coreografato, danzante.
Con gran pianto di popolo, e kolossal glorificazione corale,
cimiteriale e celestiale, da Mahagonny sudamericana di
massa, nella patria del tango. Un gran Requiem per Evita,
con doppia bara, una su e una giù, per offrire la salma agli
idolatri in tumulto. Fra quegli adoranti lacrimanti si staglia
sempre più vistosamente soprattutto un popolarissimo divo
rock, David Essex, ovviamente identico all’iconografia dei
posters del ’68, ma già applauditissimo Gesù Cristo in
Godspell, ai tempi di Jesus Christ Superstar. Ed è lui, il
mitico Che Guevara nato argentino a Rosario, commosso
nell’esaltare con una beguine molto ballabile tutte le gran
doti teatrali e le magnifiche interpretazioni della defunta.
Che per di più era di sinistra, espressa dal proletariato e
amicissima delle masse, che ora sfilano desolate
singhiozzando e cantando un Salve Regina in latino–
argentino sacro e pecoreccio. Fra le masse, la più
singhiozzante è proprio lei, Evita (l’eccellente ma un po’
fiacca Eiaine Paige) che segue inconsolabile il proprio
funerale col feretro e il cantico. Tenta invano di consolare il
Che lacrimante. E quindi in uno sfacciato flashback da
vecchia Hollywood in bianco–e–nero stabilisce di piangersi
un po’ addosso rievocando la propria vita e carriera. Sempre
accompagnata dal Che talmente storico e presentatore da
risultare vero protagonista: ‘agisce’ tutti come marionette,
con l’evidente presupposto che Evita fu soprattutto una
fantasia masturbatoria e consolatoria in favore dei meno
abbienti.
Eccola, ambiziosa ragazza provinciale, in uno spettrale
night–club con dietro una famigliaccia che sogna la gran
città attraverso proiezioni di fotografie stupende che si
riflettono su enormi specchi; e anche rifrazioni musicali tra
Weill e Bernstein (Candide), e costumi bellissimi. La
scoperta o conquista di Buenos Aires è Balzac, è Rastignac,
su tanti schermi come ai tempi di Abel Gance. Si risolve
presto in un girotondo di amanti — tutto un allacciarsi di
braghette in flanella o in divisa attraverso una porta
girevole, con commenti del Che — mentre un coretto di
generali giocherella su sedie a dondolo, e sullo sfondo le
prigioni e le esecuzioni si fanno tremende.
Non nuovissime solfe del «mostrare la vera faccia». In
Cambogia o nel Cile, chi muove un dito o fa una piega di
fronte alle vessazioni? Ma nelle nostre democrazie un po’
malandate, tutto un daffare perché il Potere butti la
maschera, mostri il ghigno e il regime e il fascio. Così
quando si sta malissimo, tranquilli: finalmente si è capito
dove si sta.
Intanto, coreografie magnifiche: balli e tornei di polo
della vecchia oligarchia miliardaria tutta marsine e cilindri e
diamanti e piume e bianco–e–nero edoardiano da My Fair
Lady. E marce preoccupanti di plotoncini militari in vivaci
uniformi bianche–giallerosse–blu da Walt Disney. Ma con un
affiatamento terribile, e minacciosi occhiali da sole, modello
Gheddafi o Pinochet.
Ed ecco l’incontro indimenticabile! Perón ha appena finito
un comizio, che vediamo di sguincio, come dalle quinte di un
palcoscenico; e lei, attrice di successo, carica in questa fase
di pellicce e colbacchi e stole strabilianti, lo conquista col
suo chic e la sua manina, gli getta fuori dal letto capitonné
una brava ragazza “fatta in casa” che in fondo gli andava
benissimo, e sopraffa le sue inclinazioni casarecce. Con un
po’ di soldi all’estero, colazione tardi a letto, cocktails in
piscina, qualche piccina da accarezzare sulle ginocchia…
Qui gli autori di Evita, tutti (fra cui Tom O’Horgan di Hair)
mostrano una certa simpatia per il poveruomo Perón e i suoi
mediocri modesti limiti. Invece il Che, in scena, continua a
esaltare Evita perché ha portato avanti la sua rivoluzione.
Così la camera nuziale della coppiaccia diventa un trionfale
comizio nella gran tradizione di Arturo Ui, man mano invaso
da tutti i sindacati possibili, con posters e striscioni sempre
più enormi e impressionanti, in una grafica costruttivista
rossa e nera molto più a sinistra di “Rinascita” o “Lotta
Continua”. Acclamazioni e invocazioni talmente insistenti
dei compagni della metalmeccanica e della zolla, dei tessili e
del petrolchimico, dei policlinici e dei telefoni, che la
coppiaccia soccombe all’entusiasmo superproletario nel
finale di primo tempo più costruttivista ed engelomarxista
che si sia mai visto dai funerali di Lenin o Stalin. Anche un
Ballo Excelsior contadino e operaio, nelle gigantografie
della vera Evita ricoperta di ermellini e diamanti fra i
descamisados in adorazione. (E il Che: giusto! vedete? è così
che bisogna fare!).
L’inizio del secondo tempo è altrettanto sensazionale.
Sulla balconata della Casa Rosada, Perón e tutta la sua
oligarchia si spogliano delle alte uniformi e degli abiti da
cerimonia davanti ai descamisados contenti, per restare in
camicia come loro. E via le cravatte, via le marsine e i
plastrons, via le giacche da generali cariche di decorazioni
da chissà quali guerre — finché arriva lei, in una nube di
tulle e costellata di perle, dichiarando (approvata dal Che)
che le masse vogliono applaudire soprattutto un gran lusso
di sinistra, e non di destra. E infatti la osannano, deliranti,
come se fosse una Madonna del Pilar o Belén o Medjugorje.
Passano sugli schermi multipli le immagini autentiche e
storiche di un’Argentina popolare e povera che invece di
tirarle il collo le si butta ai piedi come se fosse una Wanda
Osiris di Guadalupe. E lei, sempre fin troppo avallata dal
Che in tanghi struggenti con plettri proclama “sono
Christian Dior dalla testa ai piedi, soltanto per le masse
dalle quali sono uscita e che continuo a rappresentare in
tutto!”.
Assisa su un trono fatto di poveri esegue donazioni e
promuove fondazioni in contanti coi soldi portati via ai
ricchi, mentre molti altri soldi partono per la Svizzera e la
dittatura chiude giornali e sequestra libri e il musical
sfoggia ottimi sentimenti democratici. E in pigiami di raso
bianco su letti di velluto rosso, sempre con molta polizia
segreta fin dentro i comodini, ecco qualche lezione di praxis
peronista: “Gli esuli sono più divertenti dei morti”, riflette il
perplesso generale, tastando sederi di piccine. Ma qui la
documentazione fotografica e cinematografica diventa
impressionante, oltre qualunque immaginazione felliniana di
Harold Prince. Quando Evita incomincia il grand tour di
ospedali e orfanotrofi, i cappellini e le stole si lasciano
indietro sia Elsa Schiaparelli sia Salvador Dali, o Bunuel.
Incontri dementi con Franco a Madrid. Ma la visita a Roma è
ancora meglio. Ecco il Conte Sforza con una ‘magiostrina’ di
paglia da suonatore di banjo anni Venti che strappa urli di
felicità al pubblico: è la stessa di Nino Taranto quando fa
Ciccio Formaggio, ah se lo sapessero. Ma soprattutto la
benda nera da pirata in Vaticano del vecchio Maestro dei
Sacri Palazzi strappa ovazioni punk, perché saltella
nervosissimo su un piede solo davanti a questa diva
superstar: momento supremo per gli smodati fans di Mick
Jagger abituati a trafiggersi di tutto, ma all’occhio non si era
ancora pensato.
Una platea sempre più eccitata e scostumata, mentre la
musica si fa piuttosto banale: vecchi valzer e vecchie solfe
spagnoleggianti, durante quadri sempre più prevedibili.
L’oligarchia viene dunque spogliata, Evita cade malata,
rientrano i plotoncini che fanno delle marcette prepotenti, di
tipo cinese, e così intanto la poverina muore nel suo letto, in
un accesso di signorilità finale dello spettacolo, che
vorrebbe chiudersi accorato e sommesso. Con l’inferma in
clinica che noiosamente entra nella bara già vista all’inizio.
(Anni e anni dopo, al Theater an der Wien, la formula di
Evita riapparirà utilizzata nel musical austriaco Elisabeth, a
proposito della sfortunata imperatrice Sissi e del suo
uccisore, l’anarchico Luccheni).
Londra, Prince Edward Theatre, giugno 1978
Potrebbero piacerti anche
- Il Cavaliere dello Spirito Santo: Storia d'una giornataDa EverandIl Cavaliere dello Spirito Santo: Storia d'una giornataNessuna valutazione finora
- Due Colori Esistono Al MondoDocumento53 pagineDue Colori Esistono Al MondoCost KiaNessuna valutazione finora
- A Testa in Giù - Fabrizio GabrielliDocumento5 pagineA Testa in Giù - Fabrizio Gabrielligabriellifabriz8400Nessuna valutazione finora
- Cronache e Profili Della Belle EpoqueDocumento254 pagineCronache e Profili Della Belle EpoqueDaniela CerratoNessuna valutazione finora
- 101 storie su Napoli che non ti hanno mai raccontatoDa Everand101 storie su Napoli che non ti hanno mai raccontatoNessuna valutazione finora
- (Ebook - ITA - NARR) Tabucchi Antonio - Il Filo Dell'OrizzonteDocumento33 pagine(Ebook - ITA - NARR) Tabucchi Antonio - Il Filo Dell'Orizzontefrancesco_lucchettaNessuna valutazione finora
- Poesie - Pier Paolo PasoliniDocumento18 paginePoesie - Pier Paolo PasolinidiegoNessuna valutazione finora
- La Bottega Di SpinalbaDocumento27 pagineLa Bottega Di SpinalbaKatrovarNessuna valutazione finora
- Paul Gauguin 2Documento43 paginePaul Gauguin 2Renato MatarozzoNessuna valutazione finora
- Luna Nuova: Cronaca dalla rivoluzione cubana del 1868Da EverandLuna Nuova: Cronaca dalla rivoluzione cubana del 1868Nessuna valutazione finora
- "L'Adalgisa" Una Performance IntroduttivaDocumento9 pagine"L'Adalgisa" Una Performance IntroduttivaAntonio BaroneNessuna valutazione finora
- 194395-Text de L'article-270327-1-10-20101004Documento17 pagine194395-Text de L'article-270327-1-10-20101004FrancoNessuna valutazione finora
- Racconti - ArchintiDocumento68 pagineRacconti - Archintisimonsun70Nessuna valutazione finora
- Viaggi straordinarissimi di Saturnino Farandola. Parte quinta. S. E. Il Governatore del Polo Nord: Nelle 5 o 6 parti del Mondo ed in tutti i paesi visitati e non visitati da Giulio VerneDa EverandViaggi straordinarissimi di Saturnino Farandola. Parte quinta. S. E. Il Governatore del Polo Nord: Nelle 5 o 6 parti del Mondo ed in tutti i paesi visitati e non visitati da Giulio VerneNessuna valutazione finora
- Duende LorcaDocumento13 pagineDuende LorcaMauraNessuna valutazione finora
- 101 cose da fare a Napoli almeno una volta nella vitaDa Everand101 cose da fare a Napoli almeno una volta nella vitaNessuna valutazione finora
- De lo novo medièvo barbarico et capitalista (ovvero De la Cina ch'è più vicina)Da EverandDe lo novo medièvo barbarico et capitalista (ovvero De la Cina ch'è più vicina)Nessuna valutazione finora
- Napoli, Figure e PaesiDocumento400 pagineNapoli, Figure e PaesiFrancescoPellegrinoNessuna valutazione finora
- I Cremonesi Mangia FagioliDocumento14 pagineI Cremonesi Mangia FagioliAlberto BrancaNessuna valutazione finora
- Programma Pianoforte ConservatorioDocumento1 paginaProgramma Pianoforte ConservatorioFrancesco BlackDraco CaprioliNessuna valutazione finora
- 22° L'opera Lirica Italiana Ela Riforma Di Gluck PDF PDF Ok OkDocumento3 pagine22° L'opera Lirica Italiana Ela Riforma Di Gluck PDF PDF Ok OkCarmelo GarofaloNessuna valutazione finora
- Appunti 4a BeethovenDocumento3 pagineAppunti 4a BeethovenEuridice PezzottaNessuna valutazione finora
- El Condor Pasa PianoDocumento2 pagineEl Condor Pasa PianoBruna MendesNessuna valutazione finora
- Frühlingsgesang, D.740 (Franz Schubert)Documento15 pagineFrühlingsgesang, D.740 (Franz Schubert)Ongki GamesNessuna valutazione finora
- Carl CzernyDocumento2 pagineCarl CzernyfulvioNessuna valutazione finora
- Antonio Vivaldi Cantata RV 651Documento15 pagineAntonio Vivaldi Cantata RV 651Alejandro Mercuri67% (3)
- Linea Del Tempo Storia Della MusicaDocumento1 paginaLinea Del Tempo Storia Della MusicaMirko ZanottiNessuna valutazione finora
- Puccini Turandot Non Piangere LiuDocumento4 paginePuccini Turandot Non Piangere LiuEmil-George AtanassovNessuna valutazione finora
- 03 Maestricollab 2020 Dig ItaDocumento9 pagine03 Maestricollab 2020 Dig Itaileana tomasielloNessuna valutazione finora
- Brochureprovefinalidelpremiodelconservatorio PDFDocumento18 pagineBrochureprovefinalidelpremiodelconservatorio PDFLorenzo SimoniNessuna valutazione finora
- Mozart - Così Fan Tutte - I, 10 - Soave in RE Con AccompagnamentoDocumento4 pagineMozart - Così Fan Tutte - I, 10 - Soave in RE Con AccompagnamentoGuido MenestrinaNessuna valutazione finora
- Arias Alte Meister Alto ContraltoDocumento348 pagineArias Alte Meister Alto ContraltoGogoNessuna valutazione finora
- StudiVerdiani28Bietti L'Orchestrazione Di AidaDocumento39 pagineStudiVerdiani28Bietti L'Orchestrazione Di Aidaalessandro boeriNessuna valutazione finora
- Handel Coll'Ardor Del Tuo Bel Core (Agrippina)Documento4 pagineHandel Coll'Ardor Del Tuo Bel Core (Agrippina)jeanm87Nessuna valutazione finora
- Trame Opere LiricheDocumento93 pagineTrame Opere LirichefedericoNessuna valutazione finora
- Aneddoti Sui Musicisiti PDFDocumento56 pagineAneddoti Sui Musicisiti PDFMirko MuscoNessuna valutazione finora
- Mozart - L'Ho Perduta, Me Meschina! From Figaro For DuetDocumento2 pagineMozart - L'Ho Perduta, Me Meschina! From Figaro For DuetJimmy AnuszewskiNessuna valutazione finora
- Il Barbiere Di SivigliaDocumento5 pagineIl Barbiere Di SivigliaMarzia FicarraNessuna valutazione finora
- Brahms 1 AnalisiDocumento16 pagineBrahms 1 Analisialessandro boeriNessuna valutazione finora
- Lettura Della PartituraDocumento3 pagineLettura Della PartituranikNessuna valutazione finora
- Una FurtivaDocumento4 pagineUna FurtivaAndoni Martinez BarañanoNessuna valutazione finora
- Voi Che Sapete - Le Nozze Di Figaro - Mozart - PianDocumento5 pagineVoi Che Sapete - Le Nozze Di Figaro - Mozart - PianMihaeluka100% (2)
- Vivaldi Concerto Per Oboe RV 447 OboeDocumento6 pagineVivaldi Concerto Per Oboe RV 447 OboeVanderlei De Paula MachucoNessuna valutazione finora
- Seconda Lezione Storia Del MusicalDocumento2 pagineSeconda Lezione Storia Del MusicalIlaria CossuNessuna valutazione finora
- BookletDocumento64 pagineBookletdeme_gm5129Nessuna valutazione finora
- Gluck Prefazione AlcesteDocumento1 paginaGluck Prefazione Alcestegiuseppe.mocciaro080Nessuna valutazione finora
- Esercizi GrammaticaDocumento21 pagineEsercizi GrammaticaSebastian LopisNessuna valutazione finora
- Nuove Prospettive Di Analisi Del Repertorio Clavicembalistico GalanteDocumento171 pagineNuove Prospettive Di Analisi Del Repertorio Clavicembalistico GalanteAlessandro CasaliNessuna valutazione finora
- 08 Verdi - La Vergine Degli Angeli - TimpaniDocumento1 pagina08 Verdi - La Vergine Degli Angeli - TimpaniPetar KrizanicNessuna valutazione finora