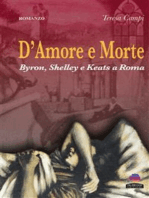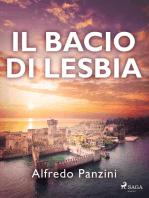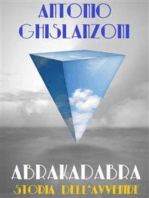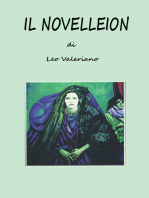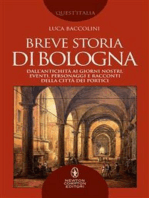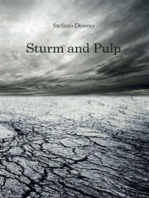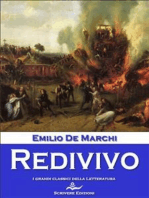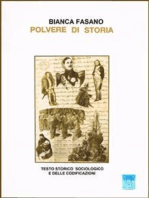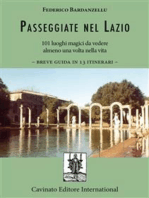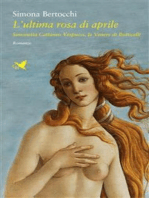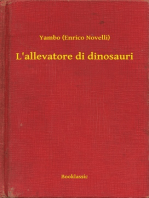Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
I Cremonesi Mangia Fagioli
Caricato da
Alberto Branca0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
4 visualizzazioni14 pagineTitolo originale
i Cremonesi Mangia Fagioli
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
4 visualizzazioni14 pagineI Cremonesi Mangia Fagioli
Caricato da
Alberto BrancaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 14
I cremonesi?
Mangiafagioli
Teofilo Folengo, arguto e divertito, a proposito dei cremonesi, nel
libro II della sua opera maggiore, Baldus, scrive:
“Si mangiare cupis fasolos vade Cremonam”.
Perché, se volete mangiare fagioli, dovete andate a Cremona?
Appoggiata come una matrona al fiume Po, antico porto di pianura,
la città era famosa in verità non per il torrone o per la mostarda, per
il salame speziato o per i marubini in brodo, ma per i fagioli, che
sfamavano gran parte dei villani:
“Quale cremonesis plenum caldare fasolis, / quando
parecchiatur villanis coena famatis”
(Come una caldaia piena di fagioli cremonesi, quando si prepara la
cena ai villani affamati) recita Folengo nel libro XIX.
L’ irriverente poeta mantovano, sarcastico e dissacratore, si diverte
a prendere in giro i luoghi comuni medievali sulla citta lungo il fiume
e ride con un gioco di parole. Anticamente Cremona veniva
chiamata “Magna Phaselus”, “grande vascello”, perché allungata
sul Po e con il Torrazzo a fare da albero maestro, ma nel linguaggio
maccheronico di Folengo, mezzo latino e mezzo volgare, l’epiteto
suona come “magna faselus”, vale a dire mangiafagioli (Phaselus in
latino significa anche “fava”).
I cremonesi dunque? Doppiamente mangiafagioli.
Il Po a Cremona è anche un limite invalicabile, come dimostra un
racconto della Cronica di Salimbene de Adam, quando lo scrittore
parla del periodo dei flagellanti che correvano da una parte all’altra
della città per invitare al pentimento e alla conversione.
Molti parmigiani, racconta Salimbene, erano decisi ad attraversare il
Po per predicare:
“Molti giovani coraggiosi di Parma progettavano di andare là senza
indugio, intendendo morire con gioia per la remissione dei propri
peccati, per la fede cattolica e per l’onore di Dio”.
Il Pallavicino, assai malvagio, che reggeva la signoria di Cremona,
per avvertire di non oltrepassare il Po fece levare sulla sponda del
fiume una lunga fila di forche. Un’immagine dell’orrore, degna di un
set cinematografico.
Se solo qualcuno avesse osato contravvenire all’ordine sarebbe
stato impiccato subito. Fu così che il podestà di Parma mandò in
giro per le strade nunzi e banditori per avvertire, sotto gravissima
pena, “che nessun parmigiano avesse l’ardire di andare al di là del
Po”.
La leggenda di Alceo Dossena
Il modo di scolpire e plasmare la materia di Alceo Dossena
(Cremona, 1878 - Roma, 1937) ha qualcosa che mi incuriosisce e
affascina.
Un talento straordinario per la creta e il marmo, un genio che, se
fosse nato nel Rinascimento, sarebbe accanto a Michelangelo o a
Donatello, ma essendo nato alla fine dell’Ottocento ha la condanna
di essere non un autore ma un replicante, non un genio della
scultura ma solo un falsario.
La storia di Alceo Dossena mi intriga perché su di lui si potrebbe
scrivere un romanzo: un artista che produceva falsi per vivere,
eppure capace di creare vere e proprie opere d’arte, come se la
sua mano riprendesse i movimenti gentili di Donatello.
Alceo scolpisce e lavora nell’ombra per commercianti senza
scrupoli che vendono le sue opere pagate fior di quattrini dai più
grandi musei del mondo – il Metropolitan Museum di New York, i
musei di Cleveland e di Boston – spacciandole per originali dei
grandi maestri rinascimentali.
Dossena aveva iniziato la sua carriera con un raggiro.
Quella di Alceo non era solo una burla, bensì un modo per gridare il
proprio talento non riconosciuto.
Non ancora ventenne lavora come scultore al cimitero cittadino.
Gli artisti cremonesi lo considerano un artigiano, talentuoso, ma
solo un artigiano; e lui si vendica lavorando una testina romana,
falsificando il marmo, creando la patinatura del tempo, ma
soprattutto modellando quel frammento con quel suo tocco
classico: ne viene fuori una scultura di rara bellezza.
Corrompe un amico stradino che sta scavando in citta, e con lui
organizza il ritrovamento, che sale agli onori della cronaca. La
stampa nazionale dà rilievo alla notizia. Alceo allora si presenta alla
conferenza stampa e dichiara che la testina è sua. Il giovane
scultore viene accusato, come Michelangelo, di aver falsificato il
suo putto. “Questa è un’opera d’arte e tu non sei nessuno!”
La rivendicazione è ancora più clamorosa.
Alceo, di fronte a tutti, prende la testina e la butta per terra: dentro
c’è una copia del “Corriere della Sera”.
Ma non basta questo gesto sfrontato a farlo salire nell’Olimpo
dell’arte. Il fatto viene presto dimenticato.
Alceo viene richiamato alle armi per la Prima guerra mondiale.
Il giovane cremonese ha un figlio e una moglie. Poggio Mirteto,
vicino a Rieti, è la destinazione. Qui, nel forno reggimentale e con il
lucido da scarpe nero, lavora a una Madonnina che un astuto
antiquario senza scrupoli compra per settecento lire. Per Alceo
sono soldi. Comincia così il suo calvario. Lavora alle sue Madonne,
ai bassorilievi, alle sculture. Si ispira a opere note, poi inventa di
suo genio e scolpisce, con il suo talento, una serie di lavori che
girano il mondo; non finiscono però, come gli hanno raccontato i
mercanti,
in una grande cattedrale in costruzione, bensì nei musei, pagati a
peso d’oro, con false attribuzioni.
Un esperto d’arte capisce che quelle opere sono false, perché
opera di una stessa mano. Il critico parte per l’Italia e cerca lo
scultore.
Lo trova a Roma, dove Alceo si è trasferito e lavora, ignaro del
raggiro. I suoi potenti mercanti d’arte gli commissionano una testa
del Duce e una del re, ma anche qui, tra verità e leggenda, invece
della martellata al ginocchio come fece Michelangelo al Mosè,
Alceo sputa sulla testa di Mussolini appena terminata. E finisce in
prigione.
Ma le disgrazie di questo scultore non finiscono qui. L’ onorevole
Farinacci, potente ras di regime, eletto nelle file fasciste a
Cremona, prende le difese del suo artista concittadino e lo tira fuori
di prigione, con tanto di polemiche. La sua fama aumenta, gli
vengono commissionati ritratti e dipinti, ma sembra impossibile
togliersi quella etichetta di falsario che lo perseguita da sempre,
malgrado la sua volontà.
Oggi le opere del cremonese Alceo Dossena, in molti musei del
mondo, portano in calce il suo nome, tardivo riconoscimento a un
genio della scultura vissuto in un tempo in cui il talento può rivelarsi
solo tra falsificazione e inganno.
Dalla provinciale tra Cremona e Casalmaggiore incontro San
Daniele Po.
Il sindaco di questo paese si chiama Davide Persico, è un
paleontologo che ha costituito un Museo del Po proprio qui, nella
Bassa cremonese, uno dei più importanti della Lombardia.
Mentre nel 1998 pubblicavo i racconti de Il coccodrillo sull’altare e
immaginavo due fratelli che cercavano armi e ossa nel letto del
fiume, Davide cercava davvero quello che oggi è raccolto in questo
meraviglioso Museo paleoantropologico che custodisce teschi,
ossa, reperti archeologici ritrovati nel fiume da quelli che io chiamo
“cercatori di crani”.
Con Davide e Alberto Branca, attore e assessore alla cultura di San
Daniele Po, partiamo dal pontile e navighiamo con la barca a
motore sul fiume. Spegniamo il motore e lasciando la barca alla
corrente, beviamouna bottiglia di vino bianco. Il fiume scorre lento,
smeriglia la luce del tramonto mentre i pioppi sussurrano sulle
piante, sfiorati dalla brezza. Alberto recita a memoria la poesia di
Petrarca che parla del fiume, quando il sole basso si specchia
nell’acqua.
Ugo Tognazzi, l’abbuffone
La cucina lungo il Po è un piacere vitale, è un’arte che talvolta rivela
un lato voluttuoso, spinto verso l’ingordigia, la cupidigia e il rito
orgiastico, quando sul punto di massimo piacere sconfina verso gli
abissi della morte. Il film che racconta tutto questo è La grande
abbuffata con la regia di Marco Ferreri del 1973. L’ abbuffone per
eccellenza, uno dei protagonisti del film insieme a Marcello
Mastroianni, Michel Piccoli e Philippe Noiret è Ugo Tognazzi,
indimenticato attore nato a Cremona nel 1922 e morto a Roma nel
1990.
Per Tognazzi la cucina è una forma di teatro dove i commensali
sono attori e spettatori che partecipano allo spettacolo del
cuoco attore-intrattenitore-regista.
«Ho la cucina nel sangue. Il quale, penso, comprenderà senz’altro
globuli rossi e globuli bianchi, ma nel mio caso anche una discreta
percentuale di salsa di pomodoro.»
Così scrive Tognazzi nel suo capolavoro L’ abbuffone, storie da
ridere e ricette da morire (1974) e continua:
«Ingordigia, golosità: parole sciocche, dettate dalla morale
corrente punitiva e masochista. Ognuno è libero di fare la sua
scelta, anche di morire gonfio di foie gras o stremato dagli
amplessi.
Disoccultiamo queste due sane, grandi e materialistiche passioni,
per troppo tempo tenute nel ghetto della peccaminosità».
Tognazzi, da vero uomo di pianura, da figlio del Po, invita a vivere
nella sua pienezza la passione gastronomica e amorosa,
liberandola dalla morale.
Nella descrizione del Risotto di fine stagione, incluso nella seconda
sezione de L’Abbuffone, la realizzazione della ricetta prende la
forma di uno spettacolo teatrale:
Risotto di fine stagione
Mezzo chilo di riso, un buon brodo di verdura, un etto e mezzo di
burro, una cipolla, un gambo di sedano, una carota, un ciuffo di
prezzemolo, due pomodori ben rossi, del vino bianco, due
zucchine, una melanzana non troppo grande, un ciuffettino di
basilico e formaggio parmigiano. Questi i protagonisti del risotto fine
stagione per 6 persone. E ora vediamo come e perché entrano in
scena.
Il sipario di apre su un etto di burro che soffrigge con: la cipolla, il
sedano, la carota, il prezzemolo (tagliati sottili sottili). Stanno lì
rosolando, quando entrano, tagliate a pezzettini, le zucchine e le
melanzane con il basilico. Applausi a scena aperta.
E’ la volta del vino bianco, di cui ogni tanto compare una spruzzata.
Ma ecco i due pomodori (tagliati a pezzetti) che fanno il loro
trionfale ingresso nel tegame. Quando tutto si è ben rosolato,
squillano le trombe ed entra il riso.
Mescolata generale.
Di volta in volta, un mestolo versa il brodo di verdure, fino a tirare il
risotto nel giro di un quarto d’ora, diciotto minuti. Il fuoco viene
spento quando il riso è un pochino al dente. Sul riso che riposa
nella pignatta si posa dolcemente l’altro mezzo etto di burro crudo,
mentre dall’alto, come una silenziosa nevicata, scende il
parmigiano. In questo clima cecoviano-gastronomico, cala la tela.
Applausi. Richiesta di Bis.
Morire mangiando all’infinito: questa e il tema del film La grande
abbuffata. Non si mangia più, si recitano le ricette. Tognazzi ricorda
di aver stracciato il copione e di aver buttato le pagine dal balcone
di casa sulla testa del regista: reciteranno giorno dopo giorno
sapendo che uno alla volta moriranno tutti.
Leggendo le ricette utilizzate nel film, tra Pâté di cinghiale, Cocktail
di gamberetti e Caviar d’aubergine, passando dall’Insalata Niçoise,
passando dal Puré di patate alla Faraona arrosto alla Cassoulet di
Casterlnaudary, per chiudere con una Bavarese di tette, mi viene
da pensare che noi emiliani che viviamo lungo il Po non mangiamo,
ogni volta a tavola, come in un grande teatro, recitiamo il nostro
copione gastronomico.
Chi attraversò la piena nel 1951
La voce di Aldo si trasforma in quella di suo padre: «Nel 1951
a Casalmaggiore eravamo preoccupati per le piogge insistenti. Il
fiume non l’avevamo mai visto così brutto. Cresceva di ora in ora,
mettevano sacchetti di sabbia su argini e muri, ma per la prima
volta abbiamo temuto che l’acqua esondasse come una pentola
che bolle, riversando acqua e fango in citta.
Sapevamo di molta gente rimasta imprigionata nelle case dentro la
golena. Dall’altra parte, tra Sissa e Torricella, c’era un gruppo di
famiglie in trappola, alcuni di loro stavano sui tetti per cercare aiuto.
Avevo deciso di portarle in salvo. C’erano due famiglie che
conoscevo bene. Ero sicuro che fossero ancora la ad aspettare
qualcuno che portasse soccorso. Cosi avevo deciso.
“Tu sei matto!” mi dicevano. “Matto sul serio. Non si attraversa
il fiume in piena. Non lo vedi? In mezzo c’è una corrente fortissima,
si formano delle onde paurose, alte anche due o tre metri. E poi ci
sono i tronchi, i legni, e tutto quello che porta giù il fiume diventa un
pericolo. Se vieni colpito da un tronco sei fritto. Diventano proiettili.”
Ma avevo deciso di andare comunque. Avevo preparato la barca,
avevo fissato i remi agli scalmi e li avevo legati con le corde, per
evitare che un colpo potesse portar via tutto. Mi ero intabarrato
bene perché continuava a piovere.
“Ma vai da solo?”
“Chi vuole può venire con me. Io non ho paura. Io di là ci vado in
ogni modo!” dissi. “Ve lo posso garantire. Non posso lasciare quelle
famiglie da sole. La barca la so portare. Non è la prima volta che
attraverso il fiume in piena!”
“Si, ma non questa volta! Non si è mai visto così alto. La corrente fa
paura. Non senti come urla?”
Mi preparavo all’attraversata in silenzio.
L’ acqua era color fango scuro e mattone. Poi diventava grigia
specchiando il cielo. Ma quello che faceva impressione era il
muggito, il verso che il fiume fa quando è in piena. Mentre
preparavo la barca, sentivo quel verso animale che viene dal fondo
dell’inferno.
Il fiume è un toro, è un dio malato che muggisce dalle viscere della
terra. Prima di mettere la barca in acqua, mi feci il segno della
croce, e poi partii.
“Mi raccomando!”
“Aspetta!” gli disse il suo migliore amico. “Vengo con te!”
Sul mio volto comparve un sorriso grande così. In due avremmo
bilanciato meglio la barca.
L’ inizio non fu difficile.
“Il problema sarà prendere la corrente. Dovremo seguirla e poi
guidarla mentre ci spostiamo. Non dobbiamo farci travolgere!”
“Hai paura?” chiesi al mio amico.
“Mi cago addosso, se lo vuoi sapere!”
Partimmo con calma. Man mano che ci avvicinavamo alla corrente,
sentivamo che l’acqua ci portava via. La barca cominciò a muoversi
da sola, prendendo velocità, e quando vedemmo le onde nel mezzo
pensammo di tornare indietro. Si alzavano dei muri d’acqua di due,
tre metri. La corrente era fortissima, non avevamo mai visto niente
del genere e, adesso che iniziavamo ad avere paura, la barca
cominciava a correre sempre più veloce.
Sembrava legata al dorso di uomini-pesce, di tritoni che la
trascinavano a valle come demoni pazzi. Cercammo di governarla.
Niente. Il fiume era diventato padrone del legno. Le braccia si
fecero dure come il ferro per lo sforzo. “Si comincia a ballare!” urlai,
quando capii che ormai eravamo prigionieri della corrente. Era
come stare sul dorso di un toro impazzito.
“Dai che si va!” L’ urlo del fiume era sempre più potente man mano
che la barca correva. “La corrente è fortissima!” gridai prendendo gli
spruzzi in faccia, ma il mio amico non mi sentì. “Guarda!”
Il fiume tirava in giù la barca, come se fosse agganciata a un
elastico. Scendeva correndo, seguendo le onde. Cercavo di non
farla girare, perché sarebbe stata la fine. Quando capii che dovevo
lasciarla andare non frenammo più la corsa, ci lasciammo portare
dalla corrente come se fossimo stati un tronco o un albero.
Stavamo aggrappati alla barca, con le onde che schizzavano il
fango in faccia. Era come saltare in un mare in tempesta. Le onde
seguivano e correvano davanti, di fianco, ai lati. Tutto si svolgeva
in modo convulso, e io urlavo come un pazzo.
“Non ci freghi, bello mio! Non ci porti all’inferno!”
La barca volava come una delle macchine da corsa della Mille
Miglia.
Prima o poi la corrente ci avrebbe inghiottiti. Non ci avrebbero
più trovati.
I nostri corpi sarebbero finiti nella tomba del mare. E invece riuscii a
capire: la corrente faceva le gobbe, bastava prenderle nel verso
giusto perché la barca scivolasse oltre. E cosi facemmo.
Quando fui sul punto cruciale affondai i remi, la barca scartò di lato,
prese un’onda gigante, salto sulla cresta e discese dolcemente.
Il mio amico davanti aveva mollato i remi per tenersi agli scalmi con
tutta la forza che aveva. Ci eravamo sentiti lo stomaco in gola ma
tutto era andato bene. Facemmo un altro dondolo, meno forte, ma
sempre con la barca che sembrava volare con la prua verso il cielo.
Una, due, tre volte: all’ultimo sembrò volare in cielo. Poi ci
rendemmo conto di aver superato il peggio, la tensione del fiume
diminuiva.
Era ora di spingere con i remi e di andare verso la sponda di
Sissa che compariva all’orizzonte. Alla nostra destra vedevamo le
cime degli alberi della golena completamente sommersa. Quando
capimmo che ce l’avevamo fatta, che avevamo superato la
corrente, dopo che un’onda ci aveva sputati fuori come un tronco
qualsiasi, cominciammo ad andare leggeri.
Urlavamo dalla gioia! Vedemmo in lontananza dei tetti. Erano quelli
che cercavamo. Remammo fino alla casa. Il muggito del fiume era
diventato più lontano, lo avevamo lasciato alle spalle.
L’ acqua era calma.
“Ce l’abbiamo fatta!” dissi al mio amico.
“Si, ma non lo rifarei per tutto l’oro del mondo. Mi sono visto
all’inferno. Pensavo che la corrente c’inghiottisse dopo averci fatto
volare verso il cielo.”
Mentre remavamo sfogavamo la tensione, parlavamo e ridevamo
del fatto che avremmo raccontato a tutti che avevamo domato il
fiume in piena e avevamo portato soccorso alla riva parmigiana.
Lontano si sentirono delle grida.
Nel pomeriggio plumbeo, nel grande mare del fiume, un bambino
sopra il tetto di una casa sventolava lontano una specie di bandiera,
con una canottiera bianca fissata a un palo.
“Eccoli là! Visto che non mi sbagliavo?”
Raggiungemmo la casa, con forza, felici come non lo eravamo mai
stati, con le onde della corrente negli occhi, il muggito nelle
orecchie e il lago calmo che solcavamo con tutta la forza delle
nostre braccia.
“E quelli cosa sono?” mi chiese il mio amico. Ci avvicinammo.
Erano delle galline morte e un maiale immobile, gonfio. Li
scansammo con i remi. Dalle case arrivavano le urla di aiuto e noi
rispondemmo alle grida. Approdammo infine alla finestra del terzo
piano. Lo sterco di vacca galleggiava vicino alla casa con sopra le
galline, isole nella calma piatta del fiume. Aspettavano tutti alla
finestra. Piangevano e ridevano per l’arrivo dei soccorsi. Salii in
piedi sul davanzale, mi tolsi il cappello e la tela cerata.
“Come va?” dissi sorridendo.
Feci un salto in casa facendo traballare il pavimento.
Ci abbracciammo.
“E da dove venite?”
“Da Casalmaggiore!”
“E avete superato la piena del fiume?”
“Certo, per portarvi fuori di qui!”
“Siete dei matti! Dei folli. Avete rischiato la vita per noi!”
Io e il mio amico ridemmo. “Un gioco da ragazzi!”
“E come sapevate che noi eravamo in mezzo all’acqua?”
Sorrisi di nuovo. Guardai una ragazza con i capelli raccolti sotto un
fazzoletto, che diventò rossa. Era dolce e gentile. Aveva gli occhi
pieni di lacrime. Ci abbracciammo davanti a tutti. Per lei avevo
rischiato la morte attraversando il Po in piena. Quella poi sarebbe
diventata mia moglie.»
Potrebbero piacerti anche
- 101 storie su Genova che non ti hanno mai raccontatoDa Everand101 storie su Genova che non ti hanno mai raccontatoNessuna valutazione finora
- 101 storie su Napoli che non ti hanno mai raccontatoDa Everand101 storie su Napoli che non ti hanno mai raccontatoNessuna valutazione finora
- Il Cavaliere dello Spirito Santo: Storia d'una giornataDa EverandIl Cavaliere dello Spirito Santo: Storia d'una giornataNessuna valutazione finora
- Il commissario Richard. Il fatto di via delle ArgonneDa EverandIl commissario Richard. Il fatto di via delle ArgonneNessuna valutazione finora
- Due Colori Esistono Al MondoDocumento53 pagineDue Colori Esistono Al MondoCost KiaNessuna valutazione finora
- L'Incendiario; col rapporto sulla vittoria futurista di TriesteDa EverandL'Incendiario; col rapporto sulla vittoria futurista di TriesteNessuna valutazione finora
- IL MUSEO DEL MONDO 9 - La Morte Di Procri Di Piero Di Cosimo (1495-1500) - La Repubblica 24.02.2013Documento1 paginaIL MUSEO DEL MONDO 9 - La Morte Di Procri Di Piero Di Cosimo (1495-1500) - La Repubblica 24.02.2013glisfogliati100% (1)
- 101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vitaDa Everand101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vitaNessuna valutazione finora
- Cronache dal mondo dell'arte 1: Storie curiose di artisti e dintorniDa EverandCronache dal mondo dell'arte 1: Storie curiose di artisti e dintorniNessuna valutazione finora
- Luoghi ed itinerari sentimentali di Giacomo CasanovaDa EverandLuoghi ed itinerari sentimentali di Giacomo CasanovaNessuna valutazione finora
- Murger Vita Di BohemeDocumento367 pagineMurger Vita Di Bohemeundamaris2006Nessuna valutazione finora
- Polvere di storia: Testo storico, sociologico e delle codificazioniDa EverandPolvere di storia: Testo storico, sociologico e delle codificazioniValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- L’ultima rosa di aprile – II ed.: Simonetta Cattaneo Vespucci, la Venere del BotticelliDa EverandL’ultima rosa di aprile – II ed.: Simonetta Cattaneo Vespucci, la Venere del BotticelliNessuna valutazione finora
- Nero Caravaggio - Rosso Barocco - Il giallo di Ponte SistoDa EverandNero Caravaggio - Rosso Barocco - Il giallo di Ponte SistoNessuna valutazione finora
- IL MUSEO DEL MONDO 22 - San Giorgio e La Principessa Di Pisanello (1437-38) - La Repubblica 26.05.2013Documento1 paginaIL MUSEO DEL MONDO 22 - San Giorgio e La Principessa Di Pisanello (1437-38) - La Repubblica 26.05.2013glisfogliatiNessuna valutazione finora
- "L'Adalgisa" Una Performance IntroduttivaDocumento9 pagine"L'Adalgisa" Una Performance IntroduttivaAntonio BaroneNessuna valutazione finora
- GiovenaleDocumento3 pagineGiovenaleVERONICA PIERACCININessuna valutazione finora
- Shakespeare William - Il Mercante Di VeneziaDocumento157 pagineShakespeare William - Il Mercante Di Veneziazonoz100% (1)
- A Mosca CiecaDocumento3 pagineA Mosca CiecaEsonet.orgNessuna valutazione finora
- Leggende Praghesi - Frantisek LangerDocumento56 pagineLeggende Praghesi - Frantisek Langerromeo5757Nessuna valutazione finora
- Pinocchio Croce PDFDocumento11 paginePinocchio Croce PDFMacioniliaNessuna valutazione finora
- Nwouiiay - Caricabatteria - Auto - Di-Nb Comperarlo Su Amazon NBNBDocumento7 pagineNwouiiay - Caricabatteria - Auto - Di-Nb Comperarlo Su Amazon NBNBgiuseppeNessuna valutazione finora
- Lavatrice Samsung ww60j4Documento56 pagineLavatrice Samsung ww60j4GianlucaNessuna valutazione finora
- Cicli Di Lavorazione Esercizio CicloDocumento18 pagineCicli Di Lavorazione Esercizio CicloucimolfettaNessuna valutazione finora
- Direttiva Antincendio VKFDocumento5 pagineDirettiva Antincendio VKFmattpurificatoNessuna valutazione finora
- AtanasioDocumento33 pagineAtanasiooctavioagpNessuna valutazione finora
- Infarto Del MiocardioDocumento9 pagineInfarto Del MiocardioGiuseppe IntelliNessuna valutazione finora