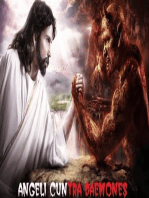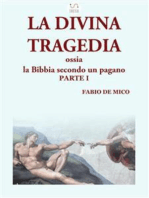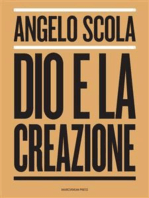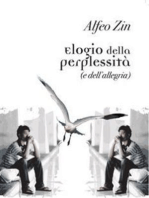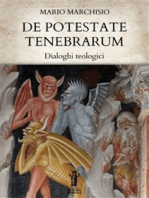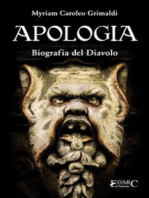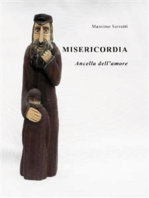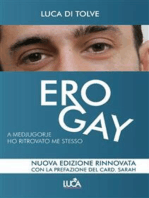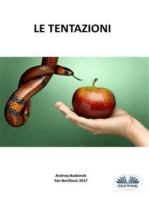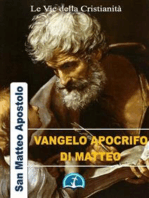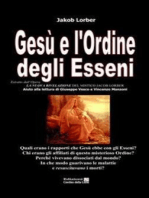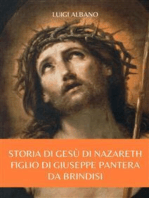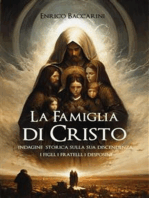Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Comentario FT Italiano
Caricato da
Yehosua0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
217 visualizzazioni17 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
217 visualizzazioni17 pagineComentario FT Italiano
Caricato da
YehosuaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 17
Adamo, dove sei?
Siamo fratelli in umanità
https://www.retesicomoro.it/fratelli-tutti-papa-francesco-introduzione/
1. Legami e relazioni umane nella traiettoria del libro della Genesi
Per approfondire il volto fraterno dell’umanità alla luce delle scritture ebraico-cristiane,
avremmo potuto focalizzare la domanda che Dio rivolge a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?»
(Gn 4,9). La risposta indolente di Caino – «Sono forse io il custode di mio fratello?» –
manifesta la terza caduta di una umanità incapace non solo di coltivare il giardino di Eden,
ma anche di custodire i rapporti con gli altri esseri umani. Infatti , dopo la disobbedienza
originaria, che compromette i rapporti tra Dio e l’uomo – il peccato originale, appunto -, e
dopo l’alterazione della reciprocità uomo-donna, arriva una terza tossina a inquinare
l’ecosistema delle origini: la rivalità tra fratello e fratello e, più in generale, nei rapporti
orizzontali e simmetrici.
All’omicidio di Abele seguiranno altri peccati – meno originali, ma pur sempre prototipici -,
lungo la traiettoria narrativa di Gn 1-11, che disegna una parabola discendente in cui
s’intreccia, con il linguaggio del mito, la triste trama del reale. Poco più tardi, l’episodio di
Cam, che scopre la nudità del padre Noè (Gn 9,20-28), rappresenta la degradazione dei
legami tra genitori e figli e, più in generale, di ogni relazione verticale e asimmetrica. Infine,
l’episodio della torre di Babele spiega come mai siano apparsi nel mondo l’inimicizia e
l’incomprensione tra i popoli. Anche questo episodio avrebbe potuto rappresentare un buon
punto di partenza per la nostra riflessione sulla fraternità.
Gli uomini, posti da Dio a custodi della terra, voglio occuparsi di tutt’altro, costruendo
Babele (in accadico, Bab-ili = Porta di Dio), una torre verso il cielo; ma vengono nuovamente
dispersi su tutta la terra. Desiderosi di darsi una sigla comune e sedotti dal potere
omologante, contraddicono la molteplicità e la diversità delle origini, doni preziosi di una
creazione libera di esprimersi; ma Dio decide di «scendere» — è lo stesso verbo che scatena
la saga esodale in Es 3,7-8! — e di l’«impastare» le loro lingue, creando i presupposti di un
sano relativismo che ha salvato l’umanità – non c’è alcuna punizione in questa dispersione! –
dal rischio dell’assolutismo, dell’esclusivismo e dell’autoreferenzialità.
Potremmo andare avanti, per vedere come le relazioni (tra fratelli, tra famiglie e tra popoli)
vengono tematizzate anche nella storia dei patriarchi. Anzi, sembra che l’intero libro della
Genesi si occupi di mettere a tema la frattura delle relazioni come dramma tipico dell’umano,
un dramma ad atto unico. Tant’è vero che, da un punto di vista narrativo, potremmo trovare
la soluzione dell’intero libro nell’episodio – commovente e carico di misericordia – del ri-
conoscimento di Giuseppe da parte dei suoi fratelli. In Gn 45,4, dopo lunghe schermaglie e
distanze forzate, Giuseppe dice ai suoi fratelli: «Avvicinatevi a me!». Nel contesto di questa
prossimità, il governatore del Faraone manifesta finalmente la sua vera identità: «Io sono
Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l’Egitto». Grazie a
queste parole vengono ricomposte a ritroso tutte le precedenti fratture scomposte della
storia umana: la relazione con l’Egitto, salva Israele dalla carestia e guarisce i rapporti
familiari, sia quelli verticali che quelli orizzontali; il popolo, insediatosi nelle terre egiziane,
diventa numeroso (Es 1,1-7), segno che anche i rapporti tra uomo e donna e tra l’umanità e il
Dio creatore sono stati sanati.
Insomma, la bibbia, ad ogni piè sospinto, drammatizza il tema delle relazioni umane. A me è
stato dato, tuttavia, il compito di andare alle origini di questo grande dramma. Per essere
fratelli nell’ordine della creazione, infatti , bisogna che tutti gli uomini si riconoscano
creature. Per riconoscersi creature occorre riconoscere il Creatore, senza nascondersi da lui.
Ebbene, nella storia delle origini, invece, assistiamo a questo nascondimento, che sarà causa
di ogni futura disgrazia.
Tutto ha inizio con l’inganno del serpente, che ingenera il sospetto – insensato – che Dio
abbia creato l’uomo solo per tenerlo sotto ricatto. La situazione di partenza – l’umanità ante
lapsum – è pacifica, priva di tensione: l’uomo e la donna erano nudi ( ‘arummim), ma non ne
provavano vergogna (cf. Gn 2,25). Gn 3,1 presenta l’elemento destabilizzatore di questo
quadro iniziale: il serpente, che è descritto come il più astuto ( ‘arum) tra tutti gli animali
selvatici. C’è un evidente gioco di parole tra la nudità libera dei progenitori e la malizia del
serpente. È come se l’originaria forma dell’umano, a immagine e somiglianza di Dio, venisse
sostituita da una progressiva somiglianza al serpente. Questa cata-morfosi è un processo
involutivo in cui l’identità creaturale — essere nudi — viene vissuta come rivalsa, complesso
d’inferiorità, motivo di vergogna e, quindi, come pulsione mimetica verso la malizia del
serpente, che guarda tutte le cose in maniera cattiva. Se in Gn 2,25, l’uomo e la donna sono
nudi (‘arummim) e senza vergogna, in Gn 3,7, senza più Dio all’orizzonte, essi si conoscono
nudi (‘eyrummim): si usa lo stesso aggetti vo di 2,25, ma vocalizzato in maniera diversa,
perché qui segnala una nudità ormai caduta nella trappola del serpente, nudo e astuto.
La vergogna non scaturisce dall’essere nudi, ma dall’aver carpito il proprio limite, con
risentimento nei confronti di Dio, finendo per leggere in quella nudità un elemento di
vulnerabilità e, quindi, la possibilità che l’altro sia ostile e antagonista alla mia realizzazione.
Davanti a questo tragico fraintendimento bisogna preservarsi dallo sguardo vulnerante
dell’altro/a, separandosi persino dallo sguardo di Dio, implicitamente riconosciuto come
possibile Dis-creatore. Questa nudità è diventata insopportabile per l’uomo e la donna: ecco,
allora, che le foglie di fico diventano cinture (cf. Gn 3,7) mentre gli alberi del giardino
diventano nascondigli non appena essi odono «la voce di YHWH Dio che andava camminando
nel giardino» (cf. v. 8). La compulsione al nascondimento finisce per trasformare la casa
comune in un covo di latitanti. I custodi in clandestini. Il paradiso in un inferno.
La vergogna, allora, è l’esito di un sospetto che si condensa contro l’altro, sia esso Dio o
chiunque si trovi accanto: «l’inferno sono gli altri». La donna che era stata posta a fianco
dell’uomo come alleata, diventa nemica. La natura che era fonte di sostentamento diventa
matrigna ostile. Dio stesso finisce per essere il primo sospettato di una prevaricazione
consumata a dispetto dell’uomo. Infatti , poco dopo non mancherà il gioco dello scarica barile
(cf. Gn 3,11-13): «l’uomo addossa la colpa della propria scelta di aver mangiato dell’albero
alla donna – quasi colpevolizzando Dio di avergliela posta accanto -, mentre la donna accusa
il serpente di averla sedotta con l’inganno. In tal modo, l’equilibrio originario dell’intera
creazione viene completamente sovvertito: tra Dio e l’uomo, tra l’uomo e i propri simili e tra
questi e gli animali non regna più la comunione ma l’alienazione».
Papa Francesco ha intuito che il tema dell’ecologia, della salvaguardia della casa comune, ha
a che fare con i rapporti interpersonali e con Dio. Ebbene, per parlare di fraternità universale
dobbiamo partire dalla manomissione di questo equilibrio originario. I progenitori sembrano
capricciosamente indispetti ti da quel “tutto, tranne…” con cui Dio ha innescato nel cuore
dell’uomo il delicato meccanismo del dono. Infatti , il limite rende possibile il donare e il
donarsi. Purtroppo, il peccato ha reso ambigua la percezione del limite: se non ci fosse stato
il peccato, «il limite sarebbe rimasto soltanto limite e non mutilazione dell’umano, ostilità
alla vita». La proposta di Dio, invece, era chiara: a te, uomo, tocca tutto, tranne tutto; sei
signore sul creato, ma come custode. P. Beauchamp sintetizza in tre passi l’ecosistema della
creazione, il sogno di Dio sul mondo e sull’uomo: «1. Non tutto = tutti gli alberi eccetto uno;
2. Non senza un altro = non è bene essere solo; 3. Non con il medesimo = non con padre e
madre». Purtroppo, il capriccio ha prevalso sul sogno di Dio.
Davanti alla disperata ricerca di nascondigli da parte dell’umanità, Dio si spoglia della sua
onniscienza anche lui resta nudo! e chiede ad Adamo: «dove sei?» ( ’ayyekkah, cf. Gn 3,9).
Con il peccato gli occhi di Adamo ed Eva si erano aperti. Invece, gli occhi di Dio sembrano
perdere di vista l’umanità. L’inchiesta sulla posizione spaziale, ovviamente, ha dei risvolti
ironici ed eminentemente esistenziali. Dentro a una semplice domanda, si possono trovare
tutte le migliori domande sul senso della vita. Dio chiede ad Adamo di collocarsi, di
“condividere la sua posizione” come facciamo oggi con i nostri cellulari quando vogliamo
raggiungere qualcuno.
Dio aveva già parlato, ma la domanda «dove sei?» segnala il primo tu-per tu tra Dio e l’uomo.
Alla lettera, potremmo rendere il lessema ebraico così: «dove tu?». Essendo un costrutto
nominale manca il verbo essere e la frase sembra emanciparsi dal tempo grammaticale e
proiettarsi su ogni su ogni “tu” che questo racconto biblico intercetta lungo il tempo della
storia. La base di ogni relazione autentica – con i fratelli e con il creato – si trova
nell’interiorizzazione a questa domanda. La risposta di Adamo non può soddisfarci: «ho
avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Eppure, nella replica di Dio non c’è
nessuna rappresaglia: «Chi ti ha detto che sei nudo?». Si noti che la domanda non è “chi ti ha
fatto conoscere…”, ma “chi ti ha detto… ”. Quanto è accolto da Adamo ed Eva come
conoscenza certa, per Dio è solo un inganno. Quello che il serpente ha presentato come
progresso gnoseologico («… voi diventerete come dèi, conoscitori del bene e del male», cf.
Gn 3,5) è, in realtà, solamente un’illusione.
2. Il sogno di Dio: fratelli in umanità
Il testo che abbiamo accostato è inesauribile. La lettura simbolica è decisamente quella più
conforme alla mentalità dello stesso autore biblico. Arrivati a questo punto, mi pare che
abbiamo raccolto abbastanza elementi per ritornare al tema della fraternità universale e
vedere quale strada ci attende nel recupero di questo grande inganno che ci ha manomesso
geneticamente la nostra capacità di guardare Dio, gli altri e il mondo con fiducia e con
empatia. In uno slogan, possiamo legitti mamente sperare di poter annunciare alla Chiesa e al
mondo che il paradiso sono gli altri?
Per fondare questa speranza, dobbiamo capire bene che cosa ha determinato, a cascata, la
patologizzazione del desiderio e dell’identità creaturale: come abbiamo potuto cedere
all’inganno? Saziati dallo sguardo di Dio, in Eden, perché ci siamo sentiti esposti e
vulnerabili? Perché ci siamo convinti che l’unica strada possibile per sopravvivere a quello
sguardo fosse la rivalsa, la rivendicazione e la rapina? A mio avviso, il punto generativo del
conflitto – e, dunque, il tumore che deve essere estirpato in una seria terapia spirituale – è il
rifiuto di ogni responsabilità personale e colletti va. Non posso credere, come spesso si dice,
che il peccato originale sia il rifiuto di Dio. lo sgambetto delle origini, come tutti i peccati, è
sollecitato da una falsa apparenza, sub specie boni. Più che un rifiuto di Dio, è un rifiuto di se
stessi, che non è altro l’esplicito proposito del male: annientarci. A questo va aggiunto
un’altra sottolineatura: le fratture genesiache non nascono dalla differenza — che, anzi,
valorizza al massimo la possibilità della comunione — ma dall’ostinazione dell’uomo che,
dopo il peccato, continua ad alimentare il conflitto con la reticenza e la
deresponsabilizzazione.
Credo che la diagnosi di questo male – oggi così diffuso nella società senza padri, in cui
evapora persino il concetto stesso di cura – passi attraverso l’umile esposizione a quella
domanda: «dove tu?». Anziché ostinarsi a «correggere i pensieri di Dio», bisognerebbe
imparare a riconoscere la mistificazione del serpente e cominciare a confessare la nostra
identità creaturale. Occorre prendersi la responsabilità di indicare sempre la propria
posizione, essere sempre rintracciabili da Colui che ci ha donato l’esistenza. La responsabilità
del qui è la condizione per iniziare l’esodo verso là, verso l’oltre che rappresenta il compito
che spetta ad ogni essere umano. Per cominciare a pensare e generare quel mondo aperto
che sogna il Creatore, bisogna dare valore ai legami e alle relazioni.
«Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare
la propria pienezza “se non attraverso un dono sincero di sé”. E ugualmente non giunge a
riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri: “Non comunico
effetti vamente con me stesso se non nella misura in cui comunico con l’altro”. Questo spiega
perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta
un segreto dell’autentica esistenza umana, perché «la vita sussiste dove c’è legame,
comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni
vere e legami di fedeltà» (Fratelli tutti, n. 87).
Fin qui si è parlato di una fraternità nell’ordine della creazione. Tuttavia, non posso
accennare anche a un ulteriore sviluppo della fraternità nell’ordine della redenzione. A
ridonare all’uomo la divina «immagine e somiglianza» delle origini sarà Gesù Cristo, lui che
«essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l’essere
uguale a Dio» (Fil 2,6-7), a differenza dei nostri progenitori che carpirono avidamente il
frutto dell’albero. La novità di Cristo ha aggiornato il sistema della fraternità e lo ha reso
perfetto nel vincolo dell’amore fraterno, che non nasce “universale” come la fraternità
nell’ordine della creazione, ma che aspira a diventare tale, attraverso le libere scelte dei suoi
discepoli, nella dinamica evangelica del lievito disperso in mezzo alla massa.
Concludo rammentando che anche l’inizio della missione di Gesù inizia con un dove. Nel
vangelo di Giovanni, che potremmo chiamare il bereshit del Nuovo Testamento a motivo
dell’incipit, sembra che la ricerca dell’uomo da parte di Dio conosca una certa reciprocità.
Alla domanda delle origini della creazione “Adamo, dove sei?” finalmente corrisponde la
domanda delle origini della redenzione: «Rabbì, dove dimori?» (Gv 1,38). Anche l’uomo si
mette a cercare Dio. Gesù non si nasconde dietro a un albero, ma si espone sopra un albero.
Per aprire i nostri occhi sulla vita eterna, egli chiude gli occhi inchiodato alla croce. Per farci
entrare in Eden, è ucciso fuori dalla città. La fraternità inaugurata da Cristo attende una terza
fase della storia della salvezza: attende che «Dio sia tutto in tutti » (1Cor 15,28) e che l’ordine
della creazione e l’ordine della redenzione vadano a confluire in un terzo e definitivo
ecosistema, quello della divinizzazione, messa in moto dall’opera trasformatrice dello Spirito
Santo.
3. Piste di riflessione sulla fraternità universale
Avviando questo cammino, vorrei proporvi alcune domande, per precisare meglio la rotta di
navigazione. Difatti , sento che questo mio intervento resta monco finché non raggiunge quel
formidabile secondo capitolo dell’enciclica Fratelli tutti , dedicata alla parabola del Buon
Samaritano. Volutamente, dunque, mi fermo a problematizzare i presupposti di un’adeguata
comprensione della fraternità universale:
– condividete questo sguardo storico salvifico sulla fraternità che ho cercato di presentare
attraverso le tre tappe della storia della salvezza (creazione, redenzione, divinizzazione)? In
altre parole, quale profezia incorpora la promozione della fraternità universale promossa da
papa Francesco?
– sapete che il tema della fraternità è un tema molto tematizzato in epoca borghese anche
da altri soggetti : basta pensare al motto della rivoluzione francese (fraternité) o ai vincoli
d’interesse che vigono all’interno delle varie logge massoniche. Secondo voi, nella riflessione
che stiamo avviando, serve prendere le distanze da queste manifestazioni non evangeliche
della fraternità quali mistificazioni del vangelo di Cristo? Oppure ci sono margini per
recuperare e valorizzare anche quelle istanze?
– a questo proposito, avrebbe senso introdurre una differenza tra fratellanza e fraternità?
A mo’ di suggestione, consiglio a tutti di ascoltare una canzone intitolata You want it darker,
di Leonard Cohen. La canzone si trova all’interno dell’omonimo album, uscito appena
qualche giorno prima della morte del grande cantautore e poeta. Un passaggio della canzone
dice: “Hineni, hineni, I’m ready my Lord”, “Eccomi, eccomi, sono pronto, Signore!”. Cantata
poco prima della morte, sembra un presentimento: vorrei leggerla, invece, come invito alla
responsabilità o, se preferite, come una preghiera per vivere e morire in pace. Come già M.
Buber, anche secondo il nostro cantautore ogni volta che si sente il grido Hinneni inizia il
dialogo, che ri-crea la connessione con i propri simili, interrotta dal peccato, e manifesta il
presupposto indispensabile della fraternità universale. Hinneni è l’inizio di un cammino che
conduce l’umanità ad accogliere il dono della redenzione e della divinizzazione. Hinneni è la
posizione di Abramo, di Giacobbe, di Mosè… di tutti coloro che hanno risposto prontamente
alla domanda di Dio. Iniziando questi mercoledì di spiritualità, sentiamo rivolta anche a noi la
prima domanda di Dio all’umanità: ’ayyekkah? Dove sei? L’unica risposta possibile è hinneni:
eccomi! Il Regno di Dio, che è già in mezzo a noi, qui e ora, attende un compimento che
passerà anche attraverso l’universalizzazione della fraternità evangelica.
Don Carmelo Russo
Mercoledì della spiritualità, 25/10/2021, Fraternità Carmelitana di Barcellona Pozzo di Gotto
Le ombre di un mondo chiuso: la fraternità tradita
https://www.retesicomoro.it/fratelli-tutti-papa-francesco-commento-capitolo-i/
1. Unioni e divisioni
Nella complessità dell’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, il primo capitolo rappresenta
l’affresco generale sulle criticità del mondo contemporaneo. Il titolo del capitolo “Le ombre
di un mondo chiuso” già dà il segno inequivocabile della forte preoccupazione di Papa
Francesco verso un mondo tendente alla chiusura e per questo produttore di ombre che
impediscono alla luce di penetrare e illuminare la vita delle persone. Ombre obnubilanti per
molti popoli e comunità che vivono forti divisioni ed egoismi colletti vi e individuali. I tempi
del Concilio Vaticano II sembrano davvero lontanissimi quando si gioiva dei chiarori di
un’aurora promettente dopo gli orrori della II guerra mondiale. «Per decenni è sembrato che
il mondo avesse imparato da tante guerre e fallimenti e si dirigesse lentamente verso varie
forme di integrazione. Per esempio, si è sviluppato il sogno di un’Europa unita, capace di
riconoscere radici comuni e di gioire per la diversità che la abita» (Fratelli tutti , n. 10).
Papa Francesco mette in risalto come negli anni immediatamente dopo la II guerra mondiale
si avesse fiducia nel futuro, poiché dopo i milioni di morti, gli eccidi, l’olocausto di ebrei e
rom e la distruzione di intere città, lavorare per costruire percorsi di pace diventava un
imperativo. Forte speranza nonostante tutte le contraddizioni del secondo dopoguerra
mondiale, come sottolineato negli scritti di un uomo di fede e di impegno sociale e politico
come Giuseppe Dossetti , che rimarcò i rischi del persistere di profonde ingiustizie con la
costituzione di blocchi contrapposti all’interno della stessa Europa che secondo la sua visione
avrebbe dovuto invece essere unita ed indipendente dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica.
Nonostante tutti i limiti del nuovo ordine mondiale, è indubitabile che nei decenni successivi
almeno in Europa si diede vita a processi di integrazione tra Stati e popoli per esorcizzare il
ritorno a nazionalismi esasperati, già produttori di persecuzioni di minoranze interne e di
guerre tra Stati. L’utopia di un’Europa Unita – immaginata e tratteggiata attraverso il
Manifesto per un’Europa Libera e Unita da oppositori del regime fascista al confine nell’isola
di Ventotene come Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni – non è rimasta
irrealizzata. Oggi l’Europa non è una vera federazione di Stati ma certamente un’Unione di
Stati che potrebbe accrescere ulteriormente la sua coesione interna se a impedirla non
fossero i risorti nazionalismi mascherati da sovranismi. «Si accendono conflitti anacronistici –
scrive Papa Francesco – che si ritenevano superati, risorgono nazionalismi chiusi, esasperati,
risentiti e aggressivi. In vari Paesi un’idea dell’unità del popolo e della nazione, impregnata di
diverse ideologie, crea nuove forme di egoismo e di perdita del senso sociale mascherate da
una presunta difesa degli interessi nazionali» (Fratelli tutti , n. 11).
Se in Europa la situazione è a forte rischio di crescenti nazionalismi, soprattutto nei paesi
dell’ex blocco socialista, in Africa purtroppo non mancano i casi di leader e gruppi politici
pronti a costruire le loro fortune fomentando odio contro gruppi di popolazioni non uniformi
alla maggioranza. Ma effetti vamente in Africa purtroppo conflitti esasperati sono una
costante degli ultimi tre decenni. Un esempio emblematico è la Costa d’Avorio e la
cosiddetta invenzione dell’ivoirité. Questo paese è stato caratterizzato da consistenti flussi
migratori prima e dopo l’indipendenza del 1960 guidata da Houphouët-Boigny, poiché le sue
terre fertili hanno continuato ad attrarre lavoratori per tutto il Novecento e intere famiglie
dagli Stati confinanti come Burkina Faso (ex Alto Volta, solo nel 1947 separato della Costa
d’Avorio), del Mali, della Guinea, del Ghana. Negli anni Ottanta la Costa d’Avorio era “il
paese della pace e dell’ospitalità” con quindici milioni di abitanti, di cui un terzo di origine
straniera. Tuttavia gli stranieri coltivavano le terre considerandole loro, ma senza avere alcun
documento che lo certificasse ed oltretutto, nonostante risiedessero in quel paese da più
generazioni non avevano acquisito la cittadinanza, pur avendo diritto a voto.
Quando, su spinta della Francia, dal partito unico negli anni Novanta si è passati ad una vera
e propria concorrenza elettorale, con la nascita del Fronte Popolare Ivoriano, con un leader
in ascesa come Laurent Gbambo, tutti i nodi irrisolti sono emersi pericolosamente.
Quest’ultimo, infatti , per contrastare lo strapotere del vecchio Presidente ha fomentato
l’odio verso coloro che si erano insediati in Costa d’Avorio provenendo dagli Stati vicini. Dai
primi anni Novanta ad oggi il paese è stato insanguinato da continui scontri e profonde
lacerazioni. La comunità internazionale e alcune organizzazioni come Sant’Egidio hanno più
volte contribuito a promuovere accordi di pace, ma l’esasperazione delle differenze per scopi
politici ed economici crea delle spaccature che diffi cilmente si rimarginano. Tra la
popolazione del Nord e del Sud rimangono forti pregiudizi e diffi denze reciproche, che
spesso si registrano tra gli stessi emigranti nei paesi europei .
«I conflitti locali e il disinteresse per il bene comune – si legge ancora nell’enciclica –
vengono strumentalizzati dall’economia globale per imporre un modello culturale unico. Tale
cultura unifica il mondo ma divide le persone e le nazioni, perché “la società sempre più
globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli”. […] L’avanzare di questo globalismo
favorisce normalmente l’identità dei più forti che proteggono sé stessi, ma cerca di
dissolvere le identità delle regioni più deboli e povere, rendendole più vulnerabili e
dipendenti. In tal modo la politica diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici
transnazionali che applicano il “divide et impera”» (Fratelli tutti , n. 12).
Il tema dell’identità dei popoli e delle nazioni è molto delicato, poiché bisogna sicuramente
difendere l’indipendenza e la capacità di trovare vie nuove e originali al benessere dei
proprio cittadini, soprattutto in un momento in cui finalmente il legame tra pericolosi
cambiamenti climatici e l’inquinamento ambientale è innegabile, ma bisogna sperare e
lavorare per favorire le unioni e le integrazioni regionali evitando di irrigidire i confini.
Purtroppo i confini con tutta l’ambiguità della loro maggiore o minore porosità accrescono
diseguaglianze e lacerazioni, soprattutto oggi in cui i drammi ambientali portano sempre più
gruppi di popolazione a spostarsi per sfuggire alla desertificazione. Per rendere meno
vulnerabili e meno dipendenti i piccoli paesi dalle potenze regionali bisogna trovare
opportunità di nuove unioni anziché di nuove lacerazioni. Il tema in questione è
particolarmente importante per l’Africa, divenuta di nuovo territorio di conquista di varie
potenze.
Come ha scritto Mario Giro: «Dopo un decennio di abbandono l’Africa è tornata ad essere al
centro degli interessi del commercio globale, sia per le materie prime che per le infinite
possibilità economiche che offre, inclusi i traffi ci illeciti. Tutto ciò sta alla base di molti
conflitti e crisi che stanno insanguinando il continente e continuano a tormentarlo».
Purtroppo in molti paesi africani non emergono ultimamente imprenditori politici della
speranza capaci di scommettere sul futuro, ma imprenditori politici della paura, che, spesso,
si trasformano in nuovi dittatori o signori della guerra. E la guerra diventa spesso essa stessa
un affare, perché i “capi milizia” come dei veri e propri imprenditori sono capaci di attrarre
tanti giovani a sé e di fare rete con altri traffi canti, contrabbandieri e speculatori per
aumentare a dismisura il loro giro di affari. I traffi canti di armi legati ad aziende delle
potenze occidentali e orientali fanno grandi affari come decenni prima, allorquando a
fomentare le guerre locali erano il blocco occidentale o il blocco sovietico, in
contrapposizione l’uno all’altro. Come evidenziato nell’enciclica le guerre locali
apparentemente dovuti a conflitti etnici non sono altro che il frutto di una globalizzazione
capace di portare in ogni angolo del pianeta gli interessi capitalistici.
2. Democrazia e libertà
«Un modo effi cace di dissolvere la coscienza storica, il pensiero critico, l’impegno per la
giustizia e i percorsi di integrazione è quello di svuotare di senso o alterare le grandi parole.
Che cosa significano oggi alcune espressioni come democrazia, libertà, giustizia, unità? Sono
state manipolate e deformate per utilizzarle come strumenti di dominio, come titoli vuoti di
contenuto che possono servire per giustificare qualsiasi azione» (Fratelli tutti , n. 14). Parlare
oggi del significato delle parole libertà, democrazia e giustizia è davvero dura. La lunga uscita
dalla pandemia di Covid 19 sta mostrando tutte le debolezze del pensiero critico. Infatti , se
giustamente abbiamo con durezza criticato il sistema neoliberale imperante che spinge gli
Stati di quasi tutto il mondo ad un ripiegamento strategico per passare il testimone agli
individui inaugurando la stagione della ragion dello Stato minimo , nel momento in cui lo
Stato – a seguito di una devastante pandemia in termini di morti e di danni sull’economia
reale – prova a mettere dei limiti ragionevoli alla libertà individuale a favore della salute
pubblica e della colletti vità, si scatenano critiche feroci e proteste di ogni tipo.
Se da un lato Papa Francesco giustamente sottolinea il rischio che parole come democrazia e
libertà vengano utilizzate in maniera distorta dal pensiero unico globalista e neoliberale,
d’altra parte è necessario che noi cristiani prendiamo coscienza dell’individualismo da cui
sono pervasi e che si riviene anche tra i sinceri amanti della giustizia sociale. Forse
l’individualismo liberista tanto a parole esecrato, nei fatti lo abbiamo talmente introiettato
nelle nostre vite che viviamo secondo i suoi precetti ma crediamo di esserne i critici più
attenti. Per comprendere meglio questo atteggiamento culturale, si potrebbe utilizzare il
concetto di senso comune di Antonio Gramsci come lo ha proposto David Harvey in Breve
storia del neoliberalismo: «A differenza del “buon senso”, che può essere il risultato di una
riflessione critica, il “senso comune” si costruisce attraverso pratiche consolidate di
socializzazione culturale, spesso profondamente radicate in tradizioni regionali o nazionali;
esso può dunque essere particolarmente fuorviante, in quanto maschera i veri problemi
sotto pregiudizi culturali».
Se aggiorniamo il tema delle tradizioni con quello dell’informazione sul web e sull’uso
spregiudicato dei social media, possiamo agevolmente comprendere come si possa costruire
un forte “senso comune” basato solo su semplici pregiudizi culturali. In tal senso mi sembra
utile fare un salto nella lettura dell’enciclica e rileggere insieme la riflessione sui movimenti
digitali: «D’altra parte, i movimenti digitali di odio e distruzione non costituiscono – come
qualcuno vorrebbe far credere – un’otti ma forma di mutuo aiuto, bensì mere associazioni
contro un nemico. Piuttosto, “i media digitali possono esporre al rischio di dipendenza, di
isolamento e di progressiva perdita di contatto con la realtà concreta, ostacolando lo
sviluppo di relazioni interpersonali autentiche”. C’è bisogno di gesti fisici, di espressioni del
volto, di silenzi, di linguaggio corporeo, e persino di profumo, tremito delle mani, rossore,
sudore, perché tutto ciò parla e fa parte della comunicazione umana. I rapporti digitali, che
dispensano dalla fatica di coltivare un’amicizia, una reciprocità stabile e anche un consenso
che matura con il tempo, hanno un’apparenza di socievolezza. Non costruiscono veramente
un noi” ma solitamente dissimulano e amplificano lo stesso individualismo che si esprime
nella xenofobia e nel disprezzo dei deboli. La connessione digitale non basta per gettare
ponti, non è in grado di unire l’umanità» (Fratelli tutti , n. 43).
Non posso fare a meno leggendo questa pagina dell’Enciclica di pensare a un personaggio
molto riuscito del comico Maurizio Crozza: Napalm51. Chiaramente si tratta di una figura
caricaturale ma che rende l’idea meglio di qualsiasi tipizzazione sociologica. Questo
personaggio, infatti , vive il rapporto con le notizie raccolte sul web in modo talmente
immersivo da diventare un fanatico capace di credere a qualsiasi tipo di complotto e odiare
con tutto se stesso il nemico di turno individuato. Purtroppo sappiamo dalla storia quante
volte i grandi complotti , inventati totalmente o ispirati da piccoli fatti reali, possano portare
a drammatici esiti. Sappiamo anche quanto oggi sia facile in pochissimi click diffondere
notizie totalmente infondate ma utili a confermare teorie complotti ste o istigare all’odio
contro il nemico di turno.
3. I diritti umani dalla proclamazione alla realtà
«Molte volte si constata che, di fatto, i diritti umani non sono uguali per tutti . Il rispetto di
tali diritti ” è condizione preliminare per lo stesso sviluppo sociale ed economico di un Paese.
Quando la dignità dell’uomo viene rispettata e i suoi diritti vengono riconosciuti e garantiti,
fioriscono anche la creatività e l’intraprendenza e la personalità umana può dispiegare le sue
molteplici iniziative a favore del bene comune”. Ma “osservando con attenzione le nostre
società contemporanee, si riscontrano numerose contraddizioni che inducono a chiederci se
davvero l’eguale dignità di tutti gli esseri umani, solennemente proclamata 70 anni or sono,
sia riconosciuta, rispettata, protetta e promossa in ogni circostanza. Persistono oggi nel
mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da visioni antropologiche ridutti ve e da un
modello economico fondato sul profitto, che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad
uccidere l’uomo. Mentre una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la
propria dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali ignorati o
violati”. Che cosa dice questo riguardo all’uguaglianza di diritti fondata sulla medesima
dignità umana?» (Fratelli tutti , n. 22).
È del tutto evidente che ci sono seri ostacoli alla possibilità di garantire i diritti umani in tutto
il mondo. L’Afghanistan purtroppo non è l’unico paese al mondo che non riesce a liberarsi da
forze oscurantiste e liberticide. Vent’anni di occupazione di Stati Uniti e alleati, costata un
numero di morti civili superiore secondo alcune stime alle trecentomila unità, insegna
d’altronde che affi darsi alle armi per promuovere libertà e diritti umani non è poi così
sensato. Oggi la speranza è che l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale continui a
mantenere il più possibile il faro puntato su questo paese, per ridurre i rischi di persecuzione
nei confronti delle donne emancipate che vogliono continuare a lavorare o delle ragazzine
che vogliono continuare a frequentare la scuola. I paesi in cui persistono situazioni di rischio
per i diritti umani sono veramente tanti. L’Egitto nei mass media italiani è emerso in tal
senso prima per la tragica morte a seguito di inaudite torture del ricercatore sociale Giulio
Regeni e successivamente per l’arresto di Patrick Zaki (dottorando di ricerca a Bologna)
detenuto da più di un anno per reati di opinione. L’Egitto è il chiaro esempio di quanto siano
sacrificabili i diritti umani sull’altare della realpolitik che poi in questo caso sono grosse
commesse militari o contratti di compagnie energetiche italiane.
Ma è certamente la Libia il caso più scandaloso per l’opinione pubblica italiana e più
vergognoso per le istituzioni italiane, che hanno promosso una serie di accordi prima con
Gheddafi e poi con i governi provvisori succedutisi dopo la sua destituzione. La Libia toglie
qualsiasi patina di ipocrisia rispetto al tema dei diritti umani. La stessa Unhcr, tornata in Libia
dopo un accordo del dicembre 2015 con le autorità civili e militari libiche per cercare di
monitorare la situazione, già in un rapporto del settembre 2018 scriveva apertamente che
nulla era cambiato e tutto rimaneva in mano ad una miriade di milizie nel più sfrenato
disprezzo dei diritti umani. «Uomini armati – scrive l’avvocato Lorenzo Trucco dell’Asgi a
proposito dei contenuti del rapporto Unhcr – che lucrano soprattutto sui migranti
provenienti dal Corno d’Africa e dai Paesi sub-sahariani e che attraverso la Libia sperano di
poter raggiungere l’Europa. […] Qui subiscono trattamenti disumani, che spesso portano alla
morte o a indelebili conseguenze fisiche o psichiche. Poco importa che questi luoghi
dell’orrore siano uffi ciali o non uffi ciali. La Libia sarebbe per il rapporto un paese senza
legge, dove nessuno rispetta i diritti umani».
Papa Francesco affronta anche il tema ricorrente delle vecchie nuove forme di schiavitù:
«Riconosciamo ugualmente che, “malgrado la comunità internazionale abbia adottato
numerosi accordi al fine di porre un termine alla schiavitù in tutte le sue forme e avviato
diverse strategie per combattere questo fenomeno, ancora oggi milioni di persone –
bambini, uomini e donne di ogni età – vengono private della libertà e costrette a vivere in
condizioni assimilabili a quelle della schiavitù. […] Oggi come ieri, alla radice della schiavitù si
trova una concezione della persona umana che ammette la possibilità di trattarla come un
oggetto. […] La persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio, con la forza,
l’inganno o la costrizione fisica o psicologica viene privata della libertà, mercificata, ridotta a
proprietà di qualcuno; viene trattata come un mezzo e non come un fine» ( Fratelli tutti , n.
24).
Non tutto è schiavitù e alcune volte si tende a banalizzare lo stesso concetto di schiavitù. Le
pagine più interessanti su questi argomenti sono state scritte da studiosi-attivisti black, tra
cui in primis William Du Bois che negli anni ‘30 in un articolo su The Crisis spiegava il legame
indissolubile tra questione razziale, schiavismo e capitalismo. Anche oggi profitto
capitalistico, razzismo e situazioni di schiavismo o para-schiavismo sono inscindibili.
Certamente la razializzazione di alcuni gruppi sociali con conseguenti percorsi di de-
umanizzazione e marginalizzazione servono a creare situazioni tipiche della condizione di
totale subalternità e dipendenza. Sono queste situazioni che spesso fanno parlare di nuovi
schiavi, ma forse è più opportuno utilizzare termini come “sfruttati” o “razializzati” o
“inclusione differenziale”.
4. Le mafie oggi
«La solitudine, le paure e l’insicurezza di tante persone, che si sentono abbandonate dal
sistema, fanno sì che si vada creando un terreno fertile per le mafie. Queste infatti si
impongono presentandosi come “protettrici” dei dimenticati, spesso mediante vari tipi di
aiuto, mentre perseguono i loro interessi criminali. C’è una pedagogia tipicamente mafiosa
che, con un falso spirito comunitario, crea legami di dipendenza e di subordinazione dai quali
è molto diffi cile liberarsi» (Fratelli tutti , n. 27).
Papa Francesco non perde occasione di attenzionare con preoccupazione la questione delle
mafie, che sfruttando le insicurezze e paure del momento potrebbero diventare strumento di
dominio sulla società. Parlando di “dipendenza e subordinazione” il Pontefice tocca il tema
preoccupante dello “Stato sociale” alternativo offerto dalle mafie nei riguardi della
popolazione sprovvista di tutela istituzionale. La fortificazione dello Stato Sociale diventa
dunque la via per sottrarre alle mafie la manovalanza dell’organizzazione, la cui carenza
impedirebbe alle borghesie mafiose di espandersi. La metamorfosi della questione sociale:
una cronaca del salariato di Robert Castel (del 1995 ma tradotto e pubblicato in Italia solo
nel 2019), libro ormai classico per gli studi sociali, mette in luce i rischi di una società senza
lavoro o con lavori talmente inconsistenti o con salari così bassi da mantenere comunque i
lavoratori nel disagio. Di questo pericolo è consapevole Papa Francesco, come emerge
dall’appello di questi giorni per un salario minimo e la riduzione dell’orario di lavoro in
occasione dell’incontro in Vaticano con i “Movimenti popolari”. Occasione in cui ha anche
chiesto alle case farmaceutiche di liberalizzare i brevetti dei vaccini e ai grandi gruppi
finanziari di condonare i debiti contratti dai Paesi più poveri affi nché possano garantire i
bisogni primari dei cittadini.
I messaggi contenuti in questo primo capitolo di Fratelli tutti , che sono frutto anche di molte
conferenze e prese di posizione di questi ultimi anni, così come i discorsi di questi ultimi
giorni ci consegnano un vescovo di Roma con idee molto nette sulle questioni sociali. Dagli
esiti dell’avviato sinodo delle Chiese locali si potrà appurare in che misura le posizioni
assunte da Francesco su queste tematiche sociali siano sentite e accolte dentro la comunità
cristiana.
Tindaro Bellinvia
Mercoledì della spiritualità, 4/11/2021, Fraternità Carmelitana di Barcellona Pozzo di Gotto
Gesù, buon samaritano, ci rivela la vera umanità
https://www.retesicomoro.it/fratelli-tutti-papa-francesco-commento-capitolo-ii/
1. Introduzione
Nel capitolo 1 dell’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco, viene messo in evidenza – come
abbiamo visto – il paradosso della nostra epoca: a una crescente globalizzazione corrisponde
una frammentazione e un isolamento molto elevati che la pandemia del Covid-19 ha reso
ancora più evidente. Viene sottolineato: «Malgrado si sia iper-connessi, si è verificata una
frammentazione che ha reso più diffi cile risolvere i problemi che ci toccano tutti » (n. 7). Al n.
12 viene evidenziato ancora di più che si tratta di una dinamica che attraversa tutte le
dimensioni della vita sociale: «I conflitti locali e il disinteresse per il bene comune vengono
strumentalizzati dall’economia globale per imporre un modello culturale unico. Tale cultura
unifica il mondo ma divide le persone e le nazioni, perché “la società sempre più globalizzata
ci rende vicini, ma non ci rende fratelli”».
Quindi, nonostante gli apparenti legami, «siamo più soli che mai in questo mondo
massificato che privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria
dell’esistenza. Aumentano piuttosto i mercati, dove le persone svolgono il ruolo di
consumatori o di spettatori. L’avanzare di questo globalismo favorisce normalmente
l’identità dei più forti che proteggono sé stessi, ma cerca di dissolvere le identità delle
regioni più deboli e povere, rendendole più vulnerabili e dipendenti. In tal modo la politica
diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici transnazionali che applicano il
“divide et impera”» (n. 12). Di fronte a questa situazione, per tanti versi drammatica perché
crea divisione e scarti nella società, nell’enciclica, al capitolo 2, papa Francesco propone di
prendere come riferimento la parabola del Buon Samaritano: «Nell’intento di cercare una
luce in mezzo a ciò che stiamo vivendo, e prima di impostare alcune linee di azione, intendo
dedicare un capitolo a una parabola narrata da Gesù duemila anni fa. Infatti , benché questa
Lettera sia rivolta a tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose,
la parabola si esprime in modo tale che chiunque di noi può lasciarsene interpellare» (n. 56).
2. Leggiamo il testo della parabola
«In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese:
“Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Che cosa sta
scritto nella Legge? Come leggi?”. Costui rispose: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo
prossimo come te stesso”. Gli disse: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”. Ma quello,
volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un uomo
scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre.
Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le
ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si
prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo:
“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. Quello rispose:
“Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”» (Lc 10,25-37).
3. Chi è il prossimo?
Come definirlo? Credo che il problema si pone anche per noi, oggi. Al tempo di Gesù il
dottore della legge pone il problema a Gesù: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la
vita eterna?». Gesù gli fa notare che essendo dottore della legge deve conoscere ciò che vi è
scritto in essa. E il dottore risponde bene: «Costui rispose: “Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il
tuo prossimo come te stesso”. Gli disse: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”». «… e il tuo
prossimo come te stesso…». L’espressione è significativa: tu riesci ad amare l’altro come
prescrive la Legge solo quando metti l’altro sullo stesso livello in cui poni te stesso e
costruisci l’equilibrio. Nell’esperienza di Gesù questo amore cresce fino a traboccare nel
dono della propria vita. Provocato, ancora, dal dottore della legge che chiede: «E chi è mio
prossimo?», Gesù racconta una parabola. Tutta la parabola quindi vuole rispondere a questo
interrogativo.
«Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti,
che gli portarono via tutto (lo spogliarono), lo percossero a sangue e se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto». Ecco alcune sottolineature della parabola: lo spogliarono di tutto,
lo percossero a sangue, lasciandolo mezzo morto e se ne andarono. Gli tolsero dignità e
quasi la vita. Di fronte a questo caso si trovano un sacerdote e un levita che sono sulla stessa
strada, lo vedono e passano oltre. Sono due personalità molto importanti, proprio loro, per
professionalità diremmo, avrebbero dovuto interessarsi alla salute. Spettava a loro
dichiarare lo stato di salute di una persona malata e quindi ammetterla o meno nella
comunità. Ma essi, nel dubbio che potrebbe essere morto, preferiscono non contaminarsi,
vogliono garantire se stessi. Si fermano all’osservanza giuridica e sono incapaci di atti vare la
compassione, l’amore. Gesù rimprovera questo atteggiamento: osservate le vostre tradizioni
e avete dimenticato il comandamento dell’amore.
Sulla stessa strada arriva anche un samaritano il quale vede la stessa scena e ne ebbe
compassione e, a differenza del sacerdote e del levita, si lascia interpellare dalla situazione
drammatica di quell’uomo. È il vedere e la compassione che modificano e determinano
l’atteggiamento del samaritano di fronte all’uomo abbandonato, e mettono in moto una serie
di azioni – espresse con tanti verbi – nelle quali si sviluppa il suo soccorso progressivo ed
effi cace. La compassione porta il samaritano ad avvicinarsi all’uomo ferito e abbandonato e
lo stimola a prestargli un soccorso premuroso e diligente, espresso con un verbo molto
significativo epimeléomai – aver cura –, ripreso due volte. Il samaritano si avvicina per capire
meglio la situazione e vedendolo ne ebbe compassione ( esplanchnìsthe), si sentì muovere le
viscere dalla compassione. E quindi gli va accanto come prossimo – proselthon, dice il testo
greco: pros è una preposizione da cui viene anche prossimo –; gli si fece vicino, gli fasciò le
ferite, versandovi olio e vino: è l’olio della dolcezza e il vino della fortezza.
«Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno
seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”». Sono molto significativi i gesti che compie il
samaritano: il primo, fondamentale, è quello che, senza preoccuparsi di se stesso, cerca di
capire quale è la situazione reale dell’altro, da questo atteggiamento scaturiscono tutti gli
altri gesti. Se vedi una situazione, è la situazione in quanto tale che poi ti coinvolge, provoca
la compassione, un amore misericordioso e ti porta a compiere gesti che rendono concreta la
vicinanza, l’attenzione e l’intimità.
Se, invece, chiudiamo gli occhi, determinati dal nostro egoismo, ci tagliamo fuori dalla
possibilità di intervenire e di prenderci cura. Quindi aprire gli occhi e rompere i muri (oggi
anche a livello comunitario si elevano tanti muri…) della proprio caverna egoica, per
guardare la realtà, il quotidiano drammatico di tanti fratelli è il primo gesto fondamentale da
compiere, il resto viene come conseguenza, poi un gesto ne stimola un altro. Il samaritano ha
prima cercato di capire quello che gli stava davanti: un uomo mezzo morto e abbandonato,
questo atteggiamento l’ha coinvolto e l’ha reso prossimo dell’uomo calpestato. Il dono della
prossimità gli ha aperto gli occhi e l’ha reso disponibile a versare sulle ferite dell’altro l’olio
della dolcezza e il vino della forza che custodiva dentro di sé. Ha scoperto infatti di essere
premuroso e forte al punto di poter caricare il fratello moribondo sulle sue spalle,
considerandolo tutt’uno con se stesso. Inoltre trova il coraggio di coinvolgere nell’attenzione
verso il povero malcapitato l’intera struttura sociale. E questo è molto importante.
Il samaritano attraverso questo rapporto nuovo con l’uomo pestato e derubato, si rende
conto che, per aiutarlo concretamente, non è suffi ciente un semplice rapporto da uomo ad
uomo, ma c’è bisogno di coinvolgere anche le strutture sociali perché siano a servizio
dell’uomo. E per questo dice all’albergatore: «Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo
pagherò al mio ritorno». La parabola termina così. E a conclusione, Gesù pone l’interrogativo
al dottore della legge: secondo te, dopo che ti ho raccontato questo fatto: «Chi di questi tre
ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. Quello rispose:
“Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”»
4. «Va’ e anche tu fa’ così»
È capovolto tutto. Il dottore della legge aveva chiesto: chi è il mio prossimo? E Gesù gli dice
come fare per farsi prossimo. Tutto è rovesciato. L’interlocutore di Gesù comprende e
risponde: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”». Siamo
di fronte a una parabola, ma a risentirla ci rendiamo conto, spero, del cammino che la Parola
di Dio ci invita a fare. La risposta potrebbe essere dunque questa: tu cercavi di capire chi è il
prossimo indicato dalla legge; io ti dico: il prossimo sei tu ogni volta che ti fai prossimo ad un
uomo che ha bisogno di te. Vuol dire che l’uomo che ha bisogno di aiuto, è colui che ti regala
la possibilità di amare.
5. La parabola del Buon Samaritano icona del vissuto di Gesù
Mi piace vedere in questa parabola una sintesi allegorica del Volto di Dio rivelato nell’AT che
Gesù ha pienamente espresso, reso visibile, attraverso il suo vissuto e i gesti quotidiani. A
leggere il brano in questa prospetti va siamo invitati e aiutati da alcuni Padri della Chiesa, a
partire almeno dal II secolo e con una certa continuità, tra di essi: Origene, Agostino,
Ambrogio e Ireneo di Lione, che vedono nel buon samaritano Gesù stesso, immagine vivente
della misericordia del Padre. Il samaritano è una persona non gradita ai custodi della Legge e
del tempio, ma qui è Gesù che dalla Samaria ha indurito il suo volto verso Gerusalemme (cf.
Lc 9,51), Lui, che con disprezzo viene indicato come «samaritano e indemoniato» (Gv 8,48),
sta viaggiando verso Gerusalemme. Lui che è disceso si fa vicino e condivide la sventura
dell’uomo.
«Mosso a compassione»: l’umanità di Gesù è presenza di misericordia, segno della
compassione di Dio per i deboli, per i vacillanti: si fa vicino a loro. Nei Vangeli spesso viene
evidenziato che Gesù si commuove: «Gli si avvicina un lebbroso e lo supplica in ginocchio
dicendogli: “Se vuoi puoi purificarmi”. Mosso a compassione ( splancnisthéis), Gesù stese la
mano, lo toccò: “Sì lo voglio; sii purificato”» (Mc 1,40-41). Più avanti Marco registra:
«Sbarcando, egli vide una grande folla e ne ebbe compassione (esplancnìsthe) poiché erano
come pecore che non hanno pastore. Allora incominciò a insegnare loro molte cose» (Mc
6,34). Gesù, col suo vissuto umano racconta la misericordia/compassione che esprime la vita
stessa di Dio: in Es 34,6, Dio passa davanti a Mosè proclamando: «JHWH, JHWH, Dio di
misericordia e di grazia, lento all’ira e ricco di amore e fedeltà». E lo farà con profonda
libertà interiore (Mt 22,16). Misericordia/compassione e libertà, quindi, caratterizzeranno il
vissuto pubblico di Gesù, con questi atteggiamenti racconta il volto del Padre (Gv 1,18).
La misericordia di Dio, però, non è la lacrimuccia, frutto di emozione momentanea! È
presenza rigeneratrice. Misericordia traduce la parola ebraica: rachamim, che incontriamo
tante volte nella Bibbia. Rachamim è il plurale di rechem che designa il grembo materno in
cui il bambino viene formato e portato, prima della nascita. Indica, quindi lo spazio fatto in
sé alla vita dell’altro, spazio di comunione profonda di con-sentire, di com-patire, di con-
gioire. Ma indica anche l’amore materno e paterno verso il figlio, il legame tra fratelli,
designa, dunque sempre un rapporto che non può venir meno, forte come il legame
viscerale. La misericordia è dunque la più radicale protesta contro l’indifferenza,
l’individualismo, il rifiuto dell’altro. La misericordia è mistero che genera vita e comunione, è
dinamica di condivisione.
Gesù con il suo vissuto rende umano e palpabile il volto misericordioso del Padre. Più volte
gli evangelisti registrano, come dicevamo prima, che Gesù si commuove. Nel vangelo di Luca
(cap. 15), poi, Gesù soprattutto attraverso la parabola del padre misericordioso vuole
consegnarci il volto di Dio che commosso corre incontro al figlio, lo abbraccia, lo bacia (gli
dona il suo respiro) e gli ridona il vestito bello, la dignità di figlio amato che aveva prima di
abbandonare la casa. (Lc 15,20-22). Gesù ci mostra questo volto del Padre e invita tutti noi a
vivere di questa passione del Padre e sua. Nel vangelo di Luca esplicitamente ci dice:
«Diventate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36).
6. Sollecitazioni
Le situazioni del nostro mondo, tratteggiate nel primo capitolo di Fratelli tutti non sono
diverse da quelle raccontate nella parabola, ma la parabola ci offre orizzonti che ci stimolano
ad affrontare diversamente il quotidiano per dar vita a una società più umana. Infatti :
«Questa parabola è un’icona illuminante, capace di mettere in evidenza l’opzione di fondo
che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà pena… La parabola
ci mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a partire da uomini e donne che
fanno propria la fragilità degli altri» (n. 67). Il racconto con concretezza ci dice che la
pienezza della vita si ha solo nell’amore gratuito, ed è possibile se ci lasciamo animare dal
respiro di Dio che si è rivelato nel vero buon samaritano, come abbiamo evidenziato, Gesù.
Acquisire questa nuova identità, non è facile ed è frutto di una lotta interiore, perché dentro
ognuno di noi è presente «qualcosa dell’uomo ferito, qualcosa dei briganti, qualcosa di quelli
che passano a distanza e qualcosa del buon samaritano» (n. 69). La scelta e il
comportamento non dipende dai ruoli ma è frutto di un cammino con Gesù, è lui che ci toglie
la maschera ci apre gli occhi sulla nostra storia che non è diversa da quella tracciata nella
parabola.
a) I briganti oggi
La storia raccontata nella parabola si ripete, Gesù ci incoraggia a intervenire ci dice che sono
i briganti che lasciano l’uomo mezzo morto sulla strada. Questi briganti anche oggi, «Li
conosciamo. Abbiamo visto avanzare nel mondo le dense ombre dell’abbandono, della
violenza utilizzata per meschini interessi di potere, accumulazione e divisione» (n. 72). Sono
presenti in tutto il mondo, ma anche nell’Europa e nella nostra Italia. Sono essi che lasciano
tanti moribondi in mezzo alla strada. Si calcola che nel 2020 le persone in stato di insicurezza
alimentare acuta siano arrivati a 155 milioni. Molti di essi vivono in Africa e spesso questa
situazione è determinata da conflitti armati. A titolo di esempio desidero evidenziare quello
che è sotto i nostri occhi in queste ultime setti mane:
– Colpi di redini. Agenti federali statunitensi che usano le redini dei propri cavalli per colpire
e respingere i migranti che tentano di attraversare il Rio Grande, al confine col Messico. Vere
e proprie frustate che si abbattono anche su donne e bambini che urlano in preda al panico.
Sono immagini choc riprese da diversi media internazionali e che gettano ancora una volta
un’ombra su quanto da mesi sta accadendo alla frontiera sud degli Stati Uniti, teatro oramai
di una crisi umanitaria. Sono ormai oltre 10 mila le persone che bivaccano in condizioni
igieniche disastrose sotto il ponte di Del Rio che collega Stati Uniti e Messico, vivono in tende
e rifugi improvvisati, in un degrado indescrivibile. La maggior parte di loro proviene da Haiti.
– Alzare muri. In Europa la situazione non è meno drammatica. È di queste ultime setti mane
la richiesta di tredici stati dell’unione europea, dell’utilizzo delle risorse comuni per la
costruzione di muri anti-migranti. È inaccettabile che non si voglia accettare i profughi in
fuga da miseria e da guerre, spesso causate da noi. L’Europa foraggia, tramite l’Italia, sia il
governo di Tripoli, sia la Guardia Costiera libica perché trattengano in Libia mezzo milione di
rifugiati sub-sahariani. E quando questi tentano la fuga sui gommoni, li riportano nei lager.
Lo sottolineava anche papa Francesco domenica dopo la preghiera dell’Angelus:
«Occorre porre fine al ritorno dei migranti in Paesi non sicuri e dare priorità al soccorso di
vite umane in mare con dispositivi di salvataggio e di sbarco prevedibile. […] Tanti di questi
uomini, donne e bambini sono sottoposti a una violenza disumana. Ancora una volta chiedo
alla comunità internazionale di mantenere le promesse di cercare soluzioni comuni, concrete
e durevoli per la gestione dei flussi migratori in Libia e in tutto il Mediterraneo. […] Quanto
soffrono coloro che sono rimandati! Ci soni dei veri lager».
Queste politiche migratorie portano alla morte di migliaia e migliaia di profughi nel
Mediterraneo. Mare nostrum è ormai diventato Cimiterium nostrum, dove sono sepolti dai
50 ai 100 mila profughi. I briganti anche oggi, per vari interessi, lasciano l’uomo mezzo morto
per terra, che atteggiamento assumiamo noi di fronte a questa drammatica situazione?
Passeremo a distanza, segnati dal terribile virus che è l’indifferenza? O addirittura con uno
sguardo di disprezzo verso i poveri e la loro cultura? (cf. n. 73). Quelli che passano a
distanza, Gesù, nella parabola, evidenzia che sono persone religiose che dovrebbero
conoscere la passione di Dio per i calpestati. Afferma la Fratelli tutti al n. 74:
«Questo è degno di speciale nota: indica che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non
garantisce di vivere come a Dio piace. Una persona di fede può non essere fedele a tutto ciò
la fede stessa esige, e tuttavia può sentirsi vicina a Dio e ritenersi più degna degli altri. Ci
sono invece dei modi di vivere la fede che favoriscono l’apertura del cuore ai fratelli, e quella
sarà la garanzia di un’autentica apertura a Dio. San Giovanni Crisostomo giunse ad esprimere
con grande chiarezza tale sfida che si presenta ai cristiani: “Volete onorare veramente il
corpo di Cristo? Non disprezzatelo quando è nudo. Non onoratelo nel tempio con paramenti
di seta, mentre fuori lo lasciate a patire il freddo e la nudità”. Il paradosso è che, a volte,
coloro che dicono di non credere possono vivere la volontà di Dio meglio dei credenti».
I briganti della nostra storia, in fondo, hanno come segreti alleati quelli che guardano
dall’altra parte e con ipocrisia dicono: “tutto va male”, “nessuno può aggiustare le cose”,
“che posso fare io?” (cf. n. 75). E l’uomo ferito resta lì, destinato a morire, senza speranza.
L’esperienza di essere feriti, possiamo farla tutti , quando «Ci sentiamo anche abbandonati
dalle nostre istituzioni sguarnite e carenti, o rivolte al servizio degli interessi di pochi,
all’esterno e all’interno» (76).
b) Ricominciare
Di fronte a questa realtà dobbiamo educarci, senza aspettare che tutto sia risolto da coloro
che ci governano, a diventare parte atti va a sostegno della società ferita, «alimentando ciò
che è buono e mettendoci al servizio del bene» (n. 77). Si tratta di cominciare dal basso
coinvolgendo anche le istituzioni e gli altri per incontrarci in un “noi”, «con la stessa cura che
il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo ferito» (n. 78). A volte, «Le diffi coltà
che sembrano enormi sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza inerte
che favorisce la sottomissione» (n. 78). Questo impegno per l’altro, che ci fa uscire dalla
nostra indifferenza e dalla nostra ignavia «ci farà risorgere e farà perdere la paura a noi
stessi e agli altri» (n. 78). Questo impegno cerchiamo di portarlo avanti senza aspettarci
riconoscimenti o ringraziamenti, ma nella pura gratuità e «con quell’atteggiamento solidale e
attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano» (n. 79)
Ricordiamoci sempre che siamo chiamati noi a farci prossimi, vicini «alla persona bisognosa
di aiuto, senza guardare se fa parte della propria cerchia di appartenenza» (n. 81), «dando
alla nostra capacità di amare una dimensione universale, in grado di superare tutti i
pregiudizi, tutte le barriere storiche o culturali, tutti gli interessi meschini» (n. 83). La carità
gratuita e disinteressata stimola il progresso della giustizia. La carità previene, riesce a
intuire i bisogni nuovi dell’uomo e della società, fin dal loro sorgere. Non è raro che l’amore
anticipi e stimoli il cammino, di per sé più lento, del diritto e della giustizia. Come
sottolineava S. Caterina da Siena, «la carità è la conchiglia che contiene la perla della
giustizia». La giustizia e la politica, animate dalla carità, fanno sì che gli uomini si incontrino
non solo sul piano obietti vo dei diritti e dei beni da tutelare, ma anche su quanto essi hanno
di più intimo e soggetti vo (la propria dignità e la propria coscienza) a livello individuale e
comunitario.
E allora, oggi, mentre rimane la carità intesa in senso più tradizionale, anche se purificata e
potenziata – pensiamo al dovere di superare il livello dell’elemosina per approdare a quello
della condivisione, condivisione anche del necessario e non solo del superfluo – emerge
l’esigenza di andare alla radice di queste espressioni di carità. Esse sono finalizzate alla
persona, vogliono essere contributo a salvaguardare la dignità e i diritti , e fare sì che la
persona sia veramente libera, autonoma, in grado di contribuire assieme a tutti gli altri
uomini, a realizzare una società più umana, più giusta. Si tratta, allora, per camminare verso
la pienezza della carità, di consentire all’io di aprirsi con docilità all’azione, alla carità dello
Spirito. Se ci si apre e si collabora atti vamente, facendosi terreno spoglio, recetti vo all’agape
di Dio, allora piano piano tutta la persona diventa «strumento musicale pizzicato dallo
Spirito, che canta la gloria e la potenza divina» (Gregorio Nazianzeno).
Alberto Neglia
Mercoledì della spiritualità,15/11/2021, Fraternità Carmelitana di Barcellona Pozzo di Gotto
Potrebbero piacerti anche
- L'espulsione di Adamo ed Eva dal Cielo secondo Il DiavoloDa EverandL'espulsione di Adamo ed Eva dal Cielo secondo Il DiavoloNessuna valutazione finora
- 9 NuditàepauraDocumento4 pagine9 NuditàepauraMarco MarchettiNessuna valutazione finora
- La Bibbia CensurataDocumento3 pagineLa Bibbia Censuratababonzo100% (2)
- Contro Dio: La lotta millenaria tra Dio e l'UmanitàDa EverandContro Dio: La lotta millenaria tra Dio e l'UmanitàNessuna valutazione finora
- 새 텍스트 문서Documento3 pagine새 텍스트 문서Joonho KimNessuna valutazione finora
- Le mie Riflessioni su Dio: Sulla Creazione, il Dolore, l'InfelicitàDa EverandLe mie Riflessioni su Dio: Sulla Creazione, il Dolore, l'InfelicitàNessuna valutazione finora
- Genesi 1-11 RiassuntoDocumento25 pagineGenesi 1-11 RiassuntoPedro Valbuena100% (1)
- LA DIVINA TRAGEDIA ossia la Bibbia secondo un pagano Parte IDa EverandLA DIVINA TRAGEDIA ossia la Bibbia secondo un pagano Parte INessuna valutazione finora
- Jacopo Fo - La Bibbia CensurataDocumento3 pagineJacopo Fo - La Bibbia CensurataEleonoraNessuna valutazione finora
- Adamo Ed EvaDocumento6 pagineAdamo Ed EvaSturm brightbladeNessuna valutazione finora
- La Famiglia Nelle Sacre ScrittureDocumento10 pagineLa Famiglia Nelle Sacre ScrittureMauro SquillanteNessuna valutazione finora
- Sara, La Prima Delle MadriDocumento7 pagineSara, La Prima Delle MadriCiprian Bejan P.Nessuna valutazione finora
- Conferenza-LA PRIMA DONNA DI ADAMO (Lumen 4 Maggio 2018)Documento14 pagineConferenza-LA PRIMA DONNA DI ADAMO (Lumen 4 Maggio 2018)Pietro GelmiNessuna valutazione finora
- Gen 4, 1-16Documento3 pagineGen 4, 1-16Garrett JohnsonNessuna valutazione finora
- Samael l'Angelo Caduto: Tutti quanti abbiamo una storia che nessuno ha mai raccontatoDa EverandSamael l'Angelo Caduto: Tutti quanti abbiamo una storia che nessuno ha mai raccontatoNessuna valutazione finora
- Recalcati CainoDocumento3 pagineRecalcati CainopvelazcosjNessuna valutazione finora
- Norea Universo Ebraico CristianoDocumento6 pagineNorea Universo Ebraico CristianoCarmelo Antonino Di BellaNessuna valutazione finora
- Virgili Estratto PDFDocumento9 pagineVirgili Estratto PDFMichele CarrettaNessuna valutazione finora
- Antropologia Dell' Affettività e Celibato SacerdotaleDocumento24 pagineAntropologia Dell' Affettività e Celibato SacerdotaleMichele FattaNessuna valutazione finora
- 5Documento3 pagine5Joonho KimNessuna valutazione finora
- La via della perfezione - Il Vangelo Unificato di CristoDa EverandLa via della perfezione - Il Vangelo Unificato di CristoNessuna valutazione finora
- 00 Lucrezio V 195ss ApprofondimentiDocumento3 pagine00 Lucrezio V 195ss ApprofondimentiFerdinando D'AlessandroNessuna valutazione finora
- (eBook-Cri-ITA) Amato Giuseppe - Trilogia Sulla Nascita Dell'UomoDocumento79 pagine(eBook-Cri-ITA) Amato Giuseppe - Trilogia Sulla Nascita Dell'Uomotiziotizia60Nessuna valutazione finora
- Pentateuco e Libri StoriciDocumento61 paginePentateuco e Libri StoriciJair Romero GuzmànNessuna valutazione finora
- Costacurta - Antropologia BiblicaDocumento125 pagineCostacurta - Antropologia BiblicaPaolo MichelNessuna valutazione finora
- Giovanni Paolo II Il Dono Disinteressato 1994Documento10 pagineGiovanni Paolo II Il Dono Disinteressato 1994MicheleNessuna valutazione finora
- Il Corpo e La ParolaDocumento9 pagineIl Corpo e La ParolaVididiana SaJaNessuna valutazione finora
- L’omosessualità Secondo O Contro Natura?Da EverandL’omosessualità Secondo O Contro Natura?Nessuna valutazione finora
- Amarsi Da Dio - Recensione (2019)Documento9 pagineAmarsi Da Dio - Recensione (2019)alberto.prontiNessuna valutazione finora
- Sansone ITDocumento9 pagineSansone ITWenin AndréNessuna valutazione finora
- Bruno Maggioni - Introduzione Alla GenesiDocumento5 pagineBruno Maggioni - Introduzione Alla GenesiGrethousand100% (1)
- Mosaico Di AdamoDocumento25 pagineMosaico Di AdamoAugusto CosentinoNessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento25 pagineLetteratura ItalianagabrieleNessuna valutazione finora
- 15 - 3 Il Sacramento Della PenitenzaDocumento26 pagine15 - 3 Il Sacramento Della PenitenzaPaolopiniNessuna valutazione finora
- FatoDocumento3 pagineFatoGiovanniNessuna valutazione finora
- Scheda Di Lettura Dodds I Greci e L'irrazionaleDocumento11 pagineScheda Di Lettura Dodds I Greci e L'irrazionaleFederico VirgilioNessuna valutazione finora
- Gen Il Serpente e La DonnaDocumento2 pagineGen Il Serpente e La DonnaAntonio VieiraNessuna valutazione finora
- La BestemmiaDocumento10 pagineLa BestemmiaMario BamonteNessuna valutazione finora
- Mistero Dell'eucaristiaDocumento24 pagineMistero Dell'eucaristiaGiacomo Gubert100% (1)
- 새 텍스트 문서Documento3 pagine새 텍스트 문서Joonho KimNessuna valutazione finora
- Dostoevskij - I Fratelli KaramazovDocumento6 pagineDostoevskij - I Fratelli KaramazovNiccolò Lomys50% (2)
- Operette MoraliDocumento6 pagineOperette MoraliGiampaolo MeleNessuna valutazione finora
- Addomesticare DioDocumento4 pagineAddomesticare DiovitazzoNessuna valutazione finora
- Intersezioni - Modi Di Pensare La Psiche (Rivista Di Psicologia Analitica, Nuova Serie N. 6, 1998)Documento193 pagineIntersezioni - Modi Di Pensare La Psiche (Rivista Di Psicologia Analitica, Nuova Serie N. 6, 1998)OscarNessuna valutazione finora
- Esodo 3Documento3 pagineEsodo 3Branimir ŠarićNessuna valutazione finora
- Lez2 Metodologia Generale Dell'insegnamento S Trumentale Didattica Della ComplessitàDocumento24 pagineLez2 Metodologia Generale Dell'insegnamento S Trumentale Didattica Della Complessitàbottesini76Nessuna valutazione finora
- GD DORIGO - Home Door Collections 2019 PDFDocumento228 pagineGD DORIGO - Home Door Collections 2019 PDFreysanchez88Nessuna valutazione finora
- Ritorno Ai Longobardi PDFDocumento34 pagineRitorno Ai Longobardi PDFbruno pausaNessuna valutazione finora
- Studio Di FunzioneDocumento77 pagineStudio Di FunzioneRita MazzeiNessuna valutazione finora
- La Gnosi Cristiana: Le verità nascoste dei Vangeli, dei Mistici e del Cristo-LogosDa EverandLa Gnosi Cristiana: Le verità nascoste dei Vangeli, dei Mistici e del Cristo-LogosNessuna valutazione finora
- L'Interpretazione dei Detti Segreti del Vangelo di TommasoDa EverandL'Interpretazione dei Detti Segreti del Vangelo di TommasoNessuna valutazione finora
- Storia di Gesù di Nazareth: Figlio di Giuseppe Pantera da BrindisiDa EverandStoria di Gesù di Nazareth: Figlio di Giuseppe Pantera da BrindisiNessuna valutazione finora
- Diario della divina Misericordia: Edizione critica a cura di Alessandro e Ilario MessinaDa EverandDiario della divina Misericordia: Edizione critica a cura di Alessandro e Ilario MessinaNessuna valutazione finora
- La Famiglia di Cristo: Indagine storica sulla sua discendenza I Figli, i Fratelli, i DesposiniDa EverandLa Famiglia di Cristo: Indagine storica sulla sua discendenza I Figli, i Fratelli, i DesposiniNessuna valutazione finora