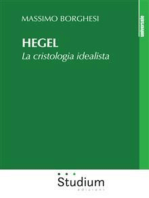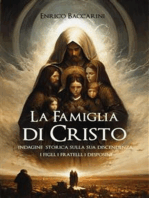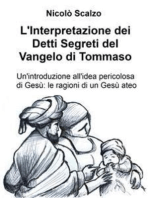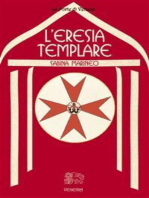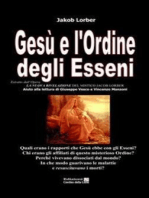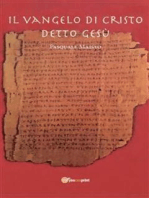Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Lezione 02-16
Caricato da
Welton Ramos Sabino0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
6 visualizzazioni5 pagineLezione Vangelo di Marco
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoLezione Vangelo di Marco
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
6 visualizzazioni5 pagineLezione 02-16
Caricato da
Welton Ramos SabinoLezione Vangelo di Marco
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 5
Le differenze tra i sinottici e Gv
I segni. Altra differenza tra i sinottici e Gv. I sinottici hanno 29 storie. Gv
ha soltanto 3 che si trovano nei sinottici. Una prima, La moltiplicazione dei
pani, il cammino di Gesù sulle acque. Invece Gv ha quattro segni che non
appaiono nei sinottici: Cana, il paralitico alla piscina di Betsaida (cap. 5), il
cieco nato (cap.9) e Lazzaro. Come mai Gv ha o non ha tutto questo?
Mentre i sinottici insistono molto sugli esorcismi, in Gv non troviamo
nessun esorcismo. Gv non presenta nessuna parabola. Il Buon Pastore non è
una parabola. Ci sono tante parabole nei sinottici che in Gv non c’è.
Un’altra caratteristica sono le feste giudaiche. Gv insiste molto sulle feste
giudaiche, soprattuto le tre feste più importanti: pesach, la festa delle
settimane e la festa delle cappane. Gv presenta la Pasqua, parla della festa
delle cappane (cap.7), e parla delle altre feste, per esempio, la festa della
dedicazione del tempio. Questa festa viene ricordata dagli ebrei nella festa
della dedicazione del tempio, che cellebrano più o meno nel tempo del
nostro natale. Queste feste sono ricordate da Gv in maniera molto
accentuate. Un’altra differenza, più problematica, è la morte di Gesù. Sia
per Gv e per i sinottici, Gesù muore nel venerdì. Tuttavia, secondo i
sinottici, quel venerdì è il giorno solenissimo di Pasqua. Il giorno inizia alla
sera (giovedì sera), dove Gesù mangia la Pasqua con i suoi discepoli, come
si faceva in ogni famiglia. Poi Gesù va nel Getsemani, viene arrestato,
viene il processo giudaico, poi, il processo romano, la condanna e la morte.
Per Gv, Gesù muore alla vigilia di Pasqua, cioè, quando la festa di Pasqua
non era ancora iniziata. Gesù muore alla vigilia, quando ancora gli agnelli
non erano stati mangiati, ma muore quando si sacrificavano gli agnelli. La
domanda è: chi ci racconta ciò che è accaduto realmente? Una francese ha
fatto un’ipotesi la quale Gesù seguiva il calendario degli esseni e non
quello ufficiale, ma questa ipotesi non va. Un’altra ipotesi, è che Gv
presentando Gesù come agnello pasquale, vuole che Gesù muoia quando
veniva sacrificati gli agnelli.
Oggi, invece, la domanda è: è possibile che tutto questo processo accada
della festa di Pasqua? Cioè, non ha ragione Gv, che mette l’evento della
morte di Gesù prima della festa di Pasqua? Le differenze sono teologiche.
La prospettiva dei sinottici sono diverse da quelli di Gv.
È Gv che presenta l’incarnazione, altri vangeli no. Dobbiamo abbituare un
linguaggio più preciso per un esame biblico.
Gv quando scrive conosceva i sinottici? Grossa questione. R. Brown
sostiene che Gv conosceva la tradizione orale che hanno dato vita ai
sinottici, ma non aveva davanti i libri sinottici. È un’ipotesi. Le differenze
sono molto diverse. Quello che Gv dice sono certamente più per
confermare la fede; ma vale anche per i sinottici, però la teologia è diversa.
Tutto il complesso teologico di Gv è molto più (non matturo) ma un’altra
prospettiva. In Gv il vangelo dell’infanza non abbiamo nulla. La
prospettiva è del Verbo Incarnato. Io sono è il motivo principale del
vangelo di Gv.
L’attendibilità storica dei Vangeli
Possiamo essere certi che i vangeli ci raccontino una storia vera, reale, la
storia, la vita di Gesù per quello che è? A volte notiamo delle contradizioni.
? quando mise accanto il testo di Mc (quasi completamente Mc é in Mt e
Lc, ma lo troviamo in maniera diversa. Mt lo mette sulla montagna, mentre
Lc lo mette in un luogo pianeggiante. Mt 5 e Lc 6 (breve). Ci sono delle
contradizioni talvolta anche molto forti. Come sono nati i vangeli/ Quale è
la realtá, dunque, la storia reale che possiamo in qualche modo riscontrare?
Sono attendibili storicamente i vangeli?
Marcione si era posto questo problema e preferiva il vangelo di Lc; altri
vangeli erano meno attendibili secondo lui. Marcione si basava sui
pregiudizi. L’AT per Marcione non era parola di Dio. Che cosa, invece
possiamo dire? Agostino si rende conto delle diversità tra i vangeli, però
cerca di risolvere in maniera un po’ stranea: Gesù che ha discosso sulla
montagna (Mt 5) e lo ha finito nella pianura (Lc 6). Nei primi secoli questo
problema non era messo in discussione. Il problema inizia nel XVIII
secolo. La domanda che ci si fa è: che cosa è accaduto? Lo sviluppo dal
1700 in poi e quanto è accaduto per quanto riguarda la ricerca del Gesù
storico.
Fino al secolo XVII-XVIII il problema esisteva, ma si risolveva in maniera
piuttosto semplice, non in maniera scientifica. Nel 1778 accade che
Reimarus prima di morire scrive delle note, alcune pagine, alcuni studi, ma
non osa pubblicarli. Solo dopo la sua morte, un suo collega pubblica questi
scritti. Reimarus distingueva tra il Gesù della storia e il Cristo della fede. Il
Gesù della storia è un personaggio, un profeta che è andato incontro a un
fallimento. I discepoli, dopo la sua morte, hanno rivestito questo
personaggio Gesù, con un manto teologico. Sono i discepoli che hanno, con
la fede ecclesiastica, rivestito e non lo hanno lasciato pure alla ricerca
razionale e hanno introdotto la fede. Se vogliamo raggiungere il gesù
storico, dobbiamo spogliarlo di questo rivestimento, secondo Reimarus. È
una spiegazione puramente razionale. Da quel momento nasce una corrente
che tende a raccontare o a ricercare qual’era l’autentica vita di Gesù: Leben
Jesun. Tutti scrivono una vita di Gesù; cercano di scrivere una vita di Gesù
che si apre ad una ricerca scientifica sulla vita di Gesù. Tutto questo studio
portò a un resultato che viene messo in evidenza per Schweitzer, che
scrisse un opera molto interessante, intitolata La storia della ricerca sulla
vita di Gesù, in cui esaminava tutta questa ricerca che va sotto il nome della
ricerca sulla vita di Gesù, e arriva a una conclusione, cioè, ciascuno,
scrivendo sulla vita di Gesù, ha un limite che è un soggetivismo, orientata
dai pregiudixzi, di ordine filosofica, religioso, ecc. Per esempio, una vita di
Gesù scritto da un romantico, presenta un Gesù in uno stile romantico. I
pregiudizi filosofici, culturali, orientano lo scrittore a mostrare un Gesù a
propria immagine e somiglianza, non un Gesù reale. Molto spesso accade
che gli orientamenti che noi abbiamo, in qualche modo, influenzano sulla
figura che abbiamo di Gesù.
A questo punto si presenta Bultmann, una persona molto ricca, intelligente,
apassionato sulla ricerca del Gesù storico. Lui orienta la ricerca su Gesù
storico, sia a livello metodologico sia a livello teologico. A livello
metodologico: dice che prima che i vangeli fossero scritti, c’è stata una
tradizione orale. Tra l’apparizione del libro e il Gesù storico ha un periodo
che ha determinato lo scrittore, lo evangelista, che è un periodo che
appartiene alla comunità, alla predicazione su Gesù. Questo intermezzo,
che è la comunità. Ci sono 40 anni tra la morte di Gesù e l’apparizione del
primo vangelo. Succede che c’è una comunità messianica, probabilmente
c’è stata anche qualche scritto che, però, non abbiamo. C’è una comunitá
che tramanda i detti di Gesù. A livello metodologico Bultmann dice che gli
evangelisti sono raccoglitori di tradizioni, cioè, non sono dei veri propri
autori.
A livello teologico, Bultmann dice un’altra cosa: che il Gesù storico noi
non possiamo raggiungerlo, perché proprio a motivo della tradizione della
comunità noi sappiamo che i vangeli sono nati nella comunità. Dunque, i
vangeli non rispecchiano la vita di Gesù, ma rispecchiano la vita della
comunità. Il Gesù storico non è raggiungibile, perché c’è la comunità.
Bultmann acresce: ma c’è bisogno di raggiungere il Gesù storico? Io devo
mi confrontare con il kerigma; non è necessario andare a sviscerare i
vangeli per capire che cos’è accaduto.
Ovviamente c’è del vero e del falso. Con Bultmann viene dopo the old
quest, poi c’è Bultmann, poi c’è la New quest (1953-1975) in cui Bultmann
(muore nel 1976) ha un peso, ma Käesemann, che fa una conferenza
rimasta celebre (1953) Il problema del Gesù storico. Lui è un discepolo di
Bultmann, ma lo critica, dicendo due cose: 1)a livello metodologico dice
che certamente i vangeli nascono da una convergenza di tradizioni, però c’è
anche una fase redazionale. L’autore, che noi chiamiamo Mc, Mt, Lc, non è
un semplice raccoglitore; ha dato la sua impronta al vangelo. Non
dobbiamo soltanto guardare la tradizione orale, dobbiamo guardare la
redazione. Gli autori, dunque, sono veri autori, perché sono responsabili
per la redazione del vangelo in quel modo. Ad esempio, il vangelo di Mc
ha uno scoppo, è raccontato ordinatamente con una finalità. Non si possono
considerare i vangeli semplicmente come una raccolta di tradizioni; c’è una
composizione finale.
Se è importante soltanto il kerigma, come diceva Bultmann, perché sono
stati scritti i vangeli? Per quale ragione? Sono stati scritti, significa che
qualcuno ha voluto dire che cosa ha detto Gesù. La comunità non ha creato
gli eventi; gli ha interpretati. Quindi, la ricerca del Gesù storico è una
ricerca valida. È certamente la comunità che ha, in qualche modo, influito
sulla redazione dei vangeli, ma la comunità non ha creato il Gesù storico.
Per esempio, se leggiamo il vangelo di Mt, la domanda: è lecito l’uomo
repudiare la propria moglie? In Mt, la risposta è: se un uomo ripudia la
propria donna comette adulterio. In Mc, si aggiunge la donna che ripudia
l’uomo che commette adulterio. In questo caso, la comunità ovviamente ha
influito sulle parole di Gesù. È un’interpretazione che Mc da, a partire dal
contesto della comunità (probabilmente a Roma). Käesemann dice che, se
ci sono stati scritti i vangeli, c’era un interesse di ciò che Gesù ha fatto.
Nel 1970 nasce una nuova ricerca: quale sono le differenze tra i sinottici;
come hannop interpretato le aprole di Gesù. Nel 1975, dopo la New quest,
siamo nel contesto della Third quest: si da un passo avanti: dobbiamo
sbarazzarci dall’elenismo, dal mondo greco, e dobbiamo ritornare
all’ebraismo, al guidaismo dell’epoca di Gesù. Imparare a conoscere il
mondo giudaico così come era vissuto nel tempo di Gesù. Lui non è mai
uscito dalla Palestina, frequentava il tempio; era chiamato Rabi; celebrava
le feste ebraica; pregava con la Bibbia ebraica, ecc. In questi ultimi anni si
è studiato moltissimo il tempo di Gesù. Non possiamo parlare di ebraismo,
ma di ebraismi, cioè, era molto variegato, in contrasto tra gli uni gli altri.
Noi abbiamo un’idea di farisei al nostro modo cristiano, a dire che i farisei
erano ipocriti, come se fosse un bloco unico. Perché Mt ha parole molto
violente contro i farisei? Perché Mt scrive do´po l’anno 70, dove l’unico
partito era quello dei farisei (non c’è più nessuno altro gruppo). Non
dobbiamo trattare questo mondo del tempo di Gesù come se fosse un
blocco unico; c’è stato un mondo molto variegato. C’era una scuola
rabinica che si domandava chi è il prossimo. C’era una varietà di opinioni
per definire chi è il prossimo. Una scuola rabinica che giocava sulla radice
( ) ָרעmalvaggio e ( ) ֵר ַעprossimo.
Questa terza ricerca ci ha fatto comprendere che dietro tanti termini greci,
c’è tanto contenuto in ebraico. Ad esempio eirene (ἠ) è shalom (
)ָׁשלֹום. Studiare il mondo ebraico al tempo di Gesù ci fa arrivare molto
vicino alla verità di Gesù. Il contesto vitale dove sono nati i vangeli non
sono solo quelli della comunità.
Le conclusioni di tutta questa ricerca sul Gesù storico.
Potrebbero piacerti anche
- Simbolo (Estratto Di Mura, Phronesis. Ermeneutica e Filosofia Pratica, 215-267)Documento52 pagineSimbolo (Estratto Di Mura, Phronesis. Ermeneutica e Filosofia Pratica, 215-267)Welton Ramos SabinoNessuna valutazione finora
- Criteri Individuazione Simboli Biblici, in Gasparro, Simbolo e Narrazione in MarcoDocumento5 pagineCriteri Individuazione Simboli Biblici, in Gasparro, Simbolo e Narrazione in MarcoWelton Ramos SabinoNessuna valutazione finora
- PONTIFICIA-COMMISSIONE-BIBLICA-Linterpretazione-della-Bibbia-nella-Chiesa 1993Documento53 paginePONTIFICIA-COMMISSIONE-BIBLICA-Linterpretazione-della-Bibbia-nella-Chiesa 1993Welton Ramos SabinoNessuna valutazione finora
- Meynet Qualche - Consiglio - Per - La - Tesi - Di - LicenzaDocumento45 pagineMeynet Qualche - Consiglio - Per - La - Tesi - Di - LicenzaWelton Ramos SabinoNessuna valutazione finora
- Le Tappe Essenziali Del Lavoro Esegetico (Schema Meynet 2019)Documento1 paginaLe Tappe Essenziali Del Lavoro Esegetico (Schema Meynet 2019)Welton Ramos SabinoNessuna valutazione finora
- Lezione 03-02Documento6 pagineLezione 03-02Welton Ramos SabinoNessuna valutazione finora
- Lezione 03-16Documento7 pagineLezione 03-16Welton Ramos SabinoNessuna valutazione finora
- Lectura Comprensiva IIDocumento6 pagineLectura Comprensiva IIAxel CazaresNessuna valutazione finora
- Nascita Del Luteranesimo e Del CalvinismoDocumento8 pagineNascita Del Luteranesimo e Del CalvinismoMartina CiprianoNessuna valutazione finora
- Chiesa Viva 514 ADocumento24 pagineChiesa Viva 514 Amariadelujantorre100% (1)
- Wilmart - Prieres Medievales Pour L'adoration de La Croix.2Documento23 pagineWilmart - Prieres Medievales Pour L'adoration de La Croix.2Gabriel Garcia DiazNessuna valutazione finora
- Teorie Della Conoscenza (Riassunto Parziale)Documento50 pagineTeorie Della Conoscenza (Riassunto Parziale)Emilia Scarfo'Nessuna valutazione finora
- Teologia, Magia e Politica in Tommaso CampanellaDocumento118 pagineTeologia, Magia e Politica in Tommaso CampanellaSte EnriNessuna valutazione finora
- Orazione A Sant' Antonio - Notizie Di Una Persona LontanaDocumento1 paginaOrazione A Sant' Antonio - Notizie Di Una Persona LontanaMahaotNessuna valutazione finora
- Quale Volto Di DioDocumento3 pagineQuale Volto Di DioMatt Visual BeatNessuna valutazione finora
- Cariche Pubbliche RomaneDocumento9 pagineCariche Pubbliche RomaneKiyara Rosheli Urala LiyanageNessuna valutazione finora
- Leggenda Del MinotauroDocumento1 paginaLeggenda Del MinotauroFerdinandoNessuna valutazione finora
- Adorazione Eucaristica Mese Maggio II IncontroDocumento12 pagineAdorazione Eucaristica Mese Maggio II IncontrofrancescaNessuna valutazione finora
- Dante I Diavoli e L'ira Di VirgilioDocumento43 pagineDante I Diavoli e L'ira Di VirgilioEmilio MOLARONessuna valutazione finora
- Canto Iii ParadisoDocumento5 pagineCanto Iii ParadisoKadija El mokaddemNessuna valutazione finora
- Spell Compendium - ITA-12Documento17 pagineSpell Compendium - ITA-12Addario PoggioliNessuna valutazione finora
- Signore Dammi La Forza Di Essere Tuo TestimoneDocumento10 pagineSignore Dammi La Forza Di Essere Tuo TestimonelucaNessuna valutazione finora
- La S. Scrittura Apuntes Della ChiesaDocumento10 pagineLa S. Scrittura Apuntes Della ChiesaJhs ShakaoscNessuna valutazione finora
- Ludovico Barone Von Pastor - Storia Dei Papi - Volume II PDFDocumento880 pagineLudovico Barone Von Pastor - Storia Dei Papi - Volume II PDFPauloNessuna valutazione finora
- 13 Albero e Intro Temi Atlante 230-240Documento49 pagine13 Albero e Intro Temi Atlante 230-240PatricioVCNessuna valutazione finora
- La Gnosi Cristiana: Le verità nascoste dei Vangeli, dei Mistici e del Cristo-LogosDa EverandLa Gnosi Cristiana: Le verità nascoste dei Vangeli, dei Mistici e del Cristo-LogosNessuna valutazione finora
- La Famiglia di Cristo: Indagine storica sulla sua discendenza I Figli, i Fratelli, i DesposiniDa EverandLa Famiglia di Cristo: Indagine storica sulla sua discendenza I Figli, i Fratelli, i DesposiniNessuna valutazione finora
- Diario della divina Misericordia: Edizione critica a cura di Alessandro e Ilario MessinaDa EverandDiario della divina Misericordia: Edizione critica a cura di Alessandro e Ilario MessinaNessuna valutazione finora
- L'Interpretazione dei Detti Segreti del Vangelo di TommasoDa EverandL'Interpretazione dei Detti Segreti del Vangelo di TommasoNessuna valutazione finora
- Via Crucis, Via cordis: Via Crucis con meditazioni dagli scritti di Padre PioDa EverandVia Crucis, Via cordis: Via Crucis con meditazioni dagli scritti di Padre PioNessuna valutazione finora
- Tesori nascosti. I vangeli apocrifi gnostici di Tommaso, Filippo, Giuda e Maria MaddalenaDa EverandTesori nascosti. I vangeli apocrifi gnostici di Tommaso, Filippo, Giuda e Maria MaddalenaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)