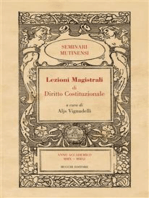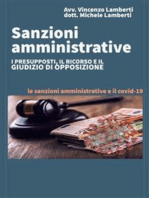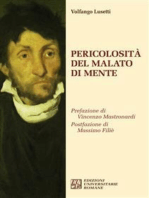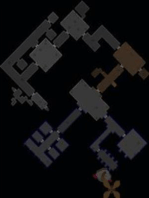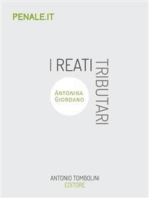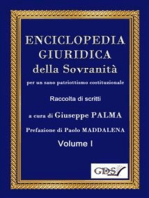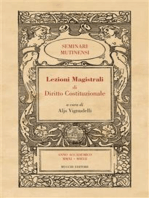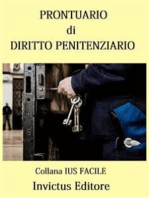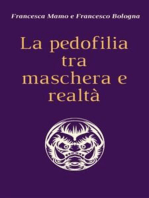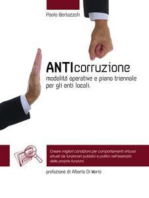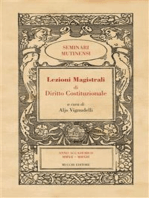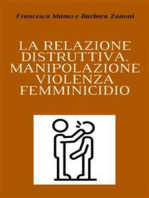Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Barbera ENCICLOPEDIA
Caricato da
FernandoMuñozLeónCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Barbera ENCICLOPEDIA
Caricato da
FernandoMuñozLeónCopyright:
Formati disponibili
ESTRATTO
ANNALI VIII
Augusto Barbera
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
pubblicazione fuori commercio
Costituzione della Repubblica italiana
FONTI. Art. 2, 13, 32 cost.; art. 8 CEDU; art. 3 della
Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, Nizza, 7
dicembre 2000, e Strasburgo, 12 dicembre 2007; art. 4, 5, 6,
9, 16, 17, 20, 22, 24 della Convenzione di Oviedo sui diritti
delluomo e la biomedicina, 4 aprile 1997; art. 5 c.c.; art. 2 l.
26 giugno 1967, n. 458, sul trapianto del rene tra persone
viventi; art. 9 l. 14 luglio 1967, n. 592, sulla raccolta,
conservazione e distribuzione del sangue umano; art. 12
comma 2, 18 l. 22 maggio 1978, n. 194, norme per la tutela
sociale della maternit e sullinterruzione volontaria della
gravidanza; art. 32 e 33 l. 23 dicembre 1978, n. 833, istituzione del Servizio sanitario nazionale; art. 5 l. 5 giugno 1990,
n. 135, piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta dellAIDS; l. 28 marzo 2001, n. 145, ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Oviedo sui diritti delluomo e la biomedicina del 1997, nonch del Protocollo
addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di
clonazione di esseri umani; art. 3 lett. d, 4, 5 d. lg. 24 giugno
2003, n. 211, attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 aprile 2001, n. 2001/20/CE, relativa
allapplicazione della buona pratica clinica nellesecuzione
delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
art. 23, 24, 26 d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia
di protezione dei dati personali; art. 3 comma 4 d. lg. 6
novembre 2007, n. 200, attuazione della direttiva della Commissione 8 aprile 2005, n. 2005/28/CE, recante principi e
linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai
medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonch
requisiti per lautorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali; art. 5 comma 2 d. lg. 4 marzo 2014,
n. 38, attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 9 marzo 2011, n. 2011/24/UE, concernente lapplicazione dei diritti dei pazienti relativi allassistenza sanitaria transfrontaliera, nonch della direttiva della Commissione 20 dicembre 2012, n. 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette
mediche emesse in un altro Stato membro.
LETTERATURA. ANDREWS e NELKIN, Il mercato del corpo.
Il commercio dei tessuti umani nellera biotecnologica, Milano, 2002; AZZALINI, Le disposizioni anticipate del paziente:
prospettiva civilistica, in Il governo del corpo a cura di CANESTRARI, FERRANDO, MAZZONI, RODOT e ZATTI, I, in Trattato di
biodiritto diretto da RODOT e ZATTI, Milano, 2011, 1935 ss.;
BEN-SHAHAR e SCHNEIDER, More Than You Wanted To Know.
The Failure of Mandated Disclosure, Princeton, 2014; BOMPIANI, Consiglio dEuropa, diritti umani e biomedicina. Genesi
della Convenzione di Oviedo e dei Protocolli, Roma, 2009;
BUSNELLI e PALMERINI, Bioetica e diritto privato, in questa
Enciclopedia, Aggiornamento, V, 2001, 142 ss.; CARUSI, Atti
di disposizione del corpo, in Enc. giur., Aggiornamento, 1998;
ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics, New York, 1996
(trad. it. Manuale di bioetica, Milano, 1999); FADEN, BEAUCHAMP e KING, History and Theory of Informed Consent, New
York, 1986; FERRANDO, Consenso informato del paziente e
responsabilit del medico. Principi, problemi e linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv., 1998, 37 ss.; FOSTER, Human
Dignity in Bioethics and Law, New York-Oxford, 2013;
KATZ, The Silent World of Doctor and Patient, New York,
1984; MANNA, Sperimentazione medica, in questa Enciclopedia, Aggiornamento, IV, 2000, 1120 ss.; MONNIER, La reconnaissance constitutionnelle du droit au consentement en matire biomdicale. tude de droit compar, in Rev. intern. dr.
comp., 2001, 383 ss.; NICOLUSSI, Autonomia privata e diritti
della persona, in questa Enciclopedia, Annali, IV, 2011, 133
ss.; OHLY, Volenti non fit iniuria . Die Einwilligung im
Privatrecht, Tbingen, 2002; PESANTE, Corpo umano (atti di
disposizione), in questa Enciclopedia, X, 1962, 653 ss.; PICCINNI, Il consenso al trattamento medico del minore, Padova,
2007; PINO, Lidentit personale, in Ambito e fonti del biodiritto a cura di RODOT e TALLACCHINI, in Trattato di biodiritto
diretto da RODOT e ZATTI, cit., 2010, 297 ss.; PIZZETTI, Alle
frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona, Milano, 2008; RESTA,
Autonomia privata e diritti della personalit, Napoli, 2005;
ID., Dignit, persone, mercati, Torino, 2014; RUGER, Health
and Social Justice, Oxford, 2009; SALARIS, Corpo umano e
diritto civile, Milano, 2007; SANTOSUOSSO, Il consenso informato, Ancona, 1996; The Oxford Textbook Of Clinical Research Ethics a cura di EMANUEL, GRADY, CROUCH, LIE, MILLER
e WENDLER, New York, 2008; TORDINI CAGLI, Principio di
autodeterminazione e consenso dellavente diritto, Bologna,
2008; ZENO-ZENCOVICH, Personalit (diritti della), in D. disc.
priv., sez. civ., XIII, 1995, 430 ss.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SOMMARIO: 1. In premessa. Sez. I. Lordinamento costituzionale: 2.
Una Carta non isolata. 3. Principi supremi e ordine
costituzionale. 4. La Carta costituzionale e il contesto dei
valori. 5. La Carta costituzionale e il contesto normativo.
6. Il sistema delle fonti. Sez. II. La accresciuta forza dei
principi costituzionali: 7. Il progressivo radicamento della Costituzione. 8. Le letture inizialmente divaricanti. 9. La svolta
del Sessantotto. 10. La prova dei terrorismi. 11. La
stagione del bipolarismo. 12. La progressiva atrofizzazione dei
partiti. 13. I principi dello Stato sociale, fra Costituzione e
globalizzazione. Sez. III. La fragilit delle istituzioni politiche:
14. La forma di governo incompiuta. 15. I regolamenti delle
Camere: tra governo assembleare e governo parlamentare.
16. Il Parlamento bicamerale. 17. Il Presidente della Repubblica. 18. I referendum abrogativi: dal modello della Costituente alla conformazione giurisprudenziale. 19. Le Regioni e
il tentativo federalista. Sez. IV. Lespandersi delle giurisdizioni: 20. La Corte costituzionale: dal sillogismo alla lettura
secondo valori. 21. Dal catalogo costituzionale ai nuovi
diritti. 22. Lemarginazione della mediazione parlamentare.
23. La giurisdizionalizzazione dellattivit politica. Sez. V.
Lordinamento costituzionale in trasformazione: 24. Le revisioni
della Carta (quelle tentate e quelle realizzate). 25. I vincoli
europei, ovvero le metamorfosi dellordinamento costituzionale. 26. Una Costituzione a virtualit multiple.
1. In premessa. Nella trattazione precedente pubblicata in questa Enciclopedia, Costantino Mortati, che della Costituzione stato uno dei
padri nobili, metteva in luce le diverse incongruenze progettuali, le antinomie , che a suo
avviso attraversano la parte seconda della Costituzione (1). Ne elencava cinque in particolare.
Una prima antinomia fra efficienza delle istituzioni di governo e vincoli garantisti, dovuti sia alle
esigenze di tutela dei diritti dei singoli sia, in una
situazione di tensione fra le classi come quella
attuale , al timore che le maggioranze detentrici
del potere ne usino per rivolgerlo contro gli avversari . Una seconda antinomia fra il potere
formale attribuito agli organi dello Stato e il po(1) C. MORTATI, Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana), in questa Enciclopedia, XI, 1962, 222 ss.
263
Costituzione della Repubblica italiana
tere reale assunto dai partiti politici, venuti ad
assorbire di fatto i poteri di decisione propri del
Parlamento (di questa antinomia considerava
manifestazione, tra le altre, la prassi delle crisi
extraparlamentari). Una terza antinomia fra i poteri attribuiti agli organi dello Stato e le resistenze
e le pressioni dei contrapposti interessi sociali
organizzati, che, impedendo decisioni e conseguenti assunzioni di responsabilit politica, favoriscono forme di neo feudalesimo Una quarta
fra lindispensabile decentramento regionale e laltrettanto necessario bisogno di accentramento di
una direzione unitaria , proprio dello Stato sociale contemporaneo. Infine segnalava una contraddizione fra ladozione della rappresentanza
proporzionale, non imposta dalla Costituzione ma
presupposta da coloro che lavevano stesa, e il
processo di razionalizzazione della forma di
governo parlamentare, che esige stabilit ed incisivit dellazione di governo.
Mortati si mostrava invece pi fiducioso e
ha avuto ragione sulla possibilit di fare coesistere i principi che informano la prima parte della
Costituzione, nonostante motivi ispiratori diversi
( il cristiano, il liberale, il socialista ), anche con
laiuto dellinterpretazione sistematica , di contro ad autori che invece ne mettevano in evidenza
linsidiosa scarsa organicit e la mera giustapposizione di princpi [...] confliggenti (Mortati citava espressamente Maranini, Esposito, Pierandrei, Bobbio e Calamandrei). Peraltro, non
sottovalutava le non poche riserve mentali con
le quali i Costituenti avevano approvato taluni
principi (2).
In queste pagine intendiamo rendere evidente
come detti principi si siano progressivamente radicati nellordinamento, e come anzi, oggi, essi
siano assai pi radicati nella coscienza degli italiani
di quanto non lo fossero in quei primi decenni in
cui la Carta costituzionale aveva iniziato il suo
cammino. La lettura secondo valori adottata
dalla giurisprudenza costituzionale, pur andando
spesso al di l del testo costituzionale, ha arricchito, non contraddetto, il quadro dei principi.
Nuovi diritti si sono aggiunti al catalogo costituzionale ma senza contraddire, anzi rafforzando,
i principi costituzionali.
Di fronte a principi costituzionali sempre pi
solidi e radicati, le istituzioni di governo hanno
invece evidenziato non poche fragilit: permangono, infatti, e si sono anzi aggravate, le contraddizioni evidenziate da Mortati. Le istituzioni di
(2) MORTATI, op. cit., 229, nonch 221 nt. 225.
264
governo disegnate dal Costituente hanno rappresentato (parafrasando Nietzsche) una solida fune
tesa sul possibile abisso della guerra fredda, ma
oggi rappresentano un freno alla capacit dellItalia di stare in Europa e nel mondo globalizzato.
Proprio perch i principi costituzionali si sono
ormai fortemente radicati nella coscienza degli
italiani, stato possibile tentare di chiudere le
pagine lasciate aperte dal Costituente, ridando
maggiore vigore alle istituzioni della Repubblica;
ma veti e conservatorismi pesano da decenni sui
tentativi di riforma delle istituzioni.
La Costituzione non tuttavia rimasta immutata. Ha incorporato talune riforme parziali
alcune utili, altre negative ma ha anche subito
profondi processi di trasformazione. In una duplice direzione: da un lato, la sempre pi stretta
integrazione europea ha provocato il ridimensionamento dei poteri nazionali fissati dalla Costituzione stessa e la conseguente alterazione del (gi
complesso) sistema delle fonti, giunta fino al
punto di mettere in dissolvenza alcune importanti
disposizioni costituzionali. Dallaltro, si sono progressivamente alterati gli equilibri fra gli organi
politici e gli organi di garanzia, a favore dei
secondi, Magistrature, Capo dello Stato, Corte
costituzionale, Autorit indipendenti. In particolare, rispetto al modello costituzionale, si sono
modificati gli equilibri fra il Parlamento e la Corte
costituzionale, con effetti che non possibile considerare tutti in positivo o tutti in negativo. Alla
sussunzione della norma nel parametro costituzionale si sono aggiunti criteri ermeneutici quali il
bilanciamento dei diritti, lo scrutinio di proporzionalit, la ricerca della ragionevolezza. In breve,
a fondamento dellordinamento sono posti, non la
legge, ma i diritti del cittadino. Lattivismo di
giudici e Corte ha portato ad una notevole estensione dei valori costituzionali ma ha, nel contempo, contratto oltre misura gli spazi della mediazione parlamentare, anchessa, peraltro, in
quanto espressione del principio democratico,
annoverabile fra i valori costituzionali. Una costituzione mantiene forza e prestigio se i principi
costituzionali costituiscono non solo trama e ordito per una sempre pi ricca giurisprudenza, ma
anche basi per decisioni forti, assunte da soggetti politici espressivi della sovranit popolare.
La Costituzione del 48 , nel complesso, tuttora robusta perch il suo un testo ecclettico,
inclusivo e, come cercheremo di evidenziare, a
virtualit multiple. Sopravvissuta alla fine dei partiti dellarco costituzionale, che per decenni
lhanno sostenuta, ha potuto conciliarsi sia con i
Costituzione della Repubblica italiana
sistemi elettorali a base proporzionale (cos stato
fino al 1993), sia con quelli a base o effetto maggioritario (dal 1994 in poi). Ha convissuto sia con
i regolamenti parlamentari propri di una forma di
governo interpretata in chiave assembleare, sia con
le (anche se ancora parziali) modifiche ispirate ad
un governo di gabinetto. Ha accompagnato sia
la prima giurisprudenza costituzionale sui diritti,
ancora legata ai valori di una societ rurale, sia
quella successiva alla svolta degli anni Settanta.
Tali virtualit inducono a leggere la Carta costituzionale non come testo separato ma come parte
irradiante di un pi ampio ordinamento costituzionale, alimentato dalla base materiale, in continua evoluzione, su cui essa si appoggia.
Sez. I. LORDINAMENTO
COSTITUZIONALE.
2. Una Carta non isolata. Chiunque
avesse letto lo Statuto albertino, rimasto in vigore
sia nel periodo liberale sia in quello fascista, e non
avesse tenuto conto del complessivo ordinamento
costituzionale, nei suoi aspetti sia normativi (le
varie leggi fasciste) sia materiali (la fascistizzazione
della societ e il ruolo pervasivo del partito nazionale fascista), sarebbe arrivato a conclusioni assai
distanti dalla realt (3). Non riteniamo quindi
(3) Per quanti sforzi siano stati fatti non sono risultati
convincenti i tentativi di quanti nel ventennio fascista hanno
continuato a individuare nello Statuto albertino la fonte del
diritto costituzionale. Dietro il simulacro albertino, le varie
leggi fasciste hanno caratterizzato lordinamento costituzionale. In pochi anni (tra il 1922 e il 1926) era avvenuto un
vero e proprio mutamento costituzionale. Le leggi che si
erano susseguite spesso formalmente non in puntuale
antinomia con le norme elastiche dello Statuto avevano
dato vita ad un diverso ordinamento costituzionale (ad un
diverso regime appunto): dalle leggi che avevano introdotto la censura sulla stampa alla legge elettorale basata su
lista unica e voto palese, alle leggi che avevano eliminato il
diritto di associazione politica e sindacale, alle leggi che
avevano inserito nella struttura dello Stato milizie e gerarchie
del partito nazionale fascista, fino alla trasformazione della
Camera dei deputati in una Camera corporativa. Dello Statuto albertino, scriveva gi nel 1928 Gerhard Leibholz, sono
rimaste certe funzioni simboliche che riguardano la posizione del Re (ora in G. LEIBHOLZ, Il diritto costituzionale
fascista, trad. it. a cura di A. SCALONE, Guida, Napoli, 2007,
125). Tanto implicitamente riconosceva lo stesso Mussolini
al Senato nella seduta del 12 maggio 1928 richiamandosi
allart. 27 della Dichiarazione francese dei diritti (MUSSOLINI,
Opera omnia, XXIII, La Fenice, Firenze, 1957, 145).
Altri esempi potrebbero essere offerti da regimi che
mantennero per un certo periodo il vecchio testo costituzionale, pur innovando incisivamente lordinamento costituzionale. Cos avvenuto fino al 1947 (o al 1952 secondo altre
letture) per la Polonia dopo la conquista sovietica: fu mantenuta la Costituzione e ci si limit a mutare le leggi elettorali
e le leggi di polizia. Cos avvenuto nel 1989-1990 per
lUngheria nel passaggio dal regime comunista a quello
metodologicamente corretto isolare la Carta costituzionale: se si vuole evitare di ridurre lanalisi
giuridica ad uno sterile esercizio di semantica
giuridica, caratteri e sviluppi del testo costituzionale vanno letti nel contesto del pi ampio ordinamento costituzionale, di cui esso costituisce
ovviamente il nucleo essenziale (certamente destinato a condizionarlo, ma anche ad esserne condizionato). Lordinamento costituzionale, tuttavia,
come qualunque ordinamento, sollecita a prendere in considerazione anche il lato materiale dello
stesso, vale a dire il progetto attorno a cui i vari
elementi si connettono. Le norme non rappresentano il prius, che , invece, rappresentato dallordinamento (4). lordinamento, infatti, che stabilisce come individuare le fonti abilitate a produrre
quelle disposizioni. Non sono le singole disposizioni che messe insieme compongono lordinamento: ci troveremmo di fronte ad una disordinata
sommatoria di testi, non ad un sistema normativo, che invece presuppone un ordine (da mantenere e/o da raggiungere ma sempre in relazione
dialettica). Una forza ordinante tale perch essa
stessa ordinata, cio organizzata. Ed ordinata
necessariamente sulla base di determinati principi
democratico (per ambedue gli Stati v. S. CECCANTI, La forma
di governo parlamentare in transizione, Il Mulino, Bologna,
1997, 195 ss. e 210 ss.). Cos avvenuto per la Costituzione
argentina del 1853, pi volte emendata e formalmente rimasta in vigore anche durante la dittatura dei generali (non
citiamo, per una evidente abrogazione di fatto, la Germania
nazista che mantenne formalmente in vita per diversi anni la
Costituzione di Weimar).
(4) Il riferimento al dibattito pi ampio fra normativisti e istituzionalisti. Per questi ultimi, come richiamato nel
testo, il prius rappresentato dallordinamento, non dalle
norme, che rappresentano, viceversa, il posterius. Il riferimento dobbligo alle pagine di Santi ROMANO, Lordinamento giuridico2, Sansoni, Firenze, 1951, ma sono anche le
posizioni di Costantino Mortati, Maurice Hauriou, Carl
Schmitt ed altri. Mentre le posizioni normativiste trascurano
che qualsiasi fonte del diritto anche quella suprema
gi essa stessa regolata dal diritto, per le posizioni istituzionaliste non c organizzazione che non sia retta, gi nel suo
sorgere, da regole, sia pure grezze ed elementari. Per lo
stesso Kelsen, la norma fondamentale di un ordinamento
giuridico non il prodotto arbitrario dellimmaginazione
giuridica ma il suo contenuto determinato dai fatti .
Per detto autore la norma fondamentale determinata, in
breve, dal principio di effettivit; effettivit che solo una
conditio sine qua non , non una conditio per quam : v.
H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, trad. it.,
Edizioni di Comunit, Milano, 1952, 116 ss., in particolare
120 e 121; ulteriori riferimenti in A. GIOVANNELLI, Dottrina
pura e teoria della costituzione in Kelsen, Giuffr, Milano,
1979, passim. Sul punto v. anche F. MODUGNO, Il concetto di
costituzione, in Aspetti e tendenze del diritto costituzionale.
Scritti in onore di Costantino Mortati, I, Giuffr, Milano,
1977, 200-201; cfr. anche ID., Lineamenti di teoria del diritto
oggettivo, Giappichelli, Torino, 2009, 81 ss.
265
Costituzione della Repubblica italiana
e valori. Lordinamento costituzionale, in quanto
secondo la celeberrima affermazione di Santi
Romano tronco da cui si dipartono in modo
ordinato tutti i rami dellordinamento giuridico (5), presuppone esso stesso un fattore ordinante. Per queste ragioni lordinamento costituzionale non si riduce, allora, solo ad un testo
normativo, sia pure formalmente qualificato come
Costituzione. Livio Paladin, che pure non condivideva le teorie materiali, sottolineava che il
diritto costituzionale eccede gli spazi delimitati dal
testo costituzionale giacch molte norme concernenti la stessa formula politica dello stato non
sono iscritte nella Carta fondamentale (6). La
Carta costituzionale deve intendersi, in breve,
come il precipitato formale di un complessivo
ordine costituzionale, come se fosse la cuspide
emergente di un continente per la massima parte
sommerso (da cui per quella cuspide trae continuo nutrimento) (7).
Eviteremo, tuttavia, di riferirci alla costituzione materiale, espressione suscettibile di creare
fraintendimenti e diffidenze, essendo spesso utilizzata, involgarendola e banalizzandola, per legittimare i comportamenti di quanti si scostano dalla
regola formale e per giustificare distorsioni o violazioni della Carta costituzionale (8). Detto uso
(5) Santi ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1933, 12.
(6) L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Il Mulino,
Bologna, 1996, 127. Impostazione analoga in V. ZANGARA,
Costituzione materiale e costituzione convenzionale (notazioni
e spunti), in Aspetti e tendenze del diritto costituzionale.
Scritti in onore di Costantino Mortati, I, cit., 333 ss. Riduttiva, dopo uno slancio iniziale, la definizione di A. CELOTTO,
Diritto costituzionale, in Dizionario di diritto pubblico diretto
da S. CASSESE, III, Giuffr, Milano, 2006, ad vocem, che
collega la disciplina solo al contenuto dellart. 16 della
Dichiarazione francese dei diritti (impostazione diffusa in
dottrina, ma che non riesce a raccogliere lintera dimensione
dei testi costituzionali, fra i quali, peraltro, si annoverano
anche testi estranei al costituzionalismo liberaldemocratico,
non riducibili alla tutela dei diritti e alla separazione dei
poteri).
(7) P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Laterza, RomaBari, 2007, 90.
(8) Limpostazione di Mortati volta in tutta altra
direzione: la nozione di costituzione materiale ha una funzione di integrazione e interpretazione, non di contrapposizione al testo costituzionale (v. MORTATI, op. cit., 140). Ci
siamo intrattenuti sul punto in A. BARBERA, Prefazione a Una
e indivisibile, Giuffr, Milano, 2007 (edizione fuori commercio che ripubblica la citata trattazione di Mortati). Quando
Mortati ha inteso contrapporre al testo costituzionale una
diversa e contrastante realt ha fatto uso dellespressione
costituzione reale, contrapponendola alla costituzione formale. Anzi appena il caso di sottolinearlo egli fu
sempre in prima linea nel condannare le in-attuazioni costituzionali che altri (anche costituzionalisti) pretendevano di
giustificare in nome della situazione politica venutasi a creare
266
strumentale avvenuto pi volte: sia negli anni
Cinquanta, nel periodo della in-attuazione costituzionale; sia negli anni Novanta, nel periodo della
transizione maggioritaria; ma anche negli anni Ottanta per legittimare gli spazi abusivamente occupati da partiti e sindacati a scapito delle istituzioni.
Questo equivoco materiale contrapposto a
formale non imputabile a Mortati: frequente invece nei politologi e nei commentatori
politici, ma anche, non poche volte, sia in giuristi
che accettano tale nozione sia in giuristi che la
rifiutano (9).
3. Principi supremi e ordine costituzionale.
Il nesso stretto fra il testo costituzionale,
formalmente al vertice dellordinamento, e il progetto ordinante che percorre lintero ordinamento, e contribuisce a determinarne lidentit,
pu essere meglio espresso a noi pare ricorrendo, pi che alla coppia concettuale costituzione
materiale-costituzione formale, ad una pi complessa interazione sistemica rappresentata da
quello che noi chiamiamo ordinamento costituzionale (10). Questo ordinato su tre elementi,
con la guerra fredda. Limpostazione di Costantino MORTATI
(su cui v. La Costituzione in senso materiale (1940), Giuffr,
Milano, 1998) era stata in parte anticipata da Vincenzo
GUELI, Il regime politico, Officina tipografica De Luca,
Roma, 1939, ora in ID., Scritti vari, I, Giuffr, Milano, 1976,
387 ss. Su questi temi v. V. CRISAFULLI, Costituzione, in
Enciclopedia del Novecento, I, Treccani, Roma, 1975, 1037.
Sulla pluralit di significati dellespressione costituzione
materiale v. R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti,
Giuffr, Milano, 1998, 319 ss. La letteratura vastissima: sul
tema di recente tornato M. DOGLIANI, Costituzione in senso
formale, materiale, strutturale e funzionale. A proposito di una
riflessione di Gunther Teubner sulle tendenze autodistruttive
dei sistemi sociali, in Dir. pubbl., 2009, 295 ss.; v. anche S.
FOIS, Costituzione legale e costituzione materiale, in La costituzione materiale. Percorsi culturali e attualit di unidea
(Autori vari), Giuffr, Milano, 2001, 36. Talvolta il concetto
di costituzione materiale servito per spingere allattuazione
delle norme programmatiche: v. P. BARILE, La Costituzione
come norma giuridica, Barbera, Firenze, 1951.
(9) Ad esempio R. BIN, Che cos la Costituzione?, in
Quaderni costituzionali, 2007, 36, e S. BARTOLE, Costituzione
(dottrine generali e diritto costituzionale), in D. disc. pubbl.,
IV, 1989, 308, che tornato sullargomento in ID., La
Costituzione di tutti, Il Mulino, Bologna, 2013, 163 ss. (v.
anche ID., Princpi generali del diritto (diritto costituzionale),
in questa Enciclopedia, XXXV, 1986, 530). Di frequente
volgarizzazione e banalizzazione parla G. ZAGREBELSKY, Premessa a MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit.,
XXXII.
(10) Abbiamo approfondito il tema in A. BARBERA, Ordinamento costituzionale e Carte costituzionali, in Quaderni
costituzionali, 2010, 311 ss. La rilevanza della nozione di
ordine costituzionale ivi sottolineata accolta da M. FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale, in Riv. trim. dir.
pubbl., 2014, 295 ss., in particolare 306 (il saggio pubblicato anche in Dalla Costituzione inattuata alla Costituzione
Costituzione della Repubblica italiana
fra loro influenti: a) il testo, nel caso italiano la
Carta del 1948, con le revisioni intervenute
elemento che ovviamente manca in alcuni Paesi, il
Regno Unito in primis (11) ; b) il contesto
inattuale? a cura di G. BRUNELLI e G. CAZZETTA, Giuffr,
Milano, 2013, 355 ss., e v. in particolare 361-362).
(11) Tutti gli Stati hanno (ed hanno sempre avuto) un
ordinamento costituzionale, non tutti, come noto, hanno
per una Carta costituzionale. E non tutte le Carte sono
improntate ai principi del costituzionalismo. Proprio in
una delle culle del costituzionalismo, nel Regno Unito, non
si hanno leggi formalmente costituzionali, nondimeno un
Paese retto da un puntuale ordinamento costituzionale (monarchia ereditaria, libero Parlamento, tutela dei pi rilevanti
diritti di libert, autonomia dei giudici), espressione dei fini
e dei valori di cui sono portatrici le forze politiche, sociali e
culturali egemoni, senza lintermediazione di una Carta costituzionale.
Usiamo lespressione egemoni per indicare quelle
forze politiche sociali e culturali che sono in grado di
produrre valori che hanno attivato, o possono attivare, processi di integrazione (R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale, trad. it., Giuffr, Milano, 1988) o rappresentazioni
di valore (K. HESSE, Die normative Kraft der Verfassung,
Mohr, Tbingen, 1959) o determinare le condizioni fondamentali dellesistenza di un popolo (C. SCHMITT, Dottrina
della Costituzione, trad. it., Giuffr, Milano, 1984). Non ci
riferiamo necessariamente alla nota categoria di Gramsci
(anche se la categoria egemonia, proprio perch contrapposta alla categoria del dominio, pienamente compatibile con i modelli del costituzionalismo). Giuseppe VOLPE (Il
costituzionalismo del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 2000,
127) ha messo bene in luce il filo che collega le concezioni
materiali della Costituzione sia alla teoria liberale delle lites,
di Mosca, Pareto e Michels, sia a quella gramsciana dellegemonia; concezioni che si riferiscono tutte a quei soggetti
collettivi che siano in grado di fare prevalere propri progetti
e propri sistemi di valori. Anche per Mortati, a differenza di
quanto sostenuto dalle dottrine del pouvoir constituant, il
lato materiale della Costituzione non pu individuarsi direttamente nel popolo. Esso, bench sovrano, privo di
capacit di azione giuridica , non meno di quanto lo fossero
la Nazione o altre entit astratte. Le basi della Costituzione
vanno individuate, piuttosto, nei fini e valori attorno a
cui si ordinano le forze politiche egemoni che alla Costituzione hanno dato vita oppure che ad essa hanno successivamente aderito. Limpostazione di Mortati di teoria generale
e allarga lo sguardo ad altri ordinamenti ma attento lo
sguardo alla realt italiana. Negli anni Trenta portatore di
tale progetto era stato il partito nazionale fascista; negli anni
del dopoguerra sarebbero state le forze egemoni rappresentate nellAssemblea costituente democraticamente eletta (C.
MORTATI, La Costituente: la teoria, la storia, il problema
italiano (1945), ora in ID., Raccolta di scritti, I, Giuffr,
Milano, 1972). Nel comporre la base materiale di una Costituzione vengono in rilievo sono da aggiungere anche
quelle forze sociali e culturali che insieme alle forze politiche
sono integrate in una determinata comunit statale (e tra le
forze culturali ovviamente, ma senza pretendere un monopolio, anche i cultori del diritto costituzionale: v. P. HBERLE,
Die Wesensgehaltgarantie des art. 19 Abs. 2 Grundgesetz3,
Mller, Heidelberg, 1993, in parte tradotto in ID., Le libert
fondamentali nello Stato costituzionale a cura di P. RIDOLA,
Nuova Italia scientifica, Roma, 1993). Che Mortati si sia
riferito solo alle forze politiche ben comprensibile; lo
sarebbe di meno in un periodo in cui la loro rappresentati-
normativo, rappresentato dal complesso degli altri testi normativi, spesso non formalmente costituzionali, che ad esso si collegano strettamente; c)
lordine costituzionale, vale a dire il contesto
politico-sociale e politico-culturale entro cui si
produce il riconoscimento dei principi costituzionali fondamentali, lordito attorno al quale si intessono le varie norme. Questultimo la base
materiale, un ordine sociale modellato dai fini e
dai valori delle forze politiche, sociali e culturali
egemoni, che in quel testo si riconoscono.
lenergia ordinante il logos che percorre
lintero ordinamento costituzionale, che lelaborazione del testo non cancella ma incanala negli
argini normativi (12). Soprattutto il riferimento
allordine costituzionale pu evidenziare, tra laltro, la continuit o meno di un ordinamento:
lordine costituzionale italiano, ad esempio, precede sia la Carta costituzionale sia le leggi che ne
costituiscono il contesto. Il 1o gennaio 1948 entr
in vigore la Carta costituzionale ma un nuovo
ordine costituzionale si era gi andato formando
progressivamente: non solo con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 ma prima ancora con
la vittoria sul nazifascismo, il ripristino delle principali libert e la nascita dei partiti democratici (13). Delle tre dimensioni che compongono
lordinamento costituzionale un ordine costituvit ha perso, in tutto lOccidente, la antica incidenza. Del
resto CRISAFULLI, op. cit., usa lespressione forze politicamente attive con un significato analogo a quello qui richiamato.
(12) Cfr. al riguardo le considerazioni di A. SPADARO,
Costituzione (dottrine generali), in Dizionario di diritto pubblico diretto da CASSESE, cit., II, ad vocem, nonch ID., Dalla
Costituzione come atto (puntuale nel tempo) alla Costituzione come processo (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalit, in Quaderni costituzionali, 1998, 343 ss.
(13) Fin dalla costituzione dei comitati di liberazione
nazionale a Roma il 9 settembre del 1943, allindomani
della fuga del Re avevano iniziato il loro cammino i
principi fondamentali dellordinamento costituzionale (sovranit del popolo, dignit costituzionale dei partiti, rispetto
dei diritti delluomo, autonomia delle formazioni sociali e
libera organizzazione sindacale dei lavoratori). Ci siamo
riferiti a fatti normativi ma se si vuole un aggancio giuridico formale si pu andare alla cosiddetta Costituzione
provvisoria, voluta dalle medesime forze politiche e trasfusa
nel d.l. lt. 25 giugno 1944, n. 151 e ulteriormente modificata
nel marzo 1946 (con il d. lg. lt. 16 marzo 1946, n. 98). Ad essi
vanno aggiunte le leggi che avevano soppresso il Tribunale
speciale per la difesa dello Stato (r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668,
convertito dalla l. 5 maggio 1949, n. 178), soppresso il
partito nazionale fascista (r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704),
soppresso la Camera dei fasci e delle corporazioni (r.d.l. 2
agosto 1943, n. 705), reintegrati nei loro diritti i cittadini
perseguitati per motivi razziali (r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25,
convertito dalla l. n. 178 del 1949), e alle quali si possono
ulteriormente aggiungere i vari atti con cui si sono iniziate a
267
Costituzione della Repubblica italiana
zionale materiale, le normative caratterizzanti
detto ordine, il testo costituzionale due si erano
gi formattate prima del 1o gennaio 1948. Il
testo costituzionale completer, arricchir e stabilizzer il quadro.
In breve: lordinamento costituzionale ha pi
dimensioni, non solo il risultato di atti comunicativi linguistici ma anche di atti, fatti e rapporti
sociali in senso ampio. Possono aversi come si
sono avute assai limitate revisioni del testo
costituzionale ma, nello stesso tempo, assai sensibili modificazioni dellordinamento costituzionale (come vedremo, quel che accaduto allItalia
con ladesione allUnione europea) e, inoltre, non
meno sensibili linee interpretative del testo in
relazione alle trasformazioni della base materiale
(lo vedremo seguendo le varie fasi della pluridecennale storia politico-costituzionale della Repubblica).
Lordinamento costituzionale dunque un insieme, ordinato e ordinante. Quale il fattore ordinante? Lo si pu leggere recandosi ai confini fra
lessere della societ e il dovere essere del
diritto; lo si pu individuare nei principi fondamentali che marcano la identit dellordinamento
costituzionale e racchiudono le informazioni genetiche attorno a cui si modella lordinamento costituzionale e, attraverso questo, lintero ordinamento giuridico. Essi fondano e sostengono lordinamento costituzionale, ne assecondano le trasformazioni possibili e individuano i confini entro
cui queste possono realizzarsi. Per queste caratteristiche tali principi sono individuati dalla Corte, e
dalla dottrina pressoch unanime, quali possibili
limiti alla revisione e quali contro-limiti allingresso di norme di altri ordinamenti (14) (i prinriconoscere le autonomie speciali, la firma del Trattato di
pace nel febbraio 1947 e via elencando.
Analoghe considerazioni potrebbero farsi per la Spagna.
Come noto, seguendo le regole franchiste sulla revisione
costituzionale, si pervenne ad un nuovo assetto costituzionale improntato ad opposti principi. Ma il nuovo ordine
costituzionale nasce in quel Paese con il varo del testo
costituzionale il 27 dicembre 1978? ovvero con le prime
elezioni democratiche del 15 giugno 1977 o, prima, con la
ratifica referendaria il 15 dicembre 1976 della legge di
riforma politica? o, prima ancora, con il processo avviato
con lassunzione al trono di Juan Carlos il 22 novembre del
1975, qualche giorno dopo la morte del Generalissimo Francisco Franco? Le varie opinioni sul processo costituente in
Spagna sono richiamate in F.F. SEGADO, El sistema constitucional espaol, Dykinson, Madrid, 1992, 54 ss.: ivi riferimenti alla tesi della rottura costituzionale senza riforma ,
di Lucas Verd, e alla legge di riforma costituzionale ratificata con referendum come fatto democratico che ribalta
lordine costituzionale , di Luis Snchez Agesta.
(14) Oltre a C. cost. 29 dicembre 1988, n. 1146, che ha
268
cipi supremi nel linguaggio della Corte). Non
solo essi sono invalicabili da parte di altri ordinamenti (europeo, concordatario, internazionale),
pur collegati a quello italiano, ma stabiliscono
altres i confini invalicabili dallo stesso potere di
revisione costituzionale. Rappresentano quei tratti
identitari, alterati i quali tale potere perderebbe
legittimazione e darebbe vita non ad una revisione ma ad un mutamento costituzionale, trasformandosi da costituito a costituente (15).
Al pari di tutti i principi, essi possono essere anche
individuato nel nucleo duro dei principi fondamentali un
limite alla revisione costituzionale, possono ricordarsi C.
cost. 1o marzo 1971, n. 30, C. cost. 2 febbraio 1972, n. 12, C.
cost. 11 dicembre 1973, n. 175, C. cost. 5 gennaio 1977, n.
1 e C. cost. 2 febbraio 1982, n. 18, che hanno individuato
negli stessi un limite allordinamento concordatario; C. cost.
27 dicembre 1973, n. 183 e C. cost. 8 giugno 1984, n. 170,
relative ai controlimiti allordinamento comunitario; C.
cost. 22 ottobre 2014, n. 238, relativa ai controlimiti
allordinamento internazionale consuetudinario; nonch C.
cost. 12 aprile 1989, n. 203, relativa in particolare al principio di laicit.
(15) Al pari delle singole decisioni politiche fondamentali, come individuate da Carl Schmitt, detti principi
supremi possono formare die Substanz der Verfassung :
v. SCHMITT, op. cit., 42 ss., a proposito di principi democratici, repubblicani, federali, diritti fondamentali e separazione
dei poteri (la citazione testuale a p. 43 e a p. 24 delled.
tedesca, Verfassungslehre, Duncker-Humblot, Berlin, 1989).
La distinzione suggerita nel testo potrebbe essere non distante, in poche parole, da quella che intercorre fra Verfassung e Verfassungsgesetz in SCHMITT (op. ult. cit., 38) o, sia
pure con i necessari distinguo, tra Constitution e Law of the
Constitution in A.V. DICEY (Introduzione allo studio del
diritto costituzionale, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2003, 20
ss.) e non lontana dalle categorie su cui sta lavorando
Ackerman (v. infra, nt. 37). Da noi si potrebbe distinguere
fra Costituzione (vale a dire la Costituzione quale ordinamento costituzionale) e Legge costituzionale (vale a
dire la Costituzione quale testo costituzionale, quale documento formalmente collocato al vertice della gerarchia delle
fonti) ma come sappiamo tali termini hanno ormai
assunto altri significati nello spazio semantico ed bene
evitare confusioni. Riferendoci alla Germania di oggi eviteremmo il riferimento al verfassungsmige Ordnung, espressione richiamata negli art. 2 comma 1, 9 comma 2 e 20
comma 3 della Costituzione federale, perch tale espressione
non ha il significato qui accolto di ordinamento costituzionale (cos potrebbe sembrare dallart. 9) ma, come sancito
dalla giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht fin dal
1957, quello, assai pi largo, di ordinamento giuridico
conforme a Costituzione ( Verfassungsmige Ordnung
[...] ist die verfassungsmige Rechtsordnung, d.h. die Gesamtheit der Normen, die formell und materiell der Verfassung
gem sind : cos la Elfes Urteil BVerfG 16 gennaio
1957, BverfGE 6, 32 tuttora assai citata dalla giurisprudenza). Comunque tale nozione rischia di esaurirsi in una
tautologia qualora non riesca a collegarsi a principi che
sottendono le disposizioni formali, in primo luogo i principi
di proporzionalit, il rispetto del Wesengehalt e la stessa
Sittengesetz: sul punto v. le osservazioni di F. PEDRINI, Il
libero sviluppo della personalit nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale. Un diritto per tutte le stagioni?, in Quaderni costituzionali, 2006, 161 ss. La dottrina
Costituzione della Repubblica italiana
inespressi. Come affermato dalla Corte, sono da
considerarsi supremi tanto i principi che la
stessa Costituzione esplicitamente prevede come
limiti assoluti al potere di revisione costituzionale,
quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati [...] appartengono allessenza
dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana (16).
4. La Carta costituzionale e il contesto dei
valori. Ma come individuare i principi supremi? La Corte non lo ha ancora detto; e comprendiamo perch: per la loro natura essi rifuggono da una lettura basata esclusivamente su
enunciati linguistici. E rifuggono altres da una
lettura che vagamente si richiami solo ai principi
politico-ideologici del costituzionalismo (17).
tedesca peraltro stretta fra il richiamo alle numerose
clausole aperte del Grundgesetz alcune delle quali
sempre pi assimilabili a principi o valori costituzionali e
il tradizionale rifiuto della costituzione materiale (cos F.
PALERMO e J. WOELK, Una lettura critica della recente dottrina
costituzionalistica tedesca, ivi, 2003, 409 nt. 2).
(16) C. cost. 29 dicembre 1988, n. 1146, cit. Dopo tale
pronuncia, nella quale la Corte teorizz la presenza di limiti
impliciti, i dubbi della dottrina si sono fortemente attenuati. Da allora in poi, temendo un potere destabilizzante
di fronte a cui il diritto costituzionale pu improvvisamente
cadere senza avere strumenti giuridici di difesa (V. ANGIOLINI, Costituente e costituito nellItalia repubblicana, Cedam,
Padova, 1995, 79), si giunti ad una alquanto disordinata
proliferazione dei limiti ipotizzati. Non tuttavia questo il
punto che intendiamo sottolineare; ci chiediamo, piuttosto,
come sia possibile individuare limiti impliciti seguendo concezioni della Costituzione che non sappiano andare al di l di
elementi e procedimenti testuali. Colpisce, infatti, che limiti
impliciti alla revisione costituzionale vengano individuati
anche da quella parte della letteratura che su posizioni
normativiste. Si tratta di posizioni che dovrebbero coerentemente sostenere che lunico limite alla revisione costituzionale possa essere rappresentato dalle norme (o meglio dai
principi: v. A. BARBERA, La Commissione Bozzi e lart. 138, in
Scritti in onore di Aldo Bozzi, Cedam, Padova, 1991) che
stabiliscono le procedure di revisione. Non a caso Mortati
aveva avuto modo di affermare che il formalismo kelseniano, svincolando la volont della suprema autorit da ogni
limite sostanziale di contenuto e consentendo qualunque
mutamento [...] viene in un certo senso a sboccare nel
decisionismo (cos MORTATI, Costituzione dello Stato, cit.,
162). Sul punto v. anche A. MERKL, ora Il duplice volto del
diritto, trad. it., Giuffr, Milano, 1987, 13 ss. e 136. Se,
invece, come gi detto, lelemento primigenio dellesperienza
giuridica va rinvenuto nellordinamento pi che nelle
norme, il riferimento allordinamento costituzionale, e alla
base materiale che esso sottende, consente, in modo pi
coerente, di mettere a fuoco i principi supremi.
(17) Per esempio G. FERRARA, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Feltrinelli, Milano, 2006,
passim e 205 ss., che pur partendo da una interessante analisi
della Costituzione come frutto di principi politici normativizzati si affida soltanto ai principi del costituzionalismo,
come se essi fossero suscettibili di una sola e definitiva
lettura.
Come ha sottolineato Maurizio Fioravanti, la selezione di detti principi non pu essere il frutto di
mera tecnica (18); come ha precisato Antonio
Ruggeri, la loro selezione non pu farsi se non
risalendo ai valori in nome dei quali in un certo
momento storico certe forze politiche hanno combattuto determinate battaglie (19); mentre sospende il giudizio Franco Modugno, costretto a
concludere che il principio supremo non una
norma superiore ad unaltra ma unentit diversa,
irriducibile al mondo della norma (20).
In realt il collegamento fra tali principi e le
culture presenti nella base materiale dellordinamento costituzionale cos stretto da renderli non
facilmente distinguibili. E ci opportuno
precisarlo senza necessariamente trarre da tale
base vincoli normativi che si pongano in diretta
antinomia rispetto a puntuali disposizioni del testo, n cedere ai timori di chi rifiuta un siffatto
riferimento perch vuole mantenere il testo costituzionale indenne da contaminazioni: quelle culture possono rappresentare delle luci che rendono
possibile la lettura di un testo, perch ne rendono
chiari i contorni, ma non si sovrappongono al testo
stesso, non lo modificano n tanto meno si sostituiscono allo stesso (come i fotoni non si sostituiscono al foglio che colpiscono illuminandolo). E
daltro canto, come si pu parlare di ragionevolezza nel bilanciamento fra diritti, o addirittura
fra principi (21), prescindendo da ci che si intende per razionale in una determinata cultura,
in un determinato ordine materiale (22)? E come
utilizzare concetti quali libert o dignit della
(18) FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale, cit.,
306.
(19) A. RUGGERI, Lo Stato costituzionale e le sue mutazioni genetiche, in Quaderni costituzionali, 2014, 837 ss.
Come stato sottolineato (G. MORBIDELLI, Lezioni di diritto
pubblico comparato, Monduzzi, Bologna, 2000, 85), solo la
maturazione degli orientamenti delle forze politiche e culturali intervenuta nella costituzione materiale ha consentito
di leggere la tutela del paesaggio di cui allart. 9 cost. non
solo come tutela delle bellezze naturali ma anche come tutela
dellambiente e dellecosistema, che viene cos ad assumere
un ruolo superprimario .
(20) F. MODUGNO, Fonti del diritto (gerarchia delle), in
questa Enciclopedia, Aggiornamento, I, 1997, 572.
(21) Ad esempio C. cost. 22 ottobre 2014, n. 238, cit.,
pone un problema di bilanciamento anche fra principi supremi: quello alla difesa dei diritti (tracciato dallart. 24 cost.)
e il principio internazionalista (tracciato dallart. 10 cost.): sul
punto P. FARAGUNA, La sentenza 238 del 2014: i controlimiti in
azione, in Quaderni costituzionali, 2014, 899 ss.
(22) questo il senso, peraltro, della ragione comunicativa, cui in pi sedi si riferisce Jrgen HABERMAS (per
esempio in Teoria dellagire comunicativo, trad. it., Il Mulino,
Bologna, 1997).
269
Costituzione della Repubblica italiana
persona (et similia) prescindendo dal medesimo
ordine materiale?
Collocati ai confini fra lessere della societ e
il dovere essere del diritto, tali principi possono
dirsi, contemporaneamente, diritto e fattore ordinante del diritto stesso. Tale loro natura, pluriversa, renderebbe un esercizio vano se non
inutile (23) chiedersi se appartengono alluno o
allaltro versante, quello teoretico o quello dommatico, quello cognitivo o quello normativo,
quello analitico o quello deontico (24). Servono sia
allambito della scienza giuridica, volta alla costruzione del sistema normativo, sia allambito delle
scienze sociali, volte a ricostruire lidentit storicofattuale di un ordinamento. Del resto, parallassi
siffatte sono consuete nel mondo del diritto: basti
pensare al concetto classico di sovranit, che ha
una funzione di chiusura sia sul versante analitico
sia su quello normativo (25).
I principi supremi assumono, dunque, un
duplice volto, uno espressivo della comunit sottostante, laltro proiettato verso lordinamento
giuridico. Essi, quali muri maestri, marcano
lidentit della Repubblica e contribuiscono a delineare (ma nello stesso tempo ne sono il frutto)
quello che prima abbiamo chiamato lordine costituzionale, un ordine ordinante (26) al
(23) Cos, in riferimento allo Stato sociale, M.S. GIANStato sociale: una nozione inutile, in Aspetti e tendenze
del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, I, cit., 139 ss.
(24) Rinviamo alla distinzione di V. GUELI, Elementi di
una dottrina dello Stato e del diritto come introduzione al
diritto pubblico, Il Foro italiano, Roma, 1959, 416 ss. (e alla
dottrina ivi richiamata). Per la distinzione normativo versus descrittivo riferimenti in R. GUASTINI, Diritto, filosofia e
teoria generale del, in Enciclopedia delle scienze sociali, III,
Treccani, Roma, 1993, ad vocem.
(25) Pu anche essere richiamato in proposito riferendoci ad un campo assai diverso quanto lungamente
dibattuto in riferimento allattivit di indirizzo politico, se
normativa o esistenziale. Anche chi rifiuta la prescrittivit della stessa, perch ritiene che la determinazione dei fini
dellattivit di governo al di fuori degli strumenti di
conoscenza del giurista, impegnato a valutare solo gli atti
tipici previsti dallordinamento, tende tuttavia a rifiutare una
versione estrema della concezione esistenziale atteso che
lindirizzo esistito non pu non costituire un dato
giuridicamente rilevante, [...] un oggetto storico che pu [...]
essere assunto come criterio ermeneutico . Riferimenti in
M. DOGLIANI, Indirizzo politico. Regole e regolarit nel diritto
costituzionale, Jovene, Napoli, 1985, 46 ss. e in particolare
49, nonch in E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo
politico, Giuffr, Milano, 1961, 106 ss. Da sottolineare che
V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dellindirizzo politico,
in St. urb., 1939, p. II dellintroduzione, sottolinea lesigenza
di non irrigidire i concetti nello sforzo di ricondurli nel
campo giuridico.
(26) Lespressione anche in MODUGNO, Il concetto di
costituzione, cit., 200-201.
NINI,
270
pari, se il riferimento non risulta ardito, delle
spinoziane natura naturans e natura naturata
che d via via espressione a quei valori che si
sono affermati, o vanno affermandosi, nella societ
italiana (27).
Non possibile individuarli n ricorrendo solo
ad elementi testuali n ricorrendo ad eteree valutazioni storico-spirituali (28). Entrambe le posizioni rischiano di essere di scarsa utilit. Pu
essere invece utile il riferimento ai valori di cui
sono portatrici le forze politiche e sociali che
sostengono la Costituzione. In taluni ordinamenti
possono venire in aiuto i preamboli costituzionali (29), che spesso svolgono una funzione espressiva di un ordine costituzionale sottostante (o che
(27) Sono gli elementi che identificano la forma di
Stato o (usiamo espressioni non sempre equivalenti) il
regime costituzionale o (come nella letteratura giuridica
francese) il regime politico. Per evitare di creare un equivoco terminologico, veniva precisato che questultima nonostante il qualificativo non una nozione di carattere
puramente politico : GUELI, Il regime politico, cit., 408.
Sulla forma di Stato quale punto cruciale in cui la politica
si stabilizza convertendosi in diritto [...] con la capacit di
acclarare gli equilibri in cui viene a muoversi lordinamento
concreto in una specifica situazione storico-sociale v. F.
LANCHESTER, Stato (forme di), in questa Enciclopedia, XLIII,
1990, 798, ed ivi (812 nt. 85) la ricostruzione del concetto di
regime politico in unottica storica e comparata.
Il ricorso al concetto di ordinamento costituzionale
consente di tenere lontano un pericolo: che i testi costituzionali siano sospesi nellaria rarefatta delle pure forme,
immobili e sottoponibili solo ad una velleitaria lettura oggettiva, staccata dalla soggettivit degli interpreti, siano essi
soggetti politici o sociali o interpreti professionali. Ove ci
dovesse accadere, le Costituzioni rischierebbero di non essere in grado di marcare lidentit dellintero ordinamento
giuridico. Si ripeterebbero i deprecati limiti delle concezioni
positiviste europee (a partire da Laband) che, a differenza di
quelle nordamericane, vedevano nella Costituzione le stesse
caratteristiche formali della legge, fatta salva la diversa procedura di approvazione e revisione. Sul tema A. PACE, Potere
costituente, rigidit costituzionale, autovincoli legislativi, Cedam, Padova, 1997 (2a ed., 2002), che valorizza la tesi di
Bryce secondo la quale le Costituzioni sono rigide perch
superiori e non solo perch la loro revisione richieda un
speciale procedimento (come invece equivocato da quella
letteratura che portava a ritenere flessibili tutte le Costituzioni che non avessero previsto un procedimento aggravato).
(28) V. citate le numerose posizioni in N. ZANON, Premesse ad uno studio sui principi supremi di organizzazione
come limiti alla revisione costituzionale, in Giur. cost., 1998,
1902 ss. ed ivi importanti notazioni critiche.
(29) La funzione dei preamboli stata particolarmente
valorizzata da Carl SCHMITT (Dottrina della Costituzione, cit.,
43 ss.) e da Rudolf SMEND (Costituzione e diritto costituzionale, cit., 188 ss.): per il primo essi hanno la funzione di
fissare i valori che esprimono la raggiunta unit politica di un
ordinamento; per il secondo hanno, piuttosto, la funzione di
indicare i valori attorno a cui si costruisce il processo di
integrazione di una comunit. Per entrambi hanno un ruolo
non puramente politico-simbolico, atteso che essi sono anche giuridicamente rilevanti non solo in quanto orientano
linterprete nella lettura delle varie disposizioni ma in quanto
Costituzione della Repubblica italiana
rappresentano un progetto di un nuovo ordine).
In assenza di tali punti di riferimento inevitabile
rifarsi noi crediamo alle culture politiche
egemoni chiamate ad alimentare gli orientamenti
della comunit degli interpreti (non necessariamente limitati ai soli interpreti professionali) (30).
Bene ha fatto la Corte a sottolineare pi volte
che detti principi sono limiti invalicabili al potere
di revisione costituzionale. Poich il procedimento
di revisione esso stesso un potere costituito
non pu erodere le proprie basi di legittimazione,
ed ove si dovesse individuare la violazione di
principi supremi saremmo di fronte non ad una
revisione ma ad un mutamento costituzionale:
la revisione proceduralmente corretta che si ponesse contro principi fondamentali della Costituzione porrebbe in essere un atto legale ma non
legittimo. Quali limiti alla revisione costituzionale
i principi supremi rappresentano una possibile
barriera che la Corte costituzionale dovrebbe opporre financo ad una ampia maggioranza parlamentare (i due terzi del Parlamento o la maggioranza assoluta confortata da un referendum confermativo). Siamo in un campo in cui la legittimazione delluna pu escludere la legittimazione dellaltra, tanto che Crisafulli preferisce affidarsi ai
soli limiti positivamente previsti in Costituzione
(lart. 139 e le procedure ex art. 138) (31). Il
possibile conflitto forse astratto ma serve a sotconsentono al medesimo interprete di individuare sia le
disposizioni costituzionali che di quellordine sono parte
essenziale, sia i confini al di l dei quali eventuali revisioni
del testo costituzionale non sono pi legittimate dalla Costituzione stessa. Casi in cui, possiamo dire, alla legalit della
procedura di revisione non corrisponderebbe la legittimit
della stessa. Sui vari tipi di preambolo v. P. HBERLE, Potere
costituente (teoria generale), in Enc. giur., Aggiornamento,
2000; nonch, da ultimo, J.O. FROSINI, Constitutional Preambles. At a Crossroads between Politics and Law, Maggioli,
Rimini, 2012.
(30) A. BALDASSARRE, Il problema del metodo nel diritto
costituzionale, in Il metodo nella scienza del diritto costituzionale (Atti del XVII Convegno annuale dellAssociazione
italiana dei costituzionalisti, Milano, 11-12 ottobre 2002),
Cedam, Padova, 2004, 95, per il quale il diritto costituzionale riducibile a tre distinti ambiti: quello delle disposizioni normative, quello dellautorit e del processo decisionale, quello della comunit di persone e delle sue dinamiche.
Cfr. ancora ivi, 137 (Replica), dove si osserva come oltre
alle norme, nel diritto pubblico, ci sono le istituzioni, il
processo decisionale, la produzione di senso collegata allopinione pubblica. Ognuno di questi ambiti produce autonomamente significati giuridici, cio significati rilevanti
per la comprensione del fenomeno giuridico ; nonch ivi,
143: lopinione pubblica non pi una sfera che il diritto
costituzionale non riesce a spiegare, ma entra nella problematica di questo diritto, contribuendo a dargli una significativa curvatura relativistica .
(31) CRISAFULLI, Costituzione, cit., 1037.
tolineare la carica di politicit posseduta da detti
principi.
Il riferimento allordinamento costituzionale,
sia negli aspetti formali che in quelli materiali, non
pu svilire la posizione gerarchicamente superiore
della Carta costituzionale nel sistema delle fonti.
Quale allora la sua utilit? Esso pu: a) segnare,
allinterno della Carta costituzionale, una gerarchia materiale fra i principi supremi e gli altri
principi, essendo solo i primi insuscettibili di revisione costituzionale o dotati di attitudine ad
agire come contro-limiti; b) orientare la interpretazione del testo costituzionale, mettendone a
fuoco i valori; c) contribuire ad accertare la effettiva sussistenza e il contenuto di consuetudini (e
desuetudini) costituzionali (sia che si tratti di effettive consuetudini che di espansione di principi
costituzionali); d) contribuire ad individuare gli
organi che possono definirsi costituzionali (supremi si definivano un tempo, o addirittura sovrani) in quanto la loro presenza caratterizza lidentit stessa dellordinamento costituzionale (32); e) favorire linterpretazione di alcune
(32) Come noto, nella forma di Stato italiano sono
certamente considerati organi costituzionali: il Parlamento, il
Capo dello Stato, il Governo, la Corte costituzionale. Essi
sono in posizione di parit e accomunati dai seguenti
elementi distintivi: trovano la loro disciplina (o comunque le
linee essenziali della stessa) direttamente nella Costituzione
(la legge, laddove presente, solo attuativa di norme costituzionali); sono collocati in unarea di controlli reciproci e di
reciproche interferenze (il Capo dello Stato eletto dal
Parlamento, pu essere messo in stato daccusa dallo stesso
e a sua volta pu sciogliere una o entrambe le Camere;
altrettanto dicasi per i rapporti tra Capo dello Stato e
Governo, come delimitati dalla controfirma); godono di
un potere di autoregolamentazione (da qui i regolamenti
parlamentari; il regolamento della Corte; il regolamento
della Presidenza della Repubblica; e, nei limiti della riserva
di legge di cui allart. 95 cost., un potere di auto-organizzazione del Governo); operano essi stessi la verifica dei poteri
dei loro componenti (cos per Parlamento e Corte costituzionale); in alcuni casi godono di auto-dichia (Parlamento e
forse Corte costituzionale e Presidenza della Repubblica); i
titolari degli stessi godono di variegate prerogative volte a
garantire la loro autonomia, fino a giungere alla sottrazione
a talune regole di diritto comune. Nonostante il tema sia
stato ampiamente dibattuto a proposito del regime degli atti,
se da sottoporre o meno a rimedi giurisdizionali (v. E. CHELI,
Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale, in
Arch. giur., 1965, 62 ss.), nonostante lart. 289 c.p. (anche
dopo la modifica introdotta con la l. 24 febbraio 2006, n. 85)
non lo inserisca fra gli organi costituzionali, rimane incerta la
natura del Consiglio superiore della magistratura. organo
costituzionale o soltanto organo di rilevanza costituzionale?
Mancando una testuale definizione di organo costituzionale, a differenza di quanto previsto in altre Costituzioni,
una qualificazione in tal senso potrebbe essere attribuita agli
organi che marcano lidentit della forma di Stato, e che
quindi traggono la loro legittimazione direttamente dalla
Costituzione. Modificando sensibilmente i poteri o le auto-
271
Costituzione della Repubblica italiana
disposizioni, costituzionali ed ordinarie, che fanno
riferimento generico alla Costituzione lattentato alla Costituzione nellart. 90 cost., la fedelt
alla Repubblica negli art. 54 e 91 cost. (33) od
operano un testuale riferimento allordine costituzionale (34). appena il caso di accennare che
lordine costituzionale, in quanto riferito ai principi supremi della Costituzione, pu spingere ulteriormente ai margini, ridimensionandone il significato (35), quell ordine pubblico costituzionale riferito alla pacifica convivenza e ai
nomie di questi organi si modificano, infatti, i connotati
dellordinamento costituzionale. E proprio per questo il
riferimento allordine costituzionale pu essere utile sia al
fine di distinguerli dagli organi a mera rilevanza costituzionale sia al fine di metterne a fuoco poteri, autonomie e
prerogative. Tornando al Consiglio superiore della magistratura, la risposta non semplice. Le non infrequenti puntate
polemiche nei confronti di tale organo e alcuni propositi di
drastiche riforme non possono comunque mettere in dubbio
che la sua presenza e i suoi poteri (per larga parte se non
tutti) sono un elemento di identit della Costituzione perch
direttamente collegati alla garanzia di autogoverno e di
autonomia del potere giudiziario. Non crediamo, al contrario per limitarci ad un facile esempio , che le norme
costituzionali che prevedono il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL) siano ritenute dalle forze politiche
che si riconoscono nella Costituzione pur da quelle restie
ad innovare talmente espressive di principi supremi da
ritenere compromessa dalla sua soppressione la stessa identit dellordinamento costituzionale.
(33) Per tali riferimenti v. L. MAZZAROLLI, in Commentario breve alla Costituzione a cura di S. BARTOLE e R. BIN,
Cedam, Padova, 2008, sub art. 90; ID., ivi, sub art. 54; R. DI
CESARE, ivi, sub art. 91; v. anche G. RAGNO, I delitti di alto
tradimento e attentato alla costituzione, Giuffr, Milano,
1974. Il dovere di fedelt come riconoscimento del nucleo
duro della Costituzione in A. MORELLI, I paradossi della
fedelt alla Repubblica, Giuffr, Milano, 2013, 226 ss.
(34) Lespressione ordinamento costituzionale
usata in modo contorto dallart. 11 l. 29 maggio 1982, n. 304,
Misure per la difesa dellordinamento costituzionale laddove si riferisce ai reati di eversione dellordine democratico
(cos E. GALLO e E. MUSCO, I delitti contro lordine costituzionale, Patron, Bologna, 1984), e quindi ai reati previsti
dagli art. 270, 270-bis, 304, 305 e 306 c.p., mentre lespressione ordine costituzionale adottata dapprima da C.
cost. 24 maggio 1977, n. 86, poi assunta dallart. 12 l. 24
ottobre 1977, n. 801 e trasfusa infine nellart. 39 l. 3 agosto
2007, n. 124, nelle parti relative ai servizi di sicurezza e al
segreto di Stato.
Va segnalata, sotto questo profilo, la tesi di Alessandro
Pace secondo cui detta espressione, facendo appunto riferimento a un ordine costituzionale, riferita ai principi supremi della Costituzione, e perci riguarda non solo le
istituzioni repubblicane ma tutti i valori dello Stato-comunit, in particolare i diritti della persona: A. PACE, I fatti
eversivi dellordine costituzionale nella legge 801 del 1977 e
nella legge 124 del 2007, in Scritti in onore di Lorenza
Carlassare, III, Jovene, Napoli, 2009, 1099 ss. Espressioni
analoghe sono presenti in altri ordinamenti, per esempio
negli art. 274 e 275 del codice penale svizzero oppure nella
giurisprudenza tedesca relativa al Wertsystem che i partiti
politici sono tenuti a rispettare.
(35) A. PACE e M. MANETTI, La libert di manifestazione
272
principi della vigente legislazione con il
quale la Corte, troppo attenta ai timorosi e
timorati esaltatori della sicurezza , tent anni fa
di giustificare taluni limiti alla libert di manifestazione del pensiero (36).
Il ricorso a tale criterio euristico potr spiegare, tra laltro, come possano darsi Paesi che
abbiano mutato il proprio ordinamento costituzionale pur mantenendo la medesima Carta costituzionale per esempio gli USA abolendo la schiavit con il XIII emendamento (37) e Paesi che
abbiano mantenuto il medesimo ordinamento codel proprio pensiero, in Commentario della Costituzione fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Rapporti
civili (Art. 21), Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma,
2006, 226 ss.
(36) Lespressione di C. ESPOSITO, La libert di manifestazione del pensiero e lordine pubblico, in Giur. cost.,
1962, 196, a proposito di C. cost. 16 marzo 1962, n. 19, che
andava al di l della tutela dellordine pubblico in senso
materiale (ma ripresa nella motivazione in C. cost. 8 luglio
1971, n. 168, su cui v. A. PACE, Il concetto di ordine pubblico
nella Costituzione italiana, in Arch. giur., 1963, 111 ss.;
nonch L. PALADIN, Ordine pubblico, in Nss. D.I., XII, 1965,
ad vocem).
(37) I ventisette emendamenti approvati dal 1791 in poi
hanno modificato numerose disposizioni del testo costituzionale ma solo pochi di essi hanno effettivamente inciso
sullidentit dellordinamento costituzionale; hanno invece
inciso sullo stesso gli emendamenti XIII, XIV, XV che tra il
1865 e il 1870 hanno, rispettivamente, abolito la schiavit,
esteso il due process of law nei confronti degli Stati e
riconosciuto il diritto di voto alla popolazione di colore. Solo
formalmente si sono limitati ad emendare un testo ma,
individuando amici e nemici, hanno ristrutturato in
profondit lordinamento costituzionale. Tra laltro quegli
emendamenti ebbero come effetto anche il rafforzamento
del governo centrale: cos R. WIEBE, La democrazia americana, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2009, 134; C. BOLOGNA,
Stato federale e national interest . Le istanze unitarie nellesperienza statunitense, Bononia University Press, Bologna,
2010, 76-86; v. anche per il tema dello schiavismo L.M.
BASSANI, Dalla rivoluzione alla guerra civile. Federalismo e
stato moderno in America 1776-1865, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2009, 240 ss.
un tema presente nella letteratura americana, anche se
rifiutato dalle pervicaci posizioni originalist: come stato
efficacemente sostenuto da Bruce Ackerman, il We the
people , con cui si apre la Costituzione americana, esprime
un governo e fonda una nazione prima ancora che un
governo limitato. Ed alla evoluzione dellordinamento
costituzionale concorrono sia le istituzioni politiche che
quelle giudiziarie: anzi, queste ultime intervengono, come fu
nel caso Brown v. Board of Education (1954), allorch le
istituzioni politiche (la Presidenza secondo Ackerman)
hanno potuto imprimere alla societ (o hanno tratto dalla
stessa) il necessario impulso politico. un constitutional
regime che si stabilizza, anche attraverso leggi del Congresso ( framework statutes o landmark statutes ), in
particolari constitutional moments ; momenti della storia
che hanno valenza, sostanzialmente anche se non formalmente, costituente: v. B. ACKERMAN, We The People, III. The
Civil Rights Revolution, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2014, 229 ss. (su cui v. la discussione
apertasi in Quaderni costituzionali, 2014, 963 ss., introdotta
Costituzione della Repubblica italiana
stituzionale pur avendo adottato una nuova Carta
costituzionale per esempio la Svizzera con la
revisione totale del 1999 (38) . Non tutte le
norme di una Carta costituzionale sono espressive
dellordine costituzionale, come identificato dai
principi fondamentali, mentre possono esserlo, in
modo talvolta non meno significativo, norme di
leggi ordinarie o di regolamenti parlamentari, od
anche norme di altri ordinamenti in vario modo
recepite nello spazio giuridico interno. Non
infrequente, infatti, la presenza nelle Costituzioni
di norme che hanno la forma delle disposizioni
costituzionali ma la sostanza (assiologica) di disposizioni ordinarie. Potrebbero trarsi esempi da varie
Costituzioni infarcite di norme minute e poco
caratterizzanti ma, senza andare lontano, potrebbe
ricordarsi che non tutti i 139 articoli della Carta
costituzionale rappresentano il fondamento su cui
si regge lordinamento italiano. Vi sono norme la
cui eventuale abrogazione che comunque deve
sempre seguire le procedure aggravate non
eliminerebbe alcuno dei pilastri su cui si regge
ledificio costituzionale. Proviamo a fare un esempio specifico: nel 1963 (l. cost. 27 dicembre 1963,
n. 3) stato modificato lart. 56 cost. introducendo
un numero fisso di parlamentari (prima era variabile, rapportato alla popolazione). Questa modifica non ha scalfito lidentit del nostro ordinamento; cos non sarebbe stato se si fosse soppressa
lautonomia del Parlamento o si fosse introdotto
un vincolo di mandato per i parlamentari.
I soggetti che costituiscono il lato materiale
della Costituzione, i cui valori condizionano la lettura della stessa, sono rappresentati, lo ricordavamo prima, da quelle forze politiche, sociali e
culturali che sono egemoni nella societ, ma fra essi
vanno ovviamente ricompresi lo accennavamo
prima anche i giudici ed il ceto dei giuristi, parte
decisiva ma non esclusiva della comunit degli
interpreti (39). Se negli anni Cinquanta, e nei
da una nota dello stesso Ackerman, con interventi di E.
Balboni, C. Bologna, M. Goldoni), ma v. anche ID., op. cit.,
I. Foundations, 1991, 59 ss.
(38) La revisione totale disciplinata dallart. 193 della
Costituzione ed ivi espressamente sancito che non vi sono
limiti alla stessa, se non quelli derivanti dal diritto internazionale: v. G. FRANCIOSI, Revisione della Costituzione svizzera
e forma di Stato, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, 837 ss.; M.P.
VIVIANI SCHLEIN, La nuova Costituzione Svizzera: una soluzione originale, ivi, 499 ss.; A. REPOSO, Saggio introduttivo
sulla nuova Costituzione svizzera, in Dir. soc., 1999, 609 ss.
(39) Oggi vanno considerati pi i giudici che il ceto dei
giuristi accademici, a differenza dei decenni scorsi in cui
invece i primi apparivano subalterni allAccademia, secondo
uno stile che fu definito italiano (che si esprimeva, tra
laltro, attraverso ampie citazioni nelle sentenze pi della
primi anni Sessanta, essi hanno contribuito ad una
lettura della Costituzione di segno conservatore,
nei decenni successivi hanno invece contribuito ad
una lettura di segno opposto (40). Il testo costituzionale rimasto lo stesso, sia quando la Corte
costituzionale, nel 1961, riconosceva legittimo che
il codice penale punisse il solo adulterio femminile (41), sia qualche anno dopo, nel 1968 (42),
quando essa, mutando giurisprudenza, ha ribaltato
la decisione precedente. Nella sentenza del 1961 la
Corte si era richiamata all ambiente sociale e
alla comune opinione per giustificare la scelta
del legislatore di ritenere maggiormente grave il
comportamento della donna di concedere i suoi
amplessi ad un estraneo (43), mentre nella sentenza del 1968 il riferimento sia alla mutata realt
sociale sia alla nuova e diversa coscienza
collettiva serve per giungere alla soluzione opposta. Similmente in quegli anni muta la giurisprudenza della Corte a proposito della legittimit costituzionale dellart. 553 c.p., che prevedeva il reato
di incitamento a pratiche anticoncezionali , ritenuto legittimo in una sentenza del 1965 (44),
poi dichiarato illegittimo con una sentenza del
dottrina che dei precedenti giudiziari): v. J.H. MERRYMANN,
Lo stile italiano: linterpretazione, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1968, 378). La comunit degli interpreti la nota categoria
di Peter HBERLE elaborata fin dal 1975 in Die oeffene
Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, in JZ, 1975, 297 ss.,
e ripresa in ID., Le libert fondamentali nello Stato costituzionale, cit., 175 ss.
(40) Basta fare riferimento a due volumi, editi in periodo diverso, a pochi anni di distanza, che sottolineano
questa evoluzione: A. BATTAGLIA, I giudici e la politica, Laterza, Bari, 1962 e E. MORIONDO, Lideologia della magistratura italiana, Laterza, Bari, 1967; v. anche G. TARELLO,
Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista-interprete, in Pol. dir., 1972, 474,
ora in Luso alternativo del diritto a cura di P. BARCELLONA
(Atti dellIncontro di studio, Catania, 15-17 maggio 1972), I,
Laterza, Roma-Bari, 1973, 61 ss. La funzione dei giudici
come parte determinante nella lettura della Costituzione
approfondita in altre letterature pi di quanto non avvenga
nel nostro Paese: un quadro in R. TREVES, Sociologia del
diritto, Einaudi, Torino, 1988, 244 ss.
(41) C. cost. 28 novembre 1961, n. 64.
(42) C. cost. 19 dicembre 1968, n. 126.
(43) Ritenendo tuttavia che una condizione di eguaglianza si recuperava comunque nel pari trattamento nella
riduzione di pena prevista dallart. 587 (sic!), sia a favore
della moglie tradita che del marito tradito. Resta impregiudicata, aggiungeva la Corte, con un certo pudore, ogni
valutazione circa laccettabilit o meno dei criteri che hanno
ispirato la norma . Nel commento, C. ESPOSITO, Sulla punizione del solo adulterio femminile, in Giur. cost., 1961, 1230,
aderisce alla soluzione adottata dalla Corte ma critica liter
logico seguito ritenendo di dovere maggiormente mettere in
risalto il valore dellunit della famiglia, previsto dallart. 29
cost.
(44) C. cost. 19 febbraio 1965, n. 9.
273
Costituzione della Repubblica italiana
1971 (45). Il testo costituzionale non era cambiato:
era cambiato, invece, il lato materiale dellordinamento costituzionale; erano cambiati i valori egemoni nella societ, a partire dalla stessa cultura
politica delle Magistrature. La prima sentenza della
Corte sulladulterio si inseriva in quello stesso clima
che portava i giudici ordinari ad applicare, senza
sollevare dubbi di legittimit, contratti di lavoro
con la clausola di nubilato o ad assolvere imputati
di violenza sessuale in presenza di un matrimonio
riparatore o a concedere le attenuanti per il cosiddetto delitto donore o a disporre provvedimenti
nei confronti degli studenti del Liceo Parini di
Milano per la pubblicazione de La Zanzara. Tra le
une e le altre decisioni aveva operato da presumere il clima rovente del 68. E come ha
potuto la Corte, in non molti anni, passare dalla
giustificazione di norme di favore verso la religione
cattolica in quanto religione della maggioranza
degli italiani alla dichiarazione di illegittimit
costituzionale delle stesse per violazione del principio di laicit (46)? Determinante noi crediamo
(45) C. cost. 16 marzo 1971, n. 49. Nella prima decisione la Corte giustific la norma adeguandola tuttavia ai
valori costituzionali, non pi quindi lincremento demografico ma il buon costume.
(46) In una prima fase la Corte costituzionale ha giustificato il diverso trattamento penale delle varie confessioni
religiose sulla base del maggior numero di aderenti alla
confessione cattolica e dellampiezza delle reazioni sociali
che si sarebbero quindi determinate per effetto delle offese
intervenute. Inoltre la Corte escludendo ci riferiamo a C.
cost. 30 novembre 1957, n. 125 che si potesse parlare di
parit fra le confessioni religiose, essendo prevista per la
Chiesa cattolica una disciplina concordataria non parificabile al regime delle intese, giungeva alla conclusione che la
maggiore tutela penale prevista per le offese al culto cattolico
non toccava il libero esercizio dei culti e la libert delle
varie confessioni . Non a caso sosteneva la Corte lart.
8 cost. parla non di eguaglianza ma di eguale libert (cos
anche C. cost. 30 dicembre 1958, n. 79, C. cost. 31 maggio
1965, n. 39, C. cost. 27 febbraio 1973, n. 14, e C. cost. 8
luglio 1975, n. 188).
Un primo segnale di cambiamento arriva da C. cost. 28
luglio 1988, n. 925, successiva alla revisione di Villa Madama. Nella motivazione la Corte afferma che la sola punizione della bestemmia contro la Divinit o i Simboli o le
Persone venerati nella religione dello Stato , prevista dallart. 724 c.p., non pu continuare a giustificarsi con la
appartenenza ad essa della quasi totalit dei cittadini italiani
e nemmeno con lesigenza di tutelare il sentimento religioso
della maggior parte della popolazione italiana . Il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica sola
religione dello Stato e gli altri culti, sancito dal punto 1 del
Protocollo del 1984, renderebbe ormai inaccettabile ogni
tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore
o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni
religiose (con C. cost. 18 ottobre 1995, n. 440, poi, la Corte
avrebbe dichiarato incostituzionale la disposizione nella
parte relativa alla espressione o i simboli o le persone
venerate nella religione dello Stato ). E solo nel 1989, con
274
stata sia la crescente secolarizzazione sia linfluenza della revisione dei Patti lateranensi, avvenuta nei medesimi anni Ottanta con gli accordi di
Villa Madama (1984), approvati a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano. Disposizioni materialmente costituzionali quelle di recepimento
degli accordi si sono incrociate con i mutamenti
della base materiale dellordinamento costituzionale e hanno portato ad una diversa lettura della
Carta costituzionale (47).
I riferimenti potrebbero continuare numerosi e
C. cost. 12 aprile 1989, n. 203, cit., compare fra i principi
supremi il principio di laicit (definitivamente sviluppato
da C. cost. 20 novembre 2000, n. 508). Con detta sentenza,
nellescludere la illegittimit costituzionale dellart. 9 l. 25
marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dellaccordo di
Villa Madama del 18 febbraio 1984), che prevede linsegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado ma facendo salva la facolt di non avvalersene da
parte degli alunni , la Corte afferma in modo netto: a) che
il principio di laicit, quale emerge dagli art. 2, 3, 7, 8, 19 e
20, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libert
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale ; b) la legittimit del riconoscimento del valore della
cultura religiosa riferita non ad una specifica religione ma
al pluralismo religioso della societ civile ; c) il riconoscimento del cristianesimo come parte del patrimonio storico
del popolo italiano ; d) che tali due principi, il valore della
cultura religiosa e il cristianesimo come parte del patrimonio
storico del popolo italiano, concorrono a descrivere lattitudine laica dello Stato-comunit, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti [...] ma si pone a servizio di
concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini . In C. cost. 25 maggio 1990, n. 259, sviluppando
quanto gi detto in C. cost. 30 luglio 1984, n. 239, la Corte
torner sul principio di laicit dichiarando la illegittimit di
taluni articoli del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 che, prevedendo la natura pubblicistica delle comunit israelitiche,
realizzavano una forma di ingerenza contrastante (come
una sorta di costituzione civile ) con il principio di
laicit. In C. cost. 27 aprile 1993, n. 195, nel dichiarare
illegittima una legge della Regione Abruzzo che aveva previsto alcune agevolazioni urbanistiche solo per i culti con cui lo
Stato avesse stabilito unintesa, aveva definito il principio di
laicit (richiamandosi a C. cost. 12 aprile 1989, n. 203, cit.)
principio supremo [...] uno dei profili della forma di Stato
delineata nella Carta Costituzionale della Repubblica .
(47) La revisione intervenuta nel 1984 con gli accordi di
Villa Madama fra il Governo Craxi e la Santa Sede (trasfusi
nelle l. n. 121 del 1985, 20 maggio 1985, n. 206 e n. 222) ha
modificato sensibilmente il contenuto del Concordato evitando le norme in pi stridente contrasto con i principi
costituzionali, ma rimane la posizione di privilegio per la
Confessione cattolica. Prima ancora la Corte (cfr. C. cost. 1o
marzo 1971, n. 30, cit., nonch C. cost. 1o marzo 1971, n. 31
e n. 32; C. cost. 2 febbraio 1972, n. 12, cit., e C. cost. 29
dicembre 1972, n. 195; C. cost. 11 dicembre 1973, n. 175,
cit.; C. cost. 5 gennaio 1977, n. 1, cit.; C. cost. 2 febbraio
1982, n. 16 e n. 17, nonch C. cost. 2 febbraio 1982, n. 18,
cit.) era riuscita a stabilire il principio che le disposizioni del
Concordato non sono state costituzionalizzate e non si sottraggono, come gi accennato, allaccertamento della loro
conformit ai principi supremi dellordinamento costituzionale (anche se solo con C. cost. 2 febbraio 1982, n. 18, cit.
Costituzione della Repubblica italiana
riguardare sia diverse fattispecie aperte, sia diversi concetti giuridici indeterminati, sia diverse
clausole generali previste in varie parti del testo
costituzionale; tra essi il buon costume (art.
21), i fini sociali o le clausole di utilit generale o sociale (art. 41, 42, 43). Ci limitiamo a
ricordare il percorso interpretativo, su cui torneremo pi avanti, dellart. 2 cost. (v. infra, 21). Per
anni la Corte costituzionale ha ritenuto che esso
fosse una norma meramente riepilogativa degli
articoli che esplicitamente tutelano, dallart. 13 in
poi, le libert costituzionali; dalla met degli anni
Ottanta ha sempre pi rinvenuto in esso le basi
normative per riconoscere alcuni diritti fondamentali non espressamente inseriti nel testo costituzionale facendo non poche volte riferimento (talora
in modo apodittico) alla coscienza sociale o
alle convinzioni collettive : non crediamo che
sia arbitrario ritenere che intendesse far riferimento ai fini e ai valori prevalenti nelle (e grazie
alle) forze politiche, sociali e culturali che hanno
dato vita o che sostengono la Costituzione, in
grado di spingere a specificare la fattispecie a
schema aperto ivi custodita.
Torneremo pi avanti sullincidenza dei vincoli
europei su parti importanti dellordinamento costituzionale (v. infra, 25), frutto per anni dellattivit della Corte in dialogo (talvolta teso) con la
Corte di giustizia, fino alla sentenza del 1984 che
ha sancito il primato del diritto europeo (48). Si
trattato di una lettura ardita e non formale dellart.
11 cost. oppure di una rottura della Costituzione? In ogni caso, come stato possibile tutto
ci? Una cos impegnativa operazione ricostruttiva
ha potuto trovare la sua spinta noi crediamo
nella opzione europeistica promossa (o progressivamente accettata) dalle forze politiche, sociali e
si era dichiarata illegittima un norma concordataria che
prevedeva il riconoscimento civile dei provvedimenti pontifici per i matrimoni non consumati). Un posizione intermedia fra la tesi (della Cassazione: Cass. 23 ottobre 1964, n.
2651) della costituzionalizzazione del Concordato rectius
della l. 27 maggio 1929, n. 810, che al Concordato aveva
dato esecuzione nellordinamento interno e quella della
sua subordinazione a tutte le norme costituzionali. Successivamente alla revisione del 1984, C. cost. 12 aprile 1989, n.
203, cit., C. cost. 14 gennaio 1991, n. 13, C. cost. 5 maggio
1995, n. 149, C. cost. 8 ottobre 1996, n. 334 e C. cost. 14
novembre 1997, n. 329, suscitando qualche critica, hanno
esteso anche alle norme attuative degli accordi di revisione le
garanzie previste per le leggi di attuazione dei Patti del 1929.
Ne parliamo diffusamente in A. BARBERA, Il cammino della
laicit, in Laicit e diritto a cura di S. CANESTRARI, Bononia
University Press, Bologna, 2007, 33 ss. (anche in Forum di
Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, sub
Paper ).
(48) C. cost. 8 giugno 1984, n. 170, cit.
culturali che sostengono la Costituzione repubblicana. Esse dagli anni Settanta in poi, alcune
correggendo (la sinistra e le destre) precedenti
posizioni decisamente contrarie hanno visto
(hanno voluto vedere) nella scelta europeistica la
continuit, non la rottura, con le iniziali scelte
costituenti e hanno sostenuto o accettato un cos
impegnativo orientamento della Corte costituzionale.
Fare riferimento anche alle basi materiali di un
ordinamento costituzionale significa dunque riferirsi alle basi politiche, sociali e culturali di esso
ma andando, beninteso, oltre le forze politiche che
hanno dato inizialmente vita al testo costituzionale. Quelle forze politiche, guardando al caso
dellItalia, sono ormai scomparse dalla vita politica
e costituzionale; ci non esclude, tuttavia, che un
ordine costituzionale vi sia. Esso, come rappresenteremo nelle prossime pagine, lega ancora insieme, con un plebiscito quotidiano, la comunit
politica. Ci fu ben sottolineato da Ugo Rescigno:
la Costituzione non vige perch fu voluta, ma
perch oggi voluta (49).
5. La Carta costituzionale e il contesto normativo. Il concetto qui accolto di ordinamento
costituzionale non distante dallidea di Costituzione vivente, ma non vanno sottovalutate le
differenze. Questultima serve a registrare come
del resto la pi ampia categoria del diritto vivente quale linterpretazione che di un determinato testo costituzionale stata data nella
prassi, in particolare per opera delle Corti. Il
punto di partenza , appunto, esclusivamente il
testo, ri-letto alla luce della sua concreta applicazione. la law in action che supera, grazie al
metodo casistico, la law in the books, grazie al
judge made law (50). Nella prospettiva qui considerata, invece, il testo della Costituzione collo(49) G.U. RESCIGNO, Costituzione italiana e Stato borghese, Savelli, Roma, 1975, 156.
(50) Usiamo lespressione vivente nellaccezione utilizzata da E. EHRLICH, I fondamenti della sociologia del diritto,
trad. it., Giuffr, Milano, 1976 (ma avvertendo che Ehrlich,
che tra i primi propose la nozione, pensava soprattutto ai
comportamenti sociali). La tesi della Costituzione vivente,
ma con un significato pi ristretto, adottata da BARTOLE, La
Costituzione di tutti, cit., 163 ss., e pi in generale da A.
PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalit e diritto vivente,
Giuffr, Milano, 1994, 17 ss.
Nella letteratura americana, in particolare, la living Constitution richiamata da quanti non intendono fermarsi
alloriginal intent e incoraggiano il judicial activism della
Corte Suprema: v. G. GORLA, Diritto comparato, in questa
Enciclopedia, XII, 1964, 938. Per il dibattito negli USA sulla
living Constitution v. L.H. TRIBE e M.C. DORF, Leggere la
Costituzione. Una lezione americana, trad. it., Il Mulino,
275
Costituzione della Repubblica italiana
cato allinterno dellordinamento costituzionale, in
una relazione sistemica sia con i valori di cui si
fanno portatori i soggetti che compongono la base
materiale dellordinamento sia con i testi normativi materialmente (anche se non formalmente)
costituzionali.
al contesto normativo della Carta costituzionale che va dunque dato adeguato rilievo. Accanto ad essa vanno ricomprese noi crediamo
anche quelle altre fonti normative che, ad
integrazione della stessa, caratterizzano la forma di
Stato, marcandone lidentit, e tracciano le linee di
sviluppo dellintero ordinamento giuridico, contribuendo a costruire, in breve, quello che abbiamo
chiamato lordinamento costituzionale. Vediamo quali.
Concorrono certamente a questo risultato le
(poche) consuetudini costituzionali e le altre
leggi costituzionali: lo diciamo rapidamente ma
non ignoriamo che il livello costituzionale [...]
racchiude pi livelli (51). A queste vanno aggiunte norme che pur non formalmente costituzionali hanno tuttavia un contenuto costituzionalmente rilevante, come talune leggi cui la stessa
Costituzione rinvia (ad esempio nellart. 75
comma ult. sulle modalit attuative del referendum
o nellart. 137 comma 2 sul funzionamento della
Corte costituzionale). Vanno aggiunte, inoltre, le
norme contenute nelle pre-leggi al codice civile, in
particolare le norme sullinterpretazione o quelle
sulla successione delle leggi nel tempo (art. 10-15
disp. prel.). Gi prima della Costituzione del 1948
si era ritenuto che le leggi che dispongono su altre
leggi, anche sulla loro lettura, avessero natura
materialmente costituzionale (52). Il testo costituzionale e la prassi legislativa e giurisprudenziale ne
hanno certamente ridimensionato contenuto e significato ma non ne hanno escluso il carattere di
norme atte a comporre lordinamento costituzionale.
Possono essere collocate nel perimetro dellordinamento costituzionale ma torneremo sul
Bologna, 2005, 45 ss.; C.R. SUNSTEIN, A cosa servono le
costituzioni, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2009, passim.
(51) MODUGNO, Fonti del diritto (gerarchia delle), cit.,
572. Hanno perso attualit, invece, i problemi che avevano
affaticato la dottrina circa la natura delle leggi costituzionali cui rinvia la XVI disp. trans. della Costituzione.
(52) Gi cos F. PIERANDREI, Linterpretazione della Costituzione, in Studi di diritto costituzionale in memoria di
Luigi Rossi, Giuffr, Milano, 1952, 470-471 ed ivi citati
Mortati, Scialoja, Donati; v. anche V. CRISAFULLI, I principi
costituzionali dellinterpretazione, in Scritti giuridici in onore
di Santi Romano, I, Cedam, Padova, 1939, 680 ss.; ed ora G.
ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Il Mulino, Bologna,
2008, 264.
276
punto infra, 25 anche le norme prodotte
mediante il recepimento con legge (ordinaria) dei
Trattati che legano lItalia allUnione europea.
Sono norme che in vario modo incidono sullassetto costituzionale, fino al punto di recepire il
primato del diritto europeo e di produrre importanti deroghe perfino al testo costituzionale. Di
pi: in un ordinamento che annovera fra i principi supremi i diritti inviolabili non possono essere escluse dallordinamento costituzionale le
norme prodotte mediante il recepimento nel nostro ordinamento di importanti dichiarazioni di
diritti, e in particolare della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti delluomo del 4
novembre 1950 (l. 4 agosto 1955, n. 848). La Corte
costituzionale, dopo avere per anni negato alle
stesse una particolare posizione nel sistema delle
fonti (53), successivamente, a partire dalle note
sentenze gemelle del 2007 (54), ha riconosciuto
ad esse la capacit di integrare i parametri costituzionali, colmando un vuoto (55), o attraverso un
rinvio mobile del diritto interno alle norme pattizie (56) o considerandole norme interposte
rispetto al comma 1 dello stesso art. 117 cost. (57),
e quindi di natura sub-costituzionale , fermo
restando, in ogni caso, il bilanciamento con altri
interessi costituzionalmente protetti (58). Tali innovazioni non sono state finora estese alle norme
(ex l. 25 ottobre 1977, n. 881) che hanno dato
esecuzione ai Patti per i diritti civili, politici, sociali, economici e culturali del 16 dicembre 1966;
ma lo ha fatto una pronuncia del 2013 in riferimento alla Convenzione internazionale sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
(53) Salvo lisolato obiter dictum di C. cost. 19 gennaio
1993, n. 10.
(54) C. cost. 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349.
(55) C. cost. 26 novembre 2009, n. 311.
(56) C. cost. 4 dicembre 2009, n. 317.
(57) C. cost. 12 marzo 2010, n. 93.
(58) C. cost. 30 aprile 2008, n. 129. Sul punto D. TEGA,
Le Sentenze della Corte costituzionale 348 e 349 del 2007: la
Cedu da fonte ordinaria a fonte sub-costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2008, 133 ss.; v. anche ID., Lordinamento costituzionale italiano e il sistema CEDU: accordi e
disaccordi, in La Convenzione europea dei diritti delluomo
nellordinamento penale italiano a cura di V. MANES e V.
ZAGREBELSKY, Giuffr, Milano, 2011, 193 ss. Contesta la
natura subcostituzionale di detta normativa Antonio Ruggeri, ma sulla base di una visione complessiva che lo porta a
intravedere un assetto intercostituzionale di tutte le fonti,
italiane ed europee; la tesi stata esposta in varie sedi: fra gli
ultimi scritti cfr. A. RUGGERI, Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri costituzionali in un ordinamento intercostituzionale, ora in ID., Itinerari di una ricerca sul sistema
delle fonti, XVII. Studi dellanno 2013, Giappichelli, Torino,
2014, 320 ss.
Costituzione della Repubblica italiana
resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n.
176 (59).
Da prendere parimenti in considerazione, ai
medesimi fini, quei principi dei regolamenti parlamentari che condizionano fortemente il sistema
delle fonti normative e la stessa forma di governo
(non a caso nel Regno Unito sono, assieme alle
Conventions, la pi importante fonte del diritto
costituzionale). Questultima ha oscillato in Italia
fra due poli, entrambi parlamentari ma uno di tipo
assembleare, laltro di gabinetto. A caratterizzare la nostra forma di governo nelluna o nellaltra direzione (torneremo sul punto infra, 15)
hanno concorso, o concorrono, oltre alle sottostanti vicende politico-istituzionali, anche le
norme dei regolamenti parlamentari: lo mise in
rilievo fin dagli anni Cinquanta la prevalente dottrina (60) mentre pi recentemente la Corte costituzionale mette decisamente in rilievo la funzione
integrativa dei regolamenti degli organi costituzionali (61). Si pensi, ad esempio, alle norme
relative alla incidenza del Governo sulla formazione dellordine del giorno delle Assemblee; alla
incidenza dello stesso sulla disciplina delliter dei
(59) C. cost. 23 gennaio 2013, n. 7. Nel novellato art.
117 cost. si fatto riferimento al vincolo degli obblighi
internazionali; introdotto dalla riforma del Titolo V (con l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3) questo vincolo pu riguardare
ogni tipo di accordo internazionale, anche quelli, ad esempio, di tipo commerciale o addirittura sottoscritti al di fuori
dei casi previsti dallart. 80 cost.? La Corte non lo dice; vi
solo una affermazione molto generica in C. cost. 26 novembre 2009, n. 311, cit., laddove si asserisce che il nuovo art.
117 ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme
che a livello costituzionale garantiscono losservanza degli
obblighi internazionali pattizi . Lapertura rischia di essere
troppo ampia; la risposta, a nostro avviso, non potr che
essere collegata a determinati principi costituzionali, allorch concorrano, ad esempio, a integrare, collegandosi al
valore supremo della persona, la fattispecie a schema
aperto dellart. 2 cost. (come da tempo da noi sostenuto
anche in epoca precedente alla riforma del Titolo V: v. A.
BARBERA, in Commentario della Costituzione fondato da
BRANCA, cit., Diritti fondamentali (Art. 1-12), 1975, sub art. 2;
contrario invece A. PACE, Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quaderni costituzionali, 2001, 35 ss.). Da sottolineare che non possono venire in aiuto i lavori preparatori
data la attenzione assai distratta e frettolosa che le Camere
dedicarono a quella riforma, e a quel limite in particolare (il
Senato si limit a ratificare il testo pervenuto dalla Camera).
(60) S. TOSI, Modificazioni tacite della Costituzione attraverso il diritto parlamentare, Giuffr, Milano, 1959. Pi di
recente v. S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della
Costituzione repubblicana, Il Mulino, Bologna, 2004, 220 ss.,
che a questo proposito parla di uso conformativo dei
regolamenti parlamentari; C. DE CESARE, Le modificazioni
tacite della Costituzione nellattuale sistema parlamentare
italiano, in Rass. parl., 2010, 121 ss. (anche in I mutamenti
della forma di governo tra modificazioni tacite e progetti di
riforma a cura di M. SICLARI, Aracne, Roma, 2010).
(61) C. cost. 15 gennaio 2013, n. 1.
disegni di legge, ivi compresa la possibile posizione della questione di fiducia. Non a caso la
battaglia, che ha attraversato quasi tutti gli anni
Ottanta, per lintroduzione del voto palese nelle
deliberazioni parlamentari di spesa ebbe il tono
(acceso) di una importante riforma materialmente
costituzionale (62).
Fin qui siamo rimasti nellambito di norme
relative a fonti (anche se non tutte norme sulle
fonti) ma invitiamo ad una riflessione: allordinamento costituzionale concorrono anche quelle
norme delle leggi elettorali che caratterizzano e
condizionano la forma di governo? Abbiamo lasciato per ultimo questa categoria per una obbiettiva incertezza; ma anche qui propendiamo per
una risposta affermativa. Cos stato, a noi pare,
per la legge proporzionale, dal 1948 in poi, e cos
per le leggi a base o effetto maggioritario, dal 1993
in poi. Tutte leggi ordinarie, ma con contenuti ed
effetti materialmente costituzionali. E ci, sia per
la loro incidenza sulla forma di governo sia per la
loro attitudine a configurare per i cittadini il
diritto politico di elettorato (o in termini di maggiore rappresentativit delle loro opzioni o in termini di maggiore incidenza del loro voto). privo
di senso parlare di seconda Repubblica non
essendo mutata la Costituzione, ma sarebbe infecondo formalismo non tenere conto dei riflessi che
quelle norme elettorali hanno avuto nel concreto
configurarsi della forma di governo non a caso
Carlo Mezzanotte intravvide bagliori costituenti nellesito del referendum elettorale del
1993 (63) . ben vero che le leggi elettorali
(62) illuminante al riguardo lesito negativo della
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (cosiddetta Commissione Bozzi, istituita nel 1983), che avrebbe
dovuto occuparsi, secondo il mandato ricevuto, solo di
riforme costituzionali ma che alla fine si incepp (almeno
questa fu la causa prossima) proprio per il tentativo di
introdurre il principio della prevalenza del voto palese per le
leggi di spesa, che alla opposizione dellepoca appariva tale
da sconvolgere consolidati equilibri costituzionali: v. C. FUSARO e S. CURRERI, Voto palese, voto segreto e forma di governo
in trasformazione, in Il Filangieri. Quaderno 2007, Jovene,
Napoli, 2008, 243-286; nonch C. FUSARO, Forma di governo
e principio maggioritario, in Scritti in onore di Aldo Bozzi,
Cedam, Padova, 1992, 223 ss. Sullimportanza che fu allora
assegnata al tema del voto palese v. Rodot abbandona la
commissione Bozzi, notizia pubblicata in La Repubblica, 16
novembre 1984, e la nostra opposta posizione in A. BARBERA,
Il voto segreto si pu attenuare, in Il Messaggero, 17 agosto
1985.
(63) C. MEZZANOTTE, Referendum e legislazione, Relazione al Convegno annuale dellAssociazione italiana dei
costituzionalisti su Democrazia maggioritaria e referendum (Siena, 3-4 novembre 1993), ripresa anche da A.
MORRONE, Il miracolo costituzionale, in www.confronticostituzionali.eu, 6 dicembre 2013.
277
Costituzione della Repubblica italiana
sono talvolta frutto di una decisione di maggioranza e che la condivisione stata massima per il
principio proporzionale, fino alla fine degli anni
Ottanta, e pi debole per il principio maggioritario dagli anni Novanta in poi, ma ci non esclude
la sostanza costituzionale dei principi in esse incorporati. Proprio richiamando le leggi elettorali
Giuseppe Floridia pur decisamente contrario a
teorie materiali della Costituzione distingueva
fra norme costituzionali per loggetto e norme
costituzionali per la forma (64). Teniamo a puntualizzare che, peraltro, se si dovesse giungere alla
conclusione che esse contribuiscono a delineare
lordinamento costituzionale non sarebbe comunque possibile trarne conseguenze in ordine alla
loro collocazione nel sistema delle fonti, come
invece si tent di fare anni fa, senza successo, per
le leggi elettorali proporzionali (65). invece possibile ci limitiamo ad un accenno trarne
conseguenze (come gi si fatto negli anni Novanta) in ordine allinterpretazione di norme costituzionali, volutamente elastiche, a fattispecie
aperta (66), relative alla formazione e alla vita dei
Governi, nonch in ordine alla lettura di talune
norme regolamentari (67). Pur cos diverse, le
leggi Mattarella (l. 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277)
e la legge Calderoli (l. 21 dicembre 2005, n. 270)
avevano in comune lobbiettivo di dare vita a
Governi di investitura: e di questo si tenne
conto, ad esempio, nelle consultazioni in vista
della nomina dei Presidenti del Consiglio operate
dai Presidenti Scalfaro, Ciampi e Napolitano.
significativo che la stessa Corte costituzionale si sia
spinta fino al punto di considerare incostituzionale
non solo la assenza di una soglia per il conseguimento del premio ma anche la asimmetria fra i due
(64) G. FLORIDIA, Quest-ce que... la Constitution?
(1992), ora in ID., Scritti minori raccolti da F. SORRENTINO,
Giappichelli, Torino, 2008, 8-9 (ivi, 13-14, i motivi della sua
contrariet alla teoria della costituzione materiale); analogamente gi G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale,
Giuffr, Milano, 1953, 130 ss.
(65) C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione,
in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 849 ss., su cui rinviamo a A.
BARBERA, Sistemi elettorali e forma di governo in Carlo Lavagna, in Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna a cura di F.
LANCHESTER, Giuffr, Milano, 1996, 245 ss.
(66) L. ELIA, Governo (forme di), in questa Enciclopedia,
XIX, 1970, 640.
(67) La letteratura sul punto ormai molto vasta: da
ultimo v. i vari contributi raccolti in I regolamenti parlamentari a quarantanni dal 1971 a cura di A. MANZELLA, Il
Mulino, Bologna, 2012; La riforma dei regolamenti parlamentari al banco di prova della XVI legislatura a cura di E.
GIANFRANCESCO e N. LUPO, LUISS University Press, Roma,
2009; Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme
dei regolamenti delle Camere a cura di V. LIPPOLIS, in Fil.,
2007.
278
sistemi elettorali di Camera e Senato, previsti dalla
legge impugnata, per i possibili riflessi negativi
lo sottolinea espressamente la Corte sulla investitura e sulla stabilit dei Governi (68). Ma
questa ecco il punto era una asimmetria che
lAssemblea costituente aveva invece volutamente
perseguito, sia sfalsando la durata di Camera e
Senato, sia prevedendo due elettorati non coincidenti, sia approvando essa stessa, prima della sua
chiusura, due sistemi elettorali diversi per luna e
per laltro. In poche parole: la sentenza rilegge il
modello costituzionale del bicameralismo alla luce
degli obbiettivi perseguiti in questi ultimi anni
dalle leggi elettorali, superando nettamente lintento originario del Costituente. E questo vale per
tutte le disposizioni che compongono lordinamento costituzionale: rimane ferma la loro collocazione, per la forma, nella tradizionale gerarchia delle fonti, ma esse possono assumere una
diversa lettura (se non diverso valore) nella dinamica costituzionale.
Il ricorso al concetto di ordinamento costituzionale, come parte del pi ampio ordinamento
giuridico, consente, tra laltro, di meglio comprendere il significato di quella oscura materia costituzionale cui si riferisce la tormentata norma
dellart. 72 cost. (69). Pu costituire la base su cui
costruire una tipologia di leggi organiche? Comprende o no, ad esempio, la legislazione sulla
cittadinanza, attesa la centralit del cittadino in
un sistema costituzionale imperniato sulla sovranit popolare (70)? Ma su questo tema pesano la
prassi parlamentare e la (anche se invecchiata)
pronuncia del 1963 che, giustificando la approvazione in Commissione della legge istitutiva del
Consiglio superiore della magistratura, legge di
indubbio rilievo costituzionale, ha favorito una
erratica prassi parlamentare (71).
6. Il sistema delle fonti. Parte essenziale
dellordinamento costituzionale , dunque, rappresentata dalla disciplina sulle fonti. La Costituzione aveva fortemente innovato il sistema delle
fonti normative rispetto alla tradizione liberale,
basata solo sulla legge e sui regolamenti (cui il
regime fascista aveva affiancato le fonti corpora(68) C. cost. 13 gennaio 2014, n. 1.
(69) Rinuncia a tale impresa CRISAFULLI, Costituzione,
cit., 1034, ma non mancano tesi favorevoli a criteri sostanziali (per esempio A. CERVATI, in Commentario della Costituzione fondato da BRANCA, cit., La formazione delle leggi, t.
1. Art. 70-74, 1985, sub art. 70-72).
(70) Pi ampiamente v. A. BARBERA, Popolo, in Dizionario di diritto pubblico diretto da CASSESE, cit., V, ad vocem.
(71) C. cost. 23 dicembre 1963, n. 168.
Costituzione della Repubblica italiana
tive). La rigidit costituzionale, il pluralismo istituzionale (di Regioni ed enti locali in particolare),
lautonomia degli organi costituzionali, lautonomia riconosciuta alle contrapposte organizzazioni
sindacali (attraverso i contratti collettivi erga omnes) e alle confessioni religiose (attraverso leggi
precedute da accordi concordatari o da intese),
lapertura alle consuetudini internazionali rappresentavano scelte destinate ad incidere sulla classica
gerarchia delle fonti, dando vita a specifiche
competenze legislative. Nonostante tale variet
di fonti, la centralit della legge e quindi del
potere legislativo non era messa in discussione
e ad essa e solo ad essa erano riservati non
pochi spazi di intervento: riserve assolute in
ordine ai diritti; riserve relative in ordine alla
organizzazione amministrativa; legislazione di
principio in ordine allattivit legislativa regionale.
Negli ultimi decenni questo quadro mutato
in pi direzioni e tende a sfuggire al modello
disegnato dalla Costituzione del 1948. Richiamiamo rapidamente le principali innovazioni: a) al
quadro costituzionale prima delineato si sono aggiunte le fonti europee (le cui norme vincolano
come interpretate nelle sentenze della Corte del
Lussemburgo, ormai equiparate a fonti); b) cresciuta anche per effetto della riforma del 2001
(l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) lincidenza delle
fonti internazionali pattizie o di fonti transnazionali di vario genere, anche qui per le norme della
Convenzione europea dei diritti delluomo come
individuate dalla Corte di Strasburgo (72); c)
venuta meno sempre in forza della stessa riforma che ha introdotto pure per le Regioni
ordinarie ambiti di legislazione riservata esclusivamente alle Regioni la preminenza della legge
statale come fonte generale di individuazione dei
principi fondamentali; d) la delegazione legislativa ha sempre pi assunto forme improprie: il suo
esercizio da un lato condizionato da anomali
pareri parlamentari (73) e dallaltro sottoposto a
termini surrettiziamente dilatati dalla sempre pi
frequente pratica dei decreti integrativi e correttivi (74); e) la crisi di funzionalit del Parlamento
(72) Pur con i fragili distinguo richiamati dalle sentenze
gemelle C. cost. 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, cit.
(73) Si parla infatti di codeterminazione parlamentare : v. S. TRAVERSA, Levoluzione della delega legislativa
nella codeterminazione parlamentare dei contenuti dei decreti
legislativi, in Istruttoria parlamentare e qualit della normazione a cura di G. RECCHIA e R. DICKMANN, Cedam, Padova,
2002.
(74) Parlano di procedimento ormai divenuto polifasico A. CELOTTO e E. FRONTONI, Legge di delega e decreto
ha portato ad una situazione di crescente disordine normativo, di cui sono espressione la legislazione di tipo provvedimentale (75), il sempre
pi frequente ricorso alla decretazione durgenza (76) e alle ordinanze di necessit (77), financo prevedendo deleghe assunte per decreto (78); f) la mancata attuazione dellart. 39
cost. e la cosiddetta privatizzazione del pubblico
impiego hanno spinto o ad un uso improprio della
legge nei rapporti di lavoro o e non solo per il
pubblico impiego ad anomale fonti normative
contrattate (79); g) i fenomeni di cosiddetta
iper-legificazione hanno alimentato tentativi di
dare vita a processi di delegificazione e semplificazione obbiettivi peraltro fra loro non coincidenti (80) che hanno ingarbugliato ulteriormente il sistema delle fonti (81); h) il tentativo di
uscire dalla scissione tra potere legislativo e fonti
regolamentari nelle materie concorrenti, lambiguit del riconoscimento costituzionale del potere
legislativo, in questa Enciclopedia, Aggiornamento, VI, 2002,
ad vocem. Il fenomeno era stato da tempo messo in rilievo da
N. LUPO, Deleghe e decreti legislativi correttivi: esperienze,
problemi, prospettive, Giuffr, Milano, 1996.
(75) V. G.U. RESCIGNO, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-provvedimento costituzionalmente
illegittime, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, dicembre 2007.
(76) Tanto da far parlare di normalizzazione dellemergenza : A. CARDONE, La normalizzazione dellemergenza: contributo allo studio del potere extra ordinem del
governo, Giappichelli, Torino, 2001.
(77) In non pochi casi trasformate in anomale fonti del
diritto: v. A. MORRONE, Le ordinanze di necessit ed urgenza,
tra storia e diritto, in Istituzioni e dinamiche del diritto. I
confini mobili della separazione dei poteri a cura di A.
VIGNUDELLI, Giuffr, Milano, 2009, 133 ss.; nonch G. MARAZZITA, Lemergenza costituzionale: definizioni e modelli,
Milano, 2003; G. RAZZANO, Lamministrazione dellemergenza. Profili costituzionali, Cacucci, Bari, 2010; C. PINELLI,
Un sistema parallelo. Decreti legge e ordinanze durgenza
nellesperienza italiana, in Dir. pubbl., 2009, 317 ss.
(78) Parla di produzione normativa a cannocchiale R. ZACCARIA, Introduzione a Fuga dalla legge? Seminari sulla qualit della legislazione a cura di R. ZACCARIA,
Grafo, Brescia, 2011, 15.
(79) Abbiamo approfondito il tema in A. BARBERA, Le
fonti del diritto del lavoro, fra legge e contratto, in Il sistema
delle fonti nel diritto del lavoro (Atti delle Giornate di studio
di diritto del lavoro, Foggia, 25-26 maggio 2001), Milano,
2002, 21 (nonch in Istituzioni mercato e democrazia. Liber
amicorum per gli ottanta anni di Alberto Predieri, Giappichelli, Torino, 2002).
(80) G. DEMURO, La delegificazione come strumento di
semplificazione: una difficile coesistenza, in Osservatorio sulle
fonti 1999 a cura di U. DE SIERVO, Giappichelli, Torino,
2000, 193-203.
(81) Riferimenti in B. MATTARELLA, La trappola delle
leggi. Molte, oscure, complicate, Il Mulino, Bologna, 2011.
Nonch A. PIZZORUSSO, La manutenzione del libro delle leggi
ed altri studi sulla legislazione, Giappichelli, Torino, 1999.
279
Costituzione della Repubblica italiana
regolamentare degli enti locali (82), cui si aggiunta linsofferenza dellEsecutivo per i controlli
introdotti dalla legge sullordinamento del Governo (l. 23 agosto 1988, n. 400), hanno portato
alla evanescenza dei regolamenti come fonte del
diritto e alla diffusione di variopinti atti amministrativi a contenuto normativo (talvolta autodefinitisi di natura non regolamentare); i) la normativa tecnica, affidata alle Autorit indipendenti,
tende sempre pi a fuoriuscire dallo schema tipico
del rapporto fra la legge e i tradizionali regolamenti di altre autorit, fino ad assumere i caratteri che sarebbero propri delle norme primarie (83).
La stessa giurisprudenza non solo quella
additiva della Corte costituzionale, al di l
della qualificazione formale, divenuta strumento
di integrazione dellordinamento giuridico (le sentenze della Corte sono sempre pi presenti nei
codici a completamento o correzione delle disposizioni ivi racchiuse), tanto da rendere plausibile il
pur discusso tentativo di annoverarla fra le fonti
del diritto.
Ma soprattutto mutata, rispetto alliniziale
schema del Costituente, la struttura normativa
della Costituzione e il rapporto fra legge e Costituzione. La Costituzione non pi solo una super-legge, collocata nel gradino pi alto per limitare poteri, assicurare garanzie e indicare al legislatore le finalit da perseguire. Intanto al proprio
interno conosce ormai una gerarchia di norme,
alcune delle quali fra queste i principi supremi sono in posizione di preminenza rispetto ad altri principi o addirittura in posizione di
concorrenza fra di loro (84). Inoltre i principi
costituzionali, da limite esterno alla legge, sono
penetrati sempre pi allinterno della stessa attivit
legislativa, condizionandola allosservanza non di
puntuali norme ma dei valori costituzionali, fino
a misurarne la ragionevolezza e la proporzionalit rispetto a quei valori. Il controllo costituzionale va progressivamente perdendo la originaria struttura di sindacato di diritto oggettivo voluta
dal Costituente per assumere quella (torneremo
(82) Ne abbiamo parlato in A. BARBERA, Un ribaltone nel
sistema delle fonti?, in Quaderni costituzionali, 2002, 803 ss.
(83) Cfr. M. MANETTI, I Regolamenti delle autorit indipendenti, in Il pluralismo delle fonti previste dalla Costituzione e gli strumenti per la loro ricomposizione a cura di
SICLARI (Atti del Convegno, Roma, Universit di Roma
Tre, 27-28 novembre 2008), Editoriale scientifica, Napoli,
2012, 275 ss., nonch A. IANNUZZI, Sullapparente irrilevanza
della tecnica nella giurisprudenza costituzionale pi recente, in
Federalismi.it, www.federalismi.it, 4 aprile 2012.
(84) V. C. cost. 22 ottobre 2014, n. 238, cit.
280
sul punto infra, 20) di giurisdizione dei diritti.
Di conseguenza, non lontano dal vero intravvedere nellattivit legislativa, ormai, i caratteri propri di una attivit discrezionale, tale da indurre
il giudice costituzionale alla tentazione di forme
pi o meno velate di controllo nel merito. Parallelamente il giudice ordinario sempre meno
vincolato alla legge (art. 101 cost.) e si pone
sempre pi in rapporto diretto sia con la Costituzione, sia con altre fonti sovranazionali, tanto da
sollevare la discussione su un diritto giurisprudenziale; diritto peraltro posto in essere non solo
da Corti nazionali ma, in epoca di globalizzazione,
da una fitta rete di altre Corti (85).
Siamo di fronte ad un complesso di fonti che
e non pu essere diversamente dottrina e
giurisprudenza continuano a presupporre come
sistema, e quindi coerente, completo e tendenzialmente chiuso (86). Non pochi dubitano,
tuttavia, che questo sia ancora possibile. Vi chi
ritiene che non sia pi proponibile, neanche come
residuale, il criterio della gerarchia (87); chi
mette in discussione sia il criterio della gerarchia
sia quello della competenza e ritiene possibile
muoversi solo sulla base di criteri assiologici individuati dallinterprete in relazione al caso concreto
sottoposto (88), e persegue, quindi, lancora pi
(85) Linterrogativo diffuso: v. per tutti A. PIZZORUSSO,
Fonti del diritto2, in Commentario del codice civile ScialojaBranca a cura di F. GALGANO, Disposizioni sulla legge in
generale (Art. 1-9), Zanichelli-Il Foro italiano, BolognaRoma, 2011, ma anche ID., Comparazione giuridica e sistema
delle fonti del diritto, Utet, Torino, 2005; sul punto, altres,
A. CELOTTO, Le sentenze della Corte sono fonti del diritto?, in
Giur. cost., 2003, 27 ss. Sul rapporto fra Corti nazionali e
transnazionali v. S. CASSESE, I tribunali di Babele. I giudici alla
ricerca di un nuovo ordine globale, Donzelli, Roma, 2009; G.
DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti, Il Mulino, Bologna, 2010, 45 ss.
(86) Ancora in questa direzione, sia pur con accenti
critici, F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, Cedam, Padova,
2009; e L. CARLASSARE, Fonti del diritto (diritto costituzionale), in questa Enciclopedia, Annali, II, t. 2, 2008, ad vocem;
nonch gli scritti raccolti in La costruzione giurisprudenziale
delle fonti del diritto a cura di L. CALIFANO, Aras, Urbino,
2010.
(87) Cfr. F. MODUGNO, possibile parlare ancora di un
sistema delle fonti?, in Il pluralismo delle fonti previste dalla
Costituzione e gli strumenti per la loro ricomposizione a cura
di SICLARI, cit., 3 ss.; ma v. anche ID., Fonti del diritto
(gerarchia delle), cit.; v. inoltre S. NICCOLAI, Delegificazione e
principio di competenza, Cedam, Padova, 2001.
(88) Per Antonio Ruggeri ogni fonte, Costituzione
inclusa, valida sub condicione e pu trovare spazio [...]
unicamente laddove dimostri di potere offrire la pi intensa
tutela ai diritti : cfr., da ultimo, RUGGERI, Lo Stato costituzionale e le sue mutazioni genetiche, cit., a conclusione di una
lunga ricerca raccolta nei vari volumi degli Itinerari di una
ricerca sul sistema delle fonti, editi da Giappichelli (v. ID.,
Quale sistema delle fonti dopo la riforma del Titolo V?, in ID.,
Costituzione della Repubblica italiana
radicale obbiettivo di convertire la teoria delle
fonti nella teoria dellinterpretazione, ricorrendo ad una assai pi flessibile gerarchia (non
delle fonti ma) delle norme. E non manca in tali
orientamenti il tentativo di salvare la fonte legislativa come norma di procedura (89), volta a
legare insieme le varie autonomie istituzionali e
sociali. E a questo fine vi chi mette sempre pi in
evidenza il criterio della sussidiariet (90) ricostruito addirittura, pi in generale, come necessario criterio ordinatore delle fonti (91). Vi , infine,
chi non rimpiange lassenza di un sistema e
ritiene anzi che incoerenza e incompletezza
siano ineliminabili e forse auspicabili mentre
lunico criterio che potrebbe essere individuato
sarebbe la forza gravitazionale dei precedenti (92).
Tali ricostruzioni colgono importanti aspetti
problematici ma, mosse dallansia di dare la massima estensione ai principi e ai valori costituzionali, corrono il rischio di delegittimare, assieme al
tradizionale sistema delle fonti, la stessa Costituzione; anzi, proprio il concetto di costituzione.
Ogni Costituzione, anche pluralista, , in primo
luogo, chiamata ad assicurare lunit e lidentit di
un ordinamento: non pu ridursi solo ad un arruffato deposito di valori da cui trarre materiali
per consentire la tutela di sempre pi numerosi
diritti (93). Una Costituzione non pu non ambire
a rappresentare il nucleo attorno a cui si costruisce
un ordinamento; questo non una somma di
regole: un sistema o meglio, direbbe Simone Weil, deve presumersi che lo sia (94) , un
Itinerari, cit., X. Studi dellanno 2006, 2007; ID., possibile
parlare ancora di un sistema delle fonti?, ora ivi, XII. Studi
dellanno 2008, 2009, 469 ss.). La stessa Costituzione sarebbe in questa prospettiva una transCostituzione o interCostituzione.
(89) Da ultimo S. PARISI, La gerarchia delle fonti. Ascesa,
declino, mutazioni, Jovene, Napoli, 2012.
(90) A partire dalla notissima sentenza C. cost. 1o ottobre 2003, n. 303.
(91) V. per tutti A. MOSCARINI, Competenza e sussidiariet nel sistema delle fonti, Cedam, Padova, 2003.
(92) R. BIN, Ordine delle norme e disordine dei concetti
(e viceversa). Per una teoria quantista delle fonti del diritto, in
Scritti in onore di Lorenza Carlassare, cit., I, 35 ss.; v. ora ID.,
A discrezione del Giudice. Ordine e disordine. Una prospettiva quantistica, Franco Angeli, Milano, 2013.
(93) Cos, sulle colonne dErcole del processo di
unificazione politica tracciato nella Costituzione, A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia costituzionale), in questa Enciclopedia, Annali, II, t. 2, 2008, 202.
(94) il diritto come la linea retta, non esiste in
natura, ma serve allo spirito per capire e per agire : questa
la riportiamo in sintesi una riflessione di Simone WEIL,
Dune antinomie du droit, in ID., Premiers crits philosophiques, Gallimard, Paris, 1988, 255-259 (trad. it. di M. AZZA-
insieme in cui ogni parte in funzione dellaltra.
Lunit e la coerenza dello stesso devono essere
assicurate dalla Costituzione e da quelle altre fonti
che, pur subordinate ad essa e dotate di diversa
forza formale, concorrono a comporre lordinamento costituzionale. Se non in grado di svolgere
questa funzione, una Costituzione perde significato (95). La Costituzione non solo una carta
dei diritti n solo una meta-norma procedurale: ad essa spetta ricondurre ad unit ci che
disperso nel molteplice. Funzione questa che deve
essere informata ai principi fondamentali della
Costituzione stessa, fra cui, in primo luogo, il
principio democratico.
La ricerca di un ordine costituzionale delle
fonti normative non un cedimento Stato-centrico, come temuto da chi abbraccia concezioni
proprie del costituzionalismo societario, ma
coincide con la difesa stessa del pluralismo, come
identit fondante (96). I valori del pluralismo sono
anzi una delle decisioni politiche fondamentali
che costituiscono lordito della Costituzione italiana; sono il frutto di un non facile conflitto, mai
definitivamente vinto, con i nemici qui
inevitabile il riferimento alle note categorie di Carl
Schmitt (97) del pluralismo stesso: il totalitarismo, sconfitto con la Resistenza; il classismo
dei movimenti estremisti, sconfitto negli anni Ottanta; il fanatismo religioso, sempre in agguato.
LINI,
Primi scritti filosofici, Marietti, Genova, 1999, 212-218).
Altrettanto pu dirsi, in un universo normativo, per il concetto di sistema.
(95) CARLASSARE, Fonti del diritto (diritto costituzionale),
cit., 537, tende a spostare la causa della crisi delle fonti nei
continui tentativi di riforma della Costituzione. Conclusione accettabile se riferita alle novit introdotte dalla riforma del Titolo V; per il resto il ragionamento va ribaltato
non potendosi non risalire dagli atti-fonte ai soggetti, che
quelle fonti sono destinati ad alimentare il Parlamento, le
Regioni, il Governo, lAmministrazione, le Autorit indipendenti la cui riforma pu influire positivamente anche sul
riordino delle fonti normative. Non un caso che il ricorso
frequente ai decreti-legge sia una tendenza sconosciuta alle
altre democrazie europee, proprio perch queste riconoscono ai Governi incisivi poteri in ordine ai procedimenti
legislativi. Un orientamento analogo a quello di Lorenza
Carlassare in G. AZZARITI, Il Rapporto partiti-eletto. Per una
interpretazione evolutiva dellart. 67 cost., in Pol. dir., 2013,
286; opposta la impostazione di S. CECCANTI, Decreti obesi e
crisi economica, ovvero la vittoria strisciante dellassemblearismo, in Quaderni costituzionali, 2014, 109 ss.
(96) Il riferimento alla fortuna che sta trovando la tesi
di Gunther Teubner sul costituzionalismo autopoietico,
senza Stato; fra i tanti scritti v. G. TEUBNER, La cultura del
diritto nellepoca della globalizzazione. Lemergere delle costituzioni civili, trad. it., Armando Editore, Roma, 2005; ID., Il
diritto come sistema autopoietico, trad. it., Giuffr, Milano,
1996.
(97) SCHMITT, Dottrina della Costituzione, cit., 110 ss.
281
Costituzione della Repubblica italiana
Sez. II. LA
ACCRESCIUTA FORZA
DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI.
7. Il progressivo radicamento della Costituzione. La Costituzione italiana, prossima ai
suoi settantanni, ancora fertile e robusta? Di
fronte a questa domanda le opinioni espresse da
studiosi e politici sono state tante, varie e fra loro
diverse. Per brevit, pur forzando tale variet, le
riduciamo a tre.
La prima posizione di quanti percepiscono il
testo costituzionale come un documento datato,
ispirato a principi non pi adeguati ad una societ
e ad una economia moderne o comunque non
nascondono la voglia di un mutamento costituzionale, non escludendo in talune posizioni persino la
convocazione di una nuova Assemblea costituente. Opinioni presenti sia in settori attratti da
modelli liberisti per i quali i principi costituzionali sarebbero ispirati a modelli cattocomunisti (98) sia, lo vedremo pi avanti, in taluni
settori della sinistra movimentista (per i quali,
invece, i principi costituzionali sarebbero ispirati
ai modelli capitalisti del Novecento; v. infra, 24).
La seconda posizione di quanti sottolineano
la immutata validit ed attualit del testo costituzionale, in tutte le sue parti, fino al punto di
respingere o limitare al massimo ogni tentativo
riformatore. Sono opinioni, peraltro, che difficile
definire in blocco di conservatorismo costituzionale (99) perch oscillano fra velleit di recupero
delloriginal intent e fughe in avanti, al di l
delle stesse disposizioni costituzionali sia per
quanto riguarda i diritti sia, lo abbiamo visto
prima, per quanto riguarda le fonti (100). Vi chi,
mitizzando un passato fulgore, considera la Costituzione svuotata da ripetute debolezze e cedimenti, poco radicata nelle coscienze , logorata ed erosa (101); opinioni che risentono del(98) Per esempio G. BOGNETTI, Il modello economico
della democrazia sociale e la Costituzione della Repubblica
italiana, in Verso una nuova Costituzione (Gruppo di Milano) a cura di G. MIGLIO, I, Giuffr, Milano, 1983, 133 ss.
Ma non mancano dubbi anche in altri versanti politicoculturali: v. per esempio T. PADOA SCHIOPPA, Il governo
delleconomia, Il Mulino, Bologna, 1997, 37 ss.
(99) Lespressione stata ripresa nelleditoriale di Ernesto GALLI DELLA LOGGIA, I sacerdoti del non si pu, in
Corriere della Sera, 30 marzo 2014.
(100) Il dibattito sullart. 29 relativo allo statuto della
famiglia emblematico: da un lato si rende omaggio alla
Carta costituzionale, dallaltro la si carica di significati del
tutto estranei alla cultura dei Costituenti (ma sul matrimonio
omosessuale intervenuta a fare chiarezza C. cost. 15 aprile
2010, n. 138).
(101) Accenti ricorrenti ma da ultimo largamente presenti nel Seminario organizzato il 10 aprile 2014 dal Centro
282
lindubbio venir meno delle speranze che accompagnarono il varo della Costituzione, ma non
manca in talune di esse il tentativo di utilizzare la
Carta costituzionale come risorsa ideologico-simbolica, come strumento identitario di culture ortodosse contro avversari ritenuti estranei alle originarie culture politiche della Costituente (102),
fino a lanciare ricorrenti allarmi contro pretesi
rischi di una fuoriuscita dal modello democratico
da essa disegnato (103). Ma nonostante la diversit
di accenti e di motivazioni non manca da pi parti
per la riforma dello Stato, in particolare nella Relazione di
Mario DOGLIANI, Riforme costituzionali e qualit della democrazia, in Dem. dir., 2014, 7 ss. Ma gi con questi accenti, da
altra sponda politico-culturale, M. DANTONIO, La costituzione di carta, Mondadori, Milano, 1977, 189 ss.; v. anche M.
AINIS, Vita e morte di una costituzione, Laterza, Roma-Bari,
2006 (p. 7: la Costituzione come un fantasma della nostra
storia collettiva ).
Nel tentativo di opporsi a spinte riformiste ritenute
sbagliate vengono richiamati antichi fulgori della Costituzione (per esempio Massimo VILLONE, Decisionisti, ora ridateci la Dc, in Il Manifesto, 31 luglio 1914), rimestando quel
ricorrente giulebbe storiografico che porta a mitizzare il
dopoguerra e su cui ebbero modo di discutere Giovanni
Spadolini (cui si deve lespressione), Pietro Scoppola e Eugenio Scalfari (in La Repubblica, 22 e 28 agosto, e 1o
settembre 1984). In modo pi pacato, riflette sulla mancanza
nei partiti di oggi di una cultura della Costituzione M.
GREGORIO, Quale costituzione? Le interpretazioni della giuspubblicistica nellimmediato dopoguerra, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XXXV,
2006, 908.
(102) Questi avversari vengono individuati in chi pone
fra i suoi obbiettivi riforme elettorali o costituzionali (di
volta in volta i socialisti craxiani, il centrodestra berlusconiano, il Governo Letta, che aveva dato impulso ad un
percorso riformatore, o il Governo Renzi per limpulso dato
alla riforma del Senato). Si giunti a prospettare un partito
della Costituzione e la presentazione alle elezioni di una
lista degli amici della Costituzione o di partigiani della
Costituzione : v. P. FLORES DARCAIS, Realizzare la Costituzione!, in Micromega, dicembre 2013; v. sul punto la risposta
di L. CARLASSARE, Realizzare la Costituzione costituisce un
programma politico, in www.libertaegiustizia.it, 2 dicembre
2013, che condivide la diagnosi ma prende le distanze dalla
proposta. Su questi orientamenti v. E. GALLI DELLA LOGGIA,
Quelle letture strumentali della Costituzione, in Corriere della
Sera, 8 dicembre 2013. Sulla necessaria militanza del
costituzionalista insiste da tempo G. FERRARA, Costituzione e
Rivoluzione. Riflessioni sul Beruf del Costituzionalista (20
ottobre 2010), in Costituzionalismo.it, www.costituzionalismo.it, 2010, n. 2.
(103) Si susseguono in questi anni numerosi appelli che
lanciano gravi allarmi sulla Costituzione ferita e la democrazia in pericolo, spesso con autorevoli firme di costituzionalisti. Si trovano in vari siti; il pi attivo www.libertaegiustizia.it fa capo allomonima associazione presieduta da Gustavo Zagrebelsky; ma sulla stessa lunghezza donda i siti
www.salviamolacostituzione.it e www.adifesadellacostituzione.it (che fanno capo alle omonime associazioni). Non diverso il tono complessivo, anche se pi paludato, di www.costituzionalismo.it. In questa direzione G. ZAGREBELSKY, Postfazione a S. BONSANTI, Il gioco grande del potere, Chiarelettere, Roma, 2014, 226 ss., in cui si tende a raccontare la
Costituzione della Repubblica italiana
il riconoscimento che la Carta del 48 nonostante
tutto ha retto (104).
Entrambe queste impostazioni non appaiono
convincenti proprio perch non riescono a distinguere (o si rifiutano di farlo) fra le varie parti della
Costituzione: i principi, contenuti quasi tutti nella
prima parte, che danno identit alla comunit
politica, e le regole e le istituzioni che, ispirandosi
a quei principi, organizzano e articolano i poteri
pubblici. Fra queste posizioni andata crescendo
una tendenza intermedia che possiamo definire
di riformismo costituzionale che, pur riaffermando la perdurante validit della prima parte
della Costituzione, ritiene necessario intervenire
con modifiche sulla seconda parte. Queste modifiche in alcune proposte sono pi incisive, in altre
pi caute e limitate, e sono espresse anche nella
Relazione finale della cosiddetta Commissione dei
saggi istituita dal Governo Letta (105).
storia italiana come una deriva continua dello Stato verso
lantistato .
comunque assai diffusa lopinione che ritiene ormai
indebolita , stravolta o sfilacciata la Costituzione
repubblicana: cos, fra gli altri, G.U. RESCIGNO, A proposito di
prima e di seconda repubblica, in St. parl. pol. cost., 1994, 20
ss.; C. AMIRANTE, Per la storia del processo di erosione di un
sistema costituzionale democratico, in La democrazia riformata a cura di A. BEVERE, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli, 2004, 123 ss.; S. DALBERGO, Diritto e Stato, tra
scienza giuridica e marxismo, Teti, Roma, 2004. V. anche L.
FERRAJOLI, Democrazia e costituzione, in Il futuro della Costituzione a cura di G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO e J. LUTHER, Einaudi, Torino, 1996, 335, il quale esprime una
visione assai pessimistica sulle ferite che sarebbero state
inferte alla Costituzione sia dalla destra che dalla sinistra,
fino a dimostrare lavvenuto avvento di una seconda Repubblica. Posizioni ribadite in un dialogo fra Luciano
Canfora e Gustavo Zagrebelsky in cui questultimo afferma
che la parte relativa ai diritti largamente inattuata, dimenticata (ivi, 84) e che la democrazia voluta dalla Costituzione ha dato luogo ad oligarchie, legate ad oligarchie
internazionali (ivi, 89), cui si collegherebbero anche i tentativi di riforma costituzionale (v. L. CANFORA e G. ZAGREBELSKY, La maschera democratica delloligarchia, dialogo a cura di
G. PRETEROSSI, Laterza, Roma-Bari, 2014). Pi cauta la posizione di M. LUCIANI, in Sullattualit della Costituzione.
Quindici domande ai costituenti (Fondazione Lelio e Lisli
Basso), Manifesto Libri, Roma, 2004, 19, e di M. CALISE, La
costituzione silenziosa, Laterza, Roma-Bari, 1998, 128 s., che
in riferimento allemergere di nuovi poteri amministrativi
parla di ferite inferte alla Costituzione.
(104) BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione, cit., 441 ss.; V. ONIDA, La Costituzione, Il Mulino,
Bologna, 2004, 121 ss.; L. ELIA, La Costituzione aggredita.
Forma di governo e devolution al tempo della destra, Il
Mulino, Bologna, 2005, 67 ss.; cos anche A. PIZZORUSSO, La
Costituzione ferita, Laterza, Roma-Bari, 1999.
(105) Il dibattito e le conclusioni della cosiddetta Commissione dei saggi nominata dal Governo Letta (d.P.C. 11
giugno 2013) in Per una democrazia migliore (Presidenza del
Consiglio dei ministri), Gangemi, Roma, 2013. Allinterno
della Commissione le posizioni pi avanzate si sono mosse
La nostra opinione, che svilupperemo nelle pagine successive, che i principi costituzionali non si
sono indeboliti ma che, anzi, si sono ulteriormente
radicati nella coscienza degli italiani e che solo
grazie a questo radicamento stato possibile tentare di porre mano senza timori alla seconda parte
della Costituzione. Per anni si parlato di riforme
costituzionali. Si tenta di giungere a tale traguardo
dalla fine degli anni Settanta. Questi tentativi possono determinare una distorsione ottica e alimentare limpressione di una Costituzione labile e destabilizzata. Ma non cos: nessuno di essi ha
toccato o preteso di incidere credibilmente sui
principi costituzionali, dunque sullidentit della
Costituzione. Perfino la posizione di riforma che
parve la pi radicale, quella espressa nel Messaggio
alle Camere dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga (giugno 1991), teneva a sottolineare
la forza pedagogica dei suoi principi (106) e si
limitava a sollecitare una incisiva riforma della
parte seconda (frutto del clima di Yalta , come
Cossiga dir in altre occasioni).
Anzi, diremo di pi: le prove superate sono
state numerose le tensioni interne della guerra
fredda, la stagione del terrorismo, il crollo dellarco costituzionale ed altre se ne prospettano, non ultima lesplosione di antipolitica e di
demagogia antiparlamentari degli anni dal Duemila in poi, ma i valori e i principi costituzionali
sono ormai radicati, anzi sono oggi pi radicati
nella coscienza degli italiani di quanto non lo
fossero in quei primi decenni in cui la Costituzione
ha iniziato il suo cammino.
Come vedremo meglio pi avanti ( 24), si
sono succeduti diversi comitati parlamentari e tre
commissioni bicamerali; sono stati approvati in
Parlamento due testi di riforma: il primo andato in
porto nel 2001 ad opera di una assai risicata
maggioranza di centrosinistra, il secondo varato
nel 2005 ad opera della maggioranza di centrodelungo due direttrici, fra loro alternative: revisioni costituzionali che, unite ad una legge elettorale ad effetti maggioritari,
consentissero un sistema parlamentare di gabinetto oppure
revisioni volte ad introdurre un sistema di tipo semipresidenziale. Le posizioni pi caute allinterno della Commissione
partivano dalla convinzione che la crisi nasce sul piano del
funzionamento del sistema politico attraverso il progressivo
sfaldamento di quella democrazia dei partiti che fin dallinizio
aveva costituito la trama interna, la nervatura dello stesso
modello : E. CHELI, Nata per unire. La Costituzione italiana
fra storia e politica, Il Mulino, Bologna, 2012, 31-32.
(106) Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, trasmesso il 26 giugno 1991 (in Atti parl. Cam., X
legislatura, doc. I n. 11), su cui v. ora gli scritti pubblicati in
La grande riforma mancata. Il messaggio alle Camere del 1991
di Francesco Cossiga a cura di P. CHESSA e P. SAVONA,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014.
283
Costituzione della Repubblica italiana
stra, ma bocciato a seguito del prevalere dei
No in occasione del referendum confermativo
del 25-26 giugno 2006. Nessuna proposta e nessun
testo, tuttavia, ha preteso, nemmeno lontanamente, di toccare i principi costituzionali; si
trattato, in breve, di tentativi di revisione costituzionale senza lambizione di intaccare quei
principi in vista di un mutamento costituzionale. Se si fa eccezione per un progetto di riforma
dellart. 41 presentato (ma senza convinzione) dal
Governo Berlusconi (107), per qualche isolata iniziativa legislativa di parlamentari o per i primi
progetti elaborati dalla Lega Nord, nel periodo in
cui forte era linfluenza di Gianfranco Miglio (che
aveva contestato i principi costituzionali fin dalla
prolusione milanese del 1964) (108), nessun
gruppo politico ha proposto riforme incisive della
prima parte della Costituzione (109). Sono stati
revisionati gli art. 27 e 51 contenuti in questa parte
della Costituzione, relativi alla pena di morte e alle
pari opportunit (ne parleremo infra, 24), ma
alla quasi unanimit e soprattutto al fine dichiarato
di estendere e ampliare lapplicazione di principi
fondamentali gi contenuti nella Carta.
8. Le letture inizialmente divaricanti. Per
rispondere alla domanda posta allinizio del para(107) Ci riferiamo al disegno di legge costituzionale
presentato alla Camera dei deputati il 7 marzo 2011 (in Atti
parl. Cam., XVI legislatura, doc. n. 4144), cui erano stati
abbinati altri progetti di iniziativa parlamentare (doc. n.
3039, n. 3054, n. 3967 e n. 4328-A), per la modifica dellart.
41 cost. e per sottolineare con varie norme il principio della
libert di impresa (come scritto nella Relazione: al fine di
riportare i valori culturali propri della Costituzione al
quadro di riferimento europeo disegnato dal Trattato europeo ). Approvato dalla Commissione per gli affari costituzionali (e sottoposto ad una audizione il 22 settembre 2011)
stato poi travolto dalla crisi del Governo Berlusconi.
Successivamente altri disegni di legge di iniziativa parlamentare (per esempio la proposta di legge costituzionale La
Loggia ed altri, presentata il 20 giugno 2012, in Atti parl.
Cam., XVI legislatura, doc. n. 5299) sono tornati sulle
norme della Costituzione economica.
(108) Sollev clamore lintervista a LIndipendente del
25 marzo 1994, La Costituzione un patto che devono
imporre i vincitori ai vinti : frase non priva di spessore
storico (cos del resto stato per tante Costituzioni, compresa la Costituzione italiana, imposta dalle forze della Resistenza vincitrice a monarchici e fascisti) ma del tutto fuori
luogo a seguito di una vittoria elettorale realizzata proprio
grazie alla Costituzione repubblicana. Per la prolusione milanese v. G. MIGLIO, La trasformazione dellattuale regime
politico, in Jus, 1965, 30 ss.
(109) Un attento inventario, condotto fino alla fine degli
anni Novanta, di Giulio NAPOLITANO, Le proposte di riforma
della costituzione economica italiana, in Per una nuova costituzione economica a cura di G. DELLA CANANEA e Giulio
NAPOLITANO, Il Mulino, Bologna, 1998, 85 ss., conferma
questa conclusione.
284
grafo precedente, faremo (un rapido) riferimento
alle forze politiche, sociali e culturali che hanno
sorretto, o sorreggono, lordinamento costituzionale, e quindi alle evoluzioni da esse subite in
questi ultimi decenni. Faremo riferimento per
essere brevi alla storia politica sia al fine di
seguire lo sviluppo dei principi costituzionali sia al
fine di verificare lincidenza della base materiale
nella lettura degli stessi. Sul contributo del diritto
costituzionale nella storia nessun dubbio mentre
permangono dubbi, in gran parte ingiustificati,
sulla utilizzazione della storia nel diritto costituzionale (110). Dubbi non facili da sciogliere ma ci
richiamiamo al contributo di Rudolph Smend
sulla stretta interdipendenza fra culture politiche e
processi di integrazione costituzionale (111).
In Assemblea costituente le posizioni di partenza erano come noto assai distanti ma
alla fine si realizzer un compromesso di alto
profilo. Non si tratt di reciproche concessioni
ma, non poche volte, di reali convergenze fra forze
politiche che partivano da posizioni molto lontane. Quel compromesso, tuttavia, present il limite di rimanere a livello di lites intellettuali e
politiche, di punte colte ed avanzate (112). Fu
marcato, in particolare, il distacco fra i gruppi
dirigenti, soprattutto comunisti e cattolico-democratici, che avevano dato vita al compromesso
costituzionale, e il rispettivo elettorato, costituito
da quelle che allora venivano chiamate le masse
comuniste e le masse cattoliche (113). Non ci
riferiamo alla nota contrapposizione fra gli storici
che ritengono la Resistenza una vicenda frutto di
larga partecipazione popolare e quelli che, invece,
ritengono che essa sia stato il frutto di gruppi
sociali e politici minoritari. Ci riferiamo, in modo
specifico, alla Costituente e alla assenza di una
adesione popolare di massa ai suoi lavori, allisolamento che laccompagn (114).
(110) Riprendiamo un dubbio di Livio PALADIN, La
questione del metodo nella storia costituzionale (1997), ora in
ID., Saggi di storia costituzionale a cura di S. BARTOLE, Il
Mulino, Bologna, 2008, 18.
(111) SMEND, Costituzione e diritto costituzionale, cit.,
283 ss.
(112) E. CHELI, Costituzione e sviluppo delle istituzioni
in Italia, Il Mulino, Bologna, 1978, 25.
(113) Lo ha pi volte sottolineato, tra gli altri, P. POMBENI, Introduzione alla storia dei partiti politici, Il Mulino,
Bologna, 1990.
(114) Oltre a CHELI, lc. ult. cit., v. R. RUFFILLI, Introduzione a Costituente e lotta politica. La stampa e le scelte
costituzionali a cura di R. RUFFILLI, Vallecchi, Firenze, 1998;
nonch P. POMBENI, La Costituente, Il Mulino, Bologna,
1995, 80. La maggiore attenzione venne dal Corriere della
Sera ma con limiti che confermano lopinione anzidetta: v.
D. LO PRESTI, La Costituente dipinta da via Solferino, in
Costituzione della Repubblica italiana
A) Partiamo dai cattolici democratici e dai
Governi da essi espressi. Lapporto dei primi alla
Costituente di Dossetti, Fanfani, La Pira, Mortati, Tosato ed altri era stato indubbiamente
determinante (115). Non meno significativa
lazione svolta dallintero gruppo dirigente democristiano che aveva contenuto le pretese di ambienti vaticani contrari allaccordo con il comunismo ateo e che gi pensavano alla scomunica
vaticana (116) e favorevoli a ben altro testo
costituzionale. Come apprendiamo da una documentata indagine di Giovanni Sale, gesuita di Civilt cattolica (117), circolavano in quel periodo
testi, talvolta sostenuti dalla stessa Segreteria di
Stato, che presentavano una accentuata ispirazione confessionista, tali da far correre il rischio di
innalzare quegli storici steccati fra Guelfi e Ghibellini che invece De Gasperi voleva esorcizzare (118). Le posizioni illuminate dei cattolici
Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura
politica italiana (1943-1948) a cura di A. BURATTI e M.
FIORAVANTI, Carocci, Roma, 2010, 176 ss.
(115) Lo testimoniano ampiamente i tre volumi della
ricerca dellIstituto Sturzo I cattolici democratici e la Costituzione a cura di N. ANTONETTI, U. DE SIERVO e F. MALGERI,
Il Mulino, Bologna, 1998.
(116) Il decreto della Congregazione del Santo Uffizio
di scomunica dei comunisti del 1o luglio 1949.
(117) G. SALE, Il Vaticano e la Costituzione, Jaca Book,
Milano, 2008; v. in proposito il volume dellautorevole gesuita A. MESSINEO, Il potere costituente, Edizioni di Civilt
cattolica, Roma, 1946. Non erano mancati anche condizionamenti culturali fra gli stessi laici cattolici: come dimostra la
lettura di Costituente e Costituzione (Atti della XIX Settimana sociale dei cattolici dItalia, Firenze, 22-28 ottobre
1945), Edizioni Icas, Roma, 1946.
(118) Cfr. P. SCOPPOLA, La proposta politica di De Gasperi, Il Mulino, Bologna, 1977, 113 ss. Una rivisitazione di
quegli anni in G. DOSSETTI, Non abbiate paura dello Stato .
Funzioni e ordinamento dello Stato moderno. La Relazione
del 1951: testo e contesto a cura di E. BALBONI, Vita e
Pensiero, Milano, 2014. Si deve a Dossetti lordine del
giorno (praticamente recepito anche se formalmente non
votato) che finalizzava lo Stato alla crescita della persona
umana, cos reagendo allimpostazione iniziale delle sinistre
di fondare la Costituzione solo sullantifascismo e la lotta di
liberazione (sul punto P. POMBENI, Giuseppe Dossetti. Lavventura politica di un riformatore cristiano, Il Mulino, Bologna, 2013, 157).
Furono tuttavia presenti in Dossetti due riserve che lo
distinsero dalla posizione pi liberale di De Gasperi. La
prima sottolineata da P. SCOPPOLA, in A colloquio con
Dossetti e Lazzati, intervista a cura di L. ELIA e P. SCOPPOLA,
Il Mulino, Bologna, 2003 (ma lintervista risale al 1984),
64-65 e 131, e si riferisce alla pretesa di utilizzare le istituzioni statali come unica leva per il cambiamento sociale, per
cui lo Stato sembra diventare il monopolista del bene comune, anzich una delle realt che contribuiscono a determinarlo. La seconda si riferisce a talune visioni integraliste
che portarono i dossettiani alla Costituente, a differenza dei
degasperiani, a difendere, fino a soccombere in uno scrutinio
a voto segreto, la costituzionalizzazione dellindissolubilit
democratici nellAssemblea costituente saranno
incrinate, dopo la vittoria del 18 aprile 1948, da
marcati cedimenti integralisti e clericali, fino
per usare unespressione di Jemolo a una diffusa intolleranza religiosa (119). Infatti, anche
dopo la approvazione della Costituzione saranno
non pochi a chiedere di dare attuazione a quelle
norme del Concordato che con la Costituzione
erano pi dissonanti (per esempio lart. 5, che
vietava ai sacerdoti apostati o irretiti da censura lassunzione di uffici a contatto con il pubblico) o quanti invocheranno (e spesso otterranno)
restrizioni nei confronti dei culti acattolici, ivi
compresi i non infrequenti fogli di via per i
pastori evangelici che svolgevano proselitismo
nelle campagne o nelle localit meridionali (120).
Possono inoltre essere ricordati quanti lo stesso
Pio XII da Piazza San Pietro protesteranno per
le prime sentenze della Corte costituzionale, in
particolare per la n. 1 del 1956, che aveva eliminato le autorizzazioni di polizia sugli stamdel matrimonio civile (cfr. SALE, op. cit., in particolare 23-24,
104-114 e 227). Sullostilit alla politica economica del Ministro Corbino v. F. BRUNO, Giuseppe Dossetti. Un innovatore nella Democrazia cristiana del dopoguerra, Bollati Boringhieri, Torino, 2014, 86 ss.
Proprio per il ruolo che devono avere le istituzioni dello
Stato nel governo delleconomia e nella tutela dei diritti
sociali presente in Dossetti la consapevolezza che sarebbe
stato necessario un legame stringente tra i princpi della
prima parte della Costituzione e la ricerca di una forma di
governo incisiva, stabile ed efficiente: v. A colloquio con
Dossetti e Lazzati, cit., 62-65. Questo quadro riconfermato
dallapprofondito studio di E. GALAVOTTI, Il professorino.
Giuseppe Dossetti fra crisi del fascismo e costruzione della
democrazia (1940-1948), Il Mulino, Bologna, 2013, 329 ss.
Come ha sottolineato Pietro SCOPPOLA (Intervento, in La
Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali
(1948-2006) a cura di R. BALDUZZI, Ave, Roma 2006, in
particolare 24), senza questi precedenti si fraintende clamorosamente quanto poi sostenuto da Dossetti dal 1994 in poi,
ossia la contrariet non al riformismo costituzionale in s ma
a proposte non meditate ed estreme, quali quelle lo
dicevamo prima allora avanzate dalla Lega di Miglio e dal
Governo Berlusconi. Su queste ultime posizioni v. G. DOSSETTI, Costituzione e riforme, in Quaderni costituzionali, 1995,
257 ss.
(119) A.C. JEMOLO, I problemi pratici della libert, Giuffr, Milano, 1961, 138.
(120) Cfr. G. SPINI, Le persecuzioni contro gli evangelici
in Italia, in Il Ponte, 1953, 1 ss. Emblematico quanto si
apprende da Pret. Foggia 10 dicembre 1957, in Giust. pen.,
1958, II, 985, con nota di G. CATALANO, Libert religiosa e
rimpatrio obbligatorio. Ulteriore documentazione in G. PEYROT, Il problema delle minoranze religiose, in A. CAPITINI, C.
MAGNI, L. BORGHI e G. PEYROT, La libert religiosa in Italia,
La Nuova Italia, Firenze, 1956, 54-55; G. ROSAPEPE, Linquisizione addomesticata, Laterza, Bari, 1960; S. LARICCIA, Le
libert di religione e verso la religione, in Teoria e prassi delle
libert di religione a cura di P. BELLINI, Il Mulino, Bologna,
1975, 313 ss.
285
Costituzione della Repubblica italiana
pati (121); quella protesta fu causa non ultima
pare delle dimissioni del Presidente De Nicola
il 10 marzo 1957 (122). Frequenti le iniziative
giudiziarie rivolte a gesti o frasi ritenute offensive
nei confronti della religione di Stato. Solo a
met degli anni Sessanta il Concilio Vaticano II, in
particolare con la Dichiarazione Dignitatis humanae (dicembre 1965), fortemente innovativa, approvata sotto la spinta dellepiscopato nordamericano, avrebbe radicato nella coscienza delle
masse cattoliche i valori pluralistici della Costituzione, superando il distacco fra enunciati normativi e pratica vivente degli stessi, spesso ispirata
invece a posizioni intolleranti. Solo nel 1984 i gi
ricordati accordi di Villa Madama avrebbero eliminato definitivamente i contrasti fra i principi
costituzionali e le norme pi retrive dei Patti
lateranensi, pur richiamati nellart. 7 del testo
costituzionale.
In quegli anni, tra laltro, forti e ripetute erano
state le violazioni della Costituzione da parte dei
Governi a direzione democristiana, favorite dal
permanere della vecchia legislazione del periodo
fascista, anche se non erano mancate spinte per
riforme volute dalla Costituzione stessa (la riforma
agraria o quella tributaria, tra le altre). Spesso
pesante era stata lutilizzazione delle misure di
polizia previste dal vecchio testo unico di pubblica
sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) e il ricorso
ad altre misure di ordine pubblico per reprimere
battaglie operaie o contadine, per comprimere
la libert di iniziativa delle imprese cooperative (123), per pressare e sfiancare lautonomia dei
Comuni rossi, limitando a questi fini il diritto di
riunione, la libert di corteo, il diritto di espatrio,
o finanche linoffensivo diritto di petizione. Tale
politica passata sotto il nome di scelbismo,
dal nome dellallora Ministro degli interni Mario
Scelba (124) , ispirata in parte da arroganze
padronali, in parte da una sincera preoccupazione
(121) C. cost. 14 giugno 1956, n. 1.
(122) Ma episodio non chiaro (il che dava adito a
Gaetano Salvemini di ricordare le diverse prassi di pubblicit della Suprema Corte americana: G. SALVEMINI, La Corte
costituzionale, in La Stampa, 20 aprile 1957, citato da Piero
CRAVERI, Enrico De Nicola, in Dizionario biografico degli
italiani, XXXVIII, Treccani, Roma, 1990).
(123) Una serie di misure amministrative per limitare la
loro attivit vennero adottate dal Consiglio dei ministri del 4
dicembre 1954.
(124) V. G.C. MARINO, La repubblica della forza. Mario
Scelba e le passioni del suo tempo, Franco Angeli, Milano,
2013, nonch le pagine di G. FANELLO MARCUCCI, Scelba. Il
ministro che si oppose al fascismo e al comunismo in nome
della libert, Mondadori, Milano, 2006, 108-174, e, dal
punto di vista del PCI, G. AMENDOLA, Gli anni della Repubblica, Editori Riuniti, Roma, 1976, 89 ss.
286
per presunte attivit eversive dei comunisti e in
parte da strumentalizzazioni elettorali dei partiti di
governo, non manc di provocare anche morti e
feriti, nelle fabbriche e nelle campagne, nel Nord
e nel Sud. E frequente fu allora, inoltre, la censura
di opere cinematografiche e teatrali ritenute scomode perch critiche nei confronti dei valori
espressi dai partiti di governo (125). Solo nel 1962
sar approvata la legge sulla censura (l. 21 aprile
1962, n. 161) destinata a sostituire la legislazione
degli anni Trenta.
Le espressioni usate in riferimento alle misure
adottate in quegli anni leggi eccezionali che
avrebbero portato ad unaltra Costituzione vigente seppure eccessive, rendono lidea delle
tensioni accumulate (126). Cos come rende lidea
la insistita contrapposizione fra la forza morale
della tradizione cattolica rispetto al culturame
(125) Gli episodi sarebbero numerosi: vietate ad esempio le rappresentazioni del Vicario di Hochut (irriverente nei
confronti di Pio XII), del Don Raffaele di Brancati, de La
figlia di Jorio di DAnnunzio, di taluni testi teatrali di Sartre;
vietata laffissione del manifesto che riproduceva la Venere
di Botticelli; sottoposti a pesanti tagli diversi film, da Tot e
i Re di Roma a Umberto D di Vittorio de Sica per la cattiva
rappresentazione allestero del ceto impiegatizio italiano ,
fino, nel 1960, a Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti,
censurato per offese al buon costume ma, in realt, perch
mostrava i lati negativi dei processi di immigrazione nelle
periferie urbane. Le carte di Andreotti, allepoca sottosegretario allo Spettacolo, recentemente pubblicate, sono in proposito una miniera: in www.sturzo.it/sottos/andreotti/html.
Da ricordare, per evocare il clima di quegli anni, la
condanna inflitta dal Tribunale militare di Milano a otto anni
di carcere a Renzo Renzi e a quattro anni e mezzo a Guido
Aristarco sotto laccusa di vilipendio delle forze armate per
avere progettato un film (Larmata sagap) che si sarebbe
soffermato su episodi di violenza delle forze armate italiane
in Grecia. La reazione dellopinione pubblica port alla loro
liberazione dal carcere di Peschiera e alla successiva modifica del codice penale militare, riconducendo tali reati sotto
la giurisdizione civile (v. Archivio di La Repubblica, maggio
1985).
(126) G. SCARPARI, La Democrazia cristiana e le leggi
eccezionali, Feltrinelli, Milano, 1977; G. CAREDDA, Governo e
opposizione nellItalia del dopoguerra, Laterza, Roma-Bari,
1995; ebbe diffusione in quel periodo un volume dai toni
forti di Camilla CEDERNA, Sparare a vista. Come la polizia del
regime DC mantiene lordine pubblico, Feltrinelli, Milano,
1975.
Indicativa del clima anche la violenta battaglia attorno
alla iniziativa del Governo (presentata il 14 ottobre 1950,
approvata dalla Camera l11 giugno 1951 ma arenatasi al
Senato) per la istituzione di un servizio di difesa civile (v.
Marcella FERRARA e Maurizio FERRARA, Cronaca di vita italiana
(1944-1958), Editori Riuniti, 1960, 304 ss., nonch M.L.
SERGIO, De Gasperi e la questione socialista: lanticomunismo
democratico e lalternativa riformista, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2004, con riferimento anche ai decreti Togni
sulla tutela delle scorte industriali e al progetto Piccioni
sui cosiddetti blocchi). Sul tema v. F. MODUGNO e D.
NOCILLA, Stato dassedio, in Nss. D.I., XVIII, 1971, ad vocem.
Costituzione della Repubblica italiana
laico (secondo una celebre espressione del gi
citato Ministro Scelba) (127). Le medesime tensioni e gli scontri anche fisici che laccompagnarono possono avere portato a definire un
attentato alla Costituzione lapprovazione della
legge elettorale, la cosiddetta legge truffa (l. 31
marzo 1953, n. 148), che, peraltro nella sola Camera dei deputati, prevedeva lassegnazione di un
premio di maggioranza alla coalizione che avesse
gi ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Il
timore, fondato o meno, che il premio elettorale
avrebbe potuto essere utilizzato, in assenza della
legge attuativa dei referendum, per rendere possibile alla maggioranza la modifica della Costituzione indicativo della non ancora consolidata
trama costituzionale (128).
Nel 1955 con lelezione di Gronchi alla Presidenza della Repubblica, nel 1956 con lavvio della
Corte costituzionale, e nel 1958 con linsediamento del Consiglio superiore della magistratura,
inizier il lento periodo del cosiddetto disgelo
costituzionale. Allinizio degli anni Sessanta
con il Congresso di Napoli del febbraio 1962 la
DC avrebbe superato i veti vaticani (giustificati
anche su basi dottrinarie) e si sarebbe posto il
tema dellallargamento delle basi democratiche
dello Stato (129). Con lavvento dei primi Governi
(127) La frase, che suscit molte polemiche, fu pronunciata in un intervento al Terzo Congresso della DC, a Venezia, il 6 giugno 1949. Per dare unidea del clima, traiamo
dalle cronache dellepoca (www.fondazionecipriani.it/kronologia) che quello stesso giorno a Vado di Fossalta, in
provincia di Ferrara, nel corso di uno sciopero, le forze di
polizia caricano i braccianti ferendone diciassette, dei quali
tre per colpi darma da fuoco; a Como si sciopera contro le
repressioni della polizia e larresto del segretario della Camera del lavoro; i giornali danno notizia di un rapporto della
Segreteria di Stato vaticana al Presidente Truman sulle
attivit sovversive dei comunisti, controllate bene dalla polizia bench la raccolta delle armi non possa considerarsi
completa (ma tutti quei mesi sono carichi di episodi simili).
(128) Cfr. G.G. AMBROSINI, La Costituzione italiana, Einaudi, Torino, 2005, LXI; sulla legge M.S. PIRETTI, La legge
truffa, Il Mulino, Bologna, 119 ss., ma v. anche F. ORLANDO,
Ma non fu una legge truffa, Cinque Lune, Roma, 1989, 61 ss.
Il drammatico dibattito al Senato ricostruito nel volume La
legge elettorale del 1953, in Dibattiti storici in Parlamento a
cura di G. QUAGLIARIELLO, Il Mulino, Bologna, 2003, 39 ss.
(129) Con riflessi anche sulla politica delle istituzioni:
come emerse nel Convegno di studi di Cadenabbia del
settembre 1965, aperto dalle Relazioni di Sergio Cotta e
Leopoldo Elia: Il ruolo dei partiti nella democrazia italiana,
Novecento Grafico, Bergamo, 1965. I veti vaticani erano
stati pi volte sostenuti dallallora Prefetto del Santo Uffizio
Cardinale Ottaviani (v. E. CAVATERRA, Il Prefetto del SantOffizio. Le opere e i giorni del Cardinale Ottaviani, Mursia,
Milano, 1990, passim), che aveva, peraltro, teorizzato la
necessit dello Stato confessionale, almeno nei Paesi a maggioranza cattolica: tale posizione fu espressa in un celebre
articolo pubblicato sullOsservatore Romano del 18 maggio
di centrosinistra la pratica politica e amministrativa diverr sempre meno in dissonanza con i
principi costituzionali e cesser quellostruzionismo di maggioranza secondo la celebre espressione di Piero Calamandrei (130) che aveva
ritardato lattuazione della Costituzione. Nel 1963
(con la l. 9 febbraio 1963, n. 66) sar consentito
lingresso delle donne in Magistratura, nello stesso
anno si avr listituzione della scuola media unica
ed altre misure in sintonia con i principi costituzionali.
B) Considerazioni analoghe (ed anzi ancora pi
marcate) possono essere svolte in riferimento alle
culture politiche della sinistra. Di indubbio rilievo il contributo alla Costituente dei comunisti e
dei socialisti. Non solo erano stati decisivi per la
sconfitta del fascismo e il passaggio dalla monarchia alla repubblica, ma contribuiranno costruttivamente ai lavori della Costituente anche dopo la
rottura dellunit antifascista, nel maggio del 1947,
e la loro estromissione dal Governo. Fu per netta
in quegli anni la dissociazione fra la prassi riformista di tali partiti e lorizzonte rivoluzionario mai
abbandonato del tutto (131). La difesa della Costituzione operata con vigore dal partito comunista, fino a farne una propria bandiera, non pu
fare dimenticare che altro era il suo orizzonte
finale, n pluralista, n socialdemocratico, n,
tanto meno, ispirato al costituzionalismo liberaldemocratico (132). Il partito aveva messo ai margini le posizioni pi radicali, ma tanta parte del
popolo comunista, cio il corpo del partito, era
su posizioni filosovietiche e guardava ancora con
speranza ai modelli dellEst europeo, fino a teoriz1960 dal titolo Punti fermi, che apparve di sostegno al
Governo Tambroni e contrario ad un possibile governo di
centrosinistra presieduto da Fanfani (tale articolo non
avrebbe avuto lapprovazione di Giovanni XXIII, secondo
Alberto MELLONI, Il Papa buono contro il SantUffizio, in
Corriere della Sera, 3 novembre 2007).
(130) P. CALAMANDREI, Lostruzionismo di maggioranza,
in Il Ponte, 1953, 129 ss. (ora anche in ID., Scritti e discorsi
politici a cura di N. BOBBIO, I, La Nuova Italia, Firenze, 1966,
546 ss.).
(131) Cfr. Giorgio NAPOLITANO, Intervista sul PCI a cura
di E.J. HOBSBAWM, Laterza, Roma-Bari, 1976, 9, per il quale
nessuno dubitava che lobbiettivo finale dovesse essere [...]
una trasformazione in senso socialista della societ .
(132) Cos M.L. SALVADORI, Storia dItalia e crisi di
regime (1994), Il Mulino, Bologna, 2001; L. CAFAGNA, Cera
una volta. Riflessioni sul comunismo italiano, Marsilio, Padova, 1991; sostanzialmente daccordo E. MACALUSO, Comunisti e riformisti. Togliatti e la via italiana al socialismo,
Feltrinelli, Milano, 2013, 12 ss., il quale tuttavia mette in
discussione la natura di partito antisistema attribuita al
PCI, non ricavabile dallorizzonte pur rivoluzionario e dal
legame con lURSS ed anzi contraddetta dallapporto alla
Costituente.
287
Costituzione della Repubblica italiana
zare la transitoriet delle istituzioni borghesi. Lo
stalinismo era stato peraltro largamente presente
anche fra gli intellettuali della sinistra, da Italo
Calvino ad Antonio Banfi a Renato Guttuso (133).
Limpianto marcatamente riformista delle norme
costituzionali mal si conciliava comunque con posizioni che ipotizzavano il passaggio dal capitalismo al socialismo. La Costituzione, soprattutto
nella parte relativa ai diritti economici , era
vista come conquista sulla via italiana al socialismo , cos mettendo laccento pi sulle nazionalizzazioni dellart. 43 che sulla libert di impresa
dellart. 41 (134). Altrettanto pu dirsi per il partito socialista, a sua volta teso fino allinizio degli
anni Sessanta alla costruzione di una societ socialista: cos veniva sancito nella stessa Risoluzione
del 34o Congresso di Milano (15 marzo 1961) in
riferimento alle possibilit consentite dal sistema
costituzionale attuale (135). Solo con il primo
centrosinistra e scontando una pesante scissione i
socialisti accetteranno di confrontarsi senza riserve
con leconomia di mercato (136). E solo con le
maggioranze di solidariet nazionale i comunisti
faranno altrettanto. In un saggio di Carlo Lavagna,
costituzionalista di punta del partito socialista (137), la Costituzione era ancora letta come
punto di partenza, anzi come possibile strumento,
per il passaggio ad una societ socialista: e non
era una posizione isolata.
C) Non minori le riserve in altri ceti sociali. Se
nei ceti proletari cera laspettativa che la costituzione fosse il prologo di una rivoluzione socialista sottolinea Giuliano Amato buona
parte dei ceti borghesi erano ancora legati al vec(133) Cfr. P. HOLLANDER, Pellegrini politici. Intellettuali
occidentali in Unione sovietica, Cina e Cuba, trad. it., Il
Mulino, Bologna, 1988. V. anche P. MELOGRANI, Legemonia
culturale della sinistra, in Prospettive nel mondo, n. 5, maggio
1990.
(134) P. PETTA, Ideologie costituzionali della sinistra italiana (1892-1974), Savelli, Roma, 1975, 75 ss.
(135) V., in allegato agli Atti del 34o Congresso, P.
NENNI, Problemi e prospettive della democrazia e del socialismo, Edizioni del PSI, Roma, 1961, 55. Nel senso indicato nel
testo v. G. AMATO e L. CAFAGNA, Duello a sinistra. Socialisti
e comunisti nei lunghi anni Settanta, Il Mulino, Bologna,
1982, passim.
(136) Sia pure corretta da nazionalizzazioni dei monopoli (ma si port avanti solo la nazionalizzazione delle
imprese elettriche) e da forme incisive di programmazione
economica ( di quegli anni la polemica sulla natura di tale
programmazione, se attraverso piani coercitivi o indicativi: v. A. PREDIERI, Pianificazione e Costituzione, Edizioni di
Comunit, Milano, 1964).
(137) C. LAVAGNA, Costituzione e socialismo, Il Mulino,
Bologna, 1977.
288
chio regime (138). Una parte non secondaria
delle organizzazioni padronali guardava con diffidenza al nuovo quadro costituzionale perch
troppo avrebbe concesso alle organizzazioni operaie e contadine, soprattutto in tema di libert di
sciopero e di organizzazione sindacale. Propositi
di revisione di parti della Costituzione furono,
anzi, per diversi anni, lobbiettivo di taluni gruppi
e ambienti imprenditoriali la reazione in agguato nel frasario della sinistra dellepoca (139)
che non mancarono, attraverso vari canali, di
sostenere movimenti volti al mutamento costituzionale, talvolta ai limiti delleversione (140). Fino
al clima nuovo creato dallo statuto dei lavoratori
(l. 20 maggio 1970, n. 300) non infrequentemente
ricorreva lespressione fascismo di fabbrica; frasario talvolta dettato da enfasi sindacale, talaltra da
effettivi comportamenti padronali che sostenevano organizzazioni sindacali di comodo o addirittura negavano lingresso in fabbrica dei diritti
costituzionali, fino ai licenziamenti per motivi politici e alle discriminazioni a danno di lavoratori
ritenuti attivisti sindacali o militanti delle sinistre.
I processi di modernizzazione delleconomia,
non ultimo lintreccio virtuoso fra lotte operaie e
sviluppo capitalistico, contribuiranno progressivamente a mutare il quadro, emarginando da una
parte e dallaltra le posizioni estreme. I diritti
costituzionali dei lavoratori, il diritto di sciopero o
la libert dellorganizzazione sindacale, saranno
visti sempre pi come strumenti necessari per
governare il conflitto sociale, utili alla stessa modernizzazione del sistema produttivo; saranno
sempre pi visti lo diciamo in breve , da
parte imprenditoriale, non pi come un ostacolo
alla libert di impresa e, da parte operaia, non pi
come uno degli strumenti della lotta di classe.
Questioni che fino allinizio degli anni Settanta
affaticavano i giuristi sulla liceit di talune forme
(138) G. AMATO, I sessantanni della Costituzione, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2008, 160.
(139) V., fra i tanti documenti, Assise per la difesa delle
libert democratiche. Per il rispetto e lapplicazione della
Costituzione repubblicana, Camera confederale del lavoro,
Bologna, 1955, 10 ss.
(140) Nel 1956 Confindustria, Confagricoltura e Confcommercio avevano dato vita ad una organizzazione, la
Confintesa, per intervenire nella battaglia politica sostenendo il partito liberale contro la Democrazia cristiana (ma
con risultati deludenti nelle elezioni politiche del 1958). Tale
organizzazione avrebbe anche sostenuto, in modo non trasparente (per cui il condizionale dobbligo), il movimento
di Edgardo Sogno (lo afferma lo stesso Sogno in A. PANNOCCHIA e F. TOSOLINI, Gladio. Storia di finti complotti e di veri
patrioti, Rossato Editore, Valdagno, 2009, 183), prosciolto
dallaccusa di golpismo ma certamente ostile alla Costituzione del 1948.
Costituzione della Repubblica italiana
di lotta sindacale appariranno sempre pi datate (141). Negli anni successivi, ovviamente, i
problemi non mancheranno ma atterranno piuttosto al diverso indirizzo da imprimere alla politica
economica e alla redistribuzione dei redditi. Fra i
problemi, tra gli altri, quelli derivanti dalla mancata attuazione dellart. 39 cost. lunica norma
della Costituzione del tutto inattuata, assieme allemarginato art. 46 (142) , o quanto meno dei
principi che lo sottendono, in primo luogo la
registrazione e laccertamento della rappresentativit delle varie organizzazioni sindacali.
Lo sviluppo di uneconomia aperta, resa possibile dalla Costituzione stessa e resa ancora pi
dinamica dallapertura dei mercati, conseguente
prima ai provvedimenti di liberalizzazione degli
scambi attuati nel 1951, poi dai primi effetti del
mercato comune europeo, favorir il cosiddetto
miracolo economico il prodotto interno
lordo crescer tra gli anni Cinquanta e Sessanta al
ritmo medio del 3,10 per anno e con esso
lulteriore consolidamento dei principi costituzionali.
9. La svolta del Sessantotto. La effervescenza sociale della primavera studentesca del
1968, le lotte dellautunno operaio dellanno
successivo, il successo delle iniziative referendarie
dei radicali produrranno nel corso degli anni Settanta una ulteriore espansione dei valori costituzionali. Una espansione notevole, anche se, a differenza dei movimenti studenteschi degli anni Novanta e Duemila, il richiamo simbolico alla Costituzione pur sempre borghese sar pressoch assente (143). Pur contrari al pluralismo,
ritenuta ideologia volta a svuotare le lotte della
classe operaia pluralismo versus classismo ,
non manc tuttavia il richiamo alle garanzie costituzionali; tale richiamo fu reso possibile dalla
sconfitta allinterno dei movimenti di quanti rifiutavano il garantismo borghese riconoscendo la
legittimit della repressione come corrispettivo del
diritto alla illegalit e alla violenza (144).
(141) In quegli anni erano vivacemente dibattuti i confini degli strumenti di lotta sindacale: v. C. cost. 4 maggio
1960, n. 29, sulla liceit penale della serrata, e i commenti
ospitati in varie riviste giuridiche, improntati a impostazioni
fra loro assai diverse.
(142) Ora rilanciati, dopo anni di ostilit, dal Segretario
della CGIL, Susanna Camusso, in Corriere della Sera, 14
agosto 2014.
(143) Cfr. RESCIGNO, Costituzione italiana e Stato borghese, cit., 13 ss.; L. FERRAJOLI e D. ZOLO, Democrazia autoritaria e capitalismo maturo, Feltrinelli, Milano, 1978.
(144) V. leditoriale della rivista Critica del diritto, n.
16-17, 1980, 5 ss., che riassume i termini del dibattito nella
La espansione dei valori costituzionali si muover in una duplice direzione: i diritti del lavoro e
i diritti civili, espressione questultima, peraltro,
fino ad allora estranea al costituzionalismo europeo e importato da Oltreoceano, dove da pi anni
fiorivano importanti movimenti per i Civil Rights;
ad essi si accompagner il disinteresse per la parte
della Costituzione relativa ai doveri, quasi una
damnatio memoriae (145).
Lo statuto dei lavoratori, approvato nel 1970
(l. n. 300, cit.), rappresenter stato detto
lingresso della Costituzione in fabbrica, completando e rafforzando alcune tendenze che si erano
gi manifestate nella giurisprudenza costituzionale
e ordinaria (146). Qualche anno dopo, la l. 9
dicembre 1977, n. 903 segner il passaggio dal
riconoscimento della parit formale tra uomini e
donne a provvedimenti orientati al raggiungimento di una maggiore eguaglianza (ma potrebbero ricordarsi listituzione degli asili-nido, con la
l. 6 dicembre 1971, n. 1044, e listituzione dei
consultori familiari, con la l. 29 luglio 1975, n. 405,
frutto di rivendicazioni dei movimenti femminili).
Parallelamente, con la riforma del diritto di famiglia la l. 19 maggio 1975, n. 151 sancir la piena
parit dei coniugi finalmente dando seguito allart.
29 cost. Alla fine di quel decennio, con la l. 5
agosto 1981, n. 442 giunger al traguardo la tormentata abrogazione degli art. 544, 587 e 592 c.p.,
che ne accennavamo prima (v. supra, 4)
prevedevano sia il matrimonio riparatore come
causa di estinzione di diversi reati contro la donna,
compresa la violenza carnale, sia pene ridotte per
il cosiddetto delitto donore.
Gli anni Settanta saranno, inoltre, contrassegnati da un sempre pi diffuso riconoscimento
legislativo di diritti civili talvolta non espressamente previsti dal testo costituzionale (e fra i
diritti politici il voto ai diciottenni) ma che il clima
di quegli anni contribuir a fare germogliare: linsinistra extraparlamentare. Nello stesso fascicolo, a difesa di
una interpretazione garantista del diritto, R. GUASTINI, Che
cosa il garantismo, 63 ss., nonch, per una critica da sinistra
al pluralismo, G.U. RESCIGNO, Mutamenti entro il meccanismo politico-costituzionale e ideologia del pluralismo in Italia,
7 ss.
(145) Lespressione di F. GRANDI, Doveri costituzionali
e obiezione di coscienza, Editoriale scientifica, Napoli, 2014
(le cui conclusioni tuttavia mettono talmente laccento sui
doveri da delegittimare le varie forme di obiezione di coscienza, alcune riconosciute proprio in quegli anni).
(146) Ma anche nella legge (v. l. 15 luglio 1966, n. 604).
Sul licenziamento senza giusta causa v. C. cost. 9 giugno
1965, n. 45 (poi seguita da C. cost. 10 giugno 1966, n. 63,
sulla imprescrittibilit dei crediti del lavoratore perdurando
il rapporto di lavoro).
289
Costituzione della Repubblica italiana
troduzione del divorzio (con la l. 1o dicembre
1970, n. 898); il diritto alla maternit consapevole
(con la l. 22 maggio 1978, n. 194, per linterruzione della gravidanza); il riconoscimento di varie
forme di obiezione di coscienza (con la l. 15
dicembre 1972, n. 772, per quella al servizio militare); la chiusura degli ospedali psichiatrici e il
superamento delle metodologie segregative per
affrontare i disagi mentali e psichici (con la l. 13
maggio 1978, n. 180). In quel periodo si determinano anche quei mutamenti significativi nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, cui
abbiamo fatto riferimento supra, nel 4. Paradossalmente, altrettanto non avverr per il diritto allo
studio per capaci e meritevoli previsto dallart.
34 cost., che avrebbe richiesto non solo adeguate
risorse finanziarie ma soprattutto una adesione ai
valori del merito, allora espressamente rifiutati
dai movimenti studenteschi e operai (147), perch
considerati fattore di ineguaglianza, e non ritenuti
risorsa produttiva dalle classi dirigenti.
A parte qualche marginale risultato, da quelle
battaglie non trassero vantaggio gli studenti ma
altre due categorie: le peggiori componenti corporative dei docenti (148) e i lavoratori pensionandi, creando gli squilibri generazionali che sarebbero esplosi negli anni Duemila: sono del 1969
il collegamento fra pensione e ultime retribuzioni
e laggancio delle stesse allindice del costo della
vita (con la l. 30 aprile 1969, n. 153); sempre di
quegli anni la previsione del pensionamento anticipato per i dipendenti pubblici (con il d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092) e la ulteriore moltiplicazione dei fondi pensionistici (149). Di questa mancata ricaduta sulle loro condizioni di vita gli studenti avranno modo di accorgersi qualche anno
dopo dando vita agli ancora pi radicali movimenti del 77 (150).
Prevalsero nei ceti intellettuali, imbolsiti da
fumisterie ideologiche, pigrizie e conservatorismi:
non si voleva tanto cambiare questa o quella po(147) G. VIALE, Contro lUniversit, in Universit: lipotesi rivoluzionaria. Documenti delle lotte studentesche. Trento
Torino Napoli Pisa Milano (Autori vari), Marsilio, Padova,
1968, 113.
(148) Cos U. ALLEGRETTI, Storia costituzionale italiana,
Il Mulino, Bologna, 2014, 175, che sottolinea lemergere in
quegli anni non di fattori di miglioramento ma solo di
espansione quantitativa dellistruzione superiore .
(149) Ne parlano P. BATTILANI e F. FAURI, Leconomia
italiana dal 1945 a oggi, Il Mulino, Bologna, 2014, 111 e 129
ss.; nonch G. AMATO e A. GRAZIOSI, Grandi illusioni. Ragionando sullItalia, Il Mulino, Bologna, 2013.
(150) Si trattato di movimenti meno colti, ma oppressi da bisogni materiali non soddisfatti: v. M. GRISPIGNI, Il
Settantasette, Il Saggiatore, Milano, 1997.
290
litica ma si voleva una palingenesi universale, un
cambiamento totale (polemizzando con i regimi
comunisti dellEst ma guardando alla rivoluzione
culturale maoista). A differenza di altre parti dEuropa, dove si seppero trovare risposte adeguate,
attingendo alla carica competitiva del sistema politico, si incoraggiarono le tendenze consociative,
furono esorcizzati i tentativi di accrescere le capacit di decisione delle istituzioni, fu abbandonata
la politica di programmazione, tentata agli inizi
degli anni Sessanta, e fu alimentata da non pochi
giuristi e costituzionalisti lillusione che fosse sufficiente espandere i diritti civili per rinnovare il
sistema politico. Parallelamente, da non pochi economisti fu coltivata lillusione che i problemi economici e sociali potessero risolversi con laumento
della spesa pubblica, anche incrementando il debito pubblico. Lo stesso squilibrio del Mezzogiorno venne inteso come problema di spesa pubblica non aiut peraltro la non felice formulazione dellallora comma 3 dellart. 119 cost. , in
contrasto con la migliore letteratura meridionalistica che fin dallunificazione puntava invece sulle
riforme politiche come strumento di riscatto
meridionale (151). Lunica riforma politica di quegli anni fu il varo delle Regioni ma contrassegnato
da quei limiti che la letteratura ha da tempo
sottolineato, e su cui torneremo pi avanti (v.
infra, 19).
10. La prova dei terrorismi. anche a
causa di queste risposte mancate che lItalia ha
conosciuto fenomeni di violenza politica che non
hanno precedenti per virulenza in Europa (152).
Lespressione anni di piombo tratta da un film
di Margarethe Von Trotta che riguardava gli anni
(151) Sono gli anni che vedono la rivolta di Reggio
Calabria (autunno 1970), o prima ancora i tragici fatti di
Avola (dicembre 1968) o di Battipaglia (aprile 1969): sul
punto v. S. COLARIZI, Storia dei partiti nellItalia repubblicana,
Laterza, Roma-Bari, 1994, 296 ss. La politica per il Mezzogiorno basata sulla spesa pubblica ha accresciuto i mali
tradizionali del Mezzogiorno, dal clientelismo al trasformismo, come emerge da specifiche indagini degli anni Sessanta
e Settanta, per esempio quelle dirette da Percy Allum a
Napoli, o da Caciagli a Catania o, pi in generale, quelle
condotte da L. Graziano, da S. Tarrow o da Ada Codill
(indicazioni bibliografiche in M. CACIAGLI, Democrazia cristiana e potere nel Mezzogiorno, Guaraldi, Rimini-Firenze,
1977, 305 ss.).
(152) Tanto da far parlare di guerra civile a bassa
intensit : v. Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria
del terrorismo italiano a cura di M. LAZAR e A.M. MATARDBONUCCI, Rizzoli, Milano, 2010; pi analitiche le ricerche
condotte dallIstituto Cattaneo a cura di Donatella Della
Porta, Gianfranco Pasquino, Raimondo Catanzaro, Luigi
Manconi ed altri, reperibili sul sito dellIstituto (www.cattaneo.org/it).
Costituzione della Repubblica italiana
bui del terrorismo in Germania, ma ben pi pesanti furono gli anni attraversati dallItalia sotto il
convergente attacco del terrorismo rosso, del terrorismo nero e delleversione stragista. Il terrorismo rosso e quello nero rappresentano fenomeni
certamente assai distanti ma che lo diciamo in
breve hanno avuto in comune la contestazione
e il rifiuto dei valori costituzionali.
Il terrorismo nero fu alimentato dallidea che
la Costituzione fosse stata un incidente della storia
nazionale, un cedimento ai comunisti e che
invece bisognasse aprire la strada alla instaurazione di uno Stato autoritario. Le deviazioni in
taluni apparati dello Stato (e le coperture politiche
che non mancarono in alcune occasioni) ne alimentarono le fonti, fino alle ancora oscure pagine dello stragismo e della strategia della tensione (153).
altrettanto noto che il terrorismo rosso
nasce, invece, dal mito della resistenza tradita ;
da una rivoluzione mancata a causa del compromesso costituzionale , per perseguire il quale i
comunisti e le forze della sinistra avrebbero tradito le potenzialit rivoluzionarie del proletariato (154). Lalbum di famiglia era nella sinistra
operaia ma erano pure presenti componenti cristiane integraliste, insofferenti alle mediazioni politiche (155). Anche in chi rifiutava decisamente
ogni contiguit con la lotta armata non mancavano
le contestazioni nei confronti della Costituzione
legge di uno stato che espressione del dominio
della classe borghese capitalistica (156), cui si
affiancava il tentativo di combattere queste posi(153) Per una sintesi v. G. DE LUTIIS, Il lato oscuro del
potere, Editori Riuniti, Roma, 1996.
(154) A. NEGRI, La forma Stato. Per la critica delleconomia politica della Costituzione, Feltrinelli, Milano, 1977.
(155) Fu unespressione di Rossana ROSSANDA, Il discorso sulla Dc, in Il Manifesto, 28 marzo 1978. Larticolo suscit un notevole dibattito e acceler nella sinistra un
ripensamento autocritico. Cfr. ad esempio U. CERRONI,
Societ di massa e violenza rossa . La sinistra deve liberarsi
di molti miti, in LUnit, 26 marzo 1978, 1, o ancora, nello
stesso giorno e sulla stessa pagina, P. BUFALINI, Tirarsi su le
maniche.
(156) Cos Uno Statuto per padroni e sindacati, Intervento del Comitato di difesa e di lotta contro la repressione
al Congresso nazionale dellAssociazione nazionale magistrati (Trieste, 10 settembre 1970), ora in Quaderni Piacentini. Antologia, 1968-1972, Edizioni Gulliver, Milano, 1978,
397. Nello stesso testo la l. n. 300 del 1970, che approva lo
statuto dei lavoratori, considerata sistematica negazione
del principio di eguaglianza e restrizione dei diritti fondamentali dei lavoratori (ivi, 391) puntando tutto sulla
promozione del sindacato e sulla cristallizzazione della sua
egemonia (ivi, 396). Le posizioni critiche e meno demolitorie parlavano di diritti non dei lavoratori, ma delle organizzazioni sindacali (PETTA, Ideologie costituzionali della
zioni rivalutando la Costituzione ma dando di essa
una lettura radicale (157).
E non mancavano dubbi anche in intellettuali
del campo moderato. In uno scritto della fine degli
anni Settanta, che allora stimol non pochi inquietanti consensi, Leonardo Sciascia si poneva la
domanda ma la Costituzione esiste ancora? ;
era il tentativo di giustificare la posizione di un
gruppo di prestigiosi intellettuali, riassunta con lo
slogan n con lo Stato n con le B.R. (158).
Alcuni di essi, peraltro, intendevano cos giustificare quei cittadini torinesi che, contravvenendo ad
un preciso dovere costituzionale, si erano rifiutati
di fare parte della Corte dassise che avrebbe
processato alcuni brigatisti.
Proprio il radicamento dei principi costituzionali ha consentito il superamento di prove cos
difficili; anzi, a parte iniziali sbandamenti e sottovalutazioni, la lotta contro i terrorismi, e la vittoria
che ne conseguita, ha contribuito a rinvigorire
ancor pi i valori costituzionali e a consolidare un
filo comune fra le forze politiche democratiche.
Quei partiti seppero togliere ai gruppi eversivi
ogni possibile base di massa rappresentando in
quella occasione lordine materiale della Costituzione. Lassassinio di Aldo Moro port vero
alla fine della collaborazione parlamentare fra
comunisti e democristiani ma rinsald, non spezz
il patto costituzionale.
Nonostante ricorrenti e tragici colpi di coda,
nonostante lazione di apparati deviati, la democrazia italiana ha vinto sul duplice fronte del terrorismo nero e del terrorismo rosso. E ha vinto
utilizzando le armi della Costituzione repubblicana. Non fu unimpresa facile; basti ricordare che
non solo lallora estrema destra parlamentare del
sinistra italiana, cit., 217 ed ivi citate le repliche della sinistra riformista, in particolare di Federico Mancini).
(157) V., per tutti, DALBERGO, ora Diritto e Stato tra
scienza giuridica e marxismo, cit.
(158) L. SCIASCIA, La Sicilia come metafora, intervista di
Marcel Padovani, Mondadori, Milano, 1979, 104 e 117, ma
posizioni analoghe furono espresse da Corrado Staiano,
Giorgio Bocca, Alberto Moravia, Camilla Cederna ed altri
aderendo ad un appello del quotidiano Lotta continua. In
quegli stessi anni Norberto Bobbio denunciava la presenza
di un cripto governo : ora in N. BOBBIO, La strage di Piazza
della Loggia, Morcelliana, Brescia, 2014, 43 ss., mentre il
volumetto La strage di Stato (Samon e Savelli, Roma, 1970)
mantiene una diffusione straordinaria e diventa la Bibbia
della sinistra extraparlamentare (di quello slogan qualche
anno dopo si approprier anche la destra extraparlamentare): cos B. TOBAGI, Una stella incoronata di buio. Storia di
una strage impunita, Einaudi, Torino, 2013, 228 e 229. Sulle
connivenze o sulle sottovalutazioni o sulle simpatie e talvolta
sulle complicit di diversi intellettuali pu, da ultimo,
essere utile la rassegna (invero alquanto acida) di M. GRINER,
La zona grigia, Chiarelettere, Roma, 2014.
291
Costituzione della Repubblica italiana
MSI ma anche una parte non secondaria dellopinione pubblica democratica compreso qualche
padre costituente dopo il rapimento di Moro (159)
ebbe financo a invocare la pena di morte, vale
a dire la sospensione di un principio fondamentale
della Costituzione (la prima in Occidente a bandire la pena di morte), vanto della tradizione
giuridica italiana, da Cesare Beccaria in poi. La
legislazione dellemergenza, prodotta tra gli anni
Settanta e i primi anni Ottanta, ha sfiorato i
confini dei diritti costituzionali ma come ha
riconosciuto la Corte costituzionale pi volte (160)
non li ha mai travolti. Forte di questa esperienza, lItalia uno dei pochi Paesi occidentali
che, dopo lattacco alle Twin Towers dell11 settembre 2001, e dopo la strage di Parigi del gennaio
2015, si limitata a ritoccare la propria legislazione senza ricorrere a strumenti speciali ai fini
della lotta al terrorismo internazionale, utilizzando
ancora una volta le sole armi consentite dalla
Costituzione (161).
11. La stagione del bipolarismo. Ancora
nella prima met degli anni Settanta Giovanni
Sartori individuava in Italia un sistema partitico
polarizzato , imperniato su un partito di centro
reso immobile e immobilizzante da due ali
partitiche, il PCI e il MSI, collocate su posizioni
antisistema . Pochi anni prima Leopoldo Elia
aveva individuato una vera e propria conventio ad
excludendum nei confronti del partito comunista:
essa si giustificava non solo per le posizioni di
politica estera ma anche, affermava Elia, per il
modo di interpretare i principi costituzionali (162).
La caduta nel 1989 del muro di Berlino
avrebbe definitivamente messo in crisi il vecchio
(159) La invocazione della pena di morte la mattina
stessa del 16 marzo 1978 attribuita a Ugo La Malfa: v.
M. TOLOMELLI, Di fronte alle BR e alla RAF: percezioni sociali
a confronto, in LItalia Repubblicana nella crisi degli anni
settanta, IV. Partiti e organizzazioni di massa a cura di F.
MALGERI e L. PAGGI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003,
445.
(160) Per esempio C. cost. 1o febbraio 1982, n. 15, ma
anche C. cost. 23 gennaio 1980, n. 1, C. cost. 13 febbraio
1985, n. 38 e C. cost. 3 luglio 1985, n. 194.
(161) Avanza dubbi (infondati per) M. GALFR, La
guerra finita. LItalia e luscita dal terrorismo (1980-1987),
Laterza, Roma-Bari, 2014.
(162) G. SARTORI, Bipartitismo imperfetto o pluralismo
polarizzato?, in Il sistema politico italiano a cura di P. FARNETI, Il Mulino, Bologna, 1973, 302; L. ELIA, La forma di
governo dellItalia repubblicana, ivi, 333. Trover fondate
queste posizioni anche Livio PALADIN, I principi fondamentali della Costituzione repubblicana: una prospettiva storica,
in Giur. cost., 1997, 3029 ss., ora in ID., Saggi di storia
costituzionale, cit., 145.
292
sistema politico e consentito la spinta che porter
prima al referendum del 9 giugno 1991 poi a quello
del 18 aprile 1993. Con il primo, su un oggetto
invero assai limitato (labolizione delle preferenze
multiple), si sarebbe manifestata una profonda
volont di riforma della politica; con il secondo
si sarebbe dato vita ad un sistema parzialmente
maggioritario e bi-polarizzante. Effetto, questultimo, ulteriormente rafforzato dalla introduzione
dellelezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti
delle Province (l. 25 marzo 1993, n. 81), voluta dal
Governo Amato sotto la spinta di unulteriore
iniziativa referendaria e, successivamente, dalla
elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali (l. cost. 22 novembre 1999, n. 1).
Nel febbraio del 1992, larresto di Mario
Chiesa, un modesto esponente politico socialista,
disposto dalla Procura di Milano, d lavvio allindagine denominata mani pulite, presto estesasi a
tutta Italia con effetti dirompenti per il sistema dei
partiti, in particolare per i partiti di governo. I
referendum elettorali e le iniziative della Magistratura avrebbero portato al crollo del vecchio sistema politico. Ma quelle due vicende ne saranno
non la causa (come la pubblicistica corrente vorrebbe) ma leffetto, essendosi realizzate ed essendo
divenute possibili grazie al vuoto politico determinato dalla progressiva rottura dei vecchi equilibri,
iniziata nel corso degli anni Ottanta, e a seguito
dellincapacit di rinnovarsi da parte di quello
stesso sistema politico.
Negli anni Novanta le forze politiche che avevano dato vita al patto costituzionale non ci sono
pi; perci neppure esiste pi quel sistema dei
partiti su cui si era retta la Repubblica per un
quarantennio. Il Governo Amato, a cavallo fra il
1992 e il 1993, assumer sempre pi le caratteristiche di un governo tecnico, espresso dal Presidente della Repubblica pi che dai partiti: sar,
come dir lo stesso Amato, lultimo dei governi
della prima repubblica e il primo dei governi della
seconda (163). Sar il Governo che affronter
lemergenza finanziaria avviando lo smantellamento del sistema delle partecipazioni pubbliche
su cui si era retto il precedente sistema economicofinanziario.
Evidenti gli aspetti positivi del mutamento in
senso bipolare del sistema politico, non pi para(163) G. AMATO, Un governo nella transizione. La mia
esperienza di Presidente del Consiglio, in Quaderni costituzionali, 1994, 355 ss. (ora in ID., Le istituzioni della democrazia,
Il Mulino, Bologna, 2014, 121 ss.).
Costituzione della Repubblica italiana
lizzato dal bipartitismo imperfetto (164). Esso
ha reso possibile, in un quadro di (sia pur tormentata) alternanza, laccesso al governo di tutte le
forze politiche, anche di quelle che si erano finora
limitate a prospettare alternative di regime. Agli
inizi degli anni Novanta cadono definitivamente i
muri che avevano diviso gli italiani fra comunisti e
anticomunisti, fra fascisti ed antifascisti e che avevano costretto i cattolici ad una forzata coabitazione in un unico partito. Non privo di significato che solo in quegli stessi anni potranno farsi
strada le analisi di Claudio Pavone sulla Resistenza
come triplice guerra, non soltanto come guerra
per il riscatto nazionale ma anche come lotta di
classe e come guerra civile. Il volume era stato
inizialmente rifiutato da diverse case editrici e fu
accolto con molte polemiche ma contribu a porre
le basi di una memoria comune (165).
Travolta la conventio ad excludendum, gli
eredi del partito comunista hanno contribuito a
sostenere in pi legislature i Governi della Repubblica ed un ex dirigente comunista, Massimo DAlema, ha anche assunto nel 1998 la Presidenza del
Consiglio. Negli stessi anni al Congresso di Fiuggi
del 1995 il Movimento sociale che per lungo
tempo aveva rappresentato quanti non si riconoscevano nella Costituzione antifascista, nata dalla
Resistenza proclama ladesione ai valori costituzionali, d vita ad una nuova formazione politica, Alleanza nazionale, e arriva a riconoscere
espressamente persino i meriti dellantifasci(164) Secondo la fortunata formula di Giorgio GALLI, Il
bipartitismo imperfetto, Il Mulino, Bologna, 1966.
Collegata a quegli equilibri politici la lettura della democrazia italiana come democrazia incompiuta, per la
mancata attuazione dei principi della Costituzione. Solo alla
fine degli anni Ottanta si far strada la lettura della democrazia bloccata per il mancato funzionamento del regime
di alternanza. La prima lettura era congeniale alla strategia
del compromesso storico, la seconda alimenter la strategia delle riforme istituzionali ed elettorali. La prima valorizzava pretese diversit positive della democrazia italiana, la
seconda denuncer invece i ritardi rispetto alle altre grandi
democrazie. Sul punto sia consentito rinviare a A. BARBERA,
Il blocco della democrazia e la politica istituzionale del PCI, in
Dem. dir., 1986, 25.
(165) C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla
moralit nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 1991
(il volume era stato rifiutato dalla casa editrice Einaudi e sub
le critiche aspre di Guido Quazza, Nuto Revelli, Giorgio
Bocca, Giulio Einaudi, ma fu difeso da Vittorio Foa, Norberto Bobbio, Natalia Ginzburg ed altri). Da ricordare che
Giulio Einaudi aveva negli anni Cinquanta inizialmente
censurato il titolo del saggio di Beppe Fenoglio Racconti
della guerra civile, uscito poi con altro titolo (I ventitr giorni
della citt di Alba), in quanto parlare di guerra civile
poteva significare legittimare i repubblichini (lepisodio fu
ricostruito da Luca BUFANO, Beppe Fenoglio e il racconto
breve, Longo, Ravenna, 1999).
smo (166). Alleanza nazionale parteciper ai Governi Berlusconi ed assumer con il leader Gianfranco Fini la Presidenza della Camera. Eppure,
fin dal 25 aprile del 1994, si moltiplicheranno le
manifestazioni contro la presenza degli eredi del
fascismo nei Governi nazionali, e a difesa della
Costituzione repubblicana, non tutti riconoscendo
che queste novit avevano leffetto di rafforzare,
non di indebolire il complesso dei valori e dei
principi costituzionali. La stessa Lega Nord, a sua
volta, grazie agli incentivi offerti dal sistema bipolare, mette sempre pi sullo sfondo gli originali
intenti secessionisti, concorrendo alla formazione
dei Governi Dini (1995) e Berlusconi (1994, 2001,
2008).
Non tutte le nuove forze politiche subentrate
presentano quei caratteri che la Costituzione assegnava ai partiti, dal partito-azienda messo in piedi
da Silvio Berlusconi ad altri partiti personali
costruiti attorno a leader. C stato un indubbio
mutamento nelle forme della politica che investe
lintero Occidente (su cui torneremo infra, 12):
come sottolinea Habermas, anche grazie alla influenza dei mezzi di informazione, in primo
luogo i mezzi televisivi , le organizzazioni politiche impostano la propaganda elettorale su strategie prevalentemente commerciali, procacciandosi legittimazione in base a inchieste demoscopiche che mettono tra parentesi [...] la formazione
dellopinione (167). Non va sottovalutato tuttavia che a partire dalla seconda parte degli anni
Novanta in poi si andato acuendo un conflitto fra
i nuovi soggetti politici, che ha lambito gli stessi
principi costituzionali. Ci riferiamo alla approvazione di testi di revisione costituzionale (che tuttavia va ribadito non toccavano la prima
parte della Costituzione) con il voto delle sole
maggioranze di governo: cos il centrosinistra nel
2001 e cos il centrodestra nel 2005 (riforma,
questultima, non confermata dal successivo referendum approvativo). Ci riferiamo altres alla contestata approvazione di leggi ordinarie ritenute
dalla Corte costituzionale in violazione della Costituzione (in particolare i cosiddetti lodi ad
personam, il lodo Schifani prima, l. 20 giugno
2003, n. 140, e il lodo Alfano dopo, l. 23 luglio
2008, n. 124). Ci riferiamo, soprattutto, allinfittirsi di ricorrenti tentativi di reciproche delegitti(166) Cfr. le cronache del Corriere della Sera, 26 gennaio 1995.
(167) Cos J. HABERMAS, Fatti e norme, nuova ed. it.,
Laterza, Roma-Bari, 2013, a p. VIII della Prefazione; in
termini analoghi D. MANIN, Principi del governo rappresentativo, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2010, passim.
293
Costituzione della Repubblica italiana
mazioni. Pi volte la nostra vita democratica
apparsa in affanno sia a causa di una non sempre
felice selezione delle nuove rappresentanze parlamentari sia a causa della lettura radicale del principio di maggioranza; ma i principi costituzionali e
le istituzioni repubblicane hanno reso possibile
superare questa difficile fase di transizione politica.
Sul piano giornalistico (e non solo) si parlato
di seconda Repubblica. Parti della letteratura
giuridica hanno sostenuto che la riforma del 2001
(l. cost. n. 3, cit.) ha segnato il passaggio ad un
assetto federale della Repubblica. Tali espressioni, pur diffuse, non hanno avuto nessun valido
supporto giuridico-costituzionale n, tanto meno,
corrispondenza con la realt; hanno rappresentato
anzi un cedimento lessicale e un segno di
debolezza culturale (168). improprio parlare
di seconda Repubblica perch, nonostante i mutamenti avvenuti nel sistema politico, i principi
costituzionali hanno retto ed hanno assicurato la
continuit dellordinamento. Una seconda Repubblica avrebbe richiesto non una revisione
ma un mutamento costituzionale. Tuttavia lincidenza sul sistema politico stata notevole, e pu
invece parlarsi di secondo sistema partitico distinto dal primo. Motivando alla Camera dei deputati le dimissioni del suo Governo avvenute il 19
aprile 1993, il giorno stesso della chiusura delle
operazioni elettorali, il Presidente del Consiglio,
Giuliano Amato, definisce il voto referendario
un autentico cambiamento di regime che fa morire dopo settantanni quel modello di partitoStato che fu introdotto in Italia dal fascismo, e che
la Repubblica aveva finito per ereditare, limitandosi a trasformare un singolare in plurale .
Ed altrettanto improprio parlare di assetto
federale perch, nonostante la infelice ri-scrittura
di alcune norme del Titolo V (torneremo sul
punto infra, 19), siamo di fronte ad una confusa
accentuazione dei tratti regionalisti ed autonomisti
della Costituzione repubblicana, non ad una sua
trasformazione in senso federale. Per raggiungere
questo obbiettivo sarebbe stata necessaria come
voleva inizialmente la Lega Nord una nuova
Costituzione votata da una Assemblea costituente
in rappresentanza delle comunit regionali federande. Questo non avvenuto e non rientra oggi
nei programmi di nessuna forza politica. Anzi il
superamento di taluni eccessi autonomistici della
riforma del Titolo V divenuto un tratto comune
(168) Cos P. SCOPPOLA, La Costituzione contesa, Einaudi, Torino, 1998, 92.
294
alle culture politiche prevalenti, preoccupate per
lindebolimento delle competenze dello Stato centrale.
In questo clima si inserisce la spinta di una
parte dello schieramento politico per il varo di
riforme, anche costituzionali, dellordinamento
giudiziario, divenuto oggetto di ricorrenti ed estenuanti polemiche. Su questi temi le discussioni
sono state accese e non sono mancate le reciproche delegittimazioni: da un lato laccusa di vocazioni autoritarie nei confronti di chi intende
modellare lordinamento della Magistratura ispirandosi (a torto o a ragione) a modelli propri di
altre democrazie o rivendicando (a torto) laprioristico primato sul potere giudiziario degli organi
investiti di un mandato popolare; dallaltro la simmetrica accusa di giustizialismo e di strumentalizzazione politica della magistratura nei confronti di chi (a torto o a ragione) intende mantenere lattuale assetto (169). Un tema troppo enfatizzato, e con toni accesi, con leffetto di trascurare
nellazione di governo i pi gravi problemi della
giustizia italiana: il cattivo funzionamento della
macchina giudiziaria, larcaicit delle procedure e
leccesso di garanzie formali, temi affrontabili con
la normale attivit legislativa. E altrettanto enfatizzato da quanti, con toni altrettanto accesi, nel
tentativo di salvaguardare lautonomia dei pubblici ministeri dal potere politico, non hanno voluto considerare che la separazione delle carriere
fra organi giudicanti e magistrature requirenti, pur
se discutibile, non sconvolgerebbe i principi fissati
dalla Costituzione del 1948 ma sarebbe possibile
anche con legge ordinaria, come sancito dalla
Corte costituzionale (170). Un tale clima politico
ha impedito una riforma organica dellordinamento giudiziario voluta fin dalla VII disposizione
transitoria della Costituzione (171) ma non riusc
ad impedire nel 1999 una convergenza pressoch
unanime su una nuova formulazione dellart. 111
cost. (con la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) che,
con un taglio insolitamente analitico, ha introdotto
alcuni principi innovativi (riassunti sommariamente con lespressione giusto processo).
Nonostante qualche ferita, nonostante sulla
(169) Sul punto rinviamo alle equilibrate osservazioni di
un magistrato: cfr. V.M. CAFERRA, La giustizia e i suoi nemici,
Cacucci, Bari, 2010, 39 ss.
(170) C. cost. 7 febbraio 2000, n. 37.
(171) Prima la legge Castelli (l. 25 luglio 2005, n. 150)
poi la legge Mastella (l. 30 luglio 2007, n. 111, che ha in parte
abrogato alcune disposizioni della prima) non hanno consentito risultati significativi ma anzi sono state occasione di
scontri fra i due schieramenti e con lAssociazione dei magistrati.
Costituzione della Repubblica italiana
svolta bipolare abbiano pesato negativamente i
caratteri rusticani che ha assunto la competizione
politica (i toni di una perenne propaganda elettorale, gli scontri fra opposte tifoserie), non
azzardato giungere alla conclusione che, anche in
questa fase, siamo stati di fronte per essere
brevi non ad una sconfitta della Costituzione
ma ad una sua vittoria. Rispetto ad una certa
letteratura costituzionalistica che lo dicevamo
prima considera compromessi i principi costituzionali, noi crediamo che vadano sottolineati,
piuttosto, due risultati: a) grazie al quadro costituzionale si avuta la progressiva legittimazione
costituzionale di tutte le forze politiche, prima
escluse, assicurando Governi di alternanza politica; b) in questo delicato passaggio hanno svolto
un ruolo positivo proprio le garanzie volute dai
Costituenti, e pi volte assicurate dal Presidente
della Repubblica, dalla Corte costituzionale, dalla
Magistratura, appunto richiamandosi al testo costituzionale.
12. La progressiva atrofizzazione dei partiti.
A fronte di principi costituzionali sempre pi
saldamente radicati, un grave motivo di sofferenza
della Costituzione offerto invece dalla crescente
crisi dei partiti, manifestatasi fin dalla fine degli
anni Settanta. Nel secolo dellUnit il principale
motivo di sofferenza democratica fu rappresentato
dalle fazioni parlamentari e dallassenza di partiti
politici strutturati nella societ. Innovando sulle
Costituzioni liberali, la Costituzione italiana, seguita lanno successivo da quella tedesca, aveva
dato rilievo costituzionale ai partiti politici, attraverso i quali i cittadini avrebbero potuto concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale (art. 49). Non era solo la presa
datto di una profonda innovazione nelle forme
della rappresentanza politica, conseguente alla
estensione del suffragio elettorale (172), presente
in tutta Europa. Vi era molto di pi: il contributo
dei partiti alla Resistenza e alla liberazione dellItalia dal fascismo, la funzione di governo assunta nel
periodo 1943-1945, la decisiva presenza degli
stessi nella Assemblea costituente (173). Una funzione costituente dei partiti, quindi, come appa(172) Ne abbiamo parlato in A. BARBERA, La rappresentanza politica: un mito in declino?, in Quaderni costituzionali,
2008, 853 ss., e in ID., Relazione di sintesi, in Partiti politici
e societ civile a sessantanni dallentrata in vigore della
Costituzione (Atti del XXIII Convegno annuale della Associazione italiana dei costituzionalisti, Alessandria, 17-18 ottobre 2008), Jovene, Napoli, 2009, 343-368.
(173) P. SCOPPOLA, La Repubblica dei partiti. Evoluzione
e crisi di un sistema politico 1945-1996, nuova ed., Il Mulino,
rir anche dalla decisione degli stessi di non sottoporre il testo costituzionale ad un referendum
popolare, non solo perch paghi del referendum del
2 giugno ma perch coscienti del loro ruolo rappresentativo. Una presenza che tender ad occupare tutto lo spazio del discorso pubblico mentre
lidentit nazionale finir per essere totalmente
surclassata dalle identit politiche (174).
Sia pure frenato dal blocco della democrazia, notevole si mantenne per alcuni decenni il
protagonismo dei partiti politici. In occasione dei
tragici fatti del luglio 1960, ad esempio, quando
sembr che le istituzioni repubblicane potessero
vacillare, furono i partiti, e non gli organi costituzionali, a salvaguardare lordine repubblicano, costringendo alle dimissioni il Governo Tambroni (175). Ancora nel 1978, dopo il rapimento e
lassassinio di Aldo Moro, i partiti riuscirono a
svolgere una funzione non meno vigorosa e condivisa nella lotta al terrorismo e allo stragismo.
La crisi del sistema partitico ha tuttavia una
genealogia antica e complessa; un elemento di
debolezza di tale sistema aveva avuto modo di
manifestarsi fin dai primi anni di vita repubblicana. Il sistema politico italiano fu presto tormentato dalla ricerca del consenso attraverso metodi
clientelari e spartitori, da degenerazioni correntocratiche (176) e da forme non trasparenti di
finanziamento denunciate gi in Assemblea
costituente (177) , favorite anche dal sistema
Bologna, 1997 (1a ed., 1991, con riferimento al periodo
1945-1990).
(174) Cos E. GALLI DELLA LOGGIA, Lidentit nazionale
nella storia repubblicana, in Interpretazioni della Repubblica a
cura di A. GIOVAGNOLI, Il Mulino, Bologna, 1998, 45 (tesi
allinterno di una pi ampia posizione revisionista di
questo autore iniziata con la pubblicazione di ID., La morte
della Patria, Laterza, Roma-Bari, 1996).
(175) Lo mette in rilievo, riprendendo unanalisi di
Silvano Tosi, Giovanni SPADOLINI, Introduzione a S. TOSI, La
Repubblica alla prova, Le Monnier, Firenze, 1990, X; v.
anche R. GUALTIERI, LItalia dal 1943 al 1992. Dc e Pci nella
storia della Repubblica, Carocci, Roma, 2006.
Sulla vicenda v. ora C. PINELLI, Cinquantanni dopo:
Gronchi, Tambroni e la forma di governo, in Quaderni costituzionali, 2010, 757 ss.
(176) L. DAMATO, Correnti di partito e partito di correnti, Giuffr, Milano, 1964.
(177) La Costituente stessa dovette dare vita ad una
Commissione di inchiesta sui fatti denunciati dallonorevole
Finocchiaro Aprile, leader del Movimento per lindipendenza della Sicilia, a carico dei futuri Ministri Ezio Vanoni e
Pietro Campilli. La Commissione si chiuse con conclusioni
equivoche; fu poi il dibattito in Assemblea a scagionare i due
Ministri, grazie al voto di una larga maggioranza in cui
confluivano democristiani, comunisti, socialisti con lastensione dei liberali, dei repubblicani, dei saragattiani e il voto
contrario dei qualunquisti. La vicenda ripercorsa, assieme
ad altre degli anni successivi (in particolare lo scandalo dei
295
Costituzione della Repubblica italiana
proporzionale e dal voto di preferenza, cause non
ultime della progressiva diffusione della corruzione politica e della successiva esplosione di Tangentopoli. Ma soprattutto a partire dai primi anni
Ottanta lannebbiamento dei tradizionali cleavages, il tramonto delle ideologie, la tendenza degli
interessi ad autorappresentarsi, linfluenza dei
mass-media, sempre pi divenuti canali di trasmissione della domanda politica, attraverseranno
lOccidente e colpiranno la funzione rappresentativa dei partiti e la loro stessa credibilit (178).
Non minore lincidenza delle politiche neoliberiste, interessate in quegli anni a deprimere la funzione della politica, vista come ostacolo al libero
espandersi delle forze economiche.
Nonostante linsistita contrapposizione ai partiti di una mitizzata societ civile, frequente
negli anni Ottanta e Novanta, la crisi dei partiti era
in realt il riflesso della crisi di valori della stessa
societ di cui essi erano espressione. Il vuoto lasciato dalle ideologie respinte in quanto metanarrazioni , il rifiuto della ricerca di letture
unitarie accusate di finalismo , in breve
le tendenze della cultura post-moderna (179), avevano tolto ai partiti (sempre meno organizzati e
definiti liquidi con un neologismo di moda) ogni
linfa vitale. Un fenomeno non solo italiano ma
particolarmente accentuato al di qua delle Alpi.
Per richiamare unatmosfera: del 1981 la questione morale sollevata da Enrico Berlinguer;
sono degli stessi anni sia la campagna per il partito degli onesti condotta da Eugenio Scalfari, sia
le grida di allarme di Beniamino Andreatta per il
vincolo incestuoso fra i partiti, le amministrazioni, le banche e le imprese pubbliche (180). in
quegli stessi anni che emerger con virulenza
quello stretto intreccio fra politica, affari e criminalit (basti citare il caso Sindona, o la vicenda del
Banco ambrosiano o quelli legati alla torbida figura di Licio Gelli) che, con un andamento carsico, contrassegner ancora per diversi decenni la
finanziamenti dellIstituto nazionale gestione imposte di consumo-INGIC), da DANTONIO, La costituzione di carta, cit.,
163, nonch da O. BARRESE e M. CAPRARA, Lanonima DC.
Trentanni di scandali da Fiumicino al Quirinale, Feltrinelli,
Milano, 1977.
(178) Il fenomeno fu subito colto da P. FARNETI, Partiti
e sistema di potere, in LItalia contemporanea (1945-1975) a
cura di V. CASTRONOVO, Einaudi, Torino, 1976.
(179) Il riferimento dobbligo a Jean-Franois LYOTARD, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, trad.
it., Feltrinelli, Milano, 1981, 6 ss.
(180) Lintervista di Berlinguer con E. Scalfari in La
Repubblica, 28 luglio 1981; le dichiarazioni di Andreatta ivi,
3 gennaio 1986; sul partito degli onesti v. LUnit, 16
dicembre 1991.
296
vita politica italiana. Fenomeni questultimi che
hanno inquinato le stesse amministrazioni, nazionali e locali, tanto da mettere in discussione quella
autonomia della pubblica amministrazione che i
Costituenti avevano voluto fissare nellart. 97 cost.
e su cui aveva insistito Mortati nel delineare i
caratteri della Costituzione repubblicana. La lottizzazione e loccupazione dello Stato furono considerate allepoca non un fenomeno di arroganza
ma un tentativo disperato di sopravvivenza.
Negli anni Ottanta, i primi cauti tentativi di
autoriforma dei partiti (la DC con la Segreteria De
Mita tent la carta degli esterni, il PCI quella
degli indipendenti di sinistra) e lavvio di alcune
riforme costituzionali fra cui il tentativo della
dianzi citata Commissione parlamentare per le
riforme istituzionali (cosiddetta Commissione
Bozzi, istituita nel 1983), la legge sulla Presidenza
del Consiglio (l. n. 400 del 1988), il superamento
nelle Assemblee parlamentari del ricorso generalizzato al voto segreto, labolizione dellInquirente costeranno la vita a Roberto Ruffilli,
tragicamente assassinato per il ruolo avuto in tali
progetti, ma saranno presto assorbiti da un quadro
politico stagnante. I primi segni di crisi si avranno
con la crescita elettorale delle Leghe e con il
successo inaspettato del referendum sulla preferenza unica del giugno 1991.
Negli anni Novanta, il passaggio al sistema
maggioritario e bipolare imposto ai partiti da
movimenti della societ civile, proprio come antidoto alla crisi e alla degenerazione della politica
avrebbe potuto portare ad un rafforzamento
delle istituzioni, ma il perdurante indebolimento
dei partiti far riemergere, accanto a tentazioni
termidoriane, alcune delle pratiche trasformistiche che avevano inciso sullo Stato italiano nei
suoi primi cinquanta anni di vita (181). Basterebbe
citare le molte decine di rapidi passaggi di fronte
che hanno contrassegnato il Parlamento italiano
nel biennio 1994-1995 dopo la caduta del primo
Governo Berlusconi o nel 1998 allatto della formazione del primo Governo DAlema o le mano(181) Abbiamo approfondito il tema in A. BARBERA, Fra
governo parlamentare e governo assembleare: dallo Statuto
albertino alla Costituzione repubblicana, in Quaderni costituzionali, 2011, 9 ss. Per una rivalutazione di talune virt
democratiche del trasformismo (in particolare gli effetti di
integrazione delle ali politiche) v. invece A. MANZELLA, Sul
trasformismo, in Nuova Antologia, n. 229, 2004, 71 ss. (
anche introduzione a F. VANDER, La democrazia in Italia.
Ideologia e storia del trasformismo, Marietti, Genova, 2004,
che, al contrario, vede nel trasformismo una perniciosa
ideologia italiana ).
Costituzione della Repubblica italiana
vre che hanno accompagnato la vita del secondo
Governo Prodi (2006-2008).
I partiti rappresenteranno sempre meno quelle
formazioni associative cui, lo dicevamo sopra, si
riferisce lart. 49 cost. Sempre pi prenderanno
spazio partiti personali, legati alla figura di un
personaggio politico (cosa ben diversa dalla positiva emersione di leadership politiche) (182). Gli
stessi rimedi che saranno previsti dagli anni Novanta in poi, da alcuni partiti, per sopperire alla
crisi di partecipazione le elezioni primarie in
primo luogo o le consultazioni via web metteranno ancora pi in rilievo la loro trasformazione
da partito degli associati, come presupposto
dallart. 49 cost., a partito degli elettori, se non
la loro riduzione a meri comitati elettorali (quali
erano nello Stato liberale). Dalla presenza ipertrofica dei partiti si passer alla loro progressiva
atrofia.
A partire dalla fine del primo decennio degli
anni Duemila la crisi dei partiti si accentua ulteriormente. In quegli anni si accentua ancor pi la
crisi politica e si moltiplicano e aggravano, non
solo in Italia, le tendenze populiste e la contestazione delle stesse istituzioni parlamentari, rappresentata sia dal crescente astensionismo elettorale sia dal successo di formazioni elettorali di
pura protesta (183). Concorrono ad alimentare tali
fenomeni da un lato la recessione economica e
dallaltro lindebolimento della sovranit nazionale, per effetto e della moneta unica e dei processi di globalizzazione, che hanno aggravato la
sensazione di impotenza delle istituzioni politiche,
peraltro affidate ad un ceto politico mostratosi
incapace e per di pi inquinato da forme, anche
clamorose, di malversazione (184).
(182) Cfr. M. PROSPERO, Il Partito politico. Teoria e
modello, Carocci, Roma, 2012, il quale non sempre riesce a
distinguere i due fenomeni: lemersione di una leadership che
superi la frammentazione correntizia cosa ben diversa dalla
formazione di partiti occasionali attorno ad un personaggio.
Non ha senso quindi attribuire alle forme di democrazia
immediata perseguite con le elezioni dirette di Sindaci e
Presidenti di Regione uno dei fattori della crisi. Tali elezioni
dirette sono state perseguite, peraltro, proprio per sopperire
alla crisi dei partiti. Sulla medesima lunghezza donda S.
LUPO, Antipartiti. Il mito della nuova politica nella storia della
Repubblica (prima, seconda e terza), Donzelli, Roma, 2013.
(183) Un utile panorama dei populismi in Europa in
The Changing Faces of Populism. Systemic Challengers in
Europe and the U.S. a cura di H. GIUSTO, D. KITCHING e S.
RIZZO, Graro, Roma, 2013.
(184) Il successo del Movimento Cinque Stelle nelle
elezioni politiche del 2013 non ha portato alla contestazione
diretta dei principi costituzionali cui anzi quel movimento
pi volte dir di richiamarsi, anche ricorrendo a forme
estreme di protesta ma mette in luce una marcata crisi
I ripetuti interventi per una diversa regolamentazione (l. 6 luglio 2012, n. 96), e poi labolizione,
del finanziamento pubblico dei partiti (in ultimo il
d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con
modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, del
Governo Letta) sono stati il tentativo di reagire al
diffuso clima di sfiducia, e non poche volte di
ostilit, nei confronti dei partiti e degli stessi parlamentari. Una risposta, peraltro, giunta in grave
ritardo rispetto al referendum abolizionista del
1978 (respinto per pochi voti grazie allelettorato
delle Regioni rosse) e a quello largamente vittorioso del 1993 (cui aggiungere il 71 per cento di
voti favorevoli allabrogazione nel referendum del
2000, che tuttavia non raggiunse il quorum), disatteso, nella sostanza, dai provvedimenti degli anni
successivi, che avevano trasformato i contributi ai
partiti in fittizi rimborsi elettorali (185).
Siamo oltre la debolezza dei partiti che aveva
caratterizzato i decenni precedenti e oltre i ricorrenti fenomeni di contestazione che percorrono
altri Paesi dellOccidente (186). Parlare di progressiva eclissi della politica eccessivo ma non
vanno sottovalutate le citate e ricorrenti esplosioni
di antipolitica (ieri per effetto del qualunquismo
di destra o del movimentismo di sinistra, oggi per
effetto di reazioni indistinte alla cattiva politica),
talvolta sfruttate dagli stessi partiti per miopi calcoli elettorali, e di un mai sopito antiparlamentarismo (187), i cui ritorni possono coinvolgere lo
stesso quadro costituzionale e colpire i valori della
Costituzione. Con la crisi dei partiti e il superamento dellarco costituzionale cambier progressivamente anche il modo di leggere la Carta costidella rappresentanza, in nome della pretesa superiorit di
una equivoca democrazia diretta, e mette ancora pi in
evidenza le debolezze della forma di governo italiana che i
partiti politici tradizionali (pre e post-transizione) non sono
stati ad oggi in grado di riformare. Per di pi ha messo in
forse il consolidamento della bipolarizzazione del sistema
politico.
(185) L. STROPPIANA, Finanziamento dei partiti politici e
delle campagne elettorali: modelli a confronto, tesi di dottorato in diritto costituzionale, Universit degli Studi di Bologna, ciclo 25, 2013, consultabile allindirizzo web http://
amsdottorato.unibo.it/5767 (in corso di stampa); da ultimo
M. RUBECHI, La trasparenza nel finanziamento della politica
tra esigenze di controllo e metodo democratico, in Le nuove
frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale a
cura di L. CALIFANO e C. COLAPIETRO, Editoriale scientifica,
Napoli, 2014, 137 ss.
(186) R. LASCH, La ribellione delle lites. Il tradimento
della democrazia, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2001.
(187) Pulsioni ampiamente presenti allinizio del secolo
scorso: v. T. FROSINI, Lantiparlamentarismo e i suoi interpreti, in Rass. parl., 2008, 845 ss., nonch in Il diritto fra
interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angelo
Antonio Cervati, Aracne, Roma, 2010, 359 ss.
297
Costituzione della Repubblica italiana
tuzionale: non pi in unottica politica, quale
complesso di indirizzi da attuare per via legislativa,
ma torneremo sul punto nei 20 e 21 da
vivere in modo sempre pi prevalente nei Tribunali (188).
13. I principi dello Stato sociale, fra Costituzione e globalizzazione. Come abbiamo cercato
di sottolineare, la maggior parte dei principi costituzionali ha mantenuto, ed anzi accresciuto, il
proprio radicamento. Altrettanto pu dirsi per i
principi dello Stato sociale fissati dalla Costituzione? giustificato il lamento su una pretesa
regressione dellordinamento rispetto al quadro
costituzionale (189)? Non riteniamo giustificata
una simile conclusione. LItalia riuscita a mantenere integri i diritti sociali (se si fa eccezione per
le prestazioni pensionistiche incompatibili con
laumento delle aspettative di vita) nel periodo in
cui nellOccidente spesa pubblica in eccesso e alta
inflazione portavano a politiche neoliberiste, volte
a ridurre il perimetro dello Stato sociale. In particolare, la giurisprudenza della Corte costituzionale
riuscita a contemperare con equilibrio la salvaguardia del testo costituzionale con le trasformazioni delleconomia italiana e la crisi dello Stato
sociale (190). Nello stesso tempo la giurisprudenza
ordinaria ha sempre pi individuato nei diritti
sociali situazioni incomprimibili di fronte a cui
devono cedere i vincoli legislativi, non solo sollecitando il giudice di legittimit costituzionale ma
spesso tutelando gli stessi attraverso un intervento
o diretto o indiretto, questultimo nelle forme del
risarcimento del danno (non patrimoniale) (191).
Ancora pi in evidenza in questi ultimi anni lintervento del giudice amministrativo, trattandosi
spesso di diritti la cui soddisfazione legata a
complesse attivit organizzative delle pubbliche
amministrazioni (192).
(188) FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale, cit.,
303.
(189) Uneco in I diritti sociali dal riconoscimento alla
garanzia. Il ruolo della giurisprudenza a cura di E. CAVASINO,
G. SCALA e G. VERDE (Atti del Convegno del Gruppo di Pisa,
Trapani, 8-9 giugno 2012), Editoriale scientifica, Napoli,
2013, e in www.gruppodipisa.it.
(190) Utile al riguardo la rassegna di S. BARTOLE, Giustizia costituzionale (linee evolutive), in questa Enciclopedia,
Annali, VII, 2014, 502 ss. e letteratura ivi citata, cui adde L.
CALIFANO, Relazione di sintesi al XXVIII Convegno dellAIC:
in tema di crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista
AIC, www.rivistaaic.it, 2013, n. 4.
(191) Cfr. E. LAMARQUE, Lattuazione giudiziaria dei diritti costituzionali, in Quaderni costituzionali, 2008, 270 ss.,
nonch i vari contributi in I diritti sociali dal riconoscimento
alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, cit.
(192) A. MANGIA, Attuazione legislativa e applicazio-
298
Ma c da aggiungere un motivo pi di fondo.
Non c stata nessuna regressione rispetto al quadro costituzionale perch la legislazione dei decenni successivi era andata al di l delle caute
formulazioni costituzionali. Il modello di Stato
sociale disegnato dal Costituente, pur animato da
importanti e generose proclamazioni, era confuso
e ben lontano dal modello universalistico di
Welfare che sulla scorta del Piano Beveridge iniziava il suo cammino nei Paesi del Nord Europa (193) mentre stata proprio la legislazione
ordinaria che ha tentato (e tenta) di colmare tale
lacuna. Due riferimenti lo dimostrano.
Il primo: lart. 32 cost. riconosce il diritto alle
cure gratuite solo agli indigenti mentre un
notevole passo in avanti stato compiuto dal
legislatore ordinario con la l. 23 dicembre 1978,
n. 833 dando vita ad un impianto universalistico del servizio sanitario nazionale, ispirato al
modello inglese, che oggi viene invidiato da diversi Paesi (non ultimi gli USA di Clinton e di
Obama) (194). Il secondo: lart. 38 cost. al comma
1 prevede un diritto dei cittadini all assistenza sociale mentre al comma 2, per i casi di
infortunio, malattia, invalidit e vecchiaia, disoccupazione involontaria , fa riferimento non ai
cittadini ma ai lavoratori . Non appare chiara la
distinzione fra i cittadini , cui sarebbero riservate prestazioni di assistenza sociale , e i lavoratori , cui spetterebbero anche quelle di
previdenza sociale . Tale incertezza avrebbe
potuto essere colmata sulla base dei lavori della
Commissione DAragona, incline ai modelli universalistici, ma la cui attivit fu ostacolata lungo
tutto il 1947 da resistenze di vario titolo, da quelle
sindacali e confindustriali a quelle politiche, rene giudiziaria del diritto alla salute, in Dir. pubbl., 1998,
751 ss.
(193) Peraltro il cosiddetto Piano Beveridge, varato nel
1942, inizi a circolare in Italia subito dopo la caduta del
fascismo in una edizione in lingua italiana (Sir William
BEVERIDGE, Compendio ufficiale della relazione al governo
britannico, Stamperia Reale, Londra, 1943).
Ebbero pi rilievo la rivoluzione promessa di cui al
comma 2 dellart. 3 cost. e il riconoscimento di specifici
diritti sociali. Mentre il Piano Beveridge era agli esordi e non
erano ancora ben compresi gli echi del New Deal nordamericano, i diritti sociali trovavano precedenti importanti in
altri ordinamenti costituzionali liberaldemocratici: in particolare attorno agli anni Trenta nella Costituzione di Weimar
e in quella della seconda Repubblica spagnola (o negli anni
Venti in quella cecoslovacca), pur sfortunate ma innovative
rispetto alle tradizionali costituzioni liberali (v. P. FLORA,
Benessere (Stato del), in Enciclopedia delle scienze sociali, cit.,
I, 1991, ad vocem).
(194) V. R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in Dizionario
di diritto pubblico diretto da CASSESE, cit., VI, ad vocem.
Costituzione della Repubblica italiana
stie ad abbandonare il particolarismo categoriale (195). Non a caso il testo costituzionale sembra riflettere i limiti della attuale disciplina degli
ammortizzatori sociali, previsti solo a favore di
una minoranza di lavoratori dellindustria (196),
tradizionalmente considerati laristocrazia operaia, allavanguardia nelle lotte sociali. E sembra
riflettere i vecchi limiti della assistenza sanitaria
assicurata agli indigenti tramite le condotte
comunali ma assicurata ai lavoratori dipendenti ed
autonomi tramite le mutue di categoria. Nel
ventennio successivo alla approvazione della Costituzione, andando opportunamente oltre il testo
costituzionale, il legislatore ha consolidato i diritti
dei lavoratori subordinati e ha esteso i diritti previdenziali anche ai coltivatori diretti (l. 26 ottobre
1957, n. 1047), agli artigiani (l. 4 luglio 1959, n.
463), ai commercianti (l. 22 luglio 1966, n. 613).
Nel 1969, traducendo in prestazione para-previdenziale una misura assistenziale, venne anche
introdotto lassegno sociale per gli anziani senza
pensione e senza reddito. Sono invece rimaste un
problema insoluto le prestazioni per cittadini inoccupati e disoccupati. Limiti che altre democrazie
europee hanno progressivamente superato attraverso interventi di tipo universale, i pi vari ma
riassumibili con lespressione reddito di cittadinanza (197). In assenza di un modello universalistico cresciuta disordinatamente la spesa pubblica alimentando decine di enti previdenziali e
disperdendo risorse per fare fronte alle crisi occupazionali. Come stato sottolineato, negli anni
del miracolo economico iniziata la costruzione
dello stato sociale senza un modello generale di
(195) V. I. MASULLI, Dalla Commissione DAragona del
1947 alla Commissione Onofri del 1997: cinquantanni di
progetti di riforma disattesi, Relazione al Convegno Astrid,
Fondazione Gorrieri e Istituto per la ricerca sociale su La
riforma del welfare. Dieci anni dopo la Commissione Onofri , Roma, 4 dicembre 2007, in www.fondazionegorrieri.it; nonch F. MAZZINI, Il sistema previdenziale in Italia fra
riforma e conservazione: gli anni della Costituente, in Amministrazione pubblica e istituzioni finanziarie a cura di A. ORSI
BATTAGLINI, Il Mulino, Bologna, 1980, 447 ss.
(196) A tuttoggi solo il 31 per cento dei lavoratori
coperto dalla cassa integrazione, ordinaria e straordinaria,
finanziata dalle contribuzioni di imprese e lavoratori. La crisi
degli anni 2000 ha reso necessario un terzo tipo di interventi,
in deroga, per le categorie non protette, ma precariamente
finanziati con erratici stanziamenti a carico della fiscalit
generale.
(197) Una comparazione fra i modelli europei nei vari
saggi racchiusi in Welfare scandinavo, welfare italiano a cura
di P. BORIONI, Carocci, Roma, 2006; v. anche C. TRIPODINA, Il
diritto ad una esistenza libera e dignitosa. Sul fondamento
costituzionale del reddito di cittadinanza, Giappichelli, Torino, 2013.
riferimento (198). Lart. 38 cost., infatti, fin dal
primo comma ha frammisto prestazioni strettamente previdenziali, prestazioni para-previdenziali
e misure di assistenza sociale per inabili e minorati .
In questultimo versante, peraltro, hanno pesato la scarsit delle risorse finanziarie, assorbite
per larga parte proprio dalla spesa pensionistica,
una contrapposizione ideologica fra pubblico e
privato, solo da pochi anni in via di superamento,
nonch la presenza di alcune strutture corporative
ereditate dal passato regime che hanno frenato il
varo di una legge generale di riforma, che si sarebbe avuta solo nel 2000 (l. 8 novembre 2000, n.
328) (199). Spazi ulteriori si sono peraltro aperti in
questi ultimi anni rispetto al modello costituzionale: si pensi allo sviluppo importante delle varie
forme di volontariato (l. 11 agosto 1991, n. 266
e d. lg. 4 dicembre 1997, n. 460, sulle Organizzazioni non lucrative di utilit sociale-ONLUS) e alle
tendenze verso una Welfare Community, a fatica
ricompresi nella laconica formula dellultimo
comma dellart. 38 cost. ( Lassistenza privata
libera ) o nel richiamo pi recente dellart. 118
cost. alla sussidiariet cosiddetta orizzontale (200). Spazi peraltro valorizzati sia dalla giuri(198) BATTILANI e FAURI, Leconomia italiana dal 1945 a
oggi, cit., 117.
(199) Questa legge era stata preceduta dai d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, n. 617 e n. 618, che, in attuazione della
l. 22 luglio 1975, n. 382, avevano provveduto a smantellare
numerosi enti di assistenza a struttura corporativa, organizzati per handicap assistito o per categoria di appartenenza.
Dopo una tormentata ricognizione operata dalla cosiddetta
Commissione Cassese sono stati ricondotti al regime di
diritto privato enti quali lUnione ciechi, lEnte nazionale
sordomuti, lAssociazione mutilati ed invalidi del lavoro,
lEnte nazionale per gli orfani dei lavoratori, lOpera nazionale per gli orfani dei sanitari, lIstituto Kirner ed altri
ancora. Abbiamo parlato della vicenda in A. BARBERA, Governo locale e riforma dello Stato, Editori Riuniti, Roma,
1977, 57 ss. Il quadro precedente agli interventi del 1977 in
F. TERRANOVA, Il potere assistenziale, Editori Riuniti, Roma,
1975, nonch per il periodo successivo E. BALBONI, I servizi
sociali, in Manuale di diritto pubblico5 a cura di G. AMATO e
A. BARBERA, III, Il Mulino, Bologna, 1997, 167 ss. Pi di
recente la situazione stata analizzata da M. MASSA, Modelli
e strumenti del governo delle politiche sociali a livello nazionale e comunitario, in La garanzia dei diritti sociali nel dialogo
fra legislatori e Corte costituzionale a cura di P. BIANCHI, Pisa
University Press, Pisa, 2006, 11 ss.
(200) Su cui cfr. Welfare Community e sussidiariet a
cura di S. BELARDINELLI, Egea, Milano, 2005; E. EMMANUELE,
Il terzo pilastro. Il non profit, motore del nuovo Welfare,
Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2005, 453. Convincente il contributo di Alessandra ALBANESE, Diritto allassistenza e diritti sociali, Giuffr, Milano, 2007, sulla necessit
di mantenere la prevalenza della responsabilit pubblica,
anche alla luce della sopra citata legge quadro sullassistenza
(l. n. 328 del 2000).
299
Costituzione della Repubblica italiana
sprudenza costituzionale, talvolta in modo forse
ardito (201), sia dal legislatore, che tuttavia continua a mantenere in piedi la parte statalista del
codice civile. Linserimento del principio di sussidiariet orizzontale nei principi costituzionali
che delineano lo Stato sociale comunque avvenuto in modo armonico, senza sconvolgerli,
come inizialmente temuto da una parte della dottrina (202).
N pare del tutto vero ma torneremo sul
punto nel 25 che lingresso nellordinamento
europeo abbia alterato il profilo sociale della nostra Costituzione e che i valori del mercato abbiano oscurato tutti gli altri (203). Ci rendiamo
conto che la protezione sociale non tra gli
obbiettivi prioritari delle istituzioni europee, comprese le due Corti di Strasburgo e del Lussemburgo, ma anche vero che, negli ultimi anni, ai
valori del mercato si sono affiancati, per effetto del
Trattato di Lisbona (2007), altri valori quali la
coesione sociale, la qualit della vita, listruzione, la protezione della salute, la tutela dei
consumatori, lo sviluppo sostenibile: in tal
senso gli art. 2 e 3 Trattato UE. Rimane aperto
tuttavia in modo che pu essere preoccupante
il tema della nozione comunitaria di servizio
sociale dinteresse generale, che richiede un bilanciamento tra principi solidaristici, incorporati
nello statuto costituzionale dei servizi sociali, e
aperture alle regole di mercato per la gestione
delle varie forme di previdenza (204).
(201) Imponendo o favorendo processi di privatizzazioni: con C. cost. 7 aprile 1988, n. 396, relativa alle IPAB ed
altri enti pubblici di assistenza e beneficienza (dichiarando la
illegittimit costituzionale dellart. 1 l. 17 luglio 1890, n.
6972, la cosiddetta legge Crispi, che aveva provveduto alla
loro pubblicizzazione); nonch con C. cost. 29 settembre
2003, n. 300 e n. 301, che hanno giustificato e accelerato la
riconduzione al diritto privato delle fondazioni di origine
bancaria. Da aggiungere che per i tanti casi di incerta
qualificazione sono state estromesse le Regioni, e il potere
stato riconosciuto, in definitiva, alle sezioni unite della Cassazione (C. cost. 16 ottobre 1990, n. 466).
(202) Un grido di allarme fu lanciato, dopo le prime
proposte della Commissione DAlema, nel Convegno di Perugia del 28-29 novembre 1997 I diritti sociali, Atti raccolti in
Pol. dir., 1999, n. 1: v. in proposito la Relazione di G.G.
BALANDI, Diritti sociali e riforma dello Stato sociale, 57 ss.
(203) V., da non coincidenti punti di vista, F. BILANCIA,
Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei
diritti sociali, tra mercato unico e unione monetaria, in Rivista
AIC, www.rivistaaic.it, 2014, n. 2; N. IRTI, Iniziativa economica e concorrenza, in Per una nuova costituzione economica
a cura di G. DELLA CANANEA e Giulio NAPOLITANO, cit., 23 ss.
(204) Rinviamo sul punto a S. GIUBBONI, Diritti e solidariet in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio
giuridico europeo, Il Mulino, Bologna, 2012, anche in riferimento alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
29 aprile 2004, n. 2004/38/CE; Solidariet mercato e concor-
300
In ogni caso i diritti sociali contengono, anchessi, un nucleo incomprimibile che agisce da
contro-limite: non possono n essere subordinati
ai vincoli della provvista finanziaria n alle
esigenze del decentramento regionale (205) n
essere affidati esclusivamente al mercato autoregolato (206). La riforma dellart. 81 che ha introdotto
in Costituzione, per assicurare il rispetto dei vincoli dellEurozona (l. cost. 20 aprile 2012, n. 1), il
principio dellequilibrio di bilancio impone che
tale principio possa essere bilanciato con altri
principi costituzionali (207) ma non impone di
subordinare i diritti sociali a quellequilibrio
come temuto da alcuni (208) , ha solo vietato
che il finanziamento di essi possa avvenire ricorrendo sistematicamente allindebitamento: il che
ovviamente lascia spazio o ad una diversa dislocazione delle risorse finanziarie o a un ulteriore
ricorso alla imposizione tributaria. In breve: non
vieta le politiche keynesiane, certamente implicite
nella elaborazione dei Costituenti, ma solo il keynesismo clientelare che ha contrassegnato tanti
anni della Repubblica (209). Del resto lequilibrio
renza nel welfare italiano a cura di S. SCIARRA, Il Mulino,
Bologna, 2008; nonch a A. MORRONE, Crisi economica e
diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, in
Quaderni costituzionali, 2014, 96-98.
(205) Cfr. P. MASALA, La tutela dei diritti sociali negli
ordinamenti di tipo composto, tra uniformit e differenziazione, Pisa University Press, Pisa, 2014, pt. I, 59 ss.
(206) Ancora attuale T.H. MARSHALL, Cittadinanza e
classe sociale, trad. it., Utet, Torino, 1976, passim.
(207) C. cost. 11 febbraio 2015, n. 10.
(208) Da ultimo F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, 2012, n.
2 (ma in tal senso numerosi scritti che possibile consultare
in www.costituzionalismo.it). Sul punto ampi riferimenti in
T. GIUPPONI, Il principio costituzionale dellequilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quaderni costituzionali, 2014, 51 ss.
Non sono mancate tuttavia, sia pure in modo indiretto,
influenze negative delle politiche europee sui principi costituzionali in materia tributaria; infatti una interpretazione
estrema del principio della libera circolazione dei capitali
avallata dalla Corte di giustizia con la sentenza Cadbury
Schweppes (C. giust. CE 12 settembre 2006, causa C-196/
04) ha spinto a costituire societ capogruppo (spesso
fittizie) in quegli Stati ove pi ridotta la tassazione (non
solo il Lussemburgo) ivi trasferendo gli utili delle societ
partecipate. Da qui una minore possibilit di imposizione
fiscale sugli utili di societ di capitali e la conseguente
necessit di ricorrere maggiormente alle imposizioni sui
redditi personali e sugli immobili, indebolendo cos il principio costituzionale della progressivit delle imposte: v. S.
BIASCO, I danni della concorrenza fiscale in Europa, in Interparliamentary Conference under article 13 of The fiscal Compact (Roma, Camera dei deputati, 29-30 settembre 2014), in
www.nuovi-lavori.it.
(209) Detta politica era stata allora favorita dalla possibilit per lItalia di finanziare il proprio debito a tassi di
interesse inferiori al tasso di crescita delleconomia (negli
anni Cinquanta e Sessanta il tasso di crescita era del 5-6 per
Costituzione della Repubblica italiana
di bilancio era gi alla base dellart. 81 cost. ma
formulato in modo imperfetto tanto che il suo
rafforzamento era stato auspicato dallo stesso
Mortati nella sua trattazione sulla Costituzione,
nonch dalla Commissione Bozzi allinizio degli
anni Ottanta, negli stessi anni in cui il divorzio
fra Tesoro e Banca dItalia (effettuato nel 1981 ma
senza coinvolgere il Parlamento in una decisione
di cos alta incidenza) rendeva improcrastinabile
una tale riforma (210).
Ben altri sono i pericoli per lo Stato sociale, a
cento, mentre i tassi dinteresse erano del 2-3 per cento), ma
poi continuata anche in condizioni assai meno favorevoli.
Dati in M. FRANCESE e A. PACE, Il debito pubblico italiano
dallUnit a oggi. Una ricostruzione della serie storica, in
www.bancaditalia.it, 2008. Il fenomeno non ha riguardato
solo lItalia: v. A. LAMBERT, Deficit publics. La democratie en
danger, Armand Colin, Paris, 2013.
(210) Per laccenno a MORTATI, cfr. Costituzione dello
Stato, cit., 230.
Il divorzio fra Tesoro e Banca dItalia mirava a combattere la tendenza a contenere il debito pubblico ricorrendo alla stampa di carta moneta, ma non avendo accompagnato la misura con la riduzione della spesa pubblica (n
con laumento della pressione fiscale, allora fra le pi basse
dEuropa, attorno al 32-34 per cento) leffetto stato non
virtuoso.
Nel corso degli anni Sessanta il riferimento ai mezzi
contenuto nellart. 81 cost. per fare fronte alle spese stato
interpretato nel senso che essi potessero essere rappresentati
dal ricorso al mercato finanziario, attraverso la emissione di
titoli del debito pubblico. Tale interpretazione aveva trovato
un avallo nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
Con C. cost. 10 gennaio 1966, n. 1, pur dichiarando incostituzionale una legge di spesa (era la prima volta per una
legge dello Stato ma non per le leggi regionali: v. C. cost. 18
maggio 1959, n. 30) che non aveva previsto nessun mezzo di
copertura, la Corte aveva affermato il principio che questi
potessero consistere, oltre che nel ricorso a prelievi tributari
o nella riduzione di altre spese, anche nella emissione di
prestiti tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi
futuri e non in contraddizione con le previsioni del Governo . Tale decisione, peraltro, fu allora salutata con favore perch veniva a contraddire una prassi parlamentare, e
una non marginale dottrina di supporto, che riteneva soddisfatta la condizione posta dallart. 81 qualora si fosse
assicurata la copertura per lesercizio in corso a garanzia
dellequilibrio fissato dalla legge annuale di bilancio, a prescindere dallincidenza sugli esercizi futuri. In poche parole
si riteneva che lultimo comma dellart. 81 riguardasse il
vincolo per ogni legge di non scalfire lequilibrio della legge
annuale di bilancio (dando una lettura della norma costituzionale alla luce dellart. 43 l. cont. St., e non viceversa), e
non invece il vincolo di non alterare lequilibrio complessivo
della finanza pubblica.
Sia pure dando atto della difficolt di provvedere ,
MORTATI (op. ult. cit., 225 e 230) auspicava che, come
nellordinamento inglese, si limitasse la pienezza delliniziativa legislativa dei membri del Parlamento nella materia
finanziaria . Non coincidente la posizione di V. ONIDA, Le
leggi di spesa nella Costituzione, Giuffr, Milano, 1969. Su
questi temi v. A. BRANCASI, Legge finanziaria e legge di
bilancio, Giuffr, Milano, 1985, passim; S. SCAGLIARINI, La
partire dalla diminuzione della natalit, linvecchiamento della popolazione e la riduzione degli
occupati (con gli attuali andamenti, nel 2025 il
numero dei lavoratori pensionati sar pari a quello
degli occupati). Tali pericoli si aggiungono a quelli
derivanti dalla globalizzazione delleconomia e
dalla necessariamente conseguente flessibilizzazione delle imprese; problemi che mettono in
discussione quella centralit del lavoro, come
fondamento della stessa cittadinanza, con cui si
apre larticolo primo della Carta costituzionale (211). Sono evoluzioni da cui derivano precariet, malessere e incertezze sul futuro. La globalizzazione pu essere una risorsa ma pu anche
provocare il declino della parte dEuropa meno
attrezzata. Affrontare tali temi richiede non gi
linvocazione di astratti diritti ma politiche pubbliche in grado di incidere sulleconomia con adeguate strategie economiche e industriali, e richiede
dunque istituzioni politiche in grado di superare
estenuanti mediazioni e inevitabili resistenze corporative, e di assumere decisioni forti avendo davanti orizzonti pluriennali. Ecco perch il tema
della stabilit e dellefficacia delle istituzioni di
governo appare ineludibile proprio se si vuole
salvare limpianto dei principi costituzionali e il
profilo dello Stato sociale che lo caratterizza.
Sez. III. LA
FRAGILIT
DELLE ISTITUZIONI POLITICHE.
14. La forma di governo incompiuta. Mentre le forze politiche presenti nella Costituente
furono in grado di elaborare una avanzatissima
tavola di principi, frutto della sintesi dei valori
portati avanti da marxisti, cattolici e liberali, nella
parte relativa alla organizzazione delle funzioni di
governo prevalsero piuttosto le diffidenze reciproche. Esse portarono ad un testo i cui limiti furono
presto evidenti sia nel tracciare la forma di governo, sia nel disegnare lassetto del Parlamento.
Differenti orientamenti strategici si erano peraltro
manifestati anche nel delineare la forma regionale
quantificazione degli oneri finanziari delle leggi tra Governo,
Parlamento e Corte costituzionale, Giuffr, Milano, 2006, 13
ss. da ricordare, peraltro, che la stessa Corte aveva concorso alla crescita dellindebitamento attraverso una giurisprudenza volta ad estendere a categorie escluse i benefici
previsti per altre categorie, cos impegnando direttamente il
bilancio dello Stato, per cifre talora considerevoli (v. B.
CARAVITA, Art. 81 Cost., Stato sociale e intervento della Corte
Costituzionale, in Le sentenze della Corte costituzionale e
lart. 81, u.c., della Costituzione, Atti del Seminario, Roma,
8-9 novembre 1991, Giuffr, Milano, 1993, 225 ss.).
(211) V. G. ZAGREBELSKY, Fondata sul lavoro. La solitudine dellart. 1, Einaudi, Torino, 2013.
301
Costituzione della Repubblica italiana
dello Stato. Uniti nellescludere la forma federale, i Costituenti non seppero coniugare le ragioni dellintervento statale, cui tenevano le sinistre in vista di una auspicata pianificazione centralizzata delleconomia, e quelle delle autonomie,
intese dai cattolico-democratici come espressione
sussidiaria di libert locali.
Lordine del giorno Perassi, discusso nelle sedute del 4 e del 5 settembre 1946, e approvato con
22 voti favorevoli e 6 astensioni, aveva scelto la
forma di governo parlamentare ma aveva richiesto
nel contempo dispositivi costituzionali idonei
ad assicurare le esigenze di stabilit dellazione
di governo e ad evitare le degenerazioni del
parlamentarismo ; vale a dire ad evitare quelle
forme di assemblearismo che avevano sfiancato
le democrazie parlamentari, quella italiana e quella
di altri ordinamenti europei (212). Altre posizioni,
quelle azioniste che si richiamavano al presidenzialismo americano e quelle inizialmente portate
avanti dai comunisti che ricalcavano i modelli
assemblearistici o addirittura prevedevano
una assemblea insieme legislativa ed esecutiva (213) , rimasero emarginate (214). Di
contro alla temuta tirannia dellAssemblea, o
alla ancor pi temuta tirannia dellEsecutivo,
prevalse la linea del governo parlamentare, sulla
quale insisteva, tra gli altri, Meuccio Ruini (215),
che della Commissione dei Settantacinque era il
presidente e il relatore. Ad individuare i rimedi a
tali degenerazioni del parlamentarismo si era
accinta la Commissione dei Settantacinque. In
questa direzione avevano cominciato a lavorare
soprattutto i professori, in particolare Costantino Mortati e Egidio Tosato; il primo prefigurava
forme di scioglimento automatico in caso di ripetute crisi di governo, il secondo prevedeva forme
di sfiducia costruttiva, auspicando una specie
di contaminazione fra il governo presidenziale con
il governo parlamentare [...] nel senso di un potenziamento della figura del Presidente del Consi(212) Lespressione parlamentarismo pu avere diversi significati, non tutti in negativo come invece nellordine
del giorno Perassi: v. F. LANCHESTER, Gli strumenti della
democrazia, Giuffr, Milano, 2004, 104 nt. 53.
(213) Cos, richiamandosi a Rousseau e rifiutando la
concezione di Montesquieu , il comunista La Rocca il 5
settembre 1946 in Seconda sottocommissione (Atti dellAssemblea costituente, VII, p. 928).
(214) Sul punto G. AMATO e F. BRUNO, La forma di
governo italiana. Dalle idee dei partiti allAssemblea Costituente, in Quaderni costituzionali, 1981, 64 ss.; nonch MORTATI, op. ult. cit., 223.
(215) Cfr. CHELI, Costituzione e sviluppo delle istituzioni, cit., 29 ss. (v. anche ID., Il problema storico della
Costituente, in Pol. dir., 1973, 485 ss.).
302
glio (216), da tempo sperimentato nel Regno
Unito.
La grave crisi politica del maggio 1947, tradottasi nella rottura dellunit antifascista e nella
estromissione dei socialcomunisti dal Governo,
non ferm i lavori dellAssemblea costituente ma
blocc il lavoro su questi temi portando ad una
elusione dellordine del giorno Perassi (217).
Ancor pi, da quel momento, ciascuno dei due
schieramenti temer, come si sarebbe detto dopo,
il 18 aprile dellaltro, il riemergere dellombra
del tiranno, il tiranno socialcomunista da un lato,
quello clerico-fascista dallaltro. Entrambi si comporteranno immaginando se stessi pi allopposizione che al governo (218). Fu voluto dalla Costituente lo diciamo in sintesi un sistema di
governo debole perch nessuno schieramento
politico potesse vincere fino in fondo e nessuno
potesse essere del tutto tagliato fuori dal governo
(a questo, come vedremo, servir anche il bicameralismo a durata asimmetrica). Avevano spinto in
tale direzione i primi bagliori della guerra
fredda e la convinzione che laccordo raggiunto
sui valori di fondo della Carta costituzionale fosse,
bench di alto profilo, fragile ed esposto alle tensioni politiche ed ideologiche e a possibili ritorni
allindietro. Sebbene dunque, inizialmente, la Costituente si fosse ispirata al modello di governo
parlamentare, parzialmente razionalizzato, alla
fine non fu in grado di guardare fino in fondo alla
logica profonda dello stesso (219). Esso avrebbe
(216) Atti dellAssemblea costituente, VII, p. 935. Analoghe le posizioni di Mortati: v. A. BARBERA e S. CECCANTI, La
lenta conversione maggioritaria di Costantino Mortati, in
Quaderni costituzionali, 1995, 67 ss. Su Tosato cfr. E. CHELI,
Il contributo di Egidio Tosato alla formazione della Carta
repubblicana, in Egidio Tosato costituzionalista e costituente a
cura di M. GALIZIA, Giuffr, Milano, 2010 (Archivio di Storia
costituzionale e di Teoria della Costituzione - Biblioteca, n. 7),
251 ss.
(217) Lespressione di L. ELIA, Governo senza difese,
in La Repubblica, 29 novembre 1998. Sugli effetti della
rottura del 1947 v. A. LEPRE, Lanticomunismo e lantifascismo in Italia, Il Mulino, Bologna, 1997, 104 ss. Gli orientamenti della Costituente sulla struttura e i poteri del Governo
sono ben richiamati da S. MERLINI, Il Governo, in Manuale di
diritto pubblico a cura di AMATO e BARBERA, cit., 169 ss.
(218) La vicenda ricostruita da AMATO e BRUNO, op.
cit., 33 ss., ma confermata da Dossetti nella citata intervista
a cura di Elia e Scoppola (A colloquio con Dossetti e Lazzati,
cit.), nonch dallo stesso MORTATI, op. ult. cit., 229, che
tuttavia tiene a sottolineare che il compromesso sulla forma
di governo non fu solo patto di garanzia fra parti contrapposte rivolto a sottrarre ciascuna dal pericolo di sopraffazione per opera delle altre .
(219) Sulla mancata adozione del modello inglese, suggerito in particolare da Luigi Einaudi, v. E. CAPOZZI, Lalternativa atlantica, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, 51 ss.
(ivi il diverso avviso di Luigi Salvatorelli, pi attento alla
Costituzione della Repubblica italiana
richiesto una traduzione italiana delle istituzioni
inglesi, sia sul versante delle regole elettorali sia su
quello del rafforzamento della posizione del Governo in Parlamento, che in ogni caso il sistema
dei partiti dellepoca, gi delineato nei Comitati di
liberazione nazionale, avrebbe potuto accettare
con notevole difficolt (220). Si pu affermare cos
volendo essere brevi che il bipolarismo
politico italiano fu frenato dal bipolarismo fra
Occidente ed Oriente (221).
Certamente la rigidit della Costituzione e i
poteri assegnati al Capo dello Stato rappresentavano una novit rispetto al parlamentarismo
classico. Ma per il resto la Costituente si limit a
colmare il vuoto dello Statuto albertino disciplinando con formule assai sintetiche la relazione
fiduciaria fra Parlamento e Governo. Furono previste alcune norme procedurali: termini per il voto
iniziale di fiducia; obbligo di motivazione dello
stesso; numero minimo di sottoscrizioni per la
presentazione di eventuali mozioni di sfiducia e
termini per la votazione delle stesse; obbligo di
voto per appello nominale sia per la fiducia sia per
la sfiducia; cui si aggiunse il non obbligo di dimisesperienza maturata nel periodo statutario). un modello
cui guarder la letteratura francese nel tentativo di superare
le debolezze della IV Repubblica: da Duverger, che vedr
nel doppio turno e nella elezione diretta del Premier il modo
per importare il sistema costituzionale inglese in quei Paesi
che non hanno i partiti inglesi; da Debr, nella sua iniziale
logica di costruzione della V Repubblica, distorta poi dalle
torsioni presidenzialiste del Generale De Gaulle; da Vedel,
allorch individuer (posizione attenuata successivamente
ma poi accolta con la riforma del 2000) nella contestuale
elezione diretta del Parlamento e del Presidente della Repubblica con poteri di governo un modo per tentare di
trasporre nel continente le istituzioni di Westminster.
(220) Sul punto rinviamo a A. BARBERA e C. FUSARO, La
forma di governo nellesperienza costituzionale italiana (19472007), in La Costituzione italiana sessantanni dopo. Evoluzione e valutazioni di impatto a cura di A. CHIMENTI, R.
LEONARDI e R. NANNETTI, Edizioni della Scuola superiore
della pubblica amministrazione, Roma, 2009, 65-107. A ci
si aggiunga che lenfasi posta sulla centralit del Parlamento e quindi sia sullAssemblea in quanto tale sia sui
singoli parlamentari rendeva difficile trovare spazi garantiti per lopposizione; sul punto A. MANZELLA, Opposizione
parlamentare, in Enc. giur., XXI, 1990, 2; nonch G. DE
VERGOTTINI, Opposizione parlamentare, in questa Enciclopedia, XXX, 1980, ad vocem.
(221) Come noto, perch si possa parlare di assetto
bipolare bisogna fare riferimento (A. LIJPHART, Le democrazie
contemporanee, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1988) a una
bipolarizzazione sullasse destra-sinistra, in assenza di fratture relative alla politica estera, allassetto costituzionale di
fondo, a cleavages religiosi o linguistici. E sappiamo
quanto i fattori religiosi (lunit politica dei cattolici contro
le sinistre atee), le lotte sociali e soprattutto le divisioni sulla
politica estera abbiano influito nel tenere bloccato il sistema
politico.
sioni in caso di voti contrari a proposte del Governo.
Non solo si trattava di misure assai limitate ma
la previsione del voto iniziale di fiducia, non consueto in altri governi parlamentari, finiva per compromettere la possibilit stessa di dare vita a governi di minoranza, possibili invece in altri ordinamenti europei (che oltretutto, in pi casi, rafforzano tali governi prevedendo la maggioranza
assoluta per lapprovazione della sfiducia) (222).
Non solo venne lasciata cadere la proposta Tosato
per lintroduzione del voto di sfiducia costruttivo
(che venne poi raccolta dai Costituenti di Bonn)
ma non si volle disciplinare la stessa posizione
della questione di fiducia da parte del Governo,
che sarebbe stata lasciata alla prassi e ai regolamenti parlamentari. La scelta per un sistema elettorale proporzionale, anche se saggiamente non
costituzionalizzata, avrebbe evitato di intaccare
questo delicato equilibrio fra le forze politiche (223).
Si tratt sin dallinizio, dunque, di istituzioni di
governo volutamente deboli, ma sorrette nei primi
decenni di vita costituzionale dalla forza dei partiti
politici. La democrazia dei partiti soppiant la
democrazia dei notabili propria del vecchio
Stato liberale. Ma ancora una volta mettendo ai
margini le istituzioni (224). Ad indebolire ancor
pi il Governo e in particolare la figura del Presidente del Consiglio con lunica eccezione dei
Governi De Gasperi, il solo leader in cui coincisero, secondo un modello europeo, premiership
del Governo ed effettiva leadership del partito di
maggioranza (225) concorreranno negli anni
successivi due fattori. Prima di tutto va richiamata
la pesante struttura correntizia del partito di maggioranza relativa. Per quaranta anni questa impedir persino lapprovazione della legge sullordinamento della Presidenza del Consiglio, voluta
dalla Costituzione ma ritenuta veicolo di possibile
(222) Cfr. K. STROM, Minority Government and Majority Rule, Cambridge University Press, Cambridge, 1990,
23 ss.
(223) Cfr. E. BETTINELLI, Allorigine della democrazia dei
partiti. La formazione del nuovo ordinamento elettorale nel
periodo costituente, Edizioni di Comunit, Milano, 1982,
367-378.
(224) Cos SCOPPOLA, La Repubblica dei partiti, cit.,
91 ss.
(225) Cfr. G. TARLI BARBIERI, La forma di governo nella
prima legislatura repubblicana: un premierato ante litteram?,
in Lo Stato costituzionale: la dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli, Il
Mulino, Bologna, 2010, 441 ss. Tale coincidenza fu tentata,
ma senza successo, da Amintore Fanfani (1958-1959) e da
Ciriaco De Mita (1988-1989) ed ora (2014) da Matteo Renzi.
303
Costituzione della Repubblica italiana
rafforzamento della corrente democristiana che
avrebbe di volta in volta espresso il Presidente del
Consiglio. Fino alla l. n. 400 del 1988 saranno
richiamate in vita le norme della legge Zanardelli
(r.d. 14 novembre 1901, n. 466), nata vecchia gi
nel 1901. In secondo luogo va richiamata la teorizzazione e la prassi, dagli anni Sessanta in poi,
della cosiddetta pari dignit dei partiti necessari
per dare vita ad una coalizione di governo (sia nel
Governo centrale sia in quelli periferici), a prescindere dal consenso elettorale raccolto. Pari dignit intesa ora come potere di veto riconosciuto a
ciascun partito della coalizione, ora come piena
autonomia di indirizzo politico nei ministeri affidati a personalit provenienti dalle proprie fila, ora
soprattutto come potest concreta di determinare le dimissioni del Governo (per molti anni
estesa perfino ai componenti della coalizione non
indispensabili per garantire la maggioranza o a
singole correnti di partito). Si capisce perch ci si
tradotto non solo in una destabilizzante competizione fra partiti alleati perfino lungo gli anni
Ottanta per lassunzione della Presidenza del
Consiglio (o delle cariche locali: pur quando tra i
partiti vi fosse una notevole differenza di suffragi
elettorali), ma anche in una permanente assenza di
collegialit e omogeneit dei Governi; governi
dissociati (226), ineluttabilmente destinati a vita
precaria e breve.
La centralit del Parlamento divent lasse
attorno a cui fare ruotare la forma di governo; ma
dietro questa espressione si nascondeva in realt la
centralit dei partiti in Parlamento e la ricerca di
formule consociative. E ci sia nei Governi,
come apparir manifesto dal ruolo assegnato alle
delegazioni dei partiti nel Consiglio dei ministri
o ai ricorrenti vertici dei partiti della maggioranza o alle crisi extraparlamentari, sia nelle
Commissioni parlamentari. Non solo queste ultime poterono svolgere una imponente funzione
legislativa in sede deliberante (dove secondo lart.
72 cost. la minoranza attraverso un quinto di
parlamentari poteva sempre condizionarne il
lavoro richiamando in Aula o minacciando di
richiamare le leggi in corso di approvazione)
ma ad esse vennero progressivamente assegnate,
anche dando vita ad apposite Commissioni bicamerali, specifiche funzioni di cogestione politicoamministrative. La teorizzazione negli anni Sessanta e Settanta della distinzione fra maggioranze
(226) E. CHELI, Riflessi della transizione nella forma di
governo, in Quaderni costituzionali, 1994, 391.
304
legislative e maggioranze di governo avrebbe
fotografato tale realt (227).
Una caratteristica comune allItalia liberale e a
quella repubblicana stata in effetti linstabilit
dei Governi (nove mesi la media effettiva di vita
dei Governi dal 1948 al 1994) insieme per alla
longevit delle carriere ministeriali, alle derive assembleari e alle prevaricazioni ministeriali (228).
Lintroduzione di sistemi elettorali con effetti
maggioritari riuscir a produrre per cinque volte
consecutive (nel 1994, nel 1996, nel 2001, nel
2006, nel 2008) schieramenti alternativi di governo, superando una anomalia della storia nazionale (229) che conosceva il ricambio politico
solo in seguito a cambiamenti di regime. Gli elettori italiani erano cos giunti a poter legittimare
direttamente (in termini di diretta legittimazione
politica, non di elezione diretta) la coalizione
di governo e il candidato alla Presidenza del Consiglio, conoscendo previamente la designazione
dello stesso da parte delle rispettive coalizioni (dal
2005 la legge elettorale avrebbe reso un obbligo
indicare, al momento della presentazione delle
liste elettorali, il capo della coalizione politica,
formula scelta in quanto ritenuta pi rispettosa
delle prerogative del Capo dello Stato nella scelta
del Presidente del Consiglio).
Dalla transizione degli anni Novanta, la durata
dei Governi si certamente allungata, dai nove
(227) Tale distinzione ebbe fortuna al fine di giustificare
una collaborazione nella attivit legislativa stante limpossibilit del PCI di collaborare al governo (v. D. SASSOON,
Togliatti e la centralit del parlamento, in Critica marxista,
1985, n. 1, 35 ss.): sul tema v. C. LAVAGNA, Maggioranze al
governo e maggioranze parlamentari, in Pol. dir., 1974, 673
ss.; G. FERRARA, Regolamenti parlamentari e indirizzo politico,
in Scritti degli allievi offerti ad Alfonso Tesauro, nel quarantesimo dellinsegnamento, I, Giuffr, Milano, 1968, 325 ss.;
F. COLONNA, La regola della maggioranza e la democrazia, in
Critica marxista, 1976, 93 ss.
Decisamente contrario V. CRISAFULLI, Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffr, Milano,
1985, 279 ss.; nonch S. SICARDI, Maggioranza, minoranze,
opposizione nel sistema costituzionale italiano, Giuffr, Milano, 1984, 321. La deviazione rispetto al normale funzionamento del sistema parlamentare palese ma altrettanto
palese la deviazione di chi escludeva del tutto ogni collaborazione al di fuori del perimetro della maggioranza politica
(attraverso la formula della delimitazione della maggioranza). V. anche sul punto le caute posizioni di A. MANZELLA, Il rapporto maggioranza-opposizione in Parlamento, in
Indagine sulla funzionalit del Parlamento (Istituto per la
documentazione e gli studi legislativi), II, Giuffr, Milano,
1969.
(228) R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana. Dallo
statuto albertino alla Repubblica (1848-2001), Carocci,
Roma, 2002, 106 ss.
(229) Cos SALVADORI, Storia dItalia e crisi di regime,
cit., 19 ss.
Costituzione della Repubblica italiana
mesi dei Governi del regime proporzionale ad
oltre il doppio, ma lazione dei Governi non
riuscita a rinvigorirsi adeguatamente. I Governi
cos legittimati, pur avendo lambizione di costituire quel comitato direttivo del Parlamento che
proprio dei sistemi parlamentari pi consolidati (230), non sempre hanno avuto a disposizione
gli strumenti normativi necessari, tanto pi che
spesso essi risultavano indeboliti dalle dinamiche
politiche interne alla propria maggioranza (fosse
di centrosinistra, fosse di centrodestra). Non
hanno prodotto quei Governi di legislatura che
hanno rappresentato un traguardo pi volte perseguito nei sistemi parlamentari e che erano lobbiettivo principale dei referendum elettorali degli
anni Novanta.
15. I regolamenti delle Camere: tra governo
assembleare e governo parlamentare. Per effetto della discrasia fra il nuovo regime elettorale e
il vecchio assetto (costituzionale e regolamentare)
delle istituzioni parlamentari il sistema ha smesso
di essere a tendenza assembleare ma al tempo
stesso non si ancora trasformato in un vero e
proprio governo parlamentare di gabinetto. I poteri del Presidente del Consiglio e la sua posizione
sono rimasti quelli fissati dalla Costituzione del
1948, pur essendosi accresciute le sue responsabilit: e in relazione alla sua partecipazione al Consiglio europeo e rispetto alle attese create nellopinione pubblica in forza della sua accresciuta legittimazione politica (sia pure frenata dal necessario
ricorso a coalizioni). Hanno pesato, altres, la mancata definizione dei poteri del Capo dello Stato e la
presenza di un anomalo bicameralismo paritario.
Questo ha impedito al Presidente del Consiglio di
influire in modo incisivo sui lavori parlamentari, di
procedere alla revoca di Ministri, di proporre
credibilmente il ritorno anticipato alle urne (come
invece possibile in varie forme ci limitiamo
allEuropa ai Primi Ministri di Germania, Spagna, Regno Unito).
La vicenda dei regolamenti parlamentari
strettamente legata sia alla struttura e alle funzioni
del Parlamento sia al buon funzionamento del
governo parlamentare. Essi hanno, infatti, in tutti
gli ordinamenti una funzione rilevante, tanto da
potere essere annoverati (come dicevamo supra,
nel 5) fra le fonti che tendono a comporre
lordinamento costituzionale.
(230) L. ELIA, Il Governo come comitato direttivo del
Parlamento, in Civitas, 1951, n. 4, ora in Costituzione, partiti,
istituzioni a cura di M. OLIVETTI, Il Mulino, Bologna, 2009,
16.
indicativo della continuit nella forma di
governo rispetto al periodo statutario il fatto che
furono riesumati per il primo Parlamento repubblicano i regolamenti della Camera dei deputati
del 1920-1922 (231), i quali (pur innovativi rispetto a quelli precedenti, basati sugli Uffici parlamentari) non davano adeguato rilievo n ai
gruppi parlamentari n ai poteri del Governo.
Bisogner aspettare il 1971 (e altrettanto dovr
fare il Senato, che fino a quella data aveva utilizzato il regolamento del Senato regio, pur adattato
e modificato) per avere un regolamento nuovo.
Con la riforma di quellanno si tent di introdurre
il metodo della programmazione dei lavori
strumentale ai processi di decisione (232)
ma il taglio fu decisamente consociativo. La programmazione venne intesa non quale modo per
ricercare il collegamento con il programma di
governo (come nelle pi consolidate democrazie
parlamentari), ma quale modo per mettere in sintonia i lavori parlamentari con le decisioni assunte
allunanimit, o a larga maggioranza, dai gruppi.
Nonostante i richiami al metodo della programmazione, si accentuavano gli elementi assemblearistici: basti pensare che alla conferenza dei capigruppo riunita per fissare il programma e il calendario dei lavori non veniva invitato, fino alla met
degli anni Ottanta, un rappresentante del Governo mentre (in assenza di deliberazioni unanimi)
lordine del giorno era fissato di volta in volta alla
fine di ogni seduta per quella successiva (sulla base
del principio ottocentesco secondo il quale la Camera sempre padrona dellordine del giorno).
A ci si aggiunga che la possibile dilatazione dei
tempi di discussione e di intervento dei singoli
parlamentari, la mancanza di strumenti adeguati
per stroncare eventuali ostruzionismi facevano dipendere le decisioni parlamentari dagli accordi politici fra i vari gruppi: un sistema che verr definito
la consacrazione della consociazione (233).
A questo si aggiunga altres la scelta del Costituente di riconoscere alle Commissioni parlamentari funzioni legislative, in sede cosiddetta deliberante, secondo il modello ereditato dalla Camera dei fasci e delle corporazioni. Lattivit di
queste (molto intensa in alcune fasi della storia
repubblicana) risultata condizionata dai possibili
(231) In realt risalenti al 1868; furono riformati nel
1887-1890 e ulteriormente riformati nel 1900 dopo lostruzionismo ai Governi di Rudin e Pelloux e perci erano
molto attenti alle prerogative dei singoli parlamentari.
(232) A. MANZELLA, Il Parlamento3, Il Mulino, Bologna,
2003, 145.
(233) Lespressione di V. LIPPOLIS, Partiti, maggioranza, opposizione, Jovene, Napoli, 2007, 120.
305
Costituzione della Repubblica italiana
veti sia del Governo sia delle minoranze. Infatti, in
base al comma 3 dellart. 72, un decimo dei componenti la Assemblea o un quinto della Commissione o il Governo possono in qualsiasi momento
ottenere il trasferimento del progetto dalla Commissione allAula, ritardandone cos sensibilmente
lesame. Ci pu portare ad esiti consociativi: quelli
che in effetti hanno caratterizzato, per diversi anni,
la cosiddetta micro-legislazione di spesa (234).
Tale sistema venne messo in crisi a partire dalla
VII legislatura da una pattuglia di quattro deputati
radicali, per la prima volta presenti dopo le elezioni del 20 giugno 1976, decisi ad usare a scopi
ostruzionistici tutte le risorse regolamentari disponibili. Solo dalla legislatura successiva entrambe le
Camere inizieranno a dotarsi di norme regolamentari anti-ostruzionistiche. Il progressivo mutamento di rotta inizia con le misure che le Presidenze della Camera sono costrette ad assumere nel
corso degli anni Ottanta, sotto la Presidenza Iotti
in particolare, e soprattutto nel corso degli anni
Novanta nella stagione bipolare, sotto la Presidenza Violante, per dare pi solida consistenza al
programma dei lavori parlamentari attraverso il
contingentamento dei tempi per lapprovazione
di leggi ordinarie. La riforma del 1997, peraltro,
rinvi ad una non precisata successiva scadenza (v.
art. 154 reg. Camera) lapplicazione del contingentamento dei tempi per lapprovazione delle leggi
di conversione dei decreti-legge (235).
Guardando le vicende regolamentari nel lungo
periodo, la pi incisiva riforma dei regolamenti, in
grado di avere effetti sulla forma di governo,
stata il superamento nellautunno del 1988 del
(234) In particolare le sedi deliberanti non soggette
alla visibilit propria dellAula consentivano pi facilmente gli accordi fra i maggiori partiti. Su questo fenomeno
richiam subito lattenzione A. PREDIERI, La produzione legislativa, in S. SOMOGYI, L. LOTTI, A. PREDIERI e G. SARTORI, Il
Parlamento italiano (1946-1963), Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1963, 205 ss. Pi in generale C. FASONE,
Sistemi di commissioni parlamentari e forma di governo,
Cedam, Padova, 2012, 174 ss. Critico su questa articolazione
del Parlamento in Commissioni deliberanti, MORTATI, Costituzione dello Stato, cit., 225. Da ricordare che nella VI
legislatura al Senato su 1246 leggi approvate 830 erano state
approvate in Commissione.
(235) Si sarebbe dovuto attendere il febbraio 2014 per
vedere il Presidente della Camera applicare per la prima
volta la cos detta ghigliottina (prevista invece al Senato fin
dal 1990), evidentemente ritenendo esaurita la fase transitoria prevista dallart. 154 reg. Camera. Eppure la reazione
in Aula stata tale da portare addirittura a scontri fisici:
sintomo significativo di una cultura anti-maggioritaria tuttora molto forte, se non prevalente: v. A. SUMMA, La ghigliottina nel diritto parlamentare, in Forum di Quaderni
costituzionali, www.forumcostituzionale.it, sub Temi di attualit , Parlamento , febbraio 2014.
306
ricorso generalizzato al voto segreto. Ereditato
dai regolamenti parlamentari prefascisti, apr la
strada ai cosiddetti franchi tiratori, espressione
di correnti, di microinteressi corporativi, di trasformismi occulti, di imboscate antigovernative
poco trasparenti, incluse alleanze occasionali fra
pezzi della maggioranza e lopposizione. Si trattava di una regola pressoch sconosciuta in altre
importanti democrazie, il cui superamento stato
a lungo contrastato da un largo schieramento conservatore.
Rimangono decisivi i regolamenti parlamentari
anche in relazione al pi ampio tema dellassetto
delle fonti normative. Si sono attenuate le polemiche sulle leggine, come strumento di negoziazione e causa di iper-legificazione, diminuite anche
a causa delle tendenze bi-polarizzanti del sistema
politico e della crisi della finanza pubblica. Diffuse, invece, sia da parte della dottrina sia da parte
di tutti gli schieramenti politici le geremiadi sia
sulle prevaricazioni dellEsecutivo sulle Assemblee parlamentari, sia sul disordine delle fonti che
ne consegue. Ripetute le lamentele e le proteste, ad
esempio, o contro labuso dei decreti-legge o contro il ricorso ai cosiddetti maxiemendamenti o
contro il frequente ricorso al voto di fiducia. Il
ricorso a decreti-legge, o a maxiemendamenti sui
quali viene posta la fiducia, in effetti, coarta la
volont delle Assemblee e, per di pi, spesso le
costringe a votare testi non conosciuti o su cui,
comunque, non si sarebbe adeguatamente discusso (236). Ma proprio perch si tratta di mali
(236) Si tratta di pratiche comuni a parte qualche
variazione quantitativa sia ai Governi di centrodestra sia
a quelli di centrosinistra: nel biennio 2006-2008 (sotto la
Presidenza Prodi) si registrarono 51 decreti-legge (2,1 al
mese) mentre nel biennio 2008-luglio 2010 (sotto la Presidenza Berlusconi) si sono registrati 66 decreti-legge (2,4 al
mese). Nello stesso periodo (un biennio) si sono registrate 34
richieste di fiducia da parte del Governo Berlusconi e, nei
venti mesi di governo, 28 richieste di fiducia da parte del
Governo Prodi. Non meno consistente il numero dei decreti
emanati dal Governo Monti, dal Governo Letta e dal Governo Renzi. Le stesse Camere, pi che impedire allEsecutivo di intervenire mediante decreto-legge, preferiscono imporre proprie modifiche, nonch linserimento di oggetti
ulteriori in cambio del via libera alla conversione.
Come dicono le statistiche (v. A. BARBERA e C. FUSARO,
Corso di diritto costituzionale2, Il Mulino, Bologna, 2014,
130), la lunghezza media dei decreti adottati dal Governo
Prodi II (2006-2008), di 29 commi al momento della presentazione del disegno di legge di conversione, era diventata
di 55 commi dopo il passaggio in Parlamento. Con il Governo Berlusconi IV (2008-2011) si avevano decreti di 48
commi alladozione, ma di 79 alla conversione; con il Governo Monti (2011-2013) si passava da 76 commi a ben 121;
con il Governo Letta (2013-2014) da 59 a 93 commi. Un
fenomeno sistematico che illustra la lievitazione della decre-
Costituzione della Repubblica italiana
ricorrenti, quale che sia lo schieramento al governo, quelle lamentele rischiano di rimanere sterili se non si risale dai sintomi alle cause e se non
si riformano struttura e metodo di funzionamento
delle Assemblee parlamentari. Non sempre sarebbe necessario modificare regole costituzionali,
basterebbe porsi lobbiettivo lo diceva un secolo fa Sidney Sonnino di riformare i regolamenti parlamentari (237). I decreti-legge, infatti,
vengono usati dal Governo nel tentativo di accelerare le procedure parlamentari; richiamiamo un
solo dato: 388 giorni in media per lapprovazione
di un disegno di legge nella XIV legislatura (238).
vero: la decretazione durgenza strumento
poco conosciuto o poco praticato in altri
ordinamenti europei ma anche vero che quegli
ordinamenti garantiscono al Governo incisivi poteri nella definizione dellordine del giorno delle Assemblee parlamentari (fino a raggiungere
lestremo nel Regno Unito, che affida per i tre
quarti dei tempi parlamentari tale compito direttamente al Premier: la restante parte riservata
allopposizione e alle iniziative dei singoli parlamentari). Nella Camera dei deputati italiana,
invece, la programmazione e il calendario sono
affidati alla conferenza dei Presidenti dei gruppi,
che deve deliberare (dal 1997, prima era necessaria come abbiamo visto lunanimit) con la
maggioranza dei tre quarti (ciascun Presidente
portatore di un voto ponderato), o, in assenza di
ci, sono affidati al Presidente della Assemblea, il
quale non sempre in sintonia politica con il
Governo in carica. Infatti per molti anni il Presidente della Camera stato un autorevole deputato
dellopposizione e nelle ultime cinque legislature,
quasi sempre, il leader del secondo partito della
maggioranza di governo, non sempre in sintonia
con il partito del leader di governo (239).
tazione durgenza, non solo sul piano del numero dei decreti,
ma della loro estensione, e quindi della materia coperta
(sulle distorsioni politico-istituzionali che hanno favorito
questo fenomeno v. CECCANTI, Decreti obesi e crisi economica,
cit, 110 ss.). I decreti hanno sempre pi perduto qualsiasi
omogeneit e spesso scalfita la stessa corrispondenza tra
titolo e contenuto. Come diremo pi avanti, C. cost. 16
febbraio 2012, n. 22 e C. cost. 25 febbraio 2014, n. 32 hanno
tentato di limitare luso improprio del potere di conversione
(v. infra, 23 lett. A).
(237) S. SONNINO, I decreti legge e i regolamenti della
Camera, in La Nuova Antologia, 1899.
(238) Cfr. R. PERNA, Tempi della decisione ed abuso della
decretazione durgenza, in Quaderni costituzionali, 2010,
59 ss.
(239) Tranne per la eccezionalit della fase politica
le Presidenze Ingrao nella VII legislatura, Iotti nella VIII,
Napolitano nella XI, in queste ultime legislature i Presidenti
eletti alla Camera dei deputati sono stati esponenti di mino-
A ci si deve aggiungere la inadeguata attuazione dellart. 72 cost. laddove prevede procedure
accelerate per lapprovazione da parte del Parlamento di disegni di legge dichiarati urgenti dallo
stesso Parlamento; nei regolamenti parlamentari la
accelerazione delle procedure si traduce, infatti,
solo nella abbreviazione dei tempi (da sessanta a
trenta giorni: art. 81 reg. Camera) per la relazione
della Commissione allAula. Diversa la funzione
dei cosiddetti maxiemendamenti, su cui viene
spesso chiesto un voto di fiducia, comprimendo in
modo pesante il diritto di emendamento, la libert
di discussione e la stessa trasparenza del processo
decisionale (240). Essi, per lo pi, servono ai
Governi per limitare, nellapprovazione delle leggi
di finanza pubblica, lincidenza dei micro-interessi, rappresentati dai parlamentari di maggioranza e di opposizione. una pratica che umilia il
Parlamento e porta alla mostruosit di articoli con
decine o centinaia di commi (1364 nella legge di
stabilit del 2007, l. 27 dicembre 2006, n. 296; 700
in quella per il 2015, l. 23 dicembre 2014, n. 190).
Ed una pratica che consente, per di pi, anche
agli apparati di governo di soddisfare non trasparenti interessi corporativi.
Come ricordava Gaetano Arangio Ruiz nella
sua storia costituzionale del Regno, uno dei problemi irrisolti del governo parlamentare dellItalia
unita fu rappresentato, dagli anni Ottanta dellOttocento in poi, proprio dagli scarsi poteri riconosciuti al Governo nel mantenimento degli equilibri
finanziari, a differenza, aggiungeva, di come usaranze allinterno delle maggioranze parlamentari (Presidenze
Casini, Bertinotti, Fini, Boldrini), talvolta in posizioni di
riequilibrio rispetto al Presidente del Consiglio. Sul tema E.
GIANFRANCESCO, Il ruolo dei Presidenti delle Camere fra soggetti politici e arbitri imparziali, in Le regole del diritto
parlamentare nella dialettica tra maggioranza ed opposizione a
cura di E. GIANFRANCESCO e N. LUPO, LUISS University Press,
Roma, 2007, 11 ss.; nonch A. SCIORTINO, Il Presidente di
Assemblea parlamentare, Giappichelli, Torino, 2002, 99 ss.;
ma v. anche Regolamenti parlamentari e forma di governo: gli
ultimi quarantanni a cura di F. LANCHESTER, Giuffr, Milano,
2013.
(240) In realt occorre precisare che i maxiemendamenti danno al Governo lultima parola, ma non sempre
tagliano fuori le Camere (come talora si denuncia); nella
prassi i maxiemendamenti servono a bloccare il testo gi
negoziato in Commissione, evitando che nellulteriore passaggio in Aula, un passo alla volta, si perda la fisionomia
iniziale del decreto: v. sul punto M. RUBECHI, La sessione di
bilancio in Parlamento: Governi in fuga, in La prassi degli
organi costituzionali a cura di A. BARBERA e T. GIUPPONI,
Bononia University Press, Bologna, 2008, 271-295. Sulla
contrariet alle regole costituzionali di tali pratiche v. N.
LUPO, Emendamenti, maxiemendamenti e questione di fiducia
nelle legislature del maggioritario, in Le regole del diritto
parlamentare nella dialettica tra maggioranza ed opposizione,
cit., 41 ss.
307
Costituzione della Repubblica italiana
no altri stati, maestri nelle pratiche costituzionali (241). A questi ordinamenti si proposto da
pi parti di guardare se si vuole che il Governo
divenga, come nei sistemi parlamentari, il comitato direttivo della maggioranza (242).
16. Il Parlamento bicamerale. Le principali
funzioni del Parlamento che secondo la classica
definizione di Walter Bagehot, ruotano attorno
alla rappresentanza (243), alla legittimazione
dei Governi, allattivit legislativa hanno
subito importanti ridimensionamenti rispetto al
modello disegnato dai Costituenti, alcune fin dai
primi anni di vita repubblicana. La funzione di
rappresentanza non pi da tempo monopolio
parlamentare, essendo ormai svolta con non minore incisivit da altri soggetti pi o meno direttamente legati alla societ, come le organizzazioni
sindacali, sempre pi autonome da partiti e gruppi
parlamentari (non pi cinghie di trasmissione).
Anche taluni organi di collaborazione amministrativa (per esempio le Conferenze Stato-Regioniautonomie) o di autogoverno (per esempio il Consiglio superiore della magistratura) ambiscono ormai a contendere funzioni di rappresentanza agli
organi parlamentari.
(241) Cos, citando Francesco Crispi e richiamando
ci che consuetudinario in Inghilterra , G. ARANGIO
RUIZ, Storia costituzionale del Regno dItalia, Jovene, Napoli,
1986, 425.
(242) Fra le proposte recentemente emerse figura lintroduzione di norme analoghe a quelle previste nellart. 113
della Costituzione tedesca che danno la possibilit al Governo di porre il veto (di cui peraltro ha sempre fatto un uso
sobrio) su deliberazioni del Parlamento qualora diminuiscano lentrata o aumentino la spesa (v. BARBERA, Fra governo
parlamentare e governo assembleare, cit., 35). Sempre a tal
proposito vengono citati spesso i poteri riconosciuti al Cancelliere dello Scacchiere nel Regno Unito, il cui parere
negativo praticamente insuperabile per la Camera dei
Comuni e per lo stesso Consiglio dei ministri (non a caso il
Cancelliere dello Scacchiere ha sede al n. 11 di Downing
Street, subito accanto alla residenza del Primo Ministro).
Scartate soluzioni troppo drastiche come quelle previste
dallart. 40 della Costituzione francese, che addirittura vieta
ai parlamentari emendamenti che diminuiscano le entrate o
aumentino la spesa, pu essere segnalato lobbligo, previsto
dalla medesima Costituzione di Francia (art. 42-47), di
votare sul testo del Governo e non della Commissione (e se
necessario con voto bloccato) i progetti di legge in materia di
finanza pubblica o di finanziamento della previdenza sociale.
Da sottolineare che un rafforzamento delle prerogative dei
Governi comporta insieme un rafforzamento di quelle delle
opposizioni anche attraverso uno Statuto delle stesse. Sul
punto G. RIZZONI, Opposizione parlamentare e democrazia
deliberativa, Il Mulino, Bologna, 2012, 248 ss.
(243) E alla connessa teaching function : v. W. BAGEHOT, The English Constitution, Harper Collins, London,
1993, 154 (trad. it. La Costituzione inglese, Il Mulino, Bologna, 1995).
308
La stessa funzione di legittimazione dei Governi si era, fin dai tempi della Costituente, spostata di fatto sui partiti. Il ripetersi delle crisi
extraparlamentari, una costante dellItalia repubblicana, fin dai tempi della Costituente, con la sola
eccezione dei Governi Prodi battuti da due voti in
Parlamento nel 1998 e nel 2008, ne stato il
naturale corollario (244). Dagli anni Novanta in
poi si fatto strada, ma con esiti ancora incerti, il
tentativo di spostare sugli elettori tale funzione di
legittimazione dei Governi.
Non minori problemi ha dovuto affrontare
lattivit legislativa. Oltre allutilizzo massiccio
del decreto-legge, soprattutto dagli anni Settanta
in poi, oltre al ricorso frequente alle deleghe legislative, la legge divenuta ma su questo torneremo (v. infra, sez. IV) non solo un atto sottoposto ai tradizionali limiti esterni sanciti dalle
norme costituzionali, come previsto non senza
titubanze dai Costituenti (245), ma elemento di
unattivit da valutare anche sotto il profilo della
ragionevolezza e delluso corretto del potere
legislativo. In questo quadro gli strumenti per la
tutela dei diritti, e il conseguente necessario bilanciamento fra gli stessi, vengono assunti sempre pi
dal raccordo fra i giudici comuni e le corti costituzionali e sempre meno dai legislatori. Il Parlamento continua a rimanere la sede privilegiata per
le decisioni riguardanti micro-interessi mentre
hanno assunto un crescente rilievo altre sedi istituzionali per le decisioni relative ai macro-interessi: organizzazioni sovranazionali, autorit indipendenti, banche centrali (246). Quanto la caduta
della responsabilit governativa che consegue alla
presenza e allattivit di queste ultime sia compatibile con i principi propri di un governo rappresentativo problema tuttora aperto, in ogni caso
non previsto dalla Costituzione del 1948.
I segni di crisi del Parlamento sono evidenti.
Essi si sono accentuati con la crisi dello Statonazione e il conseguente trasferimento di funzioni
ad autorit sovranazionali; malgrado ci non va
dimenticato che le istituzioni parlamentari hanno
svolto una essenziale funzione di integrazione democratica. Nel corso dellOttocento esse avevano
consentito il compromesso fra aristocrazia e bor(244) Persino un Presidente della Camera Gianfranco Fini giunto al punto di sollecitare proprio una
crisi extraparlamentare: cfr. P. ARMAROLI, Lo strano caso di
Fini e il suo doppio nellItalia che cambia, Pagliai Editore,
Firenze, 2013.
(245) Su queste titubanze v. G. DORAZIO, La genesi
della Corte costituzionale, Edizioni di Comunit, Milano,
1981, 141 ss.
(246) Cfr. CALISE, La costituzione silenziosa, cit.
Costituzione della Repubblica italiana
ghesia liberale, nel Novecento avevano reso pi
agevole il compromesso fra partiti di estrazione
borghese e partiti legati al movimento operaio; in
particolare in Italia esse hanno svolto una essenziale funzione inclusiva, sia nel periodo della
guerra fredda sia nella successiva fase del bipolarismo.
Sul ruolo rispettivo e del Parlamento e del
Governo ha pesato non poco lanomalo bicameralismo perfetto disegnato dai Costituenti. Non
solo, in pi occasioni, esso ha reso impossibile, o
pi difficile, la formazione di maggioranze corrispondenti alla volont dellelettorato ma ha nuociuto alla autorevolezza e alla centralit della sede
della sovranit popolare, costretta a disperdersi in
due rami distinti. Ripetitivit e lungaggini hanno
reso pi facili gli ostruzionismi di maggioranza e di
minoranza e hanno favorito i gruppi di pressione
interessati alla moltiplicazione delle sedi di negoziazione. La struttura bicamerale ha inoltre contribuito ad una cattiva fattura delle leggi: spingendo alla trascuratezza nella prima lettura (fidando nella seconda lettura) ma talvolta irrigidendo la seconda lettura (ogni qualvolta non si
vuole innescare la navette: cos clamorosamente
accaduto nel 2000-2001 per la pasticciata legge di
revisione del Titolo V).
LAssemblea costituente, vicenda nota, non
seppe scegliere n la soluzione monocamerale,
proposta dalle sinistre, n la soluzione regionalcorporativa sostenuta dalla DC e solo alla fine,
dopo la rottura dellunit antifascista, opt per un
bicameralismo garantista. La scelta fu per un
Senato a base regionale (247) e con un elettorato
parzialmente diverso (maggiore et alla Camera,
venticinque anni al Senato), ma con funzioni identiche. Inoltre la scelta del Costituente, corretta poi
nel 1963, prevedeva addirittura una diversa durata
delle Camere (sei anni il Senato e cinque la Camera dei deputati). Per di pi secondo lordine del
giorno Nitti, firmato anche da Aldo Bozzi per i
(247) Definito a base regionale ma senza che, nonostante i tentativi, si fosse riuscito a dare spazio alle comunit
locali: non venne infatti accettata la proposta della Commissione per la Costituzione (cosiddetta Commissione dei Settantacinque) che agli art. 55 e 57 aveva previsto un Senato
eletto per un terzo dai Consigli regionali e per i due terzi
dagli elettori fra candidati aventi particolari requisiti (professori universitari, magistrati, decorati al valor militare
ecc.). Era altres previsto che svolgesse funzioni legislative in
collaborazione ineguale con la Camera dei deputati. Una
proposta di Senato regionale era stata avanzata subito dopo
lUnit (fra gli altri da Gino Capponi): v. P. AIMO, Strutture
e funzioni del Senato Regio, in Il Parlamento italiano. Storia
politica e parlamentare dellItalia (1861-1988) (Autori vari), I,
Nuova CEI, Milano, 1988, 125.
liberali e, a sorpresa, da Palmiro Togliatti per i
comunisti (248), la Camera avrebbe dovuto essere
eletta con il metodo proporzionale e il Senato sulla
base di collegi uninominali. Furono cos respinte
sia le proposte che puntavano anche per il Senato
sul sistema proporzionale sia la proposta Perassi e
Piccioni che invece puntava su elezioni di secondo
grado ad opera dei Consigli regionali. Lordine del
giorno Nitti, come noto, fu poi eluso per lelezione del Senato con la legge pseudo-uninominale
del 1948 (l. 6 febbraio 1948, n. 29, che pose una
soglia quasi irraggiungibile per la conquista del
collegio: il 65 per cento dei voti validi), sulla quale
si sarebbe poi innestato il referendum elettorale del
18 aprile 1993 (volto proprio ad abrogare quel
quorum ed a trasformare in semplice plurality
quella formula).
La base regionale ebbe per anni un solo
significato: che la ripartizione dei seggi avvenisse
avendo come punto di riferimento una circoscrizione regionale e in proporzione alla popolazione
delle Regioni, fermo restando che nessuna Regione pu avere un numero di senatori inferiore a
sette, tranne il Molise che ne ha due e la Valle
dAosta che ne ha uno. Il tentativo operato dalla
legge Calderoli (l. n. 270 del 2005) di prevedere
premi di maggioranza distinti Regione per Regione, in ossequio alla configurazione su base regionale del Senato, non ha retto alle censure della
Corte costituzionale (249). La legge infatti, stabilendo che lattribuzione del premio di maggioranza su scala regionale, produce leffetto che
la maggioranza in seno allassemblea del Senato sia
il risultato casuale di una somma di premi regionali , che pu finire per rovesciare il risultato
complessivamente ottenuto dalle liste o coalizioni
di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza
di una distribuzione del voto nellinsieme sostanzialmente omogenea . Ci, sempre secondo la
Corte, pu compromettere sia il funzionamento
della forma di governo parlamentare delineata
dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere ,
sia lesercizio della funzione legislativa, che lart.
70 cost. attribuisce collettivamente ad entrambe le
Camere. In definitiva, conclude la Corte, si rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con unadeguata stabilit della maggioranza parlamentare e del governo . Con questa
(248) Fu discusso il 25 settembre e approvato il 7
ottobre 1947 con 190 voti contro 181.
(249) C. cost. 13 gennaio 2014, n. 1, cit.
309
Costituzione della Repubblica italiana
decisione la Corte rende evidente lirrazionalit
del sistema a bicameralismo perfetto: rispetto al
quale diventa costituzionalmente inammissibile
qualunque metodo di elezione che riduca significativamente la possibilit che le due Camere abbiano maggioranze omogenee, soprattutto per ci
che concerne linvestitura dei Governi.
Il Costituente fu consapevole di avere adottato
una soluzione ibrida ma ritenne che essa presentava il vantaggio di accrescere le garanzie contro
eventuali dittature di assemblea, e di costituire,
avendo previsto la diversa durata delle Camere (250), un utile freno lo ha ammesso
Dossetti nella sua intervista con Scoppola ed Elia
pubblicata qualche anno fa (251) atto a sfiancare qualunque maggioranza uscita dalle urne. Ma
non valut che la scelta di un bicameralismo
perfetto avrebbe contribuito a indebolire la stessa
forma parlamentare di governo. Forme analoghe
di bicameralismo si hanno invece nei sistemi presidenziali, nei quali per non intercorre una relazione fiduciaria con il Governo, mentre il Presidente pu porre il suo veto sulle leggi approvate
dalle Camere. In nessun sistema parlamentare si
hanno due Camere chiamate entrambe a concedere la fiducia e che possiedono identici poteri di
indirizzo politico, in grado, per di pi, di paralizzarsi vicendevolmente per la presenza di due diversi sistemi elettorali.
Nonostante lequiparazione della durata delle
Camere, avvenuta nel 1963 (l. cost. 9 febbraio
1963, n. 2), lindebolimento del sistema dei partiti
e il superamento del sistema elettorale proporzionale, dopo che il voto ai diciottenni (dalle elezioni
del 1976 in poi) aveva divaricato ancor pi i due
elettorati, avrebbe reso manifesta la debolezza del
bicameralismo disegnato dal Costituente, portando in pi occasioni a maggioranze non coincidenti nelle due Camere (252).
(250) Frutto di un emendamento dellonorevole Lucifero: Atti dellAssemblea costituente, seduta del 9 ottobre
1947, 1076. Ne parliamo pi diffusamente in A. BARBERA, Il
bicameralismo allAssemblea Costituente, in Il Parlamento
italiano. Storia politica e parlamentare dellItalia, cit., XIV,
1989.
(251) V. A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., 64-65.
Sul tema C. FUSARO, La lunga ricerca di un bicameralismo che
abbia senso, in Il governo dei cittadini a cura di A. BARBERA e
G. GUZZETTA, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, 653 ss.
(252) Cos stato nella XII legislatura (con i risultati
elettorali del 1994 il centrodestra non consegu una maggioranza al Senato); cos nella XIII legislatura (con le elezioni
del 1996 la maggioranza di centrosinistra ebbe la maggioranza al Senato ma alla Camera pot dare vita al Governo
Prodi solo grazie allapporto di Rifondazione comunista,
mentre i Governi DAlema e Amato dovettero ricorrere ad
apporti di parlamentari provenienti dal centrodestra); cos
310
Tentativi di superare il bicameralismo perfetto
si susseguono dagli inizi degli anni Ottanta e
costituiscono uno dei punti centrali dei vari progetti di riforma costituzionale. In alcuni progetti
tale obbiettivo perseguito allo scopo di rafforzare la centralit del Parlamento, indebolita
dalla dispersione in due Camere della sovranit
popolare: si vedano i progetti ripetutamente presentati dal PCI e dalla Sinistra indipendente (253);
in altri progetti il medesimo obbiettivo perseguito allo scopo di rendere pi efficiente la funzione di governo. Ma se il superamento del bicameralismo indifferenziato (pars destruens) largamente condiviso non altrettanto pu dirsi per la
parte construens, in relazione alla riforma da porre
in essere: si passa da una seconda Camera che
rappresenta le autonomie, su cui si discusso a
lungo negli ultimi decenni, ad una sorta di Camera
delle garanzie, che, pur variamente declinata,
ricorda, in alcune proposte, le Camere degli ottimati (254), destinate a frenare, come teorizzava il
Conte Boissy dAnglas, con la raison gli ardori
dellimagination delle Camere basse (255) o, come
nella XV legislatura (il Governo Prodi, la cui coalizione in
maggioranza alla Camera, ebbe una esile maggioranza al
Senato e pot sopravvivere solo grazie al voto dei senatori a
vita). Per giungere infine nella XVII legislatura, dopo le
elezioni del 24-25 febbraio 2013, in cui si manifest limpossibilit di dare vita ad una maggioranza conforme alle coalizioni presentatesi davanti agli elettori e la conseguente
necessit di ricorrere a Governi cosiddetti di larghe intese
(prima il Governo Letta e poi, in parte, il Governo Renzi).
Da non trascurare il diverso calcolo degli astenuti nelle
due Camere. Nel febbraio del 2007 il Governo Prodi
entrato in crisi ed stato costretto alle dimissioni. La mozione della sua maggioranza aveva avuto, infatti, 158 voti a
favore e 136 contro. Una differenza di 22 voti che sarebbe
stata una buona vittoria nella Camera dei deputati. A quei
136 voti contrari vanno, per prassi, sommati i 24 senatori
astenuti. Ma, si chiede Andrea MANZELLA (Alice nel paese
degli astenuti, in La Repubblica, 24 febbraio 2007), conforme a Costituzione che chi si astiene cio chi non vuole
prendere posizione n da una parte n dallaltra venga
considerato uguale a chi vota contro?
(253) Chiaro e incisivo RESCIGNO, Costituzione italiana e
Stato borghese, cit., 97: Lassemblea popolare unica pi
diretta, immediata, conoscibile, controllabile, pi esposta
alla critica dellopinione pubblica .
(254) Il Senato da costruire come luogo dei pensieri
lunghi di G. ZAGREBELSKY, Una grande riforma piena di
pasticci, in La Repubblica, 3 aprile 2014. Fra i primi a
proporre il Senato regionale N. OCCHIOCUPO, La Camera
delle Regioni, Giuffr, Milano, 1975; A. BARBERA, Le istituzioni del pluralismo, De Donato, Bari, 1977, 219 ss.
(255) Citato in A. BARBERA, I Parlamenti12, Laterza,
Roma-Bari, 2014, 27; ma v. J.-P. GROSS, La Constitution de
lan III: Boissy dAnglas et la naissance du libralisme constitutionnel, in Annales historiques de la Rvolution franaise, n.
323, 2001, 122 ss.
Costituzione della Repubblica italiana
diceva Melchiorre Gioia, a raffreddare il bollore delle stesse (256).
17. Il Presidente della Repubblica. Anche
i poteri del Capo dello Stato non ebbero nella
Costituente una felice sistemazione (257). Sebbene
ri-dimensionati rispetto allart. 5 dello Statuto albertino, lindeterminatezza degli stessi e listituto
della controfirma, previsto per tutti gli atti del
Capo dello Stato (assicurata, dice lart. 87, da
Ministri proponenti ), non sempre hanno aiutato le relazioni fra lo stesso e il Governo, lasciando spazi o a prevaricazioni ministeriali o a
rinnovate tentazioni dualistiche dei Presidenti o
comunque ad obbiettive incertezze. Lo si visto,
per esempio, con il potere di grazia, su cui in
ultimo intervenuta la Corte costituzionale con una
discussa pronuncia del 2006 (258). Non poche le
incertezze sulle sue stesse prerogative e immunit,
sia per quanto concerne gli atti extra-funzionali
la discussione sulla perseguibilit penale di Scalfaro per taluni pretesi reati compiuti da Ministro o
sulla responsabilit civile di Cossiga (259) , sia
per quanto riguarda la inviolabilit delle comunicazioni su cui agli inizi del 2013 intervenuta la
Corte costituzionale per dirimere un conflitto fra
la Presidenza della Repubblica e la Procura di
Palermo (260) , sia per quanto riguarda la supplenza in caso di impedimento (la vicenda del
Presidente Segni colpito da grave infermit nel
1964).
I punti critici sui quali ha pesato una certa
ambiguit hanno in particolare riguardato la formazione del Governo e il ricorso alle elezioni
anticipate, quelle funzioni ove maggiore il punto
(256) M. GIOIA, Quale dei governi liberi meglio convenga
alla felicit dellItalia (1798), ora Edizioni Vega, Torino,
1946, 36.
(257) Il relatore Egidio Tosato allAssemblea costituente, nella seduta del 19 settembre 1947, cos delineava i
poteri del Capo dello Stato: Nella forma di Governo
parlamentare, il Capo dello Stato ha, indubbiamente, una
sua funzione: questa funzione non soltanto rappresentativa, n importa la possibilit di partecipare effettivamente
ad atti di Governo dello Stato, facendo sentire direttamente,
ma decisamente, la sua voce. Ha, tuttavia, una funzione
essenziale, quella di essere il grande regolatore del gioco
costituzionale, di avere questa funzione neutra, di assicurare
che tutti gli organi costituzionali dello Stato e, in particolare,
il Governo e le Camere funzionino secondo il piano costituzionale .
(258) C. cost. 18 maggio 2006, n. 200.
(259) Sulla giurisprudenza costituzionale v. T. GIUPPONI, Limmunit presidenziale e gli atti extra-funzionali, in
Quaderni costituzionali, 2002, 269 ss.; nonch ID., Le esternazioni di Cossiga di fronte alla Corte costituzionale, ivi, 2000,
643 ss.
(260) C. cost. 15 gennaio 2013, n. 1, cit.
di raccordo con lindirizzo politico, e maggiori
possono risultare le tentazioni di tipo orleanista (261). Di fronte alla genericit del dettato
costituzionale che si limitava a fissare solo il potere
di nomina del Governo da parte del Capo dello
Stato, ed entro dieci giorni dalla formazione il voto
di fiducia delle Camere, si andata opportunamente consolidando una prassi interpretativa, da
Einaudi in poi, ma rimangono tuttora incerti i
poteri in ordine alla scelta dellincaricato e alla
libert dazione di questultimo, tanto nella delineazione delle maggioranze possibili quanto nella
scelta dei singoli Ministri. Da qui lenigmatico
istituto del pre-incarico, a met strada fra lincarico e il mandato esplorativo, che andato
affermandosi nel corso dei primi anni di vita repubblicana e che, da ultimo con la Presidenza
Napolitano, ha creato alcune difficolt allinizio
della XVII legislatura (262). Le ricorrenti turbolenze del sistema partitico hanno, pertanto, portato ad una progressiva crescita di influenza del
Capo dello Stato sugli equilibri di governo, gi a
partire dalla formazione del Governo Pella sotto la
Presidenza Einaudi, per proseguire con la formazione dei Governi Cossiga e Spadolini sotto la
Presidenza Pertini non a caso da qualcuno
definiti a doppia fiducia, parlamentare e presidenziale (263) , passando per la formazione dei
Governi Ciampi e Dini sotto la Presidenza Scalfaro, per culminare nella formazione del Governo
Monti sotto la Presidenza Napolitano, con la parte
assunta dallo stesso Napolitano allapertura della
XVII legislatura nella formazione del Governo
Letta.
Per quanto riguarda, invece, lo scioglimento
delle Camere, per anni si affermata una prassi
sostanzialmente consociativa, che consentiva lo
scioglimento solo previo accordo fra i maggiori
partiti (264). Una sorta di autoscioglimento, cui
si era derogato ununica volta quando nel 1987 il
ricorso anticipato alle elezioni fu concordato solo
fra la DC e il PCI e contro il PSI, che intendeva
(261) C. FUSARO, Il presidente della Repubblica, Il Mulino, Bologna, 2003, 112 ss.; M. TEBALDI, Il Presidente della
Repubblica, Il Mulino, Bologna, 2005, 221 ss. e 309 ss.
(262) Si discusso infatti della natura dellincarico conferito dal Presidente della Repubblica al Segretario del PD
Bersani. Sulla prassi nella formazione dei Governi v. M.
TIMIANI, Crisi e formazione dei Governi: la prassi del maggioritario (1992-2007), in La prassi degli organi costituzionali a
cura di BARBERA e GIUPPONI, cit., 69 ss.
(263) P. ARMAROLI, La doppia fiducia, in Quaderni costituzionali, 1981, 580 ss.
(264) Ne abbiamo parlato in A. BARBERA, Tendenze nello
scioglimento delle assemblee parlamentari, in Rass. parl.,
1996, 233 ss.
311
Costituzione della Repubblica italiana
invece continuare la legislatura. Tale prassi fu
peraltro successivamente contestata dal Presidente
Cossiga sia perch svuotava i poteri del Capo dello
Stato sia perch dava potere di veto al PCI: una
conventio ad consociandum come altra faccia
sosteneva della conventio ad excludendum (265). Dissoltosi il vecchio sistema dei partiti, dalla Presidenza Scalfaro in poi si sono accentuati i poteri del Presidente: addirittura lo scioglimento del 1994, quello del cosiddetto Parlamento degli inquisiti, fu deciso nonostante i
gruppi parlamentari della DC avessero prospettato
come possibile la formazione di un nuovo Governo (266). Superata quella fase, sia il rifiuto dello
scioglimento delle Camere che era stato chiesto
con insistenza dal Presidente del Consiglio Berlusconi nel 1994 dopo la defezione della Lega Nord,
sia il rifiuto che sarebbe stato opposto a Prodi nel
1998 dopo il ritiro dalla maggioranza di Rifondazione comunista (267), sia infine la prassi di
Ciampi e Napolitano hanno portato ad affermare
che il ricorso anticipato alle urne sarebbe legittimo
solo in assenza di una altra possibile compagine di
governo. Di conseguenza si escluso che fra i
poteri del Presidente del Consiglio possa rientrare
la decisione del ricorso anticipato alle urne, vanificando cos un possibile deterrente utile a mantenere la coesione delle maggioranze. La assenza di
questa prassi presente, come dicevamo prima,
in varie forme nelle maggiori democrazie parlamentari ha contribuito non poco nellindebolire i Governi espressi in regime bipolare e pur
politicamente legittimati dal voto popolare. Eppure in periodo statutario era andata affermandosi
(265) Lettera del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga al Presidente della Camera Nilde Iotti del 16
giugno 1991 (reperibile in Archivio della Presidenza della
Camera).
(266) La presenza di una maggioranza fu espressamente
indicata in ripetute posizioni ufficiali del capogruppo della
DC, Gerardo Bianco, e resa evidente dalle riunioni di deputati dei gruppi della maggioranza promosse da Marco Pannella in ore antelucane (v. La Iotti: Paladin insulta la bicamerale. Pannella protesta, il Ministro smentisce, in Corriere
della Sera, 18 maggio 1993). Su tale vicenda v. M. TIMIANI, Il
potere di scioglimento nel sistema bipolare: considerazioni
sotto dettatura della prassi, in Quaderni costituzionali, 2008,
319 ss.
(267) Il Presidente Berlusconi chiese ufficialmente, e in
pi occasioni, il ritorno anticipato alle urne mentre la richiesta di Prodi rimase sotto traccia (ma della sua esistenza ha
recentemente parlato in una lettera al Corriere della Sera lex
Presidente del Consiglio Massimo DAlema Io cercai di
salvare Prodi. Sul mio incarico equivoci e menzogne, in Corriere della Sera, 12 febbraio 2014 , in cui conferma che il
Presidente della Repubblica non volle procedere alle elezioni anticipate chieste riservatamente dal Presidente del
Consiglio Prodi).
312
la prassi secondo cui lo scioglimento della Camera
dei deputati, anche se formalmente disposta con
decreto reale, era frutto della proposta del Presidente del Consiglio, contenuta in una Relazione
allegata al decreto stesso (268). Prassi che era
presente ai Costituenti e che (ma il punto non
chiaro) ha modo di emergere dalla richiesta della
necessaria controfirma del Presidente del Consiglio, da potere leggere sia come proposta sia
come atto di certificazione (in realt nella prassi
vista al massimo come non dissenso del Governo tanto da fare apparire come costruzione
teorica la natura duumvirale dellatto).
La possibilit di rappresentare le proprie scelte
come discendenti direttamente da regole e principi costituzionali ha finito per attribuire unaura
di sacralit costituzionale (269) allesercizio di
funzioni presidenziali altamente politiche (di una
politicit in uscita, anche se non sempre tali in
entrata, nelle intenzioni dei Presidenti). Da qui i
poteri progressivamente assunti dai Presidenti,
non sempre e non tutti riconducibili alla funzione
di garanzia (270): gli interventi ad esempio in
ordine al procedimento legislativo, per lo pi riservati ed informali nellesercizio della cosiddetta moral suasion , si sono non poche volte
tradotti in vere e proprie forme di negoziazione fra
Palazzo Chigi e Quirinale. Talvolta tali interventi
(gi a partire dalla Presidenza Ciampi) hanno toccato, in modo pi trasparente, la fase stessa della
promulgazione, tanto da spingere la dottrina ad
elaborare la categoria della promulgazione dissenziente (271). Lo stesso dicasi, in particolare, in
(268) Puntuali riferimenti in M. BELLETTI, Forma di
governo parlamentare e scioglimento delle Camere. Dallo
Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, Cedam, Padova, 2008. Ma non sempre questo strumento riusc a
svolgere la funzione di stabilizzazione delle maggioranze che
stava progressivamente assumendo in altre democrazie parlamentari.
(269) O. CHESSA, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia costituzionale, in Quaderni costituzionali,
2013, 21-24.
(270) Il tema stato ampiamente discusso in Quaderni
costituzionali, 2103, n. 1, con scritti di R. Bin, O. Chessa, A.
DAndrea, C. Fusaro, D. Galliani, I. Pellizzone, G. Scaccia.
(271) Gli episodi sarebbero non pochi: il pi eclatante
per gli effetti che ne sarebbero conseguiti allapertura
della XVII legislatura riguarderebbe le pressioni di
Ciampi alla fine del 2005 per una modifica della legge
elettorale (il cosiddetto Porcellum) volta a rispettare la
base regionale del Senato. In tema puntuali riferimenti in
S. CALZOLAIO, Il rinvio delle leggi nella prassi, in Quaderni
costituzionali, 2006, 881 ss. Sulla promulgazione dissenziente v. M. GORLANI, Il Capo dello Stato dentro la crisi del
sistema politico e costituzionale italiano, in Forum di Quaderni costituzionali, www. forumcostituzionale.it, sub Temi
di attualit , Presidente della Repubblica , 2011.
Costituzione della Repubblica italiana
ordine alla decretazione durgenza: basti ricordare, dopo un primo precedente di Pertini (272),
il rifiuto di Scalfaro di consentire il varo del decreto-legge Amato-Conso sulla depenalizzazione
di taluni reati legati allillecito finanziamento della
politica e il rifiuto di Napolitano della firma del
decreto con cui il Governo intendeva intervenire a
proposito del cosiddetto caso Englaro (273). Di
notevole rilievo altres i poteri assunti dal Capo
dello Stato nella definizione delle linee di politica
della difesa e della stessa politica estera attraverso
il Consiglio supremo di difesa, del quale Presidente (274).
Come ampiamente riconosciuto, il ruolo del
Capo dello Stato si allarga e si restringe in ragione
del comportamento degli altri due poteri costituzionali, il Parlamento e il Governo (275), vale a
dire, aggiungiamo, in ragione della forza o della
fragilit del sistema partitico. Proprio per il carattere determinante delle variabili politico-parlamentari non possibile condividere la diffusa
opinione secondo la quale si sarebbe stati di fronte
ad una sorta di torsione presidenzialistica da
parte degli ultimi Presidenti (276). Resta vero,
(272) Come riporta il diario di Antonio Maccanico (alla
data del 24 giugno 1980), allora Segretario generale della
Presidenza della Repubblica, il Presidente Pertini rifiut la
firma ad un decreto-legge che regolamentava talune procedure referendarie, gi in via di svolgimento, in senso sfavorevole ai promotori (v. A. MACCANICO, Con Pertini al Quirinale, Il Mulino, Bologna, 2014, 106).
(273) Il decreto fu rifiutato perch avrebbe contraddetto le decisioni assunte dalla Magistratura (in particolare
Cass. civ. 16 ottobre 2007, n. 21748).
(274) Convocato quindici volte da Napolitano contro le
cinque di Pertini (M. AINIS, Napolitano, lesploratore, in Il
grande gioco del Quirinale. La posta in palio nellelezione del
presidente della Repubblica a cura di M. BREDA, Edizioni
Corriere della Sera, Milano, 2013, 72). Linfluenza di Ciampi
nella condotta del Governo sulla guerra in Iraq rivendicata
dallo stesso Presidente nel suo diario, pubblicato in U.
GENTILONI SILVERI, Contro scettici e disfattisti (Gli anni di
Ciampi 1992-2006), Laterza, Roma-Bari, 2013, 193, che
giunse a minacciare un messaggio alle Camere qualora il
Governo non avesse cambiato rotta. Su Napolitano nella
vicenda libica v. G. DE VERGOTTINI, Sicurezza internazionale:
un correttivo presidenziale, in Percorsi costituzionali, 2011, n.
2-3, 83 ss.
(275) Come gli angoli di un triangolo : cos R. BIN, Il
Capo dello stato e la topologia della forma di governo, in
Quaderni costituzionali, 2013, 9.
(276) Addirittura, con la Presidenza Napolitano, si sarebbe realizzato un governo presidenziale al posto di una
repubblica parlamentare : cos G. ZAGREBELSKY intervistato
da Il Fatto Quotidiano, 9 marzo 2014. Di diverso parere
CHELI, Nata per unire, cit., 12. Per quanto riguarda detta
Presidenza, in particolare, vanno valutati noi crediamo
non solo gli interventi posti in essere ma altres quegli
interventi che Napolitano si rifiutato di porre in essere: per
esempio linvito di autorevoli costituzionalisti a procedere
allo scioglimento delle Camere senza controfirma del Presi-
comunque, che i decenni dagli anni Novanta in
poi hanno visto accrescere ruolo e poteri del Capo
dello Stato, fuori dallordinario, secondo unespressione pi volte usata dallo stesso Napolitano (277).
Le tormentate vicende che hanno preceduto la
rielezione di Napolitano (avvenuta dopo 56 giorni
dallelezione del nuovo Parlamento), in particolare
limpossibilit per il partito di maggioranza relativa di proporre un candidato che le altre forze
politiche fossero in grado di votare, hanno dimostrato non solo la gravit della crisi istituzionale
ma, altres, quanto si siano fortemente politicizzate
le votazioni per la elezione del Capo dello Stato,
divenute, ancor pi che in passato, nelle loro
modalit concrete, simili pi allelezione di un
organo di indirizzo che alla elezione di un garante.
Ci spiega vieppi le ricorrenti proposte volte alla
elezione diretta del Capo dello Stato: ne parlarono
gi i socialisti, a partire dal Segretario Craxi nel
1979 e in tale direzione and venti anni dopo una
proposta della Commissione DAlema, in realt
oscillante fra un Capo dello Stato con poteri di
governo (come in Francia) e con soli poteri di
arbitrato e garanzia (come nella realt costituzionale dellAustria). Nella stessa direzione and una
affrettata proposta votata dal Senato nel 2012, alla
fine della XVI legislatura, con il voto della sola
maggioranza di centrodestra (v. infra, 24). Tuttavia, sia chi prospetta lelezione diretta, sia chi
difende lelezione parlamentare non sempre ha
tenuto conto della fisionomia del Parlamento e
dellassetto complessivo del sistema politico. In
particolare la elezione diretta, anche se con doppio
turno, di un Capo dello Stato con poteri di governo potrebbe essere utile solo se volta a comdente del Consiglio (o ricorrendo alla Corte per conflitto di
attribuzione in caso di rifiuto della stessa); in questo senso le
proposte di Gianni FERRARA, Presidente della Repubblica e
scioglimento delle Assemblee parlamentari nellemergenza costituzionale (1o marzo 2011), in Costituzionalismo.it, www.
costituzionalismo.it, 2011, n. 1; e di Lorenza CARLASSARE, Il
Quirinale da solo non basta, in Il Fatto Quotidiano, 11
febbraio 2011. Un clima sopra le righe in cui si inserisce
linvito di Alberto ASOR ROSA a Napolitano ( tempo di usare
la forza per salvare la democrazia, in Il Manifesto, 13 aprile
2011) di procedere, anche con laiuto dei Carabinieri e
della polizia di stato , alla rimozione di Berlusconi e allo
scioglimento delle Camere stabilendo dautorit nuove
regole elettorali (linvito trov nei giorni successivi ladesione di diversi intellettuali, fra cui Barbara Spinelli, Andrea
Camilleri ed altri). Da qui, sempre per dare conto del clima,
la reazione di Giuliano FERRARA, E la sinistra pensa al golpe,
su Libero (nonch su Il Foglio), 14 aprile 2011.
(277) Dati in C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica fra
mito del garante e forma di governo parlamentare a tendenza
presidenziale, in Quaderni costituzionali, 2013, 54 ss.
313
Costituzione della Repubblica italiana
pletare una ristrutturazione in senso maggioritario
della rappresentanza politica; non sarebbe utile
ed anzi sarebbe nociva se dovesse servire a
supplire alla mancata ristrutturazione della stessa.
Si realizzerebbe in tal caso un sistema analogo a
quello di Weimar, che a un Presidente eletto
direttamente affiancava una Camera paralizzata
dal sistema proporzionale.
18. I referendum abrogativi: dal modello della
Costituente alla conformazione giurisprudenziale.
Listituto del referendum non pi il modello
disegnato dalla Costituente ma non pu ancora
dirsi che abbia un volto definito. A ri-modellarne
i profili hanno concorso quattro fattori: luso (e
talvolta abuso) che ne stato fatto dai promotori;
le insofferenze del sistema politico-rappresentativo; gli interventi della Corte costituzionale; la
sopravvenuta disaffezione degli elettori. Gli interventi della Corte in particolare, come vedremo,
sono stati decisivi e sono stati posti in essere nel
tentativo di mantenere o ripristinare un equilibrio
ritenuto, a torto o a ragione, minacciato o dai
promotori o dagli organi rappresentativi: un caso
emblematico in cui linterpretazione dellart. 75
del testo costituzionale ha dovuto fare i conti con
le basi materiali dellordinamento, in questo
caso rappresentate sia dai movimenti della societ
civile, sia dalle forze politiche organizzate e rappresentate, sia dai giuristi che hanno accompagnato (e in alcuni casi promosso) le iniziative
referendarie. Ci apparir pi chiaro soffermandosi in modo pi ravvicinato sulle vicende che
hanno accompagnato la ormai ricca vita di questo
istituto costituzionale (278).
Nel progettare gli istituti referendari, lAssemblea costituente ebbe la preoccupazione di evitare
che il circuito rappresentativo proprio della forma
di governo parlamentare fosse alterato da pronunce dirette del corpo elettorale fino al punto di
mettere in discussione la centralit e del Parlamento e dei partiti politici. In proposito accenti
non distanti si potevano riconoscere nelle posizioni espresse da liberali, come Vittorio Emanuele
Orlando o Luigi Einaudi, e da esponenti del partito comunista. Nonostante il successo conseguito
dalla Repubblica nel referendum del 2 giugno
1946, permaneva quella diffidenza che fino allultimo aveva reso incerti tanti esponenti politici sul
ricorso allo strumento referendario per dirimere la
(278) Pi ampi riferimenti in A. BARBERA e A. MORRONE,
La Repubblica dei referendum, Il Mulino, Bologna, 2003,
nonch in A. CHIMENTI, Storia dei referendum. Dal divorzio
alla riforma elettorale, Laterza, Roma-Bari, 1999.
314
questione istituzionale (i partiti della sinistra,
come noto, avrebbero preferito che la scelta
repubblicana fosse demandata alla Assemblea costituente). La progressiva potatura delle forme
di referendum inizialmente previste, nel passaggio
dalla Sottocommissione allAssemblea fino al testo
dellattuale art. 75 cost., ne costituisce la conferma
pi evidente. La Costituente, in definitiva, si attest su una soluzione tesa ad accentuare nello
strumento referendario i profili di garanzia rispetto a quelli di democrazia diretta: avrebbe dovuto rappresentare solo una estrema forma di
controllo a disposizione del corpo elettorale nel
caso in cui si fosse verificata una dissonanza clamorosa con gli orientamenti del legislatore. N
un caso che soltanto nel 1970 si arriv alla legge
attuativa sulla base di un faticoso (ma riuscito)
compromesso fra i laici, sostenitori della legge sul
divorzio, e i cattolici, che potevano avere cos a
disposizione uno strumento di appello al popolo:
la legge di disciplina dei referendum fu approvata
nel maggio del 1970 (l. 25 maggio 1970, n. 352)
mentre nel dicembre dello stesso anno veniva
approvata la legge Fortuna-Baslini sul divorzio (l.
n. 898 del 1970).
La vittoria del No nel referendum sul divorzio del 12-13 maggio 1974 segn profondamente il sistema politico e la stessa cultura politica:
significativo che in quei mesi prendesse avvio la
strategia di sempre pi intenso riconoscimento di
diritti civili. Laffermazione di una maggioranza
progressista rendeva possibili due scenari politici:
lavvio di processi di alternanza oppure il consolidarsi dei tentativi di compromesso storico. Prevalse il secondo con la formazione dei Governi
Andreotti. in questo contesto politico-parlamentare che prende forma la nuova stagione dei referendum abrogativi, divenuti lo strumento che
gruppi radicali utilizzano per dar corpo alla propria strategia di opposizione al sistema partitocratico, definito un regime. Essi verranno ad
affiancarsi, dopo lingresso del partito radicale in
Parlamento nella VII legislatura, al ricorso generalizzato allostruzionismo parlamentare, di cui abbiamo parlato prima (v. supra, 15).
Da qui, nellestate 1974, il progetto Otto referendum contro il regime riguardanti varie leggi,
ma sostanzialmente incentrati sui temi dei diritti
civili (279). Forte fu la reazione dei partiti, sia di
(279) Delle differenti richieste, per, solo il quesito per
labrogazione di alcune disposizioni del codice Rocco che
prevedevano laborto come reato riusc a raggiungere il
necessario numero di firme. La richiesta, superato il controllo di ammissibilit della Corte costituzionale, fu causa
Costituzione della Repubblica italiana
maggioranza che di opposizione. La strategia referendaria venne affrontata in modi diversi: da un
lato, attraverso tentativi di modificare le leggi sottoposte a richiesta referendaria; dallaltro mediante iniziative parlamentari volte a restringere le
maglie della disciplina del referendum abrogativo.
La risposta pi importante, tuttavia, venne dalla
Corte costituzionale che, con una storica decisione
del 1978 (280), restrinse drasticamente gli spazi
entro i quali il referendum abrogativo pu operare.
Utilizzando i discutibili criteri interpretativi dei
limiti impliciti e della natura dellistituto (in
contraddizione con la tassativit del comma 2
dellart. 75 cost.) la Corte individu ben quattro
ragioni ulteriori di inammissibilit: a) il divieto di
richieste contenenti una pluralit di domande
eterogenee, carenti di matrice razionalmente unitaria (limite della cosiddetta omogeneit del
quesito); b) il divieto di richieste tendenti ad
abrogare, oltre alla Costituzione e alle leggi costituzionali, anche gli atti legislativi dotati di resistenza passiva peculiare; c) il divieto di richieste
aventi ad oggetto disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato , il cui nucleo normativo non possa essere alterato o privato
di efficacia senza che ne risultino lese le corrispondenti norme di rango costituzionale; d) infine le
disposizioni produttive di effetti collegati in modo
cos stretto allambito di operativit delle leggi
espressamente indicate dallart. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa .
Con quella sentenza gran parte delle richieste
radicali caddero e altre ebbero la medesima sorte
in seguito allapprovazione delle leggi oggetto dei
quesiti (interruzione della gravidanza, Inquirente, manicomi), cos mostrando un inedito volto
non ultima dello scioglimento anticipato del 1976 (la causa
prossima fu il ritiro del PSI di De Martino dalla maggioranza), che consent come gi era avvenuto nel 1972 di
rinviare la consultazione referendaria (lapprovazione della l.
22 maggio 1978, n. 194 far decadere liniziativa ma stimoler la presentazione di un ulteriore quesito radicale che si
affiancher ad un quesito di segno opposto del Movimento
per la vita). Ma nel corso del 1977 i radicali poterono
completare la raccolta di firme necessarie anche per altri
referendum, alcuni su materie assai delicate. Si trattava di
iniziative referendarie contro la cosiddetta legge Reale sullordine pubblico (l. 22 maggio 1975, n. 152); contro il
finanziamento pubblico dei partiti politici (l. 2 maggio 1974,
n. 195); sulla disciplina dei manicomi (l. 14 febbraio 1904, n.
36); su norme relative ai procedimenti e ai giudizi daccusa
nei confronti di Ministri (l. 25 gennaio 1962, n. 20); su 97
articoli del codice penale; sul Concordato (art. 1 l. n. 810 del
1929); sul codice penale militare (art. 1 r.d. 20 febbraio
1941, n. 303); sui tribunali militari (r.d. 9 settembre 1941, n.
1022).
(280) C. cost. 7 febbraio 1978, n. 16.
propositivo dei referendum abrogativi. Rimase
aperta, per, la questione del referendum sulla
legge Reale (l. 22 maggio 1975, n. 152), dato che
lUfficio centrale per il referendum aveva riformulato il quesito eliminando il riferimento allart. 5 di
quella legge, ritenuto abrogato per effetto di un
successivo intervento legislativo (art. 2 l. 8 agosto
1977, n. 533). Ci provoc un ricorso dei promotori innanzi alla Corte costituzionale, per conflitto
di attribuzione tra poteri, avverso lordinanza dellUfficio centrale. Si apr cos un ulteriore importante capitolo nella storia del referendum: alla
Corte si chiedeva di stabilire, da un lato, se il
Parlamento, nelle more del procedimento, poteva
o meno intervenire sulla legge oggetto di referendum, e in che modo e fino a che punto ci era
costituzionalmente legittimo; nonch, dallaltro
lato, se esistevano o meno nellordinamento costituzionale strumenti per tutelare di fronte a possibili manipolazioni legislative linteresse costituzionale al pronunciamento popolare mediante referendum abrogativo.
Questultima questione venne risolta dalla
Corte costituzionale attribuendo anche al comitato promotore la qualifica di potere dello
Stato , in rappresentanza dei firmatari, titolari
dellesercizio di una pubblica funzione costituzionalmente rilevante (281). Ammesso il conflitto di
attribuzione, nel corso del conseguente giudizio la
Corte sollev di fronte a se stessa la questione di
legittimit costituzionale dellart. 39 l. n. 352 del
1970 in riferimento allart. 75 cost. Per evitare
possibili applicazioni lesive delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute ai firmatari delle richieste di referendum la Corte dichiar illegittima tale disposizione nella parte in cui prevedeva
che il blocco delle operazioni referendarie si potesse produrre per effetto di altra normativa, anche nel caso in cui essa dovesse apportare solo
innovazioni formali o di dettaglio, senza modificare n i contenuti normativi essenziali dei singoli
precetti, n i principi ispiratori della complessiva
disciplina sottoposta a referendum (282). La
decisione tentava cos di conciliare da un lato la
potest legislativa delle Camere e dallaltro la garanzia del referendum abrogativo, dato che solo
lintervento legislativo effettivamente innovativo
avrebbe determinato la chiusura del procedimento
referendario, laddove modifiche di pura facciata o
di dettaglio avrebbero dovuto consentire, secondo
la Corte, comunque lo svolgimento del referen(281) C. cost., ordinanza, 3 marzo 1978, n. 17, e C. cost.
23 maggio 1978, n. 69.
(282) C. cost. 17 maggio 1978, n. 68.
315
Costituzione della Repubblica italiana
dum, mediante il trasferimento del quesito che
avrebbe dovuto essere operato dallo stesso Ufficio
centrale dalle originarie alle nuove disposizioni
di legge.
Sulle ali del successo elettorale ottenuto nelle
elezioni anticipate del 1979, i radicali lanciarono
una nuova sfida referendaria proponendo altri
dieci referendum (283). Anche in questo caso le
richieste referendarie si muovevano nel solco della
strategia radicale antipartitocratica e, come tali,
vennero percepite dai partiti, che ancora una volta
manifestarono la propria opposizione allabuso
dello strumento referendario ma senza riuscire a
svolgere unazione efficace. Agli inizi del 1981 fu
costretta ad intervenire ancora una volta la Corte
costituzionale, che con varie decisioni (284) ulteriormente accrebbe e specific i limiti di ammissibilit, soprattutto con la richiesta della semplicit
e della chiarezza del quesito e con lesclusione di
quesiti su leggi collegate a quelle precluse.
Al di l delle puntuali discussioni che la giurisprudenza costituzionale ha continuato ad alimentare, evidente che la Corte costituzionale non
solo andata al di l del testo della Costituzione,
ma ha indirettamente portato argomenti alla tesi
della non facile convivenza dellistituto del referendum con il sistema politico rappresentativo. Laccoglimento di una simile impostazione, in particolare, ha costituito la premessa per configurare
lungo tutta la successiva e densa giurisprudenza
costituzionale i rapporti tra legislazione parlamentare e referendum, secondo una implicita gerarchia di valore, quasi a riconoscere una sorta di
preminenza della prima rispetto alle decisioni dirette del corpo elettorale.
Negli anni Ottanta la storia del referendum
abrogativo si incammin su nuovi percorsi che
videro protagonisti gli stessi partiti politici. Significativi, per ragioni differenti, furono, soprattutto,
nel 1985 il referendum sulla scala mobile e nel
1987 quelli sulla cosiddetta giustizia giusta e sul
nucleare. Il primo fu promosso da un partito di
opposizione, il PCI, che peraltro era sempre stato
contrario al ricorso alla decisione popolare. Liniziativa, in particolare, era indirizzata contro la
politica che il Governo Craxi aveva avviato per
contrastare linflazione rompendo il metodo della
(283) Oltre alla legge sullinterruzione della gravidanza,
e a tematiche analoghe a quelle respinte nel 1978, avevano ad
oggetto temi quali la depenalizzazione delluso delle droghe
leggere, il nucleare, la caccia, la smilitarizzazione della Guardia di finanza.
(284) C. cost. 13 febbraio 1981, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30
e n. 31.
316
concertazione, il cosiddetto decreto di San Valentino del 14 febbraio 1984 (285). I referendum
sulla giustizia, sulluso dellenergia nucleare e sulla
responsabilit civile dei giudici, dal canto loro, se
non formalmente, furono in realt promossi da
partiti di governo, sia dal partito socialista, sia da
quello liberale e da alcune associazioni radicali. E
non a caso furono non estranei alle motivazioni
che portarono allo scioglimento anticipato delle
Camere.
Fu in quelloccasione che la Corte non ammise
il referendum volto ad abrogare la legge per lelezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (l. 24 marzo 1958, n.
195) (286) sulla base di una motivazione indefettibilit della dotazione di norme elettorali
per gli organi costituzionali che avrebbe successivamente frenato i tentativi di utilizzare tale
istituto per abrogare leggi elettorali. Questo divieto avrebbe ulteriormente affaticato la vita dellistituto referendario perch lunico modo per
superarlo sarebbe stato il ricorso a quesiti che
mantenevano in vita determinate normative elettorali ma ne cambiavano con studiati ritagli il
significato, accrescendo cos la tipologia dei cosiddetti referendum manipolativi (287).
Con i referendum del giugno 1990 su caccia e
fitofarmaci e del 9 giugno 1991 sulla pluralit delle
preferenze, liniziativa torna in mano ai movimenti. Il primo, promosso da ambientalisti, non
raggiunge il quorum (il 43,4 per cento) anche
grazie allinvito allastensione da parte dei cacciatori. Il secondo, promosso da vari movimenti civici, il pi importante dei quali faceva capo a
Mario Segni, ottiene un quorum alto (il 62 per
cento) nonostante linvito a disertare le urne da
parte del Segretario della Lega Nord e del Segretario del partito socialista, Bossi e Craxi. Il successo di questa iniziativa referendaria, seguita da
quello successivo del 18 aprile 1993 (un quorum
ancora pi alto: il 77 per cento), coglier linsofferenza dellelettorato per un sistema politico in
crisi di consenso e dar vita alla stagione delle
riforme, quelle che nel decennio 80-90 il Parlamento non era riuscito a realizzare, attraverso la
modifica delle leggi elettorali di Camera, Senato e
Comuni e labolizione del finanziamento pubblico
(285) D.l. 17 aprile 1984, n. 70 (convertito con modificazioni dalla l. 12 giugno 1984, n. 219), cos definito perch
recepiva laccordo sottoscritto il 14 febbraio da CISL e UIL,
con il dissenso della CGIL.
(286) C. cost. 3 febbraio 1987, n. 29.
(287) Ne abbiamo parlato in A. BARBERA, Il contributo di
Serio Galeotti alle riforme costituzionali, in Scritti in onore di
Serio Galeotti, I, Giuffr, Milano, 1998.
Costituzione della Repubblica italiana
dei partiti. Per effetto di quei referendum si ebbe
una notevole spinta per il passaggio dalla democrazia consociativa ai governi dellalternanza a livello nazionale, locale e (con una modifica costituzionale del 1999: l. cost. n. 1, cit.) regionale.
Stabilizzatosi il quadro politico, mancheranno
invece il raggiungimento del quorum due quesiti
volti a conseguire il pieno passaggio ad un sistema
maggioritario attraverso labrogazione della quota
proporzionale (fissata al 25 per cento) prevista per
la Camera dei deputati dalla legge elettorale del
1993, la cosiddetta legge Mattarella (l. n. 277, cit.):
per poche migliaia di voti nel 1999 e in modo assai
pi consistente nel 2000. Parimenti mancher il
quorum il cosiddetto referendum Guzzetta nel
2009 (288) che cercava di colpire quella parte della
legge elettorale (la cosiddetta legge Calderoli questa volta, l. n. 270 del 2005) che attribuiva il
premio di maggioranza alle coalizioni anzich alla
lista pi votata. Successivamente la Corte non dar
il via libera al cosiddetto referendum Morrone (289) che, invece, avrebbe puntato alla reviviscenza della legge Mattarella.
Altri movimenti, stavolta riconducibili alla sinistra radicale, tenteranno la abrogazione per via
referendaria, di talune norme restrittive in materia
pensionistica, ma nel 1994 la Corte individuer
nella tutela degli equilibri finanziari un altro
confine alle iniziative referendarie, collocando tra
le materie escluse non solo le leggi tributarie e di
bilancio ma anche le leggi che (allora era la legge
finanziaria) definiscono le compatibilit economiche, le grandezze finanziarie e le determinazioni
quantitative, per gli anni considerati, degli stanziamenti o delle riduzioni di spesa (290). Non
raggiunger invece il quorum nel 2003 un altro
quesito referendario promosso da gruppi analoghi
e da Rifondazione comunista volto ad estendere
lart. 18 dello statuto dei lavoratori (l. n. 300 del
1970) anche alle imprese con meno di quindici
lavoratori.
Nel 1995, in un quadro politico non ancora
definito, si ebbe una tornata referendaria con ben
(288) Ammesso da C. cost. 30 gennaio 2008, n. 15 e
n. 16.
(289) C. cost. 24 gennaio 2012, n. 13.
(290) C. cost. 12 gennaio 1994, n. 2. In quella occasione, peraltro, si intravvide una opinione dissenziente nella
non consueta coincidenza fra il giudice relatore (Ugo Spagnoli) e il giudice redattore (Cesare Mirabelli). Analoga
decisione stata assunta dalla Corte (C. cost. 27 gennaio
2015, n. 6) su una iniziativa di abrogazione del d.l. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l.
22 dicembre 2011, n. 214, in materia pensionistica, promossa dalla Lega Nord.
dodici quesiti, promossi sulle materie pi disparate da movimenti legati ad ambienti non sempre
politicamente omogenei e talvolta contradditori:
per esempio per la privatizzazione della RAI e la
riduzione dei canali televisivi della Fininvest; contro i vincoli alle autorizzazioni nel settore del
commercio e contro i limiti agli orari dei negozi;
contro il soggiorno cautelare; contro i contributi
sindacali e le modalit della rappresentanza sindacale; per modificare ancora la legge elettorale per
i Comuni. I risultati non sempre univoci (5 S
e 7 No ) dimostreranno in quelloccasione una
non scontata capacit di scelta degli elettori fra
quesiti non sempre lineari ma confermeranno anche lutilizzazione del referendum per battaglie
trasversali tra partiti: i referendum televisivi contro il centrodestra di Berlusconi, quelli su materie
sindacali contro la sinistra, quelli sul soggiorno
cautelare a favore delle istanze leghiste.
Dopo quelloccasione non sar per diversi anni
raggiunto il quorum: ne faranno le spese nel 1999
e soprattutto nel 2000 i citati referendum elettorali;
nel 1997 diversi referendum radicali (obiezione di
coscienza, caccia, carriere dei magistrati, ordine
dei giornalisti, Ministero dellagricoltura); nel
2005 quattro referendum contro la l. 19 febbraio
2004, n. 40, relativa alla procreazione medicalmente assistita (fece molto discutere in quelloccasione linvito della Conferenza episcopale a disertare le urne). Raggiunger il traguardo invece, nel
2011, un referendum contro una pretesa privatizzazione dei cosiddetti beni comuni (in particolare i servizi idrici) e contro il ritorno allo sfruttamento dellenergia nucleare; referendum promossi da movimenti ambientalisti ma che, al di l
degli oggetti, avevano come collante lavversione
alla politica del Governo di centrodestra e come
obbiettivo politico la ri-costruzione di una diversa
sinistra di opposizione e poterono raggiungere il
quorum grazie allemozione creatasi pochi mesi
prima con il grave incidente nucleare in Giappone.
Malgrado i tentativi tesi a restringerne le potenzialit, il ricorso al confronto referendario ha
svolto un ruolo positivo nella dialettica della democrazia italiana. Ha contribuito a mettere in
moto significativi processi di trasformazione sociale e politica, non solo quando ha aperto il
dibattito politico su questioni fondamentali in materia di diritti civili e sociali, ma anche quando ha
chiamato il corpo elettorale a pronunciarsi su questioni istituzionali di essenziale importanza per il
funzionamento delle strutture costituzionali. Nonostante il modello costituente fosse diretto a
predisporre uno strumento di garanzia che offrisse
317
Costituzione della Repubblica italiana
una difesa della societ civile contro un potere
legislativo invadente, in realt solo in alcuni casi
liniziativa referendaria ha svolto detta funzione.
Essa ha invece rivelato diverse altre potenzialit:
come strumento di strategie partitiche volte a rafforzare questa o quella forza politica; come strumento di decisione su beni e valori che toccano la
coscienza individuale; come strumento per sollecitare il Parlamento allapprovazione di determinate leggi; come modo per introdurre direttamente scelte legislative (attraverso quesiti parziali con effetti manipolativi); come strumento
per rimodellare lo stesso sistema politico.
Queste potenzialit del referendum hanno incontrato vieppi un limite clamoroso tuttaltro che
immaginabile dai Costituenti: lastensionismo elettorale. Lappello allastensione dal voto, infatti, ha
fornito ai gruppi e agli interessi colpiti una formidabile arma per contrastare nella maniera pi
efficace ogni iniziativa referendaria sgradita. Aggiungendo al naturale assenteismo di una parte del
corpo elettorale la mancata partecipazione al voto
dei contrari al quesito abrogativo appare sempre
pi facile contrastare liniziativa referendaria non
gradita (291).
Tenuto conto del crescente tasso di assenteismo che affligge vieppi lelettorato anche nelle
elezioni politiche, la sorte di questo istituto di
democrazia diretta appare dunque strettamente
legata alle sorti degli stessi istituti di democrazia
parlamentare, superando quella contrapposizione
fra istituti di democrazia diretta e istituti rappresentativi che, come abbiamo visto, ha contrassegnato gli anni Settanta e Ottanta. Questa considerazione pu avere indotto la Corte a porre ulteriori
vincoli al legislatore, fin qui non sollecito nel
rispettare il risultato delle consultazioni referendarie. Nel 2012 ha dichiarato costituzionalmente
illegittima una norma contenuta in una disciplina
sui servizi pubblici locali (d.l. 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148) per non avere rispettato
il risultato del sopra citato referendum del
2011 (292). Un simile vincolo derivante dallabro(291) Sul punto A. MORRONE, Linvito a disertare le
urne, tra storia, Costituzione e regole di correttezza, in Quaderni costituzionali, 2003, 597 ss. Da qui la proposta di
calcolare il quorum non con riferimento agli aventi diritto al
voto ma al numero dei votanti registrato nelle precedenti
elezioni politiche (la proposta in BARBERA e MORRONE, La
Repubblica dei referendum, cit., 245): cos dal 2004 lart. 75
dello Statuto della Toscana e cos il progetto di riforma
costituzionale in corso di approvazione (in Atti parl. Sen.,
XVII legislatura, doc. n. 1429-B).
(292) C. cost. 20 luglio 2012, n. 199.
318
gazione referendaria si giustifica, secondo la Corte,
proprio nella prospettiva di integrazione degli
strumenti di democrazia diretta nel sistema di
democrazia rappresentativa delineato dal dettato
costituzionale. Tale vincolo, tuttavia, resta necessariamente delimitato, in ragione del suo carattere
puramente negativo: secondo la Corte il legislatore
ordinario, pur dopo laccoglimento della proposta
referendaria, conserva il potere di intervenire nella
materia oggetto di referendum purch sussistano
condizioni tali da giustificare il superamento di un
divieto di ripristino (ad esempio il tempo trascorso
nel quale si verifichino mutamenti idonei a legittimare la reintroduzione della disciplina abrogata).
19. Le Regioni e il tentativo federalista.
Mentre le riforme relative alle istituzioni centrali
di governo sono rimaste lettera morta, notevole
stato lintervento sullordinamento delle Regioni.
Come noto, la Costituente escluse decisamente la
opzione federale (peraltro allora assai minoritaria)
e proclam la Repubblica (richiamandosi alla formula della Rivoluzione francese dopo la vittoria
sui Girondini) una e indivisibile . Lordinamento regionale delineato dalla Costituente rappresent un compromesso debole fra le posizioni
regionaliste della DC e quelle pianificatrici e centraliste delle sinistre. I passaggi decisivi per lattuazione dellordinamento regionale furono poi
tormentati, e possono essere riassunti in quattro
momenti: a) il disegno della Costituente e linattuazione dello stesso negli anni Cinquanta e
larga parte degli anni Sessanta; b) lavvio delle
Regioni allinizio degli anni Settanta; c) la esplosione del fenomeno leghista negli anni Novanta e
la manifestazione di talune pulsioni secessioniste;
d) la riforma (impropriamente definita) federalista attuata con la riscrittura del Titolo V nel 2001.
In tutti questi passaggi mai noi crediamo
il regionalismo (e tanto meno il federalismo)
stato perseguito con autentica convinzione, mentre sono prevalse strategie strumentali di carattere
politico-partitico. Gi fin dal primo passaggio, fu
assai significativo il rapido mutamento di fronte
dopo il 18 aprile del 1948: i democristiani e le
sinistre si scambiarono velocemente i ruoli. La DC,
che era stata promotrice nellAssemblea costituente del disegno regionalista, forte peraltro di un
robusto retroterra culturale (293), assunse posi(293) Fin dalla fondazione del partito popolare: n. 6 del
Programma del partito popolare, ora in L. STURZO, Le autonomie regionali e il Mezzogiorno, Edizioni il Commento,
Roma, 1944, 8 ss.; v. anche ID., La Regione nella Nazione,
Zanichelli, Bologna, 1949. Ma in questo senso lo stesso
Costituzione della Repubblica italiana
zioni centraliste, a difesa dei Ministeri romani, che
ovviamente poteva controllare, mentre le sinistre,
assai tiepide nella Costituente, diventeranno strenuamente regionaliste.
Si dette vita alle Regioni siamo al secondo
passaggio con la legislazione della fine degli
anni Sessanta e le prime elezioni della primavera
del 1970. Allora quella scelta ebbe il significato di
una sorta di compensazione per i comunisti,
esclusi dal governo centrale, ancor pi che un
coerente strumento di incisiva riforma dello Stato.
Negli anni Settanta la attuazione della riforma
regionale sarebbe stata lenta e faticosa, prima con
gli insufficienti decreti del 1972 (d.P.R. 14 gennaio
1972, n. 1-6; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7-11) poi
con il pi avanzato d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Da un lato il tentativo di fare delle Regioni e dei
poteri locali lo strumento per la riforma dello
Stato e per lavvio di una programmazione economica nazionale, gi impostata dai primi Governi di
centrosinistra le Regioni per la riforma dello
Stato, le Regioni per la programmazione furono parole dordine di quegli anni (294) ;
dallaltro le resistenze centraliste, spesso in sinergia con antiche chiusure municipaliste, portarono ad un progressivo declino dellordinamento regionale che percorrer tutti gli anni Ottanta, con le Regioni, in pratica, ridotte ad agenzie
di spese decise dal centro (295).
Negli anni Novanta siamo al terzo passaggio
sotto la spinta della Lega e dei suoi successi non
si parla pi di attuazione costituzionale ma di
riforma e si inizia una fuga in avanti: si persegue
addirittura il federalismo e tutti i partiti (comprese le forze di tradizione centralista o nazionalista) abbracciano parimenti una cos impegnativa
parola dordine. In questo clima si giunge nel 1999
Romolo MURRI nel punto 4 dei Propositi di parte cattolica
(1899), ora in ID., Democrazia cristiana, Gentile Editore,
Milano-Roma, 1945, 127. Sul punto rinviamo anche a A.
BARBERA, C. DE CARO e A. AGOSTA, Lattuazione dellordinamento regionale, in Il Parlamento italiano. Storia politica e
parlamentare dellItalia, cit., XX, l992.
(294) La politica di programmazione era stata avviata
allinizio degli anni Sessanta con la trasformazione del Ministero del bilancio in Ministero del Bilancio e della
programmazione economica, il varo del primo programma
nazionale e la istituzione, in attesa delle Regioni, dei comitati
regionali della programmazione economica quali organi periferici del Ministero: v. M. CARABBA, Un ventennio di programmazione 1954/1974, Laterza, Roma-Bari, 1977; V. CASTRONOVO, La storia economica, in Storia dItalia, IV, t. 1,
Einaudi, Torino, 1975.
(295) Cfr. A. BARBERA e L. CALIFANO, Dallattuazione
dellordinamento regionale ai progetti di riforma del Titolo V,
in Saggi e materiali di diritto regionale a cura di A. BARBERA e
L. CALIFANO, Maggioli, Rimini, 1997, 15 ss.
(l. cost. n. 1, cit.) ad un notevole ampliamento
della potest statutaria delle Regioni, soprattutto
in riferimento alla forma di governo, in modi non
conosciuti da altri Stati (anche di tradizione federale). Una potest in realt mai esercitata fino in
fondo (296). In questo quadro la soluzione transitoria adottata con legge nazionale elezione
diretta del Presidente della Regione, in analogia
alla elezione diretta del Sindaco, operata nel 1993
(l. n. 81, cit.) ha ridato slancio agli Esecutivi
regionali. Invece la successiva revisione costituzionale caratterizzata dalla inversione nella distribuzione delle materie anticipata dalla generosa
legislazione di fine anni Novanta porter alladozione di un modello cosiddetto federalista
fondato sulla individuazione delle sole competenze legislative statali e concorrenti, lasciando
quelle residuali alle Regioni mentre le competenze amministrative, in forza del principio di
sussidiariet, furono riconosciute o attribuite ai
Comuni (peraltro cos come sono, non accorpati),
salva lindividuazione legislativa di un livello superiore per lesercizio di quelle non adeguatamente
esercitabili a livello municipale.
Eppure pochi anni prima (1992-1994) nella
Commissione De Mita-Iotti il termine federale
era stato bandito da tutti i gruppi politici, tranne
ovviamente dalla Lega. Poi la scelta federalista
riemerge improvvisamente allepoca del Governo
Dini (1995). il periodo in cui la Lega era incerta
se tornare alla alleanza con Berlusconi ovvero fare
una scelta opposta: una fase in cui, comunque, i
voti leghisti erano divenuti appetibili per entrambi
gli schieramenti. Da questa rincorsa alla Lega
nacque la riforma varata in tutta fretta nel 2001 (l.
cost. n. 3, cit.), e con lo scarto di appena 7 voti, da
un centrosinistra sorprendentemente unanime (ma
poi nellautunno la revisione venne confermata dal
referendum, in pratica senza opposizioni significative). Una riforma talmente generosa da risultare
stupefacente: si pensi, ad esempio, che il Parlamento non esit a trasferire alla competenza concorrente delle Regioni la produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dellenergia o le grandi
reti di trasporto e di comunicazione o lordinamento delle professioni .
La riforma del 2001 dava vita ad un groviglio
inestricabile di competenze sovrapposte fra Regioni, Province e Comuni, cos complicando o
addirittura paralizzando i processi decisionali,
mettendo in discussione la tutela degli interessi
(296) Cfr. M. RUBECHI, La forma di governo regionale fra
regole e decisioni, Aracne, Roma, 2010, 50 ss.
319
Costituzione della Repubblica italiana
nazionali (il limite dellinteresse nazionale voluto dal Costituente scompare dal testo) e costringendo la Corte costituzionale a ripetute e innaturali supplenze. In tale quadro una norma (art. 116
comma ult.) non escludeva una ulteriore differenziazione delle Regioni da affiancare alle Regioni
speciali, istituite nel particolare clima del dopoguerra. Emblematica al riguardo la lacerazione
inferta alla Carta costituzionale attraverso la riscrittura dellart. 114 ispirato a suggestioni federaliste che la Costituente, come dicevamo, aveva
espressamente escluso (297). In base alla nuova
formulazione di tale disposizione della Costituzione, la Repubblica costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Citt metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato . La Repubblica non si
riparte in Regioni, Province e Comuni (come nel
vecchio art. 114) ma costituita da quegli
stessi enti, cui si aggiungono per le Citt metropolitane e lo Stato. Sono non pochi gli interrogativi che questa norma ha suscitato. In effetti la
nuova formulazione utilizza volutamente unespressione che richiama un processo costituente, quasi ne fossero protagonisti gli enti in
questione, Stato, Regioni, Province, Citt metropolitane, Comuni (298); ma non chiaro quali
siano i soggetti che stipulerebbero il foedus, se le
Regioni o le comunit infra-regionali o lo Stato.
Diverse le implicazioni che si possono trarne; ci
limitiamo a un solo punto: secondo lo schema
dellart. 114 il Parlamento, in quanto rappresenta la Nazione (art. 67 cost.), organo della
Repubblica o organo dello Stato? Linterpretazione pi rigorosa dovrebbe portare alla paradossale conclusione che lunico organo della
Repubblica la Corte costituzionale e che solo ad
essa affidato il compito di tutelare lunit della
Repubblica e gli interessi nazionali (299). Come
(297) Scriveva allora Luigi Sturzo le ombre federaliste
non esistono perch nessun federalismo pu derivare dagli
istituti creati dallunica volont nazionale espressa dalla Costituente : Lettera di Luigi Sturzo a Carlo Bozzi Presidente
dellIstituto per gli studi giuridici e politici sulla Regione, ora
in G. COPPA, Lente regione, Editrice Pironti, Napoli, 1950,
13.
(298) Lo conferma lautore stesso della formula, Ettore
Rotelli, che la propose nellambito della Commissione DAlema: E. ROTELLI, Comuni, Province, Regioni e Stato nella
terza bicamerale, in Amministrare, 1998, 299 ss.
(299) La formula riecheggia la Dreigliedrigkeitslehre,
che risale al periodo in cui la dottrina tedesca di fine
Ottocento intendeva mettere sullo stesso piano di dignit il
Re di Prussia, Imperatore del Reich, e i duchi e monarchi dei
regni federati. Essa si basava su un triangolo formato da un
vertice, il Gesamtstaat (lo Stato complessivo), e due lati,
lOberstaat (lo Stato superiore, il Bund) e i Gliedstaaten (gli
Stati membri, i Lnder). Ma la tesi triadica stata defini-
320
gi anticipato nelle pagine precedenti, se si fosse
voluto effettivamente rifondare la Repubblica si
sarebbe mutata (non solo revisionata) la Costituzione mettendo in contraddizione il nuovo
art. 114 con il tuttora vigente art. 5 (la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali ). Qualora detta innovazione
normativa avesse voluto incidere su detti principi
avrebbe dovuto scontrarsi con i limiti alla revisione costituzionale derivanti dai principi fondamentali della Costituzione. Lunica lettura possibile pu essere offerta dalla distinzione fra Statoordinamento e Stato-persona, fra Stato-comunit e Stato-apparato, distinzione non estranea
alla Costituzione del 1948 (300).
Dietro la formula dellart. 114 c anche un
dilemma lasciato aperto dalla Costituzione del
1948: la valorizzazione della dimensione regionale
oppure la coesistenza della stessa con una impostazione di tipo municipalista, volta ad un rapporto diretto fra Stato ed enti locali. Lavviato
superamento delle Province (l. 7 aprile 2014, n.
56, cosiddetta legge Delrio) e il ruolo riconosciuto
al legislatore regionale nella ridistribuzione delle
loro funzioni possono forse rappresentare loccasione per ripensare questo tema.
Il nuovo Titolo V stata una risposta sbagliata
e radicale a problemi reali, sollevati dalla Costituzione del 1948. La scelta della Costituente a favore
dellordinamento regionale avvenne nel contesto
tivamente respinta dal Bundesverfassungsgericht nel 1961:
BVerfG 11 luglio 1961, in Deutsche Verwaltungsblatt (DVBl),
1961, 587; determinante stato largomento lo diciamo in
sintesi che il Bund non pu avere o perseguire interessi
diversi dal Gesamtstaat. In linea con tale orientamento, nella
nuova formula dellart. 72 GG, varata nel 1994, il gesamtstaatlichen Interesse corrispondente per molti versi al
nostro interesse nazionale esplicitamente affidato alla
cura del Bund, vale a dire dellOberstaat.
La portata dellart. 114 stata ridimensionata dalla
Corte in due decisioni: con C. cost. 24 luglio 2003, n. 274, la
quale ha sancito che la formula dellart. 114 non comporta
affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati,
che dispongono di poteri profondamente diversi fra loro , e
con C. cost. 7 novembre 2007, n. 365, che ha annullato una
legge della Regione Sarda la quale faceva riferimento ad una
pretesa sovranit regionale . Utile la ricostruzione di S.
CALZOLAIO, Il cammino delle materie nello Stato regionale. La
definizione delle competenze legislative nellordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2012, 262 ss., che trae
proprio dalla formula dellart. 114 la base per la tutela di
quegli interessi nazionali che invece il testo del Titolo V
aveva ignorato.
(300) Altrettanto potrebbe dirsi per il principio di sussidiariet orizzontale, inserito nellart. 118 con una forte
spinta proveniente da ambienti cattolici. Questo, lungi dal
rappresentare un nuovo principio fondamentale, invece da
intendersi una specificazione dei principi contenuti nellart.
2 cost., relativi alla valorizzazione delle formazioni sociali.
Costituzione della Repubblica italiana
di uneconomia prevalentemente rurale mentre
oggi la valorizzazione dei Governi regionali richiesta soprattutto dai processi di globalizzazione.
Il Titolo V uscito dallo schema della Costituente
ma non ha saputo adeguarsi alla flessibilit dei
livelli di governo richiesta dalla economia globalizzata e dal mercato unico europeo. Come causa
ed effetto insieme della globalizzazione delleconomia si accelerato, in breve, il passaggio dal
modello dellimpresa fordista al modello dellimpresa a rete, diffusa, interconnessa e ad alta
tecnologia. Mentre lorganizzazione fordista modellata in modo piramidale e ha bisogno di interloquire con strutture centralizzate dello Stato,
limpresa a rete ha bisogno di un contesto territoriale favorevole, n centralizzato, n frammentato
in logiche micro-localistiche e municipalistiche. Le
cosiddette variabili ambientali costituiscono ormai
fattori esterni allimpresa, strettamente dipendenti
dal territorio in cui essa opera, sia sotto il profilo
della sua infrastrutturazione sia con riferimento ai
valori culturali in esso radicati. Sono queste le
ragioni per cui la competizione in una economia
globale tende sempre pi a porsi come competizione non solo fra singole imprese ma fra sistemi
territoriali regionali (301). Sono queste le motivazioni che fanno propendere per una riconferma
della scelta regionalista della Costituzione del
1948. Lesperienza maturata, che ha fatto emergere una scarsa vocazione legislativa delle Regioni,
dovrebbe portare a rafforzarne la possibile voca(301) Basti pensare, per esempio, al ruolo del Galles, di
importanti zone dellIrlanda, della Regione del Reno settentrionale, della Regione catalana, dellarea di Tolosa, della
Regione del Rodano, oppure, in altri Continenti, della Regione-Stato di Singapore, della Regione di Osaka, di Tokyo,
della Silicon Valley, di San Diego. Lesperienza italiana dei
distretti industriali spesso con dimensioni territoriali pi
ridotte rappresenta una variante significativa di tale regionalismo, talvolta utilizzata come modello in varie parti del
mondo. Solo robusti livelli regionali e locali di governo sono,
infatti, potenzialmente in grado di creare le sopra ricordate
condizioni ambientali; di favorire cooperazione fra imprese,
flessibilit dei fattori della produzione, equilibrio fra gli
stessi, intercambiabilit di conoscenze, compatibilit produttive. Solo tali livelli di governo si ritiene possono
fornire in particolare adeguati servizi reali alle imprese,
dalla formazione professionale alla infrastrutturazione del
territorio, alle reti di approvvigionamento (idrico, energetico, ecc.), ai sistemi integrati di trasporto e di comunicazione, al cablaggio e allinformatizzazione, ai servizi di disinquinamento. Ne abbiamo parlato in A. BARBERA, Le scienze
geografiche e lassetto territoriale delle istituzioni regionali e
locali, in Bollettino della Societ geografica italiana, 2000,
fasc. 3, pubblicato anche con il titolo Lassetto territoriale
delle istituzioni regionali e locali nellera della globalizzazione,
in Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi, I,
Giappichelli, Torino, 2004, 119-133.
zione amministrativa (come in altre parti dEuropa, del resto).
Per liberarsi dal groviglio inestricabile delle
competenze emersa lesigenza di evitare il riferimento alle materie e puntare piuttosto sulle
diverse funzioni dei vari livelli di governo e sui
programmi e gli obbiettivi che ognuno di essi pu
essere chiamato a realizzare (302). Il passaggio
successivo pare, quindi, obbligato: affidare alla
legge dello Stato attraverso una clausola di supremazia come in molti Stati veramente federali
il bilanciamento fra gli interessi coinvolti,
quelli nazionali e quelli locali. Ovviamente un
bilanciamento ispirato a criteri di congruit, ragionevolezza e proporzionalit, pur sempre sindacabili dalla Corte. Un bilanciamento che parta da
una valorizzazione delle autonomie non come un
bene in s ma come modo pi flessibile e aperto
per perseguire politiche pubbliche che sono soprattutto nazionali, sia pure nella cornice europea.
La legislazione e la giurisprudenza di questi ultimi
anni, peraltro, sempre pi riescono a fare prevalere gli interessi unitari, soprattutto attraverso il
coordinamento finanziario e la normativa derivante dallintegrazione europea, fino a indurre la
Corte a giustificare interventi sullautonomia statutaria delle Regioni (303).
Il bilanciamento fra interessi nazionali e rispetto delle autonomie regionali sar possibile realizzarlo se si riuscir a chiudere una pagina lasciata
aperta dalla Costituzione del 1948, vale a dire la
presenza delle autonomie regionali nella seconda
Camera della Repubblica, di cui abbiamo prima
parlato a proposito del Parlamento. Le soluzioni
tentate in alternativa la Conferenza delle Regioni o il rafforzamento della Commissione per le
questioni regionali previsto dallinattuato art. 11 l.
cost. n. 3 del 2001 non hanno dato, o forse non
(302) Abbiamo approfondito questo aspetto in A. BARDa un federalismo insincero ad un regionalismo preso
sul serio? Una riflessione sullesperienza regionale, in St. parl.
pol. cost., 2011 (Studi in onore di Nicola Greco), n. 171-172,
19-50, nonch in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, sub Paper , 2 ottobre 2012. La
Corte, del resto, ha pi volte distinto materie e funzioni (per esempio per il coordinamento finanziario: C.
cost. 23 dicembre 2004, n. 414). Superata una lettura imperniata sulle materie la strada pare obbligata: seguire con pi
decisione una lettura finalistica, sostituendo a una rigida
distribuzione delle materie, ispirata a un federalismo duale
(anacronistico perch non pi attuale in nessun Stato federale), una pi moderna e flessibile ripartizione per funzioni
ed obbiettivi (sul punto v. anche F. BENELLI, La smaterializzazione delle materie. Problemi teorici ed applicativi del
nuovo Titolo V della Costituzione, Giuffr, Milano, 2006;
nonch CALZOLAIO, op. ult. cit., 151 ss.).
(303) C. cost. 20 luglio 2012, n. 198.
BERA,
321
Costituzione della Repubblica italiana
potevano dare, i risultati attesi. Il progetto di
riforma del Senato e del Titolo V approvato in
prima lettura dal Senato della Repubblica e dalla
Camera dei deputati (marzo 2015; v. infra, 24)
pu essere loccasione per riprendere questa pagina. Anche se non il momento migliore per
ripensare lordinamento regionale: le malversazioni ad opera di consiglieri regionali svelate nel
corso del biennio 2013-2014 hanno fatto ri-emergere una cultura centralista, mentre non mancano
forze politiche e ambienti culturali che, di tanto in
tanto, evadendo dai temi concreti, provano a rilanciare o il superamento delle Regioni o la costituzione di improbabili macroregioni (304).
Sez. IV. LESPANDERSI
DELLE GIURISDIZIONI.
20. La Corte costituzionale: dal sillogismo alla
lettura secondo valori. Come noto, fin dalla
sua prima decisione (305), la Corte costituzionale
respinse ogni tentativo di distinguere fra le disposizioni costituzionali in relazione al loro contenuto
normativo (anche se il loro contenuto precettivo
veniva graduato dalla stessa sentenza nel momento
in cui attribuiva solo ad alcune una forza direttamente abrogatrice). A questo esito aveva contribuito quella parte della dottrina fortemente impegnata nel tentativo di mettere in risalto le caratteristiche di norma giuridica delle disposizioni
costituzionali (306). In tal senso spingevano sia gli
influssi positivistici che non tolleravano norme
che non potessero tradursi in imperativi sia,
soprattutto, la necessit di rintuzzare i tentativi di
confinare la Costituzione ai margini dellordinamento, come se si trattasse di norme essenzialmente programmatiche, contenute in un documento di valore storico-politico (307).
(304) Talvolta disegnate in modo bizzarro: v. il suppl. a
Limes, 1994, n. 4.
(305) C. cost. 14 giugno 1956, n. 1, cit.
(306) Questo il significativo titolo di un volume di
Paolo BARILE (La Costituzione come norma giuridica, cit.) su
un tema allora non scontato.
(307) Inizialmente la dottrina aveva tentato di applicare
alla nuova Costituzione le categorie elaborate nei decenni
precedenti il fascismo. Il rigore della scienza giuridica
avrebbe dovuto ricondurre le novit entro binari consolidati.
In questa direzione la prima giurisprudenza delle Magistrature superiori e i primi manuali, di Ranelletti, Santi Romano, Foderaro, Biscaretti, Zanzucchi. Nella stessa Assemblea costituente Piero Calamandrei aveva manifestato la sua
forte contrariet a generiche norme programmatiche, che
uscivano dagli schemi classici della dommatica giuridica e si
traducevano cos le definiva in vaghe proclamazioni
politiche. Di esse vero lo stesso Calamandrei
sarebbe stato successivamente propagatore entusiasta in
conferenze, alcune celeberrime, presso scuole e circoli civici;
322
A queste posizioni vennero ad affiancarsi, rafforzandole ulteriormente, quelle volte a dare il
massimo di potenzialit espansiva alle norme costituzionali di principio (308) e quelle favorevoli
ad applicare i diritti costituzionali anche nei rapporti fra soggetti privati, secondo un analogo percorso ancor prima avviato in Germania da Nipperdey con la dottrina della Drittwirkung (309).
Paradossalmente le elaborazioni metodologiche
della dottrina giuridica fascista sui principi generali del diritto e sulla Carta del lavoro avrebbero facilitato linquadramento dei principi costituzionali nel nuovo ordinamento (310). Quelle
elaborazioni, infatti, valorizzavano le dichiarazioni
di principio, cui invece la vecchia dottrina guardava con diffidenza, preferendo il sicuro ancoraggio a precetti puntuali, in grado di delineare altrettanto puntuali fattispecie normative. Inoltre, la
distinzione fra disposizioni e norme, inizialma non vi contraddizione proprio perch riteneva di
divulgare, appunto, proclamazioni politiche in sedi e dibattiti politici. Parimenti Vittorio Emanuele Orlando, intervenendo nella discussione sullart. 29 cost., aveva protestato
per linserimento nella Costituzione di norme che avrebbero
dovuto trovare sede nel Codice civile , entro i sicuri binari
delle categorie civilistiche (anzi per Orlando per larga parte
erano gi nel codice vigente). Grazie allazione di Carlo
Esposito, Vezio Crisafulli, Costantino Mortati, Paolo Barile,
Alberto Predieri, Carlo Lavagna, Serio Galeotti, Vincenzo
Gueli ed altri ancora, alcuni gi affermati nellanteguerra ed
altri della nuova generazione, sarebbe stata vinta la tentazione di interpretare il testo costituzionale utilizzando le
vecchie categorie giuridiche, aprendo cos quella che possiamo definire una terza fase delle discipline costituzionalistiche, dopo quella esegetica e quella orlandiana.
(308) Si veda V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue
disposizioni di principio, Giuffr, Milano, 1952. In particolare fu punto alto di quella fase la largamente condivisa
opinione che la Costituzione, anche nella parte relativa ai
principi, deve essere interpretata magis ut valeat in quanto
atto normativo diretto a disciplinare obbligatoriamente comportamenti pubblici e privati. Si delineava cos sia un vincolo
per lindirizzo politico, sia un metodo di interpretazione.
(309) G. LOMBARDI, Potere privato e diritti fondamentali,
Giappichelli, Torino, 1970; per la letteratura tedesca C.
NIPPERDEY, Grundrechte und Privatrecht, Scherpe, Kreefeld,
1961 (su cui T. HOLLSTEIN, Die Verfassung als Algemeiner
Teil. Privatrechtsmethode und Privatrechtskonzeption, bei
Hans Carl Nipperdey (1895-1968), Mohr Siebeck,Tbingen,
2007).
(310) Il paradosso apparir pi evidente se si pensa a
qualcuno dei principi individuati in quegli anni, soprattutto
nei Convegni pisani del 1940 e del 1942 (Convegno nazionale universitario sui principi generali dellordinamento giuridico fascista, 18-19 maggio 1940; Convegno per lo studio
dei problemi economici dellordine nuovo, 18-23 maggio
1942), per esempio, Difendere e rinvigorire la stirpe il
fine precipuo dello Stato : cos lallora Preside della Facolt
di giurisprudenza di Pisa G.B. FUNAIOLI, Sui principi generali
dellordinamento giuridico dello Stato, in Studi sui principi
generali dellordinamento giuridico fascista (Autori vari), Arti
grafiche Pacini Mariotti, Pisa, 1943, 375.
Costituzione della Repubblica italiana
mente accolta con riserve, sarebbe stata negli anni
successivi alla base di importanti orientamenti giurisdizionali. Per Vezio Crisafulli non sempre la
possibilit di trarre dalla medesima disposizione
(dal medesimo testo normativo) una pluralit di
norme diverse da ascriversi come invece
ritenuto da Kelsen (311) alla patologia del
sistema ma, semmai, essenziale la univocit
della norma ad un momento dato e non anche il
permanere invariato del significato originario della
rispettiva disposizione (312). Tale distinzione
sarebbe stata largamente utilizzata dalla Corte costituzionale per ampliare gli strumenti messi a
disposizione sia dal testo costituzionale sia dalle
leggi di attuazione. In particolare ad essa si sarebbe fatto ricorso: a) per costruire quelle che
sarebbero state chiamate sentenze interpretative, sia di rigetto che di accoglimento (313); b)
per consentire, ove necessario, il trasferimento del
quesito referendario su una disposizione diversa
rispetto a quella su cui erano state raccolte le
firme (314); c) per orientarsi in tutti i casi in cui il
mutamento di disposizione non porta al mutamento della norma (per esempio per valutare la
legittimit della reiterazione di un decreto-legge
allorch, pur mutato il testo normativo, continua
tuttavia a potersene trarre la medesima norma) (315); d) per distinguere (ma un punto meno
consolidato) fra abrogazione espressa, che incide sulle disposizioni, e abrogazione implicita,
che lesito invece di unantinomia fra norme (316).
Le sentenze interpretative di rigetto, in parti(311) H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, trad. it.,
Einaudi, Torino, 1952, 92 ss.
(312) V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in questa
Enciclopedia, XIII, 1964, 208; v. anche ID., Fonti del diritto
(diritto costituzionale), ivi, XVII, 1968, ad vocem, in cui
lautore riprende le tesi sostenute in ID., Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1960, 775 ss. (e le prime lezioni litografate presso
lUniversit di Padova: ID., Lezioni di diritto costituzionale,
Padova, 1962). Come noto, nella trattazione del 1968
Crisafulli ripercorre i lineamenti generali del nuovo sistema
costituzionale delle fonti affiancando alla tradizionale gerarchia il pi dinamico criterio della competenza e mettendone in luce i complessi intrecci.
(313) In C. cost. 21 marzo 1996, n. 84, la Corte avrebbe
specificamente sottolineato che essa giudica su norme, ma
pronuncia su disposizioni .
(314) C. cost. 17 maggio 1978, n. 68, cit.
(315) In tal senso, oltre a C. cost. 21 marzo 1996, n. 84,
cit., anche C. cost. 7 novembre 1995, n. 482, nonch,
ovviamente, C. cost. 24 ottobre 1996, n. 360. Senza tale
distinzione, ha osservato CARLASSARE, Fonti del diritto (diritto
costituzionale), cit., 539, apparirebbero ormai incomprensibili molte decisioni della Corte costituzionale.
(316) Sul punto un approfondimento in A. BARBERA,
colare, avrebbero consentito alla Corte, negli anni
successivi, di spingere sempre di pi i giudici a
quibus, con un effetto ad onda sugli altri giudici, a
procedere essi stessi alla cosiddetta interpretazione conforme a Costituzione di disposizioni
suscettibili di pi letture (con successiva applicazione del medesimo canone interpretativo al diritto europeo e alla Convenzione europea dei diritti delluomo) (317). Si perveniva cos ad intaccare un duplice monopolio: a) si superava liniziale
impostazione legislativa che limitava lintervento
dei giudici ordinari al solo potere di sollevare
questioni di costituzionalit, lasciando alla Corte il
monopolio della interpretazione della Costituzione; b) si superava altres il monopolio del legislatore nellattuazione delle norme costituzionali.
Di questa possibilit la nuova generazione dei
magistrati, formatasi nel dopoguerra, avrebbe
fatto un punto di forza (318), mentre negli stessi
anni una nuova generazione di giuristi avrebbe
visto nelle fonti costituzionali lo strumento in base
al quale costruire un uso alternativo del diritto.
Il ricorso sempre pi diffuso alle sentenze additive e alle sentenze cosiddette additive di principio, non sempre a rime obbligate secondo
la nota espressione di Crisafulli (319) , ma
Leggi di piano e sistema delle fonti, Giuffr, Milano, 1968,
38-42.
(317) La richiesta di interpretazione conforme alla Costituzione pu essere datata a partire da C. cost. 22 ottobre
1996, n. 356 (nonch, a seguire, C. cost. 23 giugno 1999, n.
269; C. cost. 27 luglio 2001, n. 316; C. cost. 5 giugno 2003,
n. 198). Per la richiesta di interpretazione conforme al diritto
comunitario vi un accenno, per la prima volta, in C. cost.
26 ottobre 1981, n. 176, ma pi esplicitamente in C. cost. 13
giugno 2000, n. 190; successivamente per la interpretazione
conforme alla Convenzione europea dei diritti delluomo
interviene C. cost. 24 ottobre 2007, n. 348, ma ancora pi
chiaramente C. cost. 24 ottobre 2007, n. 349, cit., e C. cost.
24 luglio 2009, n. 239. Gli effetti sono considerati positivi, da
ultimo, da F. MODUGNO, In difesa dellinterpretazione conforme a Costituzione, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, 2014,
n. 2.
(318) del luglio 1964 la fondazione a Bologna della
corrente di Magistratura democratica ed del settembre
1965 il Convegno di Gardone Riviera. In questo Convegno
si ebbe, tra le altre, la Relazione di G. MARANINI, Funzione
giurisdizionale e indirizzo politico nella Costituzione (in Funzione giurisdizionale e indirizzo politico nella Costituzione.
Atti e commenti, XII Congresso nazionale dellAssociazione
nazionale magistrati, Brescia-Gardone, 25-28 settembre
1965, Tipografia Jasillo, Roma, 1966, 11 ss., e pubblicata
anche in Rass. parl., 1965, 529 ss.), nella quale si richiedeva
un maggiore spazio del giudice del caso concreto rispetto
alla stessa Corte costituzionale.
(319) CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha ventanni, in
La Corte costituzionale tra norma giuridica e realt sociale:
bilancio di ventanni di attivit (Atti del Convegno di Parma,
27-30 maggio 1976) a cura di N. OCCHIOCUPO, Il Mulino,
Bologna, 1978, 84.
323
Costituzione della Repubblica italiana
spesso a versi liberi e con effetti manipolativi,
avrebbe sempre pi lasciato ai margini il legislatore e rafforzato il raccordo fra giudici ordinari e
Corte nella interpretazione ed applicazione della
Costituzione (320), tanto da giustificare per alcune
decisioni la definizione di sentenze normative o
paralegislative (321) e da porre il tema (ne
abbiamo accennato supra, nel 6) della loro eventuale riconducibilit alle fonti del diritto. Partendo
dalla motivazione iniziale, la opportuna conservazione dei valori giuridici, e quindi della volont
del legislatore, il punto di arrivo rappresentato,
non poche volte, dalla sovrapposizione degli organi giurisdizionali alla volont del legislatore.
Dalla fine degli anni Settanta in poi (322) la
Corte ha utilizzato sempre pi anche lo scrutinio
di ragionevolezza, rimasto per anni oscurato
dalle pi tradizionali impostazioni, considerato
alla stregua di una costola del principio di eguaglianza. Tale canone si sviluppato ed affermato
molto al di l delloriginaria e fragile sua base
testuale, rappresentata dal principio di eguaglianza di cui allart. 3 cost. Dal divieto di discriminazioni irragionevoli (con una presunzione di
irragionevolezza, salvo prova contraria, per quelle
dettate da sesso, razza, religione, opinioni politiche) e dalla necessaria individuazione del tertium
comparationis si progressivamente passati alla
valutazione della ragionevolezza in s (e talvolta
della razionalit) di ogni misura legislativa, a
prescindere dalla possibile comparazione. Ma si
tratta di un criterio assai elastico, non definibile
con certezza ex ante. la Corte, custode della
ragionevolezza (323), a stabilire, di volta in volta,
con un inevitabile tasso di discrezionalit, se la
legge adottata dal Parlamento abbia o meno superato il test di coerenza, proporzionalit e ragione(320) Cos BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni
della Costituzione, cit., 420; nonch E. CHELI, Il giudice delle
leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri, Il
Mulino, Bologna, 1996, 35 ss.
(321) G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte
costituzionale, in Giur. cost., 1981, 1684 ss.; critico sulle
sentenze cosiddette para-legislative A. VIGNUDELLI, La
Corte delle leggi, Maggioli, Rimini, 1988. Sul punto utile il
volume di C. PANZERA, Interpretare, manipolare, combinare,
Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2013.
(322) Ma gi C. cost. 31 maggio 1965, n. 38 sottolineava
la necessit della valutazione di possibili eccessi di potere
discrezionale. Con C. cost. 28 gennaio 1981, n. 4 (che
dichiar la irragionevolezza della proroga del vincolo alberghiero) il passo della Corte diventa sempre pi spedito
abbandonando la necessit del confronto fra due norme
come base della valutazione di irragionevolezza di una disciplina.
(323) A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Giuffr, Milano, 2001, 8 ss.
324
volezza, cos ineluttabilmente allargando i propri
poteri e contraendo quelli del legislatore. Come
stato sostenuto, il termine ragionevolezza ormai meramente evocativo di varie tecniche argomentative e porta la Corte a sfiorare laccertamento metagiuridico della ingiustizia della
legge (324), varcando di fatto, quindi, i confini
del merito ad essa preclusi. Il punto di riferimento la reasonabless della giurisprudenza
nordamericana ma in termini non lontani da
quella valutazione delleccesso di potere legislativo che per anni fu auspicata da Costantino
Mortati, sia pure in riferimento a fini fissati da
norme costituzionali (325). I principi costituzionali, assunti in una valenza non assoluta, ma resi
fra loro compatibili attraverso la tecnica del bilanciamento, gi conosciuta e praticata dalle
Corti anglosassoni, e da quelle americane in particolare, entravano sempre pi a fare parte dellarmamentario della Corte costituzionale italiana.
Dalla seconda met degli anni Ottanta sar
sempre pi frequente il riferimento ai valori costituzionali. Gi nel 1991 lallora giudice della
Corte costituzionale Antonio Baldassarre metteva
in evidenza le nuove tendenze delle Corti europee
nella lettura delle Costituzioni che, a differenza
di quelle liberali, concentrate sui limiti al potere
pubblico [...] pongono al loro vertice i valori
costituzionali della persona umana e quelli eticosociali (326). Lanno successivo un volume di
Gustavo Zagrebelsky, sulla scia di Dworkin ed
Alexy, avrebbe posto laccento sui principi ,
espressivi, pi ancora delle regole , di valori
legati alla base materiale pluralista della
societ (327). Una lettura arrivata in ritardo in
Italia ma praticata fin dallimmediato dopoguerra
(324) Cos A. RUGGERI e A. SPADARO, Lineamenti di
giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2009, 115-116.
Diversa invece la posizione di G. ZAGREBELSKY e V. MARCEN,
Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, 195 ss.,
favorevoli allallargamento del giudizio (pi in generale
ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit.).
(325) C. MORTATI, Sulleccesso di potere legislativo
(1949), ora in ID., Raccolta di scritti, cit., III, 669 ss. Riferimenti in S. BOCCALATTE, La motivazione della legge. Profili
teorici e giurisprudenziali, Cedam, Padova, 2008; G. SCACCIA,
Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffr, Milano, 2000, che pi volte si richiama al
sindacato di eccesso di potere.
(326) A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Giappichelli, Torino, 1997, XVI, ma il primo
scritto risale al 1991: ID., Costituzione e teoria dei valori, in
Pol. dir., 1991, 640 ss. (ora in ID., Diritti della persona, cit.).
Di recente Baldassarre tornato sul tema: v. ID., Filosofie dei
valori ed ermeneutica dei valori (a proposito del pensare per
valori), in Lo Stato, 2012, n. 1.
(327) G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino,
1992, passim. Nello stesso anno, su posizioni analoghe, R.
Costituzione della Repubblica italiana
dal Bundesverfassungsgericht e gi serpeggiante
come ebbero a notare Carl Schmitt e Jrgen Habermas nella letteratura giuridica dellepoca di
Weimar (328). La prima sentenza del genere, in
Germania, fu appunto la Lth Urteil del 1958,
che defin la Costituzione un ordine di valori
obbiettivo , di cui i diritti sarebbero dei frammenti (329). Successivamente il riferimento ad
un sistema di valori apparir troppo vincolante
per la stessa Corte tedesca che preferir la ponderazione fra valori o interessi con un approccio pi
empirico (330).
Si confronteranno in quegli anni, con un andamento carsico, due posizioni che per brevit
possibile cos riassumere: quella testualista e
quella pi incentrata sui valori espressi dallordinamento costituzionale. Usiamo con esitazione
una dicotomia che richiama la contrapposizione
fra textualism e contextualism che, come
noto, negli USA richiama una divisione fra liberali
e conservatori mentre in Italia non pochi testualisti piegano i testi ad ardite operazioni innovatrici e non pochi fautori della lettura per valori
richiamano valori premoderni. Tornando allItalia
la prima posizione vuole essere ancorata al testo
delle disposizioni costituzionali ed ostile (o cauta)
sia alluso della clausola di cui allart. 2, sia alluso
delle tecniche di bilanciamento, quanto meno di
quelle che favoriscano uno scostamento dal testo
costituzionale. La seconda la cos detta interpretazione per valori rifugge dalla categoria
vero-falso e punta soprattutto sulla dicotomia ragionevole-non ragionevole oppure proporzionatonon proporzionato (o su categorie simili, per
esempio idoneit, necessariet, adeguatezza secondo la impostazione cosiddetta trifasica di
origine amministrativistica, la tedesca Dreistufigkeit).
La lettura dei diritti secondo valori o
interpretazione per valori (331) occuper
sempre pi lo spazio lasciato libero dalle correnti
BIN, Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella
giurisprudenza costituzionale, Giuffr, Milano, 1992.
(328) C. SCHMITT, La tirannia dei valori, trad. it., ora
Adelphi, Milano, 2008, 15; HABERMAS, ora Fatti e norme, ed.
2013, cit., 268 ss.
(329) BVerfG 15 gennaio 1958, BVerfGE 7, 198 (relatore Ritterspach).
(330) H. HOFMANN, La libert nello Stato moderno. Saggi
di dottrina della Costituzione a cura di A. CARRINO, trad. it.,
Guida, Napoli, 2009, passim.
(331) F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza
costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995, nonch ID., Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, in Interpretazione costituzionale a cura di G. AZZARITI, Giappichelli,
Torino, 2007.
giusnaturalistiche, tramontate con la metafisica (332), e, sebbene contestata da posizioni pi
strettamente legate alle formule normative (solo
per brevit definibili testualiste) (333), diverr,
grazie alla giurisprudenza della Corte, la pi seguita chiave di lettura della Costituzione del 1948.
Lespressione per valori diverr sempre pi
equivalente a quella per principi avendo progressivamente perso rilievo il non facile e tormentato tentativo di distinguere tra di essi, potendosi
tuttal pi individuare nei principi che possono considerarsi norme (spesso) senza disposizioni il veicolo attraverso cui i valori assumono una funzione normativa nellordinamento (334). In questo senso peraltro si mossa
implicitamente la stessa Corte allorch (lo abbiamo gi rilevato supra, 4) aveva enucleato
taluni principi fondamentali quali limiti alla revisione costituzionale. La Carta costituzionale ha
cos sempre pi assunto il volto di una tavola di
valori, e non solo quello, pi tradizionale, di
tavola delle regole. La Costituzione come un
deposito di valori , secondo la sintetica espressione di Valerio Onida (335); valori tuttavia non
riducibili a sistema, inteso come universo di di(332) N. IRTI, Luso giuridico della natura, Laterza, Roma-Bari, 2013 (edizione e-book).
(333) A. PACE, Metodi e costituzionalismo, in Quaderni
costituzionali, 2001, 35 ss. Su posizioni analoghe, ma ancora
pi critiche, A. VIGNUDELLI, Interpretazione e Costituzione.
Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico, Giappichelli, Torino, 2011, passim; in particolare sul rifiuto dellinterpretazione per valori cfr. ivi, 955-995, con argomenti
successivamente ripresi in ID., Valori fuori controllo? Per
unanalisi costi/benefici dun topos della letteratura costituzionalistica contemporanea, in Lo Stato, 2013, 71 ss.
(334) Distinzione pi nominalistica che di sostanza :
A. RUGGERI, Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della
giurisprudenza costituzionale, in Dir. soc., 2000, 569. In
questo senso sembra orientata anche G. RAZZANO, Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale,
Giuffr, Milano, 2002, 23 ss.
La distinzione invece netta, anche se pur sempre
tendenziale, fra principi e regole: il tema era stato
trattato da R. ALEXY, Teoria dellargomentazione giuridica. La
teoria del discorso razionale come teoria della motivazione
giuridica, Giuffr, Milano, 1998 (ma lopera originale del
1978); da R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, trad. it., Il
Mulino, Bologna, 1986, 90-91 (ma lopera originale del
1977) e ID., Freedoms Law. The moral reading of American
Constitution, Oxford University Press, Oxford, 1997, nonch da HABERMAS, op. ult. cit. Ma spunti anche in HBERLE,
Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz,
cit. La distinzione in Italia stata ripresa da Sergio BARTOLE,
specie in Princpi generali del diritto, cit., 494 ss., e da
Gustavo ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 147 ss.
(335) V. ONIDA, Le radici della giustizia costituzionale, in
Lezioni magistrali di diritto costituzionale a cura di A. VIGNUDELLI, Mucchi Editore, Modena, 2012.
325
Costituzione della Repubblica italiana
scorso deduttivo (336), ma complesso di norme e
principi la cui ricostruzione affidata (non alla
scienza giuridica ma) alla iuris-prudentia (337).
Il passaggio dal sillogismo alla bilancia (338), e pi ancora dal testo ai valori,
mette in risalto la funzione creativa dellinterprete, il suo equilibrio riflessivo (339). Da qui
il crescente rilievo dellattivit giurisdizionale rispetto allattivit legislativa (340), mentre la Costituzione perde progressivamente il carattere di
Carta affidata in primo luogo ai processi legislativi
attivati dagli organi espressivi della sovranit popolare. La importante decisione n. 10 del 2015
sebbene subito ignorata dalla decisione n. 70 dello
stesso anno (341) , consentendo alla Corte di
modulare gli effetti delle proprie decisioni in relazione agli interessi da tutelare, anche escluden(336) L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica.
Saggi, Giuffr, Milano, 1996.
(337) Cos invece ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 110 e 168,
contrario ad ogni forma di gerarchia di valori (presente
invece, come noto, nelle filosofie dei valori, in particolare in
N. HARTMANN, Etica. Assiologia dei costumi, trad. it., II,
Guida, Napoli, 1970, 29 ss., per il quale si tratta di un
presupposto logico implicito ). Sul punto v. anche DATENA, In tema di principi e valori costituzionali, in Giur. cost.,
1997, 3076.
(338) C. LUZZATI, Il giurista che cambia e non cambia, in
Dir. pubbl., 2013, 429.
(339) G. MANIACI, Razionalit ed equilibrio riflessivo
nellargomentazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2008.
(340) Peraltro auspicato dalle correnti cosiddette neocostituzionaliste, vale a dire di quella parte della scienza
giuridica doltreoceano (Dworkin, Alexy, J. Coleman, Carlos
Nino ed altri) che, messe in disparte le pi datate ricerche
giusnaturalistiche, ha trovato il modo di agganciare ai documenti costituzionali quelle visioni di giustizia e quei
principi morali che premono alle porte del diritto (G.
BONGIOVANNI, Costituzionalismo e teorie del diritto, Laterza,
Roma-Bari, 2005, 126 ss.).
Nella dottrina italiana a parte leco sempre pi
presente negli interventi di Gustavo Zagrebelsky e a parte
un agguerrito filone della filosofia del diritto (dal citato
Bongiovanni a Ferrajoli) tali tendenze tendono a mimetizzarsi nelle pieghe di una disputa su forme e modi
dellinterpretazione. V. in proposito il vivace dibattito fra
Riccardo Guastini e Antonio Baldassarre: R. GUASTINI, Sostiene Baldassarre, in Giur. cost., 2007, 1374 ss.; A. BALDASSARRE, Una risposta a Guastini, ivi, 3251 ss. In dissenso da
Guastini, pur nella diversit delle impostazioni rispetto a
Baldassarre, G.U. RESCIGNO (di cui v. Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico, in Dir. pubbl., 2005, 19 ss.,
e la risposta di R. GUASTINI, Ancora sullinterpretazione
costituzionale, ivi, 457). Mentre per Guastini le tecniche
interpretative che caratterizzano la lettura delle norme costituzionali non possono prescindere dalle regole generali
sulla interpretazione, per Ugo Rescigno, e ancor pi per
Baldassarre, la interpretazione costituzionale ha una sua
specificit.
(341) C. cost. 11 febbraio 2015, n. 10, cit., su cui v. i vari
interventi su Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, sub Rassegna , 2015, n. 4; C. cost. 30
aprile 2015, n. 70.
326
done la consueta retroattivit, potrebbe fare venire
meno la cautela non poche volte da essa impiegata
per evitare possibili conseguenze destabilizzanti
delle proprie decisioni, cos accentuando la pressione sullattivit legislativa del Parlamento (342)
fino a sfiorare i caratteri propri di un legislatore
in negativo, volto ad abrogare pi che ad annullare.
21. Dal catalogo costituzionale ai nuovi diritti. Il consolidamento dei principi costituzionali, messo in evidenza nelle pagine precedenti, ha
portato con s il consolidamento del (classico)
catalogo delle libert, fissato dal Costituente e
ulteriormente arricchito dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale e delle Corti europee. Non
mancano tuttora i problemi, ma derivanti, pi che
dalle normative ormai quasi tutte rese compatibili
(o non incompatibili) con il quadro costituzionale,
dalla configurazione delle istituzioni preposte alla
loro tutela: cos per la funzione della magistratura
inquirente o lorganizzazione delle forze di polizia
per quanto riguarda la libert personale; cos per
lamministrazione penitenziaria per quanto riguarda i diritti delle persone detenute; cos per la
tormentata legislazione e la non meno tormentata
giurisprudenza sulle emittenti radiotelevisive, che
ha inciso non poco sulla configurazione delle libert di informazione (negli anni Sessanta e Settanta per temperare con elementi di pluralismo
interno il monopolio statale; negli anni Ottanta
e Novanta per ristabilire un equilibrio fra emittenti pubbliche ed emittenti del duo-polista privato; infine, negli anni Duemila per consolidare il
pluralismo dei media e delle reti, aprendo nel
contempo un fronte nuovo per quanto riguarda sia
laccesso alle reti (343) sia la tutela delle persone
colpite) (344).
Da tempo la giurisprudenza costituzionale e, in
parte, la legislazione sulla immigrazione si sono
(342) Talvolta la cautela si manifesta attraverso moniti, sentenze di accertata ma non dichiarata incostituzionalit ed altre formule ancora; formule che, tra laltro, non
possono non spingere i giudici di merito a dichiarare la non
manifesta infondatezza delle questioni ad essi sottoposte.
Talvolta la cautela viene espressamente richiamata dalla
Corte: per esempio in C. cost. 8 giugno 1992, n. 256, a
proposito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
o in C. cost. 25 marzo 1992, n. 125, a proposito di provvedimenti nei confronti di minori.
(343) V. Accesso alla rete e uguaglianza digitale a cura di
E. DE MARCO, Giuffr, Milano, 2008.
(344) Sul catalogo delle libert classiche dobbligo il
rinvio alle varie edizioni di A. PACE, Problematica delle libert
costituzionali, pt. g. e pt. s., Cedam, Padova, 2002, nonch ai
vari contributi raccolti in I diritti costituzionali2 a cura di R.
NANIA e P. RIDOLA, 3 voll., Giappichelli, Torino, 2006.
Costituzione della Repubblica italiana
orientate per una sempre pi ampia estensione dei
diritti fondamentali anche ai non cittadini dando,
sulla base dellart. 2 cost., una lettura restrittiva di
quelle norme costituzionali che ne indicavano i
titolari nei cittadini (ma anche dello stesso art.
10 cost. in cui si avverte uneco dellantica condizione di reciprocit) (345). I problemi maggiori
riguardano i soggetti richiedenti asilo; cammino
tormentato (346) ma tracciato sul piano dei principi, anche con laiuto della sempre meno timida
giurisprudenza sia di Strasburgo che del Lussemburgo (347). Vi chi va oltre i temi della eguaglianza e si pone ulteriori traguardi che tengano
conto delle diversit da tutelare. La cautela
tuttavia opportuna perch tale ricerca, al di l
delle intenzioni, pu mettere in ombra i valori su
cui la Costituzione del 48 ancorata: fino al punto
di non escludere, per esempio, il riconoscimento
di legami poligamici, situazioni di soggezione al
marito-padre di moglie e figlie, dubbi sulla legittimit della repressione delle pratiche di mutilazione genitale, limiti alla stessa libert di espressione (348). Si potrebbe alimentare un generico
(345) Da ricordare in particolare C. cost. 18 luglio 1986,
n. 199, ma anche C. cost. 16 maggio 2008, n. 148, C. cost. 22
luglio 2010, n. 269 e C. cost. 25 luglio 2011, n. 245. La
letteratura sul punto ampia, talvolta spintasi a superare il
concetto stesso di cittadinanza su cui si fondato il
costituzionalismo dalla Rivoluzione francese in poi (ne abbiamo parlato in BARBERA, La rappresentanza politica: un mito
in declino?, cit., 865-869). Sul punto L. MELICA, Lo straniero
extracomunitario. Valori costituzionali e identit culturale,
Giappichelli, Torino, 1996, 123 ss.; nonch E. GROSSO,
La titolarit del diritto di voto, Giappichelli, Torino, 2001,
161 ss.
(346) V. per esempio le questioni sollevate da A. PUGIOTTO, La galera amministrativa degli stranieri e le sue
incostituzionali metamorfosi, in Quaderni costituzionali,
2014, 573 ss.
(347) Riferimenti in M. SAVINO, Le libert degli altri,
Giuffr, Milano, 2012, 284 ss., cui adde ID., Lespulsione dal
territorio dello Stato, in Giorn. dir. amm., 2014, 23 ss.;
nonch D. MERCADANTE, La Corte di Giustizia proibisce i
cosiddetti test di omosessualit e precisa alcuni diritti dei
richiedenti asilo perseguitati a causa dellorientamento sessuale, in Quaderni costituzionali, 2015, 211 ss.
(348) V. la documentazione di I. RUGGIU, Il giudice
antropologo, Franco Angeli, Milano, 2012, 217 ss.
La multi-culturalizzazione pu trasformare banali limitazioni di libert in temi eticamente sensibili. Imporre luso
del casco ai motociclisti Sikh ha posto problemi ai legislatori
europei (il Regno Unito li ha esentati dallobbligo); la libert
di indossare gli indumenti preferiti trova un limite sia nelle
scuole francesi sia in altri Paesi; portare il Kirpan, il pugnale
cerimoniale dei Sikh ortodossi, permesso in Canada ma
non in altri Paesi. Da ricordare che solo in base allintesa con
lUnione delle Comunit ebraiche consentito in Italia
indossare il copricapo in occasione di un giuramento in
unaula di giustizia. Sui possibili limiti alla libert di espressione dopo lattentato a Charlie Hebdo v. T. HOCHMANN,
Meinungsfreiheit nach Charlie Hebdo: das Phantom des dop-
politeismo di valori, lontano da una visione costituzionale del pluralismo, il quale (lo dicevamo
prima: v. supra, 3) indissolubilmente legato
allunit politica, e quindi allidentit, sia pure
aperta, di una comunit. Si pu alimentare cos,
per di pi, quellindifferentismo multiculturale
che gi in crisi in altre parti dEuropa (sia nella
versione inglese che in quella francese) (349).
Negli anni Settanta e Ottanta, il pieno affermarsi della soggettivit femminile; i mutamenti
intervenuti nellapplicazione delle conoscenze
scientifiche, nella genetica e nelle biotecnologie;
lutilizzazione e lavvento delle tecnologie digitali;
i processi di globalizzazione, sollecitavano, inoltre,
nuove domande di libert e spingevano per una
ri-lettura delle norme costituzionali. Si trattato di
processi in grado di innescare conflitti la cui soluzione ha finito per coinvolgere gli stessi principi
costituzionali; si vedano le tensioni suscitate dalla
proposta di riconoscimento delle unioni omosessuali, le drammatiche vicende legate alle decisioni
sul fine vita, il referendum sulla fecondazione
assistita o la giurisprudenza costituzionale sulla
fecondazione eterologa o quella ordinaria sulle
adozioni. La lettura secondo valori ha portato
ad espandere il quadro costituzionale ben oltre le
disposizioni del testo del 1948 (350), talvolta indebolendo le tradizionali ragioni della certezza del
pelten Maes, in Verfassungsblog, www.verfassungsblog.de,
25 gennaio 2015.
(349) Non da escludere, tra laltro, che lestensione
delle fattispecie di hate speech a talune forme di islamofobia possa mettere in discussione i confini liberaldemocratici
della libert di pensiero (ha fatto clamore la apertura di un
procedimento disciplinare per islamofobia da parte dellOrdine dei giornalisti nei confronti del giornalista Magdi Cristiano Allam: v. Corriere della Sera, 29 agosto 2014). E pi in
generale (il discorso vale anche per altre cosiddette fattispecie dodio), fino a che punto possibile che diritti di matrice
liberaldemocratica, su cui si fonda il costituzionalismo, possano essere esercitati allo stesso modo, con gli stessi significati, in societ profondamente cambiate, in cui vivono persone di culture e stili di vita profondamente diversi? Sul
tema v. A. MORRONE, Multiculturalismo e stato costituzionale,
in Istituzioni e dinamiche del diritto. Multiculturalismo, comunicazione, federalismo a cura di A. VIGNUDELLI, Giappichelli, Torino, 2005, 14 ss., nonch C. CARUSO, Dignit degli
altri e spazi di libert degli intolleranti. Una rilettura
dellart. 21 cost., in Quaderni costituzionali, 2013, 795 ss. Pi
in generale v. C. CASONATO, Minoranze etniche e rappresentanza politica: i modelli statunitense e canadese, Alcione,
Trento, 1998; C. TAYLOR, Multiculturalismo. Lotte per il
riconoscimento, Feltrinelli, Milano, 2008; S. MANCINI, Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicit e religione alla
prova del pluralismo, Cedam, Padova, 2008.
(350) Cos M. LUCIANI, Corte costituzionale e unit nel
nome dei valori, in La giustizia costituzionale ad una svolta a
cura di R. ROMBOLI, Giappichelli, Torino, 1991, ma anche F.
RIMOLI, Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dellintegrazione democratica, Giappichelli, Torino, 1999.
327
Costituzione della Repubblica italiana
diritto, ma ha anche consentito alla giurisprudenza
della Corte costituzionale di rispondere ad alcune
di tali domande.
Mentre i classici diritti di libert si fondano su
fattispecie puntuali manifestare un pensiero,
riunirsi, associarsi e cos via , i cosiddetti nuovi
diritti sollecitano spesso il ricorso alla tecnica dei
principi rispetto a quella delle regole analitiche: e non solo perch di prevalente enucleazione
giurisprudenziale. Di conseguenza essi tendono ad
essere individuati ricorrendo agli schemi aperti
previsti nello stesso testo costituzionale, grazie
alla loro funzione di adeguamento dellordinamento giuridico alle mutate condizioni storicosociali (351). La lettura per valori operata dalla
giurisprudenza aveva avuto modo, in primo luogo,
di manifestarsi attraverso la lettura dellart. 2 cost.
imperniata sul valore supremo della persona ivi
scolpito (352). Inizialmente contrarie gran parte
(351) Oppure ricorrendo a clausole generali, anchesse una particolare tecnica (di redazione della fattispecie) funzionale anche al riconoscimento di diritti nuovi:
precisazioni e dubbi in F. PEDRINI, Le clausole generali. Profili
teorici e aspetti costituzionali, Bononia University Press, Bologna, 2013, 182 ss.
(352) Ne abbiamo parlato in BARBERA, in Commentario
della Costituzione fondato da BRANCA, sub art. 2, cit. (successivi approfondimenti in ID., I nuovi diritti. Attenzione ai
confini, in Corte costituzionale e diritti fondamentali a cura di
L. CALIFANO, Giappichelli, Torino, 2004). In quel lavoro,
oltre a (tentare di) definire i caratteri generali dei diritti
inviolabili, giungevamo per essere brevi alle seguenti
conclusioni: 1) che le norme costituzionali riferite a specifiche libert sottendono e fissano valori della persona, da
contemperare con altri valori, in primo luogo quelli di cui
portatrice la stessa persona (p. 75 e 91-92); 2) che le libert
non si traducono solo in libert da ma altres in libert
di e richiedono lassunzione di variegati compiti di promozione da parte del potere pubblico per il pieno sviluppo
della persona umana; 3) che le libert costituzionali non
possono essere racchiuse per intero entro lo scudo dei diritti
soggettivi, ma che questi ultimi sono uno degli strumenti
(non lunico) attraverso il quale si realizzano i valori sottesi
nelle fattispecie costituzionali, e che essi si collocano accanto
ad altri strumenti istituzionali (organi di garanzia, appositi
istituti normativi e cos via); 4) che i diritti civili (non quelli
politici) sono in via di principio estesi anche ai non cittadini,
fatta salva la possibilit per la legge di modularne in modo
pi articolato la disciplina l dove espressamente riservati
dal testo costituzionale ai cittadini; 5) che lart. 2 cost.
contiene una fattispecie a schema aperto: aperta ai valori
emergenti nella societ, ivi compresi quelli veicolati attraverso le dichiarazioni internazionali dei diritti, con una
funzione sussidiaria rispetto al catalogo dei diritti specificamente enumerati dallart. 13 in poi, e non meramente
riepilogativa o riassuntiva degli stessi. La libert di informazione dicevamo, esemplificando non si esaurisce solo
in un agere o in un posse ma esprime un valore, da contemperare con altri valori (i diritti delle altre persone ad esempio), ed tutelata sia attraverso specifici diritti soggettivi sia
attraverso appositi istituti che accanto alla libert di
stampa realizzano la pi complessiva libert della stampa
328
della dottrina e la prima giurisprudenza costituzionale, ferme nel considerare detta disposizione
espressiva di una norma meramente riepilogativa
del catalogo di cui agli art. 13 ss. del testo costituzionale (353). Per esempio, in una pronuncia del
1979 la Corte aveva respinto una eccezione di
illegittimit nei confronti di quelle norme sullo
stato civile che allora non ammettevano le
variazioni anagrafiche della identit sessuale delle
persone, opponendo la non presenza fra i diritti
catalogati di un diritto alla identit sessuale (354).
Commentando quella decisione, Sergio Bartole
giustificava tale lettura restrittiva sulla base di un
principio di certezza che portava la Corte ad
ancorarsi agli specifici enunciati costituzionali (355). Lalternativa al ricorso allart. 2 cost. era
dunque quella o di negare dignit costituzionale a
nuovi diritti ovvero di rinchiuderli tutti, con
non poche forzature, in altre fattispecie di libert,
ricorrendo a espedienti non meno forieri di incertezze interpretative (356).
e un adeguato assetto del regime dei media. Usando unespressione che successivamente sarebbe stata propria di
Niklas Luhmann parlavamo dei diritti fondamentali come
istituzioni delle libert. Nello scritto di LUHMANN (I diritti
fondamentali come istituzioni, trad. it., Dedalo, Bari, 2002) il
riferimento ai diritti fondamentali come istituzioni sociali; nel nostro come specifiche istituzioni giuridiche.
Sul punto v. G. PALOMBELLA, Lautorit dei diritti. I diritti
fondamentali tra istituzioni e norme, Laterza, Roma-Bari,
2002, 131 ss.; C. CARUSO, La libert di espressione in azione.
Contributo ad una teoria costituzionale del discorso pubblico,
Bononia University Press, Bologna, 2014, 43 ss.
(353) La Corte esprime questa posizione fin da C. cost.
3 luglio 1956, n. 11 e la ribadisce in C. cost. 7 maggio 1975,
n. 102, contraria al riconoscimento di un diritto a mendicare.
(354) C. cost. 1o agosto 1979, n. 98.
(355) S. BARTOLE, Transessualismo e diritti inviolabili
delluomo, in Giur. cost., 1979, I, 1180 ss. (la frase citata a
p. 1190). Commentando la medesima decisione R. NANIA, La
libert individuale nellesperienza costituzionale italiana,
Giappichelli, Torino, 1989, 161-165, vede in essa una concezione semichiusa dellart. 2 cost. Sul punto anche F.
PIZZOLATO, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella
Costituzione italiana, Vita e Pensiero, Milano, 1999, 145 ss.
Subito favorevoli invece allutilizzazione dellart. 2 cost.: A.
PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, Roma, 1978, 97;
N. OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione nella Costituzione,
Giuffr, Milano, 1975, 76; F. BARTOLOMEI, La dignit umana
come concetto e valore costituzionale, Giappichelli, Torino,
1987, 14.
(356) quanto tentato da F. MODUGNO, I nuovi diritti
nella giurisprudenza costituzionale, cit., 11 ss., che dal diritto
di libert personale di cui allart. 13 cost., tradizionalmente
relativo alla liberta fisica o psico-fisica, fa discendere il diritto
allidentit personale, il diritto alla identit sessuale, il diritto
alla vita (anche dellembrione), il diritto allintimit, il diritto
alla privacy ed altro ancora, preferendo quindi allespressione nuovi diritti quella di diritti impliciti. Su posizioni
analoghe P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libert e Diritti
Costituzione della Repubblica italiana
La giurisprudenza muta decisamente orientamento dalla seconda parte degli anni Ottanta. La
svolta avviene con una pronuncia del 1987 (357) l
dove si riconosce, richiamando lart. 2 cost., il
diritto alla libert sessuale , e quindi il conseguente diritto al risarcimento di chi ha subito
danni anche non patrimoniali . Dalle perentorie
affermazioni circa la funzione riepilogativa di
tale disposizione, la Corte passa decisamente alla
individuazione, in base ad essa, di nuovi e specifici
diritti. Come ebbe a sottolineare lo stesso Presidente Saja nella Relazione annuale relativa al 1987,
con tale decisione la Corte ritenne maturi i tempi
per accettare lesistenza di un elenco aperto ,
utilizzando gli strumenti dellinterpretazione storico-evolutiva (358). Seguirono cos, sempre in
base allart. 2 cost., il riconoscimento del diritto
del minore allinserimento in una famiglia (359);
lenucleazione di un diritto allabitazione (360); il
diritto alla privacy (361); il diritto ad abbandonare
il proprio Paese (362); il diritto allidentit personale (363); il diritto a contrarre matrimonio (364),
fino a giungere al diritto alla libert sociale (365),
sociali, Giappichelli, Torino, 2006. Mario Dogliani vede
nellart. 2 una fonte di produzione di norme costituzionali
amministrata dalla giurisdizione ma non riusciamo a comprendere come possa conciliare questo ardito riconoscimento con il suo ostinato rifiuto di leggere una base materiale della Costituzione: v. M. DOGLIANI, I diritti fondamentali, in Il valore della Costituzione a cura di M. FIORAVANTI,
Laterza, Roma-Bari, 2009, 51.
(357) C. cost. 18 dicembre 1987, n. 561, anticipata da
C. cost. 6 maggio 1985, n. 132, C. cost. 24 maggio 1985, n.
161 e C. cost. 8 giugno 1987, n. 215.
(358) V. la Relazione del Presidente Francesco SAJA, La
giustizia costituzionale nel 1987, in Giur. cost., 1988, II, 179.
(359) C. cost. 18 febbraio 1988, n. 183.
(360) C. cost. 7 aprile 1988, n. 404; C. cost. 18 maggio
1989, n. 252 e C. cost. 26 maggio 1989, n. 310; C. cost. 19
novembre 1991, n. 419. Tali decisioni, per lo pi, si riferivano a norme che escludevano la successione nel contratto di
locazione di taluni conviventi del locatore: contrario A.
PACE, Il convivente more uxorio, il separato in casa e il c.d.
diritto fondamentale allabitazione, in Giur. cost., 1988, 175
ss., per il quale la Corte avrebbe potuto seguire altre strade.
Adesso sul punto BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni
della Costituzione, cit., 335 ss.
(361) C. cost. 26 marzo 1990, n. 139; v. anche Cass. civ.
9 giugno 1998, n. 5658.
(362) C. cost. 17 giugno 1992, n. 278, in simmetria con
lart. 13 della Dichiarazione universale dei diritti delluomo
del 1948 che ha proclamato il diritto di ogni uomo di
lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare
nel proprio Paese .
(363) C. cost. 3 febbraio 1994, n. 13. Sul punto Cass.
civ. 22 giugno 1985, n. 3769, su cui v. la nota di R. PARDOLESI,
in Foro it., I, 1985, 2211.
(364) C. cost. 24 luglio 2000, n. 332.
(365) C. cost. 12 marzo 1998, n. 50.
vale a dire un (non ben precisato) diritto a svolgere
liberamente una attivit a propria scelta (366).
In questo quadro lart. 2 cost. stato anche
utilizzato prima ancora dellintroduzione del
vincolo degli obblighi internazionali introdotto
dal nuovo Titolo V come veicolo attraverso il
quale le dichiarazioni internazionali potevano assumere maggiore rilevanza nellordinamento costituzionale (367): va ricordata, per tutte, la sentenza
del 1999 secondo la quale i diritti umani, garantiti
da Convenzioni internazionali, trovano espressione nella Costituzione , in quanto sempre pi
avvertiti dalla coscienza contemporanea come
coessenziali alla dignit della persona (368). Correlativamente i diritti della persona possono giustificare linadempimento di obblighi internazionali: una storica decisione del 1996 (369) sancisce
che il diritto alla vita (non espressamente catalogato nel testo costituzionale ma che si pu trarre
dallart. 27 comma 4, letto alla luce dellart. 2
cost.) si pone quale essenziale parametro di valutazione della legittimit costituzionale della norma
generale sulla concessione dellestradizione (art.
698 comma 2 c.p.p.), anche se in applicazione di
leggi che danno esecuzione a trattati internazionali
di estradizione e di assistenza giudiziaria: di qui il
divieto di estradizione verso Paesi che non hanno
bandito la pena di morte.
Caute aperture, nel complesso, nella giurisprudenza della Corte; meno caute, invece, sono state
parte della dottrina e parte della giurisprudenza ordinaria (ed anche amministrativa). Come
avrebbe opportunamente precisato Antonio Ruggeri, contrario a chiusure testualiste, i nuovi
(366) In numerose altre decisioni la Corte aggiunge il
riferimento anche allart. 2: ma spesso si tratta di espedienti
retorici per rafforzare un richiamo a libert catalogate. Fra i
casi numerosissimi: C. cost. 28 novembre 2002, n. 494, che
ha richiamato lart. 2 nel fissare il diritto dei figli incestuosi
al riconoscimento della paternit o, in simbiosi con il principio di eguaglianza, C. cost. 10 maggio 1999, n. 167,
relativamente al passaggio coattivo da disporre per favorire
la mobilit dei disabili. V. sul punto anche A. CORASANITI,
Note in tema di diritti fondamentali, in Dir. soc., 1990, 189 ss.
(367) Sul punto D. TEGA, I diritti in crisi, Giuffr,
Milano, 2012, 51 ss. e 63 ss.; nonch G. SORRENTI, Le carte
internazionali sui diritti umani: unipotesi di copertura costituzionale a pi facce, in Pol. dir., 1997, 349 ss.
(368) C. cost. 22 ottobre 1999, n. 388, in Giur. cost.,
1999, 2991 ss., con nota di L. MONTANARI, Dalla Corte una
conferma sul rango primario della Convenzione europea dei
diritti delluomo: ma forse uninedita apertura, 3001 ss. Abbiamo approfondito il punto in A. BARBERA, Le tre Corti e la
tutela multilivello dei diritti, in La tutela multilivello dei
diritti a cura di P. BILANCIA e E. DE MARCO, Giuffr, Milano,
2004, 89 ss.
(369) C. cost. 27 giugno 1996, n. 223, il cosiddetto caso
Venezia.
329
Costituzione della Repubblica italiana
diritti non sempre significano nuovi principi (370). Facendo ricorso allo schema dei valori costituzionali si sviluppato il tentativo di
tradurre quei valori in puntuali (ma spesso improbabili) diritti (371). Sono cos fiorite nuove situazioni soggettive quali, tra le altre, il diritto alla
pace, il diritto alla sicurezza (372), il diritto alla
democrazia (373), il diritto allefficienza (374), il
diritto alla qualit della vita, il diritto alluguaglianza sostanziale (375), il diritto alla diversit (376), un misterioso diritto di partecipazione
ad un utile sociale (377), i diritti delle generazioni
future (378), il diritto allo sviluppo (379). Parimenti partendo dal ripudio della guerra fissato
nellart. 11 cost. si costruito un diritto alla
(370) A. RUGGERI, Nuovi diritti fondamentali e tecniche
di positivizzazione, in Pol. dir., 1993, 199.
(371) Ne abbiamo parlato in BARBERA, I nuovi diritti.
Attenzione ai confini, cit.
(372) Escluso da C. cost., ordinanza, 8 giugno 2001, n.
187: v. T. GIUPPONI, La sicurezza urbana tra legislatore e Corte
costituzionale, in Sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Il
limite del potere di ordinanza dei sindaci stabilito dalla Corte
costituzionale a cura di S. BENVENUTI, P. DI FONZO, N. GALLO
e T. GIUPPONI, Franco Angeli, Milano, 2013, 77 ss. Un diritto
alla sicurezza invece individuato da P. TORRETTA, Diritto
alla sicurezza e (altri) diritti e libert della persona: un
complesso bilanciamento costituzionale, in Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite a cura di A.
DALOIA, Giuffr, Milano, 2003, 451 ss. Per un inquadramento generale, T. GIUPPONI, Le dimensioni costituzionali
della sicurezza, Bonomo Editore, Bologna, 2010, 143 ss.
(373) L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali, in Teoria politica, 1998, n. 2, 7.
(374) S. SANTORO, Il vizio di efficienza dellazione amministrativa, in Cons. St., 1973, II, 1372 ss.; A. ANDREANI, Il
principio costituzionale di buon andamento della pubblica
amministrazione, Cedam, Padova, 1979, 235 ss.
(375) V., per esempio, A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti alluguaglianza sostanziale, Jovene, Napoli,
1999.
(376) Cfr. G.M. FLICK, Minoranza ed eguaglianza: il
diritto alla diversit e al territorio come espressione dellidentit nel tempo della globalizzazione, in Pol. dir., 2004, 3 ss.
(377) Riferimenti in D. BIFULCO, Linviolabilit dei diritti sociali, Jovene, Napoli, 2003, 14 nt. 30.
(378) Cfr. F. RIMOLI, Bioetica. Diritti del nascituro. Diritti delle generazioni future, in I diritti costituzionali a cura di
NANIA e RIDOLA, cit., 527 ss.
(379) Ad essi si potrebbero aggiungere i diritti tutelati
negli Statuti regionali: i diritti degli utenti; il diritto al
pluralismo dellinformazione; il diritto alladozione; i
diritti dei bambini; i diritti degli anziani; ed altri ancora.
Ma pesa sugli stessi lorientamento (sia pure non convincente) della Corte che ha preteso di declassarli a mere
proclamazioni politiche: C. cost. 2 dicembre 2004, n. 372 e
C. cost. 6 dicembre 2004, n. 378. Decisione ampiamente
criticata in dottrina: v., per tutti, D. NOCILLA, Natura delle
disposizioni programmatiche statutarie e controlli endoregionali su leggi e regolamenti delle Regioni, in Giur. cost., 2004,
4134; A. ANZON, Linefficacia giuridica delle norme programmatiche (21 gennaio 2005), in Costituzionalismo.it,
www.costituzionalismo.it, 2004, n. 2.
330
pace, di cui sarebbero titolari singoli e collettivit (380): ma quali gli strumenti attivabili davanti
al giudice se lo chiede anche Peces Barba (381)
nel caso in cui si ritenesse violato tale diritto da
una azione dei pubblici poteri?
Di fronte a queste posizioni non si pu sfuggire
ad un dubbio: fino a che punto possibile tutelare
diritti senza prevedere forme e modi per renderli
azionabili davanti ad un giudice, senza potere
adottare misure cautelari a salvaguardia degli
stessi (382)? Probabilmente bisogna prendere atto
che la categoria dei diritti soggettivi vive ancora
una volta una crisi epocale (383), accentuata dalla
lettura per valori della Costituzione. Tale lettura, infatti, tende a superare questo scarto fra iura
e actio consentendo ai giudici di fondare il proprio
scrutinio anche su quei valori costituzionali che
non abbiano conseguito il rango di diritti soggettivi azionabili. Impresa pi facile per il giudice
delle leggi, meno per quelli del rapporto sottostante.
Pi convincente la legislazione che v. il d. lg.
14 marzo 2013, n. 33 concludendo un tormentato iter iniziato qualche decennio precedente ha
collegato il valore della trasparenza ad un diritto soggettivo a conoscere spettante ai cittadini
in quanto tali senza la necessit di dimostrare
linteresse particolare che giustifichi questa pretesa
(non tuttavia da sottovalutare che tale diritto
sembra un Reflexrecht essendo ancora delimitato dagli obblighi di pubblicazione e di trasparenza previsti in capo alle amministrazioni e non
ha ancora il carattere che negli USA ha il Freedom
of information Act del 1966) (384).
(380) In tal senso U. ALLEGRETTI, Costituzione e politica
estera: appunti preliminari, in Nuove dimensioni dei diritti di
libert. Scritti in onore di Paolo Barile, Cedam, Padova, 1990,
17-20, ma gi S. GRASSI, Le garanzie giuridiche in tema di
pace, in Dem. dir., 1986, 79 ss., e altra letteratura citata da
ALLEGRETTI, op. ult. cit. Pi articolata la posizione di L.
CHIEFFI, Il valore costituzionale della pace, Liguori, Napoli,
1990.
(381) G. PECES-BARBA MARTNEZ, Teoria dei diritti fondamentali, trad. it., Giuffr, Milano, 1993, 172 s.
(382) DWORKIN, I diritti presi sul serio, cit.; G. MENEGUS,
Misura cautelare ad tempus e tutela durgenza di diritti di
rilievo costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2014, 915 ss.
(383) Una difesa della stessa in M. LA TORRE, Disavventure del diritto soggettivo, Giuffr, Milano, 1996; per un
inquadramento storico v. P. RIDOLA, Libert e diritti nello
sviluppo storico del costituzionalismo, in I diritti costituzionali
a cura di NANIA e RIDOLA, cit., 3 ss. Sulle libert costituzionali
come valori O. CHESSA, Libert fondamentali e teoria costituzionale, Giuffr, Milano, 2002, 380 ss.
(384) Il d. lg. n. 33 del 2013 un decreto legislativo in
attuazione della delega contenuta nella l. 6 novembre 2012,
n. 190 ( Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalit nella pubblica amministra-
Costituzione della Repubblica italiana
Vogliono, anchessi, rimanere legati ai tradizionali schemi dei diritti soggettivi quanti, prendendo
spunto dallart. 13 cost., letto insieme ad altre disposizioni costituzionali, fra cui il diritto a rifiutare
le cure previsto dallart. 32 cost., individuano un
generale diritto allauto-determinazione (385),
che avrebbe come oggetto la sovranit su di s e
sul proprio corpo; diritto progressivamente declinato in varie direzioni: dalla auto-determinazione
informativa alla auto-determinazione biologica;
dalla pi pacifica auto-determinazione terapeutica al pi drammatico diritto a togliersi la vita.
Un diritto alla libera disposizione del proprio
corpo che si tradurrebbe stato detto (386)
in un moderno Habeas Corpus. Ma un simile
diritto trova spazio nella Costituzione repubblicana? In realt sono poco convincenti i richiami
testuali. Non lo il richiamo allart. 13 cost., che
zione ), volta a contenere forme di maladministration.
Per la prima volta tale valore trov un implicito riconoscimento da parte della l. 7 agosto 1990, n. 241 (diritto di
accesso, indicazione di un responsabile del procedimento,
obbligo di motivazione, partecipazione al procedimento),
successivamente rafforzato dal d. lg. 27 ottobre 2009, n. 150,
che ha arricchito il diritto di accesso, ma solo con il d. lg. n.
33, cit. si tradotto in un diritto soggettivo, per cos dire,
universale. Da diritto del singolo tenuto a dimostrare un
interesse diretto, concreto e attuale a conoscere si tradotto in un accesso civico consentito a tutti i cittadini
volto a favorire un controllo sociale diffuso sulle pubbliche
amministrazioni (v. F. PATRONI GRIFFI, La trasparenza della
pubblica amministrazione fra accessibilit totale e riservatezza,
in Federalismi.it, www.federalismi.it, 17 aprile 2013).
(385) Gi nel corso degli anni Ottanta un concetto
analogo era stato utilizzato dalla dottrina ma questo il
punto nel tentativo di superare la concezione proprietaria
e mercatista, legata al tradizionale concetto di autonomia
privata, riflessa nellart. 5 c.c., relativo agli atti di disposizione del proprio corpo: v. R. ROMBOLI, in Commentario del
codice civile Scialoja-Branca, cit., Libro I. Delle persone e della
famiglia (Art. 1-10), 1988, sub art. 5, 225 ss.
(386) S. RODOT, La vita e le regole, Feltrinelli, Milano,
2009, 73 ss., e ID., Habeas Corpus, in Ambito e fonti del
biodiritto a cura di S. RODOT e M. TALLACCHINI, in Trattato
di biodiritto a cura di S. RODOT e P. ZATTI, Giuffr, Milano,
2010, 269 ss., dove peraltro, accanto a un riferimento allart.
32 cost., si enfatizza una espressione usata dalla Corte
costituzionale in C. cost. 23 dicembre 2008, n. 438. Su
posizioni analoghe P. VERONESI, Uno statuto costituzionale
del corpo, in Il governo del corpo a cura di S. CANESTRARI e
altri, I, in Trattato di biodiritto, cit., 2011, 137 ss.; P. ZATTI,
Principi e forme del governo del corpo, in Il governo del corpo,
cit., 122 ss. ed altra dottrina ivi richiamata, nonch alcuni
scritti contenuti in Atti di disposizione del proprio corpo a
cura di R. ROMBOLI, Pisa University Press, Pisa, 2007. Nella
dottrina penalista individua un diritto allautodeterminazione S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e
consenso dellavente diritto, Bononia University Press, Bologna, 2008. Molto critico nei confronti di queste posizioni S.
MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, sub Paper , 2009.
riguarda in modo specifico le restrizioni fisiche poste in essere dalle autorit inquirenti e non coincide, come pure talvolta prospettato, con una generica libert morale (387) , vale a dire lantico
Habeas Corpus. Non lo il riferimento allart. 32
cost., che riguarda un oggetto specifico: richiedendo il consenso della persona per le terapie, e
quindi riconoscendo il diritto a rifiutare le cure,
implicitamente riconosce un diritto del paziente a
che la malattia faccia il suo corso, anche scontando
un esito letale della stessa (388). Comporta un
lasciarsi morire e un lasciare morire ma non legittima un comportamento attivo per fare morire
chi lo richieda (in pratica il ricorso a forme di
eutanasia attiva) (389). In breve non comporta
un diritto a morire che, tra laltro, renderebbe
incostituzionale lart. 580 c.p. laddove prevede
come reato l aiuto al suicidio , mentre verrebbe
ovviamente salvato solo il pi grave reato di istigazione al suicidio previsto dal medesimo codice:
cos infatti in scritti di non pochi penalisti o costituzionalisti (390).
(387) Cfr. F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, cit., 20 ss., che trae dallart. 13 la tutela
di un generale diritto alla libert morale, in linea con pi
antiche posizioni di G. VASSALLI, La libert personale nel
sistema delle libert costituzionali, in Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, V, Padova, 1958, 368 ss.; contrari ad un generico diritto alla libert morale PACE,
Problematica delle libert costituzionali, pt. s., cit., 172 ss., e
A. BARBERA, I principi costituzionali della libert personale,
Giuffr, Milano, 1967, 81 ss. Pi problematica la posizione
di R. NANIA, La libert individuale nellesperienza costituzionale italiana, Giappichelli, Torino, 1989, 223 ss.
(388) S. CANESTRARI, Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario da parte di paziente competente, in Il governo del corpo, cit., II, 1901 ss.
(389) Tale distinzione si basa su una non facile differenza tra omissione (rifiuto delle cure) e comportamento
attivo (attivit volta alleutanasia). Da ultimo un caso sottoposto ai giudici tedeschi: BGH 25 giugno 2010 (BGH 2
StR 454/09). Letteratura sul punto in C. TRIPODINA, Il diritto
nellet della tecnica. Il caso delleutanasia, Jovene, Napoli,
2004, 11 ss.
Laffermazione che non esista un diritto a disporre della
propria vita, come riflesso di un diritto a disporre del
proprio corpo, alla base della decisione della Corte di
Strasburgo nel caso Pretty v. Regno Unito (C. eur. dir. uomo
29 aprile 2002), che ha negato il right to die invocato nel
ricorso della Signora sulla base dellart. 2 CEDU (che prevede
il diritto alla vita ma non nel suo versante negativo del diritto
a togliersi la vita).
(390) G. GEMMA, Diritto a rinunciare alla vita e suoi
limiti, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, III, cit., 1005
ss.; L. STORTONI, Riflessioni in tema di eutanasia, in Eutanasia
e diritto. Confronto tra discipline a cura di S. CANESTRARI, G.
CIMBALO e G. PAPPALARDO, Giappichelli, Torino, 2003, 92 ss.;
S. SEMINARA, La dimensione del corpo nel diritto penale, in Il
governo del corpo, I, cit., 212 ss.; F. GIUNTA, Diritto di morire
e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, II, 74 ss. un
antico dibattito da Cesare Beccaria e da David Hume in poi:
331
Costituzione della Repubblica italiana
Non sono convincenti i richiami testuali e,
comunque, non sarebbero da trascurare le implicazioni di carattere sistematico. Se dovesse essere
riconosciuto un diritto costituzionale a disporre
del proprio corpo sarebbero giustificate le letture
pi radicali: che esso ricomprende non solo il
diritto a darsi la morte, ma anche il diritto (costituzionalmente tutelato) a mutilarsi (391), a drogarsi (392), a prostituirsi (393), a disporre in vario
si va dal suicidio come esercizio di una libert di fatto
allesercizio di un vero e proprio diritto costituzionale (riferimenti in F. FAENZA, Profili penali del suicidio, in Il governo
del corpo, II, cit., 1809 ss.).
(391) Esiste un diritto ad automutilarsi? Esiste un diritto a sterilizzarsi? La l. n. 194 del 1978 ha portato ad una
abrogazione del reato di sterilizzazione volontaria, gi previsto dallart. 552 c.p., ma siamo di fronte ad una scelta
discrezionale del legislatore o al riconoscimento di un diritto
costituzionale? Non mancano in letteratura risposte in senso
positivo: purch non si traduca in un atto negoziale esisterebbe viene sostenuto un diritto ad auto-mutilarsi (v.
VERONESI, op. cit., 150 ss.; ma v. anche G. GEMMA, Sterilizzazione e diritti di libert, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 247
ss.; ROMBOLI, in Commentario al Codice civile Scialoja-Branca,
sub art. 5, cit., 270 ss.).
Come sappiamo, i movimenti liberali e i movimenti
femministi dellOccidente sono allavanguardia nel combattere il fenomeno tribale delle mutilazioni genitali femminili.
Ma se si parte da una concezione che valorizza la piena e
libera disponibilit del proprio corpo, e se si aggiunge la
considerazione che queste pratiche non toccano libert altrui, come possibile negare a donne adulte il diritto
anche se ripugnante a ricorrere alla pratica della mutilazione genitale? (sul punto v. M.C. VENUTI, Integrit della
persona e multietnicit, in Diritti fondamentali e multietnicit
a cura di A. GALASSO, Flaccovio, Palermo, 2003, 202 ss.). A
questa pretesa libert si riferiscono taluni critici della l. 9
gennaio 2006, n. 7, che prevede le stesse come reato; normativa contestata, del resto, anche da chi ritiene che il diritto
penale deve rispettare le specificit etniche (G. FORNASARI,
Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo, in Legalit
penale e crisi del diritto, oggi a cura di A. BERNARDI, B.
PASTORE e A. PUGIOTTO, Giuffr, Milano, 2008, 195 ss.).
(392) Dopo il referendum dellaprile 1993, che ha portato alla abrogazione della legge Iervolino-Vassalli (l. 26
giugno 1990, n. 162), drogarsi non pi un reato. Per alcuni
tale svolta antiproibizionista stata la ricerca di un modo
migliore per combattere la diffusione delle droghe, per altri
invece il riconoscimento di un diritto di libert. La differenza fra le due posizioni, emersa anche nel dibattito che
accompagn la consultazione referendaria, non di poco
conto. Se si dovesse trattare di diritti di libert costituzionale
non solo questi comportamenti non potrebbero essere puniti
(e pu esserlo saggio non farlo), ma soprattutto non potrebbero essere ostacolati. Si possono anche non condividere le
sanzioni amministrative nei confronti di chi assume sostanze
stupefacenti, per esempio quelle previste dallart. 75 t.u.
stupefacenti, introdotto con il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,
convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49
(la cosiddetta legge Fini-Giovanardi: censurata dalla Corte
v. infra, 23 solo per motivi formali), ma non si pu
accettare noi crediamo la tesi di chi ritiene che le
sanzioni amministrative ivi previste siano incostituzionali
perch incidono su diritti di libert dei cittadini. Drogarsi
esercitare una libert (cos M. AINIS, Le libert negate, Riz-
332
modo del proprio corpo. Se le (innumerevoli)
facolt che potrebbero discendere da tale diritto
avessero un fondamento costituzionale non sarebbe possibile incidere sulle stesse, ove necessario, senza incidere su quel diritto generale di libert. Alla legge verrebbe opposto un diritto costituzionale di libert e dovrebbero essere considerate incostituzionali norme che oggi sanzionano
taluni comportamenti (per esempio le prima ricordate mutilazioni genitali di donne adulte; luso di
sostanze stupefacenti, tollerato, in alcuni casi sanzionato amministrativamente ed altro ancora). E in
pi: un punto di forza del costituzionalismo del
Novecento a differenza del costituzionalismo
liberale attento solo a porre limiti allintervento
dei poteri pubblici imperniato sullidea che
lordinamento non deve limitarsi alla mera garanzia dei diritti costituzionali ma deve adoperarsi per
il loro sviluppo. La Repubblica allora non solo
dovrebbe non interferire ma addirittura avrebbe il
compito di aiutare lesercizio di tali libert, ivi
compresi, appunto, o togliersi la vita, o drogarsi o
prostituirsi, o sterilizzarsi, o mutilarsi? Taluni
comportamenti, soprattutto se confinati nella sfera
del privato, possono (anzi spesso assai opportuno che lo siano) essere lasciati dalla legge alla
libera disponibilit dei soggetti interessati ma non
possono rappresentare lesercizio di uno specifico
diritto soggettivo di libert costituzionalmente tutelato (394). Da qui la necessit in breve di
zoli, Milano, 2004, 143 ss.) oppure privarsi di una libert ed
anzi offendere la propria dignit?
(393) La prostituzione va solo tollerata o, invece, va
considerata esercizio di un diritto di libert, della libert
sessuale in particolare ? La risposta di una parte della
letteratura (G. MARINO, Appunti per uno studio dei profili
costituzionali della prostituzione, in Atti di disposizione del
proprio corpo a cura di ROMBOLI, cit., 227 ss.) in questo
secondo senso, fino a mettere in dubbio la legittimit costituzionale delle norme che puniscono il favoreggiamento
della prostituzione (salvando ovviamente solo le fattispecie
volte allo sfruttamento della stessa) o fino a considerare
di dubbia costituzionalit ogni provvedimento che tocchi,
per chi si dedica a tale antico mestiere, il diritto di dislocare liberamente il proprio corpo in ogni parte della citt
(M. PIAZZA, Ordinanza anti-prostituzione per il buon costume o scostumatamente anti-Costituzione?, in Giur. cost.,
2008, 4038). Ma proprio necessario si potrebbe obbiettare rifarsi ad un diritto costituzionalmente tutelato alla
disponibilit del proprio corpo per riconoscere come
giusto anche a chi si prostituisce taluni diritti civili
comuni ad ogni persona? (M.R. MARELLA, Sesso, mercato e
autonomia privata, in Il governo del corpo, I, cit., 889 ss.).
(394) Il tema del dominio sul proprio corpo da tempo
dibattuto da taluni movimenti femministi che tendono a
leggere la soluzione trovata nella l. n. 194 del 1978, come il
riconoscimento di un nuovo diritto, un diritto di libert
della madre (cos M. MORI, Aborto e morale. Capire un nuovo
diritto, Einaudi, Torino, 2008, ma criticamente C. MANCINA,
Costituzione della Repubblica italiana
distinguere la mera liceit di un comportamento,
affidato al principio di legalit (un comportamento
lecito fino a quando non diversamente disposto
dalla legge), dalla sua assunzione nel novero dei
diritti di libert costituzionalmente tutelati. In
breve: non tutte le aspirazioni dellindividuo devono necessariamente tradursi in situazioni giuridiche e, in ogni caso, non tutte le situazioni giuridiche devono necessariamente avere una copertura costituzionale. Nel momento in cui le Costituzioni non solo quella italiana ambiscono a
costituire anche una tavola di valori che informa
lintero ordinamento (dignit delle persone, valore
della pace, libero sviluppo della persona, solidariet, e cos via) non possibile alle stesse restare
neutrali o agnostiche rispetto alle varie concezioni
del bene presenti nella societ (395). Non possono
consentire che le libert siano costruite sulla base
di modelli giuridici auto-referenti: n tradursi
nella tautologica libert di volere liberamente,
n essere circoscritte alla mera dimensione procedurale (previsione di riserve di legge o fissazione di
garanzie giurisdizionali), prescindendo dai contenuti. La Costituzione italiana non ha certamente a
La laicit ai tempi della bioetica. Tra pubblico e privato, Il
Mulino, Bologna, 2009, passim), un diritto di disporre di ci
che ancora parte del proprio corpo. Diverse invece la
lettura della giurisprudenza della Corte (gi in C. cost. 18
febbraio 1975, n. 27) e lintenzione del legislatore, che hanno
riconosciuto alla madre che si sottopone allinterruzione
della gravidanza non lesercizio di un diritto di libert ma un
agere licere, frutto di un bilanciamento fra il diritto alla salute
della stessa e il diritto alla vita del nascituro.
(395) A.E. GALEOTTI, La tolleranza. Una proposta pluralista, Liguori, Napoli, 1994, passim. Da mettere in rilievo che
una delle poche Costituzioni che tutela un diritto generale di
azione la Costituzione tedesca con la freie Entfaltung
seiner Persnlichkeit lo circondi di intensi limiti, ivi
compresi quelli derivanti dal Sittengesetz, dalla legge morale (PEDRINI, Il libero sviluppo della personalit, cit., 161).
Nelle posizioni classiche del liberalismo (da Stuart Mill
in poi) le libert sono viste essenzialmente come non intromissione della legge nellautonomia individuale. Qualora
non vengano intaccate le libert di altri soggetti le libert
del vicino la politica e il diritto dovrebbero arretrare
rispetto alle scelte dellindividuo, cui spetterebbe ogni valutazione sul contenuto etico della propria azione, sul proprio
progetto di vita (G.F. ZANETTI, Amicizia, felicit, diritto. Due
argomenti sul perfezionismo giuridico, Carocci, Roma, 1998,
passim). Ma vi anche chi, nellambito del medesimo pensiero liberale, ritiene che compito dello Stato non sia solo
quello di assicurare il libero dispiegarsi delle inclinazioni
individuali (v. invece F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione e
libert, trad. it., Il Saggiatore, Milano, 1986, 542 ss.) ma
soprattutto quello di assicurare che siano garantite pari
opportunit secondo principi di giustizia (J. RAWLS, Una
teoria della giustizia (1971), trad. it., Feltrinelli, Milano,
2009, 347 ss.). Del tutto opposte le posizioni communitarians, che esaltando il ruolo delle comunit di appartenenza
finiscono per svalutare lautonomia e la responsabilit individuali.
modello uno Stato etico, ricolmo di proibizionismi, ma non impone neanche al legislatore un
modello libertario, rassegnato a permissivismi (396). Se la lettura per valori della Costituzione comporta la massima estensione dei diritti
un punto da sottolineare la stessa considerazione dei valori ne pu segnare il confine. La
dignit della persona insieme fondamento e
limite delle libert costituzionali: confine (397). Come sottintende la nostra Costituzione nellart. 2, e come espressamente affermato
in altri testi costituzionali (e in molte dichiarazioni
internazionali), i diritti di libert sono riconosciuti
in funzione della tutela e dello sviluppo dei valori
della persona, in primo luogo della dignit della
stessa (398). Le libert non sono solo libera(396) Secondo L. FERRAJOLI, I fondamenti dei diritti
fondamentali, in Diritti fondamentali. Un dibattito teorico a
cura di E. VITALE, Laterza, Roma-Bari, 2008, 288 ss., e V.
ZENO ZENCOVICH, Approcci diversi a contratto e sessualit, in
Il governo del corpo, I, cit., 880 ss., bisogna stare attenti a non
superare i confini dello Stato etico. Sul punto ci limitiamo a
riprendere una domanda di DWORKIN, I diritti presi sul serio,
cit., 319 ss.: quanti, in nome dellautonomia individuale,
sono pronti a sostenere che proprio di uno Stato etico
imporre luso del casco o della cintura di sicurezza? Lesempio per Dworkin era formulato per assurdo ma in Italia la
realt ha superato la fantasia e di queste limitazioni si
dovuta occupare in due occasioni la Corte costituzionale.
Pi di recente (C. cost., ordinanza, 18 febbraio 2009, n. 49)
allorch un giudice ebbe a ritenere che lobbligo delle
cinture di sicurezza previsto dallart. 172 d. lg. 30 aprile
1992, n. 285 (codice della strada) contrasterebbe con lart.
13 cost., non costituendo misura di prevenzione atta a
evitare danni a terzi, ma paternalistica previsione dellordinamento nei confronti del singolo, considerato in posizione
di inferiorit etica e psicologica, retaggio di ordinamenti
assolutistici e illiberali e quindi con lart. 2 cost., giacch
i diritti inviolabili delluomo e lo sviluppo della sua personalit risultano gravemente compressi (sic!). Qualche anno
fa (C. cost. 16 maggio 1994, n. 180) era stato ritenuto da un
giudice remittente che le norme del codice della strada che
prevedono lobbligo del casco per i motociclisti sarebbero
lesive dellart. 32 cost., perch [...] mentre giustificabile
la sottoposizione a obblighi coercitivi per ragioni sanitarie
quando vi sia pericolo per il diritto alla salute di terzi,
sembra illegittima la coercizione dettata da un mero interesse della collettivit alla tutela della salute del singolo .
Anche in dottrina, del resto, vi era stato chi dubitava della
legittimit di tali misure espressione di cultura paternalista
estranea alla Costituzione: v. G. ANZANI, Il mancato uso delle
cinture di sicurezza nella circolazione stradale: un comportamento di disposizione della persona, in Atti di disposizione
del proprio corpo a cura di ROMBOLI, cit., 407.
(397) A. RUGGERI e A. SPADARO, Dignit delluomo e
giurisprudenza costituzionale, in Pol. dir., 1991, 347 e 368; M.
DI CIOMMO, Dignit umana e Stato costituzionale, Passigli
Editore, Firenze, 2010, passim; A. SPADARO, Il problema del
fondamento dei diritti fondamentali, in I diritti fondamentali
oggi (Atti del V Convegno dellAssociazione italiana dei
costituzionalisti, Taormina, 30 novembre-1o dicembre
1990), Cedam, Padova, 1995.
(398) La dignit come valore costituzionale non con-
333
Costituzione della Repubblica italiana
zione da impedimenti un liberarsi dal potere
pubblico o privato ma libera comunicazione
e conquista di s (ed ci che distingue la persona dallindividuo). La rimozione degli impedimenti pu essere un mezzo, non un fine.
I valori qui richiamati sono dunque assunti
secondo uno schema aperto. Ne deriva che le
ricostruzioni interpretative che abbiano come riferimento tali valori sono indotte a rispondere alle
esigenze del caso sottoposto a giudizio, cos tracciando un circolo ermeneutico che muove dal
caso, risale alla norma e ridiscende sul caso
stesso (399). Non si scende, come di solito, in
modo deduttivo, dalla norma al caso da decidere.
Mentre in altri settori si punta al raffronto fra la
fattispecie normativa e il caso sottoposto, nellambito qui considerato il caso concreto che pu
influire sulla ragionevole lettura della disposizione.
Inevitabilmente, tale operazione sar fortemente
influenzata dal contesto culturale in cui si trovano
ad operare gli interpreti; sar influenzata cio dai
valori espressi dalle forze politiche, sociali e culturali egemoni (cui, labbiamo gi detto, non sono
estranei, peraltro, gli stessi giudici), che costituiscono la base materiale dellordinamento costituzionale, lenergia ordinante che lo sottende (v.
supra, 4).
22. Lemarginazione della mediazione parlamentare. Grazie agli sviluppi del controllo di
costituzionalit, sia negli aspetti accentrati sia in
quelli diffusi incoraggiati dalla stessa Corte, si
progressivamente aperto un varco per il passaggio
da uno Stato di diritto ad uno Stato (di diritto)
costituzionale (400). Questultimo non rinnega
vince M. LUCIANI, Positivit, metapositivit e parapositivit
dei diritti fondamentali, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, III, cit., 1060 ss.; cfr. invece M.T. ANNECCA, Test
genetici e diritti della persona, in Il governo del corpo, II, cit.,
419 ss.; O. SCHACHTER, Human dignity as a normative concept,
in Am. journ. intern. Law, 1983, 849 ss. Pi articolata la
posizione di P. VERONESI, La dignit umana fra teoria dellinterpretazione e topica costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2014, 315 ss.
(399) A questultimo proposito R. ALEXY, Interpretazione giuridica, in Enciclopedia delle scienze sociali, cit., V,
1996, 65 s.: le norme sono universali e astratte, i fatti ai
quali si devono applicare sono individuali e concreti. Le
norme contengono pochi tratti distintivi; quelli dei fatti sono
potenzialmente infiniti. Da un lato i fatti vengono descritti
con lausilio dei tratti distintivi contenuti nelle fattispecie
delle norme, dallaltro i tratti distintivi dei fatti possono
essere loccasione per applicare non la norma presa in
considerazione inizialmente, ma unaltra norma volta a precisare o a rigettare un tratto distintivo della fattispecie o ad
aggiungervene un altro .
(400) Cfr. E. CHELI, Lo Stato costituzionale. Radici e
prospettive, Napoli, Editoriale scientifica, 2006, 7 ss.; nonch
334
certo le precedenti esperienze ma realizza un salto
di qualit che porta al mutamento di alcuni caratteri fondamentali dello Stato di diritto. Non solo
uno Stato che ha una Costituzione, ma uno Stato
che nella Costituzione trova la propria identit (401). Ci quanto avvenuto anche in altri
Paesi, soprattutto nella Germania federale dove si
parlato di passaggio dal Rechtsstaat al Verfassungsstaat. Si tratta di unevoluzione realizzatasi
nel giro di un quarantennio, ma solo ora se ne
intravvedono pi nettamente i profili. Sia la Costituzione italiana sia quella tedesca avevano superato il modello improntato ai canoni del costituzionalismo liberale: ma lintensa attivit delle Corti
costituzionali ha progressivamente portato ad una
loro ulteriore trasformazione fino a sottoporre le
stesse leggi costituzionali a limiti valutabili in sede
giurisdizionale.
Ma tali conclusioni pongono domande che
ancora attendono una risposta e che riguardano gli
stessi equilibri fissati dalla Costituzione (402).
Siamo su un terreno in cui le scelte finiscono con
il fondarsi necessariamente su operazioni di bilanciamento di interessi e valori. A chi spetta
questo bilanciamento? Non trattandosi di diretta
osservanza di norme o principi costituzionali ma
di enucleazione di situazioni giuridiche sulla base
di letture di valori ricavabili dalla Costituzione il
primo soggetto legittimato a farlo proprio il
legislatore (403), in quanto espressione della sovranit popolare (404). Il controllo della Corte ,
R. BIN, Stato di diritto, in questa Enciclopedia, Annali, IV,
2011, 1153 ss.
(401) HOFMANN, La libert nello Stato moderno, cit., 33,
che registra unopinione diffusa, ma non unanime, nella
letteratura tedesca: ivi ampi riferimenti bibliografici (contrari Kirchof ed altri, ivi citati, per i quali la Costituzione
presuppone pur sempre uno Stato con cui non si identifica).
(402) Siamo oltre la democrazia? si chiede Giuseppina BARCELLONA, Metamorfosi della sovranit e strategia dei
diritti, Kore University Press, Troina, 2010, 210.
(403) Spunti in C. cost. 26 settembre 1998, n. 347.
(404) In questo senso PACE, Metodi interpretativi e costituzionalismo, cit., 35 ss.; cos da ultimo L. VIOLANTE,
Magistrati, Einaudi, Torino, 2009, 181 ss. Ma v. la contrastante opinione di V. ONIDA, Politica e giustizia. Problemi
veri e risposte sbagliate, in Il Mulino, 2010, 20 ss. Pi in
generale ALEXY, Teoria dellargomentazione giuridica, cit.
Sui problemi evidenziati nel testo sono ancora importanti le pagine problematiche di Carlo MEZZANOTTE, Corte
costituzionale e legittimazione politica (1984), ora Editoriale
scientifica, Napoli, 2014, 113 ss.; v. anche RIMOLI, Pluralismo
e valori costituzionali, cit., 156; sullo stesso tema vari scritti
raccolti in Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi a cura di A. RUGGERI e G. SILVESTRI,
Giuffr, Milano, 2000; nonch in La discrezionalit del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale a cura
di M. SCUDIERO e S. STAIANO, Jovene, Napoli, 1999.
Costituzione della Repubblica italiana
ovviamente, ineliminabile ma solo al fine di valutare ragionevolezza e proporzionalit dellintervento legislativo (o del mancato intervento). Al
bilanciamento ben si prestano le tecniche della
mediazione politica, attivando un dibattito pubblico (ben pi vasto e significativo di un dibattito
limitato alle parti in giudizio) e recependo gli
stimoli partecipativi del corpo sociale. Solo lintervento legislativo, tra laltro, pu evitare che il
giudice costituzionale, come sottolinea Habermas,
chiamato a garantire lequilibrio fra i poteri, non
finisca con alterarlo a proprio favore (405). Lintervento parlamentare pu ovviamente essere condizionato da scelte politico-ideologiche ma lalternativa data dalle diverse visioni ideologiche degli
interpreti (Corte costituzionale, Corti europee,
giudici ordinari) ciascuno pronto, magari utilizzando strumenti propri di una dogmatica politicizzata e ricorrendo a precedenti sempre pi arditi, alla scoperta di ulteriori e sempre nuovi
significati [...] correndo il rischio di disintegrare la
carta costituzionale (406). Il pericolo talvolta
viene colto: stato obiettato che la attuazione
della Costituzione a differenza della applicazione della stessa sarebbe compito assai pi
della legislazione che della giurisdizione (407).
Come gi sottolineato nelle pagine precedenti,
dagli anni Novanta in poi anche i giudici ordinari
sono stati ulteriormente incoraggiati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che chiede
loro un previo giudizio di interpretazione conforme della norma in diretta applicazione dei
parametri costituzionali, europei o convenzionali.
Ma linterpretazione conforme porta a percorrere
due strade diverse: la prima quella di adeguare la
lettura di una disposizione di legge ordinaria alla
lettura di una norma costituzionale (oppure europea o convenzionale) evitando un contrasto fra le
stesse; la seconda quella di rendere la norma
ordinaria adeguata a perseguire, attuandoli con
riferimento al caso concreto, i valori racchiusi
nella norma costituzionale (od europea o convenzionale). Non differenza da poco, perch sia la
Costituzione sia le norme europee o convenzionali
spesso non sono analitiche, ma o di principio
ovvero volte a indicare obbiettivi al legislatore
(405) HABERMAS, Fatti e norme, ed. 2013, cit., 190.
(406) ANGIOLINI, Costituente e costituito nellItalia repubblicana, cit., 56 e 285 ss.
(407) M. LUCIANI, Dottrina del moto delle costituzioni e
vicende della Costituzione repubblicana, in Dalla Costituzione
inattuata alla Costituzione inattuale? a cura di BRUNELLI e
CAZZETTA, cit., 31 ss.
statale (408). Per questo, nel secondo caso, il
rischio che il giudice si sostituisca di fatto a questultimo si presenta particolarmente elevato.
Pi recenti i tentativi dei giudici amministrativi
di intervenire direttamente a tutela di diritti costituzionali in parallelo a quanto da tempo andava
facendo il giudice ordinario prescindendo dal
rinvio degli atti alla Corte costituzionale, ma soprattutto andando al di l della loro tradizionale
competenza alla valutazione degli atti amministrativi alla luce del rispetto del principio di legalit;
spintisi, talvolta, fino al punto di sindacare luso di
determinati strumenti organizzativi (importanti
quando trattasi di diritti sociali, vale a dire di
pretese a determinate prestazioni). Una tutela, in
breve, con riferimento diretto alla Costituzione,
saltando la intermediazione legislativa, e non limitandosi ad usare il parametro costituzionale per
ricostruire il parametro legislativo (409). Qualora
questa tendenza dovesse estendersi saremmo al di
l della ragione stessa della giurisdizione amministrativa, chiamata ad assicurare il rispetto della
legge da parte delle amministrazioni; ma tendenza favorita dallo stesso legislatore con la l. 21
luglio 2000, n. 205, che ha ulteriormente esteso la
giurisdizione dei tribunali amministrativi sui diritti
ed ampliato la possibilit di ricorso degli stessi a
mezzi atipici di tutela cautelare, e che ha trovato
conferma ed incoraggiamento nella giurisprudenza della Corte costituzionale (410). Tale giurisprudenza amministrativa pone in luce, comunque, lo squilibrio fra lattenzione alle situazioni
soggettive, elevate spesso al rango di diritti costi(408) Per un maggiore approfondimento rinviamo a A.
BARBERA, I (non ancora chiari) vincoli internazionali e comunitari nel primo comma dellart. 117 della Costituzione, in
Diritto comunitario e diritto interno (Atti del Seminario,
Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007), Giuffr,
Milano, 2008, 107-121 (ripreso in Quaderni costituzionali,
2007, 335 ss.).
(409) La tendenza accuratamente ricostruita da A.
PIOGGIA, Giudice amministrativo e applicazione diretta della
Costituzione: qualcosa sta cambiando?, in Dir. pubbl., 2012,
49 ss., che saluta con favore tale tendenza atteso che linterposizione della legge fra amministrazione e Costituzione fa
da schermo alla tutela dei diritti costituzionali, soprattutto
dei diritti sociali: emblematica la decisione del TAR Liguria,
sez. II, 18 marzo 2010, n. 1183 (ivi citata) che a tutela del
diritto di un disabile ha condannato lamministrazione ad
aumentare il numero degli insegnanti di sostegno al di l di
quanto previsto dalla legge di settore. Sul rilievo degli aspetti
organizzativi nella tutela dei diritti sociali, anche al fine di
evitare la cosiddetta mercificazione degli stessi attraverso il
mero risarcimento del danno non patrimoniale, v. B. PEZZINI,
La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Giuffr, Milano, 2001.
(410) C. cost. 27 aprile 2007, n. 140 e C. cost. 26
febbraio 2010, n. 80.
335
Costituzione della Repubblica italiana
tuzionali, e la scarsa attenzione alle istituzioni
che tali diritti dovrebbero assicurare.
C da chiedersi a cosa sia dovuta la diffusa
sfiducia dei costituzionalisti nel legislatore e la loro
estesa fiducia, invece, nel giudice. Sarebbe riduttivo rinvenire solo nella crisi della rappresentanza
parlamentare la ragione di tale diffidenza. Appaiono rilevanti altri due fattori. In primo luogo va
registrata la maggiore affinit del ceto dei giuristi
con i metodi e la cultura dei giudici (come gli
antichi legisti del resto), chiamati ad applicare il
diritto secondo la lettura pi corretta dellart.
101 cost. (411) , e non solo chiamati ad applicare la legge, utilizzando le pi generiche e rassicuranti tecniche della interpretazione giuridica.
Da sempre, non a torto, e non solo in Italia, i
giuristi si ritengono pi in grado di inserirsi, influenzandoli, nei linguaggi propri dei percorsi giurisprudenziali, a differenza di quanto non riesca
loro possibile con i percorsi politici, da essi poco
controllabili e meno permeabili, o anche solo naturalmente meno congeniali. Il secondo fattore
rappresentato dal prevalere di una concezione totalizzante della Costituzione (412), caratterizzata
dalla pretesa di rinvenire in essa la risposta ad ogni
problema. Tale concezione, alla cui base vi lidea
che i valori costituzionali coprono lintero ordinamento e che la Costituzione non abbia spazi vuoti,
presente e questo pu essere meno paradossale di quanto non sembri sia nelle posizioni di
chi cerca nella Costituzione il riconoscimento di
sempre pi estesi diritti individuali sia nelle posizioni di chi, allopposto, cerca nella Costituzione il
divieto di riconoscerli e garantirli. Se nel documento costituzionale devono necessariamente trovarsi tutte le risposte alle domande della societ
non pu che trattarsi di un compito che, di conseguenza, secondo tale concezione, spetta ai giudici, ordinari e costituzionali (413). Questa tesi si
pu giustificare sulla base di una lettura per
(411) In analogia allart. 20 punto 3 GG: sul punto v. D.
BIFULCO, Il Giudice soggetto soltanto al Diritto. Contributo
allo studio dellart. 101, comma 2, della Costituzione italiana,
Jovene, Napoli, 2008, 99 ss.; nonch G. VERDE, Il difficile
rapporto fra giudice e legge, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli, 2012, 177 ss.
(412) Lespressione totalizzante tratta da ANGIOLINI,
op. cit., 115 ss.; su posizioni analoghe A. SPADARO in vari
scritti, ma cos fin dal volume Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, Edizioni scientifiche
italiane, Napoli, 1990, 13 ss.
(413) Nella dottrina tedesca un analogo dibattito fra la
concezione dellordinamento settoriale (Rhamenordnung) di
W.E. Bckenfrde e lordinamento dei valori (Wertordnung)
di R. Alexy: v. F. PEDRINI, Colloquio su Princpi, Diritto e
Giustizia. Intervista al Prof. Robert Alexy, in Lo Stato, 2014,
n. 2, 125 ss.
336
valori delle disposizioni costituzionali non
testualista o letteralista ma non sempre
essa in linea con i principi democratici. Avendo
rinvenuto il fondamento di taluni nuovi diritti
nel valore della persona di cui allart. 2 cost., era
scontato accrescere cos gli spazi della giurisdizione; ma aprire gli spazi della giurisdizione non
significa questo il punto giungere ad
umiliare quelli propri della legislazione: per esempio, il riconoscimento del diritto alla privacy il
frutto comune e della funzione giurisdizionale
anche della Cassazione a partire dal caso Soraya (414) e della funzione legislativa; frutto
e della sentenza n. 139 del 1990 (415) come della
l. 31 dicembre 1996, n. 675 (nonch della normativa europea) (416).
Sul richiamo a valori quali libert e dignit
della persona si costruita una ricca giurisprudenza delle Corti nazionali e internazionali, fra cui
la Corte europea dei diritti delluomo, ma tali
valori (lo dicevamo nel paragrafo precedente)
sono suscettibili di essere letti in modo diverso,
e talvolta financo contrapposto; siamo ai limiti, ha
sottolineato Rawls, fra concetti e concezioni (417). un rischio consueto, non insopportabile nellesperienza giuridica: ma si tratta di una
lettura proprio per le caratteristiche intuizionistiche che la stessa richiede (418) che in
primo luogo dovrebbe essere affidata ad organi
rappresentativi. I valori costituzionali unificano
sempre pi le forze politiche, sociali e culturali e
molte questioni sono state risolte, ma rimangono
ancora zone dombra: cosa si intende per dignit
della persona? Vietare il burqa una scelta che
tutela la dignit della donna o, viceversa, la offende? rispettare i diritti dellembrione o rispettare solo la dignit dello stesso? come disporre
del proprio corpo? come della propria vita? cosa si
intende per famiglia naturale? Non c dubbio
che si tratta di argomenti su cui il legislatore
spesso si arrovellato invano: non a caso la incapacit ad affrontare questi ed altri temi cruciali
rafforza la tentazione di giudici remittenti e costituzionalisti simpatizzanti di spingere la Corte costituzionale verso sentenze manipolative, additive
o sostitutive (419), comunque creative. Daltra
(414) Cass. civ., sez. III, 27 maggio 1975, n. 2129.
(415) C. cost. 26 marzo 1990, n. 139, cit.
(416) Su questo intreccio v. M. TIMIANI, Contributo allo
studio del diritto alla riservatezza, in St. parl. pol. cost., 2012,
51 ss.
(417) RAWLS, Una teoria della giustizia, cit., 307-313.
(418) RAWLS, op. cit., 52-59 (e la ampia letteratura cit. a
p. 53).
(419) Cui di recente per la Corte si sottratta con C.
Costituzione della Repubblica italiana
parte, come escludere che le esitazioni o anche la
paralisi del legislatore non riflettano meglio e pi
puntualmente di un giudice i valori come effettivamente li sente il corpo sociale? Oppure si
ritiene che sta al giudice illuminato imporre al
corpo sociale riluttante la propria lettura di determinati valori?
Abbiamo richiamato temi in relazione ai quali
dottrina e giurisprudenza pretendono sempre pi
spesso di imporre questa o quella specifica soluzione, direttamente richiamandosi a principi e valori costituzionali. Siamo invece, noi crediamo, in
campi proprio perch socialmente e storicamente determinati in cui il legislatore, sulla
base appunto del principio di maggioranza, meglio
pu stabilire la liceit di determinati comportamenti o individuare lopportunit di riconoscere
determinati diritti. Siamo in campi in cui, lo si
detto per la Corte suprema degli Stati Uniti, interpretare equivale a legiferare (420). compito
primario degli organi rappresentativi, sulla base di
valutazioni politiche e/o etiche, consentire, o
meno, di indossare in pubblico il burqa; se punire
le mutilazioni genitali femminili; se punire laiuto
al suicidio; se reprimere atti di disposizione del
proprio corpo; se consentire la sterilizzazione; se
consentire la circoncisione dei minori; se reprimere luso di sostanze stupefacenti; se rendere
obbligatori taluni trattamenti immunitari; se consentire od ostacolare lesercizio della prostituzione
nelle strade, magari attraverso ordinanze sindacali (421).
E sarebbe stato opportuno lasciare al legislatore anche la decisione se vietare o non vietare la
procreazione eterologa: ma sul punto intervenuta nel 2014 una decisione della Corte (422). Ci
pare che le questioni apertesi successivamente
sullopportunit o sullobbligo di considerare immediatamente applicabile la sentenza oppure di
attendere, come avrebbe invece voluto nel caso
specifico il Governo, una normativa approvata dal
Parlamento evidenzino la problematicit di
questo tema e della soluzione di fatto impostasi.
Detta pronuncia riconoscendo lincoercibile determinazione di avere figli sembrerebbe avere
affermato che debbano essere riconosciuti come
diritti tutti i bisogni profondi dellindividuo pena
cost. 15 aprile 2010, n. 138, cit., relativa al matrimonio fra
coppie dello stesso sesso.
(420) R.H. BORK, Il giudice sovrano, trad. it. (di Coercing
Virtue), Liberilibri, Macerata, 2004, 177.
(421) Ma v. i limiti fissati da C. cost. 7 aprile 2011, n.
115.
(422) C. cost. 10 giugno 2014, n. 162.
la lesione della loro salute psichica; che a questo
fine debba essere trasformato in diritto tutto ci
che la tecnica consente; che si debba riconoscere
anche in Italia ci che altri Paesi hanno sancito
pena il rischio di turismo dei diritti (423).
Il pendolo in questi anni oscillato pi volte in
direzioni opposte, da un estremo allaltro: apparsa una forzatura ritenere che certi comportamenti debbano essere necessariamente vietati in
forza di principi costituzionali, ma apparsa una
forzatura non minore ritenere che essi siano addirittura esercizio di veri e propri diritti di libert
costituzionalmente tutelati, al punto di determinare la illegittimit costituzionale di leggi in contrasto con essi. Sotto questo profilo, pare corretta,
per esempio, la posizione della Corte (424) che ha
lasciato libero il legislatore di trovare le forme di
riconoscimento delle convivenze omosessuali, rifiutando sia la posizione di chi le riteneva gi
ricomprese nellart. 29 cost., sia di chi le riteneva
in base alla medesima norma comunque vietate.
Altrettanto corretta la sentenza che, pur riconoscendo sia il diritto della madre allanonimato sia il
diritto del figlio a conoscere le proprie origini, ha
demandato al legislatore il contemperamento dei
due diritti (425). Inevitabile, e quindi corretta
anchessa, la pronuncia sul cosiddetto divorzio
imposto (426), che si limitata ad una decisione
additiva di principio lasciando al legislatore
lonere di trovare una soluzione che contemperi i
caratteri dellistituto matrimoniale e la tutela delle
formazioni sociali, dellintreccio vissuto della
coppia ricorrente (un componente della quale
aveva cambiato sesso).
I giudici, a Roma come a Strasburgo o a Lussemburgo, hanno spesso (ma non sempre) adottato soluzioni razionalmente condivisibili (427).
(423) Cos C. TRIPODINA, Il diritto al figlio tramite
fecondazione eterologa: la Corte decide di decidere, in Giur.
cost., 2014, 2593 ss., che tuttavia si dichiara pienamente
favorevole allintroduzione di tale metodo di fecondazione
ma avrebbe voluto evitare che la sovranit del Parlamento
fosse ridotta a cos povera cosa (ivi, 2601); ma v. anche
A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura, in Forum di Quaderni
costituzionali, www.forumcostituzionale.it, sub Rassegna ,
2014, n. 6.
(424) C. cost. 15 aprile 2010, n. 138, cit.
(425) C. cost. 24 aprile 2013, n. 78.
(426) C. cost. 11 giugno 2014, n. 170.
(427) Non mancano tentativi delle Corti europee di
supplire a queste difficolt (ladozione da parte di coppie
omosessuali, lesposizione del Crocefisso ed altro ancora) ma
non manca chi, pur aperto allEuropa, teme che tale attivismo giurisdizionale possa alimentare una sorta di colonialismo giudiziario (cfr. M. CARTABIA, I diritti in azione.
Universalit e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti
europee, Il Mulino, Bologna, 2007, 13 ss.); teme, cio, che
337
Costituzione della Repubblica italiana
Ma negli anni Settanta del XX secolo molte decisioni erano venute anche dal Parlamento: cos fu
per il divorzio o per la legge sullinterruzione della
gravidanza o per la riforma del diritto di famiglia
o per il riconoscimento dellobiezione di coscienza
o per la disciplina del mutamento dei caratteri
sessuali (428). Solo decisioni parlamentari, e il
dibattito pubblico che le precede e le accompagna, sono in grado, a ben vedere, di attivare quei
circuiti partecipativi (in alcuni casi anche sollecitati da iniziative referendarie) che sono essenziali
per una comunit che voglia chiamarsi democratica. Nellobbiettivo di costruire le premesse di
uno Stato giurisdizionale , proprio di un certo
costituzionalismo irenico , stata individuata
unevidente coloritura aristocratica che esprime
lantico pregiudizio antiparlamentare (429); ma
il rischio quello lo sottolinea Maurizio Fioravanti di uno Stato politicamente esangue ,
sempre meno alimentato dalla rappresentanza democraticamente eletta (430).
Interrogativi analoghi percorrono altri Paesi
nei quali parimenti si dubita sullo spazio dato a (o
conquistato da) minoranze di chierici (di tecnocrati del diritto) i giudici delle Corti rispetto alle maggioranze democratiche (431): non a
consolidati diritti sanciti negli ordinamenti nazionali possano essere messi a repentaglio da culture estranee. Sabino
Cassese ha descritto con efficacia la trama che accomuna le
svariate relazioni fra ordinamenti globali, sovranazionali e
nazionali (v. CASSESE, I tribunali di Babele, cit.). Le Corti
internazionali, secondo Cassese, hanno in mano una leva
decisiva per assicurare, in maniera flessibile e incrementale,
la costruzione di un ordine globalizzato, nella prospettiva di
un costituzionalismo senza confini ma sottolinea lo stesso
Cassese il rapporto simmetrico fra margine di apprezzamento , lasciato al diritto degli Stati dalle Corti internazionali, e il limite dei principi fondamentali, richiesto dalle
Corti nazionali per lingresso delle decisioni sovranazionali,
sta a dimostrare che non si pu prescindere dal nucleo duro
della sovranit degli Stati, vale a dire dalla politica e dalle
decisioni che competono ai Parlamenti nazionali.
(428) Cui si potrebbe aggiungere il diritto delloperatore sanitario di essere esentato da pratiche abortive: cos
lart. 9 l. n. 194 del 1978.
(429) M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, 1661.
(430) Cos FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale,
cit., 305.
(431) Jeremy Waldron mette in evidenza che si tratta di
una tendenza non solo italiana ma pi generale, non esaltante per la tenuta dei principi democratici, frutto di
unimmagine idealizzata dellattivit giurisdizionale [...] insieme ad una attivit indecorosa di produzione delle leggi
(J. WALDRON, Principio di maggioranza e dignit della legislazione, trad. it., Giuffr, Milano, 2001, 8). Concorrono a
questa immagine fattori positivi quali limpossibilit di ridurre il diritto alla legge, ma anche negativi, non ultimo un
certo disprezzo aristocratico per i cialtroni spediti dagli
elettori a Westminster (cos A. PINTORE, Prefazione a WAL-
338
caso Hirschl ha coniato lespressione juristocracy (432). Sono Paesi nei quali emerge la preoccupazione per il sopravvento che il legal constitutionalism sembra prendere sul political constitutionalism (non ci riferiamo alle estreme posizioni
originalist) (433). Comprendiamo la vocazione
antimaggioritaria che intimamente si lega alla
tutela dei diritti, che spesso tutela dei diritti di
minoranze, ma come stato nelle occasioni
prima citate latteggiamento delle maggioranze
parlamentari pu ben essere di apertura alle
istanze delle minoranze, non necessariamente di
emarginazione del loro ruolo (434).
Siamo su un terreno pieno di insidie che pone
interrogativi non facili. Pi che continuare
senza utilit (435) a interrogarsi sulla attivit,
DRON,
op. cit.). Critico nei confronti di Waldron PALOMBELLA,
Lautorit dei diritti, cit., 8, per il quale tale posizione rischia
di riportare indietro di cento anni il pensiero giuridico
europeo continentale .
(432) Ran HIRSCHL, Towards Juristocracy. The origins
and consequences of the new constitutionalism, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2004 (cui si deve
anche lespressione Constitutional Theocracy). Sono temi
che hanno alimentato il dilemma del Giudice Brennan: v.
F. MICHELMAN, La democrazia e il potere giudiziario. Il dilemma costituzionale del giudice Brennan, trad. it., Dedalo,
Bari, 2004 (di particolare interesse lintroduzione di Giorgio
Bongiovanni e di Gianluigi Palombella). Ma si tratta di
opinioni che hanno pi volte percorso gli USA: secondo il
Giudice e Governatore di New York C.E. Hughes, We are
under a Constitution, but the Constitution is what the judges
say it is (in Addresses and Papers of Charles Evans Hughes,
Putnams Sons, New York, 1908, 139). Da mettere in evidenza che la Corte Suprema, a differenza della Corte italiana, ha la facolt di scegliere i casi di cui occuparsi (Supreme Court Case Selections Act del 1988), cos potendo
svolgere un ruolo pi attivo.
(433) R. BELLAMY, Political constitutionalism. A republican defence of the constitutionality of democracy, Cambridge
University Press, Cambridge, 2007, 13 ss. Sul tema v. linteressante saggio di M. GOLDONI, Il ritorno del costituzionalismo alla politica: il political e il popular constitutionalism,
in Quaderni costituzionali, 2010, 733 ss.
Sulla lettura originalista v. A. SCALIA, Originalism: The
Esser Levil, in University of Cincinnati Law Rewiew, 1989,
849 ss., su cui v. le critiche di TRIBE e DORF, Leggere la
Costituzione, cit., 131 ss. Sulla posizione di Scalia e su
posizioni analoghe v. A. VESPAZIANI, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, Cedam, Padova, 2002, 41
ss. e 84 ss.; ma v. anche HABERMAS, Fatti e norme, ed. 2013,
cit., 27.
(434) Cfr. A. BARBERA e S. CECCANTI, I fondamenti giuridici di una possibile convivenza, in Atlantide, n. 3, 2005,
31-47 (pubblicato, con il titolo Valori etici e principio di
maggioranza, anche in Revista brasileira de direito constitucional, 2006, fasc. 8).
(435) Cos M. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?, Giuffr,
Milano, 1984, con cui concorda R. ROMBOLI, Il ruolo del
giudice in rapporto allevoluzione del sistema delle fonti ed
alla disciplina dellordinamento giudiziario, in Associazione
per gli studi e le ricerche parlamentari. Seminario 2005,
quaderno n. 16, Giappichelli, Torino, 2006, 63 ss.
Costituzione della Repubblica italiana
creativa o meno, dei giudici bisogna invece riflettere sul rischio che dal kelseniano custode della
Costituzione si possa scivolare verso una quanto
mai discutibile costituzione dei custodi (436) e
che lazione svolta dalla Corte finisca talvolta col
rivelarsi pi vicina alla figura di tutore della
Costituzione (der Hter der Verfassung), di cui
scriveva Carl Schmitt parlando del Capo dello
Stato, che a quella di organo giurisdizionale di
cui scriveva Hans Kelsen parlando delle Corti.
Probabilmente ma non tema di queste pagine
lintroduzione delle opinioni dissenzienti, riducendo lalone di sacralit delle decisioni della
Corte, potrebbe favorire un maggiore self-restraint
ed un maggiore controllo sociale delle stesse.
23. La giurisdizionalizzazione dellattivit
politica. La crisi della politica ha accentuato
la fragilit delle istituzioni di governo e delle pubbliche amministrazioni. Il ripetuto ricorso a Governi del Presidente, talvolta nella veste di Governi tecnici, in qualche caso presieduti da non
parlamentari, ne sono un segnale preciso. Il vuoto
del potere politico, a voler considerare la prospettiva di lungo periodo, ha finito con lessere colmato da altri poteri (Autorit indipendenti, Corte
costituzionale, le diverse Magistrature), non poche
volte determinando il superamento dei confini che
la Costituzione del 1948 ha posto a garanzia della
separazione dei poteri.
Per descrivere questo complesso di tendenze
viene di solito usata lespressione giuridicizzazione della politica (437): ma preferiamo non
utilizzarla, perch con essa si sono spesso indicati
fenomeni diversi, sia i tentativi della letteratura
giuridica di riconnettere diritto e politica, colmando la scissione orlandiana (438), sia la tendenza a intervenire con prescrizioni costituzionali
sulla forma di governo (439). Preferiamo usare,
(436) Lespressione di P.P. PORTINARO, Dal custode
della costituzione alla costituzione dei custodi, in Democrazia,
diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee a cura di G. GOZZI, Il Mulino, Bologna,
1997, 401 ss.
(437) A. MANZELLA, Corte costituzionale e Parlamento, in
St. parl. pol. cost., 2011 (Studi in onore di Nicola Greco), n.
173-174, 103 ss.; usa lespressione Repubblica giuridicizzata VIOLANTE, Magistrati, cit., 64 ss.
(438) Sul punto pi volte intervenuto F. LANCHESTER,
da ultimo v. Leopoldo Elia e la tradizione giuspubblicistica a
La Sapienza, in La Sapienza del giovane Leopoldo Elia
1948-1962 (Atti del Convegno, Roma, 27 marzo 2014),
Giuffr, Milano, 2014, 1 ss. (la Relazione pubblicata anche
in Nomos, 2014, n. 1 e consultabile sul sito www.nomosleattualitaneldiritto.it).
(439) Cos BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni
della Costituzione, cit., 382 ss.
invece, lespressione giurisdizionalizzazione della
politica, la judicialisation of politics non ignota ad
altri Paesi (440). In ogni caso, al di l di ogni
giudizio di valore su queste trasformazioni, intendiamo sottolineare che ben altri erano gli equilibri
fra le istituzioni titolari di indirizzo politico e le
istituzioni di garanzia delineati nella Costituzione
del 1948. Due i versanti in cui si sono determinate
tali tendenze, il primo rivolto alla Corte costituzionale, il secondo alle altre magistrature.
A) Sul primo versante abbiamo svolto alcune
considerazioni nel precedente paragrafo, in riferimento ai giudizi di legittimit costituzionale, ma vi
sono altri aspetti da considerare. La Corte costituzionale stata costretta ad intervenire pi volte
anche per ristabilire lequilibrio fra i poteri, messo
in discussione proprio dalla fragilit della mediazione politica. Avrebbe dovuto costituire un argine contro il potere politico, e quindi contro il
Parlamento stesso, in vista di un ottimale equilibrio fra poteri, ma ormai da diversi decenni questo
schema risulta modificato: a ben vedere la Corte si
trovata in pi circostanze a supplire, pi che a
contrastare o riequilibrare il potere politico (441).
Lo abbiamo prima visto nel campo dei diritti, in
cui spesso la Corte spinta ad intervenire per
sopperire allinerzia del legislatore. Tale obbiettivo
di riequilibrio, come abbiamo gi detto, stato alla
base della giurisprudenza, talvolta creativa, relativa al giudizio di ammissibilit di referendum
abrogativi, giustificata dallo smodato ricorso allo
strumento referendario da parte dei promotori e
dalle reazioni del sistema politico-rappresentativo.
Ed stata anche alla base della giurisprudenza
sviluppatasi per porre rimedio alle forzature
federaliste della riforma del Titolo V. Riforma
che, avendo contratto le possibilit di intervento
del legislatore, e quindi del potere politico, a tutela
degli interessi nazionali, ha scaricato sulla Corte la
tutela di quegli interessi attraverso lutilizzo di un
(440) Di judicialisation of politics parla HIRSCHL, op. cit.
Sul tema v. C. GUARNIERI e P. PEDERZOLI, La Magistratura
nelle democrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari, 2002.
(441) Ad uno schema analogo corrispondono diversi
conflitti fra poteri dello Stato cresciuti significativamente
nellultimo ventennio che hanno consentito alla Corte
non pochi (assai utili talvolta) interventi che hanno tuttavia
inciso sulla forma di governo parlamentare. Tendenza rilevata anche da G. RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di
attribuzione, Cedam, Padova, 2003. Oltre alla giurisprudenza sui decreti-legge e sulle leggi di conversione, di sui si
parla nel testo, vanno ricordate quella sulla ammissibilit
della sfiducia individuale (C. cost. 18 gennaio 1996, n. 7) e
quella sul potere di grazia (C. cost. 18 maggio 2006, n. 200,
cit.).
339
Costituzione della Repubblica italiana
armamentario variopinto e vasto, in larga parte
elaborato per loccasione.
Gli esempi pi clamorosi che si possono ulteriormente richiamare consentono di fare riferimento, pi che a forme di emarginazione del
potere politico, a forme di sostanziale auto-emarginazione. Non sono pochi i casi in cui la Corte
ha operato invasioni di campo ma determinate
da ripetuti abbandoni di campo da parte delle
Assemblee parlamentari. Emblematica al riguardo
ci pare la giurisprudenza sui decreti-legge. La
decisione del 1996 che aveva ritenuto costituzionalmente illegittima la reiterazione degli stessi (442) avrebbe dovuto avere come sbocco il
ritorno allordinaria iniziativa legislativa del Governo, ma la perdurante utilizzazione abnorme
della decretazione durgenza ha portato, nel 2007,
alla sentenza sulla cosiddetta vicenda del Sindaco
di Messina e, nel 2008, alla sentenza sulla cosiddetta vicenda del Teatro Petruzzelli (443).
Traendo da vari elementi linsussistenza dei requisiti della straordinaria necessit ed urgenza, quelle
decisioni hanno dichiarato la illegittimit costituzionale delle relative leggi di conversione. In tal
modo la Corte costituzionale venuta ad inserirsi
in uno spazio che storicamente sempre stato
proprio del raccordo Parlamento-Governo: in
base allart. 77 cost., infatti, il Governo adotta i
decreti-legge sotto la sua responsabilit , rispondendone alle Camere. Successivamente la
Corte (444) si spinta ancor pi in avanti e ha
statuito che non comunque costituzionalmente
legittimo inserire nella legge di conversione emendamenti del tutto estranei alloggetto e alle finalit
del decreto originario (445). In questo modo la
Corte sia pure con una decisione assai opportuna stata costretta ad ulteriormente limitare
lo spazio delliniziativa parlamentare.
Un caso ancor pi clamoroso offerto dalla
sentenza con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune parti decisive
della l. n. 270 del 2005, la cosiddetta legge eletto(442) C. cost. 24 ottobre 1996, n. 360, cit.
(443) C. cost. 23 maggio 2007, n. 171 e C. cost. 30 aprile
2008, n. 128.
(444) C. cost. 16 febbraio 2012, n. 22, cit. (relativa al
cosiddetto decreto mille-proroghe, poi confermata da C.
cost. 25 febbraio 2014, n. 32, cit., relativa al d.l. n. 272 del
2005, come convertito dalla l. n. 49 del 2006, che conteneva
la normativa sulle droghe, la cosiddetta normativa FiniGiovanardi).
(445) Atteso che, precisa la Corte, lart. 77 comma 2
cost. istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra
decreto-legge e legge di conversione, caratterizzata da un
procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello
ordinario.
340
rale Calderoli (446). In questo caso la Corte non
solo intervenuta in una chiara posizione di supplenza (peraltro con un giudizio promosso attraverso un surrettizio ricorso incidentale), ma ha
adottato una decisione che non si vede come
definire se non di natura para-legislativa, ripristinando il sistema elettorale proporzionale e addirittura introducendo le preferenze sia per la
Camera sia per il Senato (sistema di voto, peraltro,
che questultimo mai aveva conosciuto nella sua
storia). Molteplici e rilevanti gli effetti di tale
pronuncia sullo stesso dibattito politico-parlamentare. In primo luogo essa ha fatto riemergere
dottrine sulla eguaglianza del voto anche in
uscita, che in precedenti occasioni la Corte aveva
fortemente ridimensionato (447). In secondo
luogo ha concorso a comprimere la discrezionalit
del Parlamento spingendo verso formule elettorali
dai contorni non del tutto chiari, della cui compatibilit con i principi costituzionali promette di
farsi giudice, di volta in volta, essa stessa (448). In
terzo luogo, nonostante una contraria affermazione nella sentenza, ha fatto emergere dubbi sulla
legittimazione del Parlamento della XVII legislatura a continuare nella propria attivit (449). Infine, ha reso incerta accantonando in questa
occasione il tradizionale horror vacui la normativa elettorale vigente (tanto da suggerire essa
stessa, in materia riservata alla legge, luso del
potere regolamentare). Sul piano formale si trattato di un controllo di legittimit promosso in sede
incidentale ma la forzatura rispetto ai precedenti
(non vi era alla base un effettivo giudizio a quo ma
una sorta di ricorso diretto) stata tale da fare
ritenere che, in realt, al di l delle forme, la Corte
si assunta, stante la inerzia del legislatore, il
compito di dirimere un conflitto fra corpo elettorale (rappresentato dai ricorrenti) e Parlamento (450).
(446) C. cost. 13 gennaio 2014, n. 1, cit.
(447) In C. cost. 30 gennaio 2008, n. 15, sul cosiddetto
referendum Guzzetta, la Corte aveva sottolineato che leguaglianza del voto opera in entrata, non in uscita, e prima
ancora nella giurisprudenza sulle quote rosa: da ultimo C.
cost. 14 gennaio 2010, n. 4.
(448) Cos A. MORRONE, Exit Porcellum, in Quaderni
costituzionali, 2014, 119 ss.
(449) la posizione di A. PACE, I limiti di un Parlamento delegittimato, in La Repubblica, 26 marzo 2014; ma si
tratta di una posizione accolta solo da un gruppo ristretto di
costituzionalisti. V. anche ID., La disapplicazione dellart.
138 da parte del d.d.l. cost. n. 813 AS e le resistibili giustificazioni dei suoi sostenitori, in Giur. cost., 2013, 2437 ss.
(450) Non privo di significato che in sede di esame del
disegno di legge di riforma costituzionale stata introdotta
una disposizione che prevede il ricorso in via preventiva alla
Corte da parte di una frazione di parlamentari per un
Costituzione della Repubblica italiana
B) Numerosi e rilevanti sono stati gli interventi
delle altre magistrature, civile e amministrativa,
per fare fronte al vuoto e alla debolezza degli
organi di governo e delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali. Siamo al secondo versante,
in relazione al quale sarebbero tanti i casi che si
potrebbero ricordare; ci limitiamo a qualche esempio: le vicende legate allo stabilimento ILVA di
Taranto che hanno portato ad un conflitto delle
magistrature penali e civili con il Governo (451); le
modifiche imposte dai tribunali civili, in pi occasioni, ai protocolli sanitari stabiliti dal Ministero,
dalla cura Di Bella alla terapia Stamina (452);
gli interventi anomali in vertenze e crisi aziendali;
i sempre pi numerosi interventi di tribunali amministrativi che, attraverso azioni cautelari destinate poi ad essere superate da interventi del Consiglio di Stato o da forzate modifiche degli atti
impugnati, hanno avuto leffetto di paralizzare per
anni lazione amministrativa e di condizionarne
lautonomia.
Non meno numerosi e penetranti gli interventi
della magistratura penale, soprattutto dalla fine
degli anni Ottanta in poi, certamente alimentati da
fenomeni di malaffare nellattivit politica, ma che
in non pochi casi sono stati la conseguenza della
inefficacia dei controlli amministrativi e della mancata attivazione dei normali circuiti della responsabilit politica, sia interna ai partiti sia interna
alle istituzioni. In un quadro normativo attento
alle classiche garanzie dellHabeas Corpus ma non
altrettanto alle garanzie della dignit e della repucontrollo di costituzionalit della normativa elettorale prima
della promulgazione della stessa (Atti parl. Cam., XVII
legislatura, doc. n. 2613-A, sul quale v. anche infra, 24 e nt.
495).
(451) Cfr. i rilevi al riguardo di M. MASSA, Il commissariamento dellILVA: un nuovo capitolo nel diritto delle crisi
industriali, in Quaderni costituzionali, 2013, 617 ss.; ma v.
anche C. cost. 9 maggio 2013, n. 85.
(452) Sul punto intervenuta la Corte di Strasburgo: v.
C. eur. dir. uomo, sez. II, decisione 6 maggio 2014, Durisotto c. Italia (ricorso n. 62804/13), che ha riconosciuto
legittima la mancata autorizzazione da parte del Tribunale di
Udine della terapia cosiddetta Stamina, in forza del d.l. 25
marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla l. 23
maggio 2013, n. 57. Ma numerosi altri giudici hanno autorizzato la terapia in seguito a ricorsi ex art. 700 c.p.c., perfino
dopo il rinvio a giudizio da parte della magistratura torinese
per truffa ed esercizio abusivo della professione dellinventore del metodo, Vannoni. La sentenza C. cost. 5 dicembre
2014, n. 274 dovrebbe avere posto un punto fermo riconoscendo la legittimit costituzionale del d.l. n. 24, cit., che
aveva limitato laccesso alla cura, in deroga alla normativa
vigente, ai soli casi nei quali il trattamento era gi iniziato: v.
G. DAMICO, La vicenda Stamina e la lotta per la salute nella
sent. 274 del 2014 della Corte costituzionale, in Quaderni
costituzionali, 2015, 157 ss.
tazione personali, gli interventi della magistratura
inquirente (anche se solo limitati alla doverosa
apertura di un fascicolo), amplificati dai mezzi
di comunicazione di massa e dalla scarsa tenuta
del segreto investigativo (453), hanno potuto pesantemente incidere sullattivit politica, condizionando lattivit delle pubbliche amministrazioni e
incidendo su non poche carriere politiche, in pi
casi con riflessi sulla vita stessa dei Governi, nazionali, regionali e locali: tanto che si parlato di
funzione legittimante della Magistratura o di
controllo della virt (454). A tale incidenza
non sempre si accompagnato il necessario senso
di opportunit istituzionale e di moderazione
nel linguaggio, sia da parte dei soggetti colpiti sia
da parte dei magistrati protagonisti, alcuni dei
quali, sia pure in pochi ma clamorosi casi, hanno
utilizzato la loro visibilit e popolarit per costruire proprie carriere politiche (455).
Come noto, il Parlamento stesso, abolendo
nel 1993 (l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3), sullonda
di pulsioni giustizialiste, listituto della autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare, ha lasciato ampi margini allazione della magistratura inquirente, ma la Corte nel 2007 ha
ulteriormente allargato questo varco rendendo utilizzabile nei confronti dei soggetti terzi le intercettazioni casuali di parlamentari, la immediata
distruzione delle quali era prevista dalla l. n. 140
del 2003, non escludendo contemporaneamente
che da esse possano trarsi notitiae criminis nei
confronti del parlamentare indirettamente intercettato (456). Alla stessa Corte peraltro non erano
sfuggite lo dice espressamente le possibili
conseguenze negative della diffusione attraverso i
media di colloqui di parlamentari, anche se irrilevanti ai fini processuali.
Inoltre, sollecitata dalla Magistratura stessa attraverso linstaurazione di numerosi conflitti di
attribuzione, la Corte ha perseguito la progressiva
restrizione dei confini della insindacabilit per
le opinioni espresse e i voti dati dai componenti le
due Camere, non toccata dalla riforma del 1993.
Lo ha fatto ridimensionando lambito di attivit
(453) Fenomeno analizzato da D. SOULEZ LARIVIRE, Il
circo mediatico-giudiziario, trad. it., Liberilibri, Macerata,
2000.
(454) Cos su posizioni analoghe A. PIZZORNO, Il potere
dei giudici. Stato democratico e controllo della virt, Laterza,
Roma-Bari, 1998; CAFERRA, La giustizia e i suoi nemici, cit.,
46.
(455) Cos ALLEGRETTI, Storia costituzionale italiana, cit.,
220.
(456) C. cost. 23 novembre 2007, n. 390.
341
Costituzione della Repubblica italiana
del parlamentare (457), distinguendo fra opinioni
e insulti oppure fra opinioni espresse in relazione alle funzioni effettivamente svolte allinterno
delle Assemblee ed altre non collegate alla concreta attivit svolta dal parlamentare (458). E in
ogni caso ricorrendo a indagini e motivazioni che
in altra epoca (e in altri Paesi) sarebbero state
ritenute non rispettose dellautonomia costituzionale delle Assemblee parlamentari.
Di questa tendenza altres espressione il favore progressivamente mostrato dai giudici costituzionali e da altri giudici, amministrativi o contabili, per il superamento della cosiddetta autodichia delle due Camere, considerata, da ultimo,
frutto di una non pi attuale antica tradizione
interpretativa (459), cos abbandonando il precedente richiamo a vere e proprie consuetudini
costituzionali che avrebbero rese legittime deroghe al diritto comune (460). Era stato invece il
frutto di una iniziativa referendaria labolizione,
con la l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, della Commissione parlamentare inquirente, prevista dallart. 96 cost. per i reati ministeriali, e la sottoposizione dei Ministri, a certe condizioni, alla giurisdizione ordinaria (il cosiddetto Tribunale dei ministri); ma la Corte ha poi ulteriormente e
diremmo inevitabilmente inciso sui poteri parlamentari, attribuendo alla sola autorit giudiziaria, e non al Parlamento, laccertamento della natura ministeriale di un reato (e, in caso di conflitto
con una delle due Camere, riservando a se stessa
laccertamento in via definitiva della stessa) (461).
La caduta di tali garanzie accompagnata dal
progressivo indebolimento delletica pubblica ha
ulteriormente compromesso limmagine della attivit parlamentare (462). comprensibile che i
tentativi operati con i cosiddetti lodi Schifani (l. n.
140 del 2003) e Alfano (l. n. 124 del 2008) di
introdurre forme di sospensione dei procedimenti
in corso per le alte cariche dello Stato (esattamente
(457) C. cost. 23 novembre 2007, n. 388.
(458) C. cost. 17 gennaio 2000, n. 10 e n. 11; v. inoltre
C. cost. 29 settembre 2004, n. 298. Attivit precisa la
Corte che deve precedere, non seguire lesternazione del
parlamentare (C. cost. 19 novembre 2004, n. 347 e C. cost.
28 giugno 2006, n. 249).
(459) C. cost. 9 maggio 2014, n. 120.
(460) C. cost. 10 luglio 1981, n. 129, a proposito della
sottrazione al giudizio di conto. Sul punto v. T. GIUPPONI, La
Corte e la sindacabilit indiretta dei regolamenti parlamentari: il caso dellautodichia, in Quaderni costituzionali, 2014,
675 ss.
(461) C. cost. 12 aprile 2012, n. 87 e n. 88; C. cost. 25
febbraio 2014, n. 29.
(462) Numerose le leggi cosiddette ad personam richiamate in modo puntuale da CAFERRA, op. cit., 61 ss.
342
come nella vicina Francia) abbiano visto, sia in
dottrina sia nel dibattito politico sia nella giurisprudenza, unenfatizzazione del principio di
eguaglianza, in contraddizione con una lunga tradizione del costituzionalismo che ha sempre ammesso deroghe a tale principio a tutela della separazione dei poteri (peraltro, sia per i soggetti
investiti di alte funzioni politiche (463) sia per gli
stessi magistrati: non contraddice al principio di
eguaglianza, per esempio, il fatto che in base
allart. 107 cost., a differenza di altri funzionari,
essi siano inamovibili ?). La illegittimit di
quelle proposte, dal momento che esse incidevano
sulla posizione di titolari di organi costituzionali,
era solo nel mezzo utilizzato, la legge ordinaria
anzich quella costituzionale, non nei contenuti
(pi o meno opportuni). Cos sembrerebbe ma la
Corte non stata chiarissima sul punto, forse per
lasciare aperta la porta, nel caso di eventuale
approvazione con legge costituzionale, a pi radicali motivi di illegittimit costituzionale (464).
Sez. V. LORDINAMENTO COSTITUZIONALE
IN TRASFORMAZIONE.
24. Le revisioni della Carta (quelle tentate e
quelle realizzate). Nei sessantanni di vita della
Costituzione i primi trentanni sono stati dominati
dal tema dellattuazione, i secondi dal 1979 in
poi da quello delle riforme (465). Di riforme
della Costituzione si era tuttavia cominciato a
parlare allinizio degli anni Sessanta dopo la crisi
dei primi Governi di centrosinistra. Nel 1964, in
un clima di veleni e sospetti, Randolfo Pacciardi
partigiano e comandante della Brigata Gari(463) E come negli stessi anni previsto, per decisione
giurisprudenziale peraltro, in un caso analogo in Francia. Su
questi temi v. T. GIUPPONI, Le immunit della politica. Contributo allo studio delle prerogative costituzionali, Giappichelli, Torino, 2005, passim; C. MARTINELLI, Le immunit
costituzionali nellordinamento italiano e nel diritto comparato, Giuffr, Milano, 2008, 173 ss.
(464) C. cost. 20 gennaio 2004, n. 24, C. cost. 23
ottobre 2009, n. 269 e C. cost. 25 gennaio 2011, n. 23, cui
per completezza si pu aggiungere C. cost. 15 gennaio 2013,
n. 1, cit., a proposito delle prerogative del Capo dello Stato.
In dottrina era stata prospettata la illegittimit di tali
prerogative, anche se adottate con legge costituzionale per la
violazione di principi supremi: v. A. PACE, Il legittimo
impedimento incostituzionale, in La Repubblica, 8 febbraio
2009; ma lopinione non isolata: v. fra i tanti A. RUGGERI, Il
lodo Alfano al bivio tra teoria delle fonti e teoria della
giustizia costituzionale (a margine di Corte cost. n. 262 del
2009), ora in ID., Itinerari, cit., XIII. Studi dellanno 2009,
2010, 483 ss.
(465) CHELI, Nata per unire, cit., 29 s.; cos anche FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale, cit., 295 ss.
Costituzione della Repubblica italiana
baldi nella guerra civile spagnola, deputato alla
Costituente, gi Segretario del partito repubblicano, gi vicepresidente del Consiglio e Ministro
della difesa nei Governi De Gasperi dette vita
ad un gruppo politico (lUnione democratica per
la Nuova Repubblica) con un obbiettivo semipresidenzialista, ispirato alle istituzioni della Francia
gollista (466). Nello stesso anno un gruppo di
giuristi e costituzionalisti aderiva al Manifesto di
Giuseppe Maranini per un programma di riforme
elettorali ed istituzionali ispirate, invece, al parlamentarismo anglosassone (ma nel contempo si
batteva anche per lattuazione della Costituzione,
soprattutto per quanto riguardava la indipendenza
della Magistratura) (467). Allinizio degli anni Settanta, in due dibattiti organizzati dalla rivista Gli
Stati, Vezio Crisafulli, Costantino Mortati, Antonio La Pergola, Serio Galeotti, Aldo Sandulli,
Giuseppe Ferrari suggerivano modifiche costituzionali per la formazione di Governi di legislatura imperniati attorno alla figura del Presidente
del Consiglio (468). Negli stessi anni Costantino
Mortati ebbe modo di denunciare i limiti del
(466) Non mancava un fine politico immediato: contrastare i presunti cedimenti al partito socialista legato
allora al partito comunista da parte dei partiti di centro.
Il raggruppamento si candid alle elezioni politiche del 1968
ma con assai scarso successo (poco pi di 60.000 voti). Nel
1974 Pacciardi venne indagato e sospettato di aver appoggiato presunte manovre golpiste ma fu presto liberato da
ogni sospetto ed ebbe modo di rientrare due anni dopo nel
partito repubblicano.
(467) In quello stesso anno si dava vita ad Alleanza
costituzionale, cui aderirono, oltre a Giuseppe Maranini,
Vezio Crisafulli, Vittorio Frosini, Silvano Tosi, Leonetto
Amadei, Pietro Nuvolone. Le posizioni erano non sempre
coincidenti, ed anzi talora divergenti, ma prevalentemente si
muovevano nel senso di razionalizzare il rapporto fra
partiti e istituzioni e di dare alle stesse una curvatura tale da
perseguire il modello Westminster (anche attraverso un
sistema elettorale imperniato su collegi uninominali ad un
turno): puntuali riferimenti in T. FROSINI, Maranini e il
progetto di Alleanza costituzionale, in Nuova Antologia, 1996,
290 ss., e in E. CAPOZZI, Il sogno di una costituzione. Giuseppe
Maranini e lItalia del Novecento, Il Mulino, Bologna, 2008,
361 (si deve, tra laltro, a Maranini lespressione partitocrazia).
Qualche anno dopo Serio Galeotti inizier una intensa
attivit pubblicistica a favore di incisive riforme costituzionali ed elettorali; ricordiamo per tutte la Relazione sul
potere di decisione al XVIII Convegno dei Giuristi
cattolici italiani (Roma, 7-8 dicembre 1967): v. S. GALEOTTI,
Il potere di decisione, in Posizioni di diritto e posizioni di fatto
nellesercizio del potere politico, Giuffr, Milano, 1968 (Quaderni di Iustitia, n. 19), 32 ss.
Per unapprofondita ricostruzione dei percorsi seguiti in
quegli anni v. C. FUSARO, Per una storia delle riforme istituzionali (1948-2015), in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, n. 2; ID.,
La rivoluzione costituzionale, cit.
(468) In Gli Stati, 1973 e 1974 (v. in particolare La
Costituzione e la crisi a cura di F. CANGINI, ivi, 1973, II, 10).
processo di attuazione costituzionale guardando
con tono pessimistico a quella forma di governo
cui aveva pochi anni prima guardato con fiduciosa
speranza (469). Il parlamentarismo assemblearista
questo era in sintesi il pensiero di Mortati
non si dimostrava in grado, anche per effetto del
proporzionalismo, di tradursi in un effettivo
canale di espressione della sovranit popolare (470).
Alla fine degli anni Settanta maturano anche le
posizioni riformatrici di Giuliano Amato e del
gruppo di intellettuali riunito attorno alla rivista
Mondo operaio, che troveranno parziale sbocco
politico nella proposta di Grande riforma lanciata da Bettino Craxi sulle colonne de LAvanti
nellestate del 1979, dopo la crisi che aveva colpito
la strategia della solidariet nazionale inaugurata
con i Governi Andreotti (471). Allinizio degli
anni Ottanta il Presidente del Consiglio Spadolini
allatto della presentazione del suo secondo Governo (agosto 1982) espone un programma di
riforme (il Decalogo) con cui tenta di coinvolgere lintero Parlamento, al di l della maggioranza
politica che lo sosteneva: fra queste, la legge sulla
Presidenza del Consiglio di cui allart. 95 cost.,
lordinamento delle autonomie, il potere di revoca
dei Ministri, e soprattutto la fissazione di tempi
parlamentari certi per lapprovazione di iniziative
previste dal programma di governo (472).
(469) C. MORTATI, in Commentario della Costituzione
fondato da BRANCA, Principi fondamentali, cit., sub art. 1, che
del 1975, mentre ID., Costituzione dello Stato, cit., del
1962.
(470) Cfr. BARBERA e CECCANTI, La lenta conversione
maggioritaria di Costantino Mortati, cit., 67 ss.
(471) Le posizioni socialiste sono ben riassunte in Una
costituzione per governare a cura di S. AMOROSINO e M.
BACCIANINI, Marsilio, Venezia, 1981 (Quaderni di Mondoperaio, n. 13). La proposta di Bettino Craxi per una Grande
riforma fu pubblicata su LAvanti, 28 settembre 1979. V.
anche G. AMATO, Una repubblica da riformare, Il Mulino,
Bologna, 1975.
(472) Il Decalogo si pu leggere in La Voce repubblicana, 17 agosto 1982, ma anche esposto in G. SPADOLINI,
Discorsi parlamentari (Archivio storico del Senato), Il Mulino, Bologna, 2002, con un saggio di Cosimo Ceccuti. Reso
pubblico allatto della presentazione del secondo Governo
Spadolini (il cosiddetto Governo fotocopia), il decalogo era
stato predisposto da un gruppo di lavoro coordinato da
Andrea Manzella e di cui facevano parte Vincenzo Caianiello, Silvano Tosi, Stefano Folli ed altri: v. T. FROSINI,
Spadolini riformista, in Confronti costituzionali, www.confronticostituzionali.eu, 4 agosto 2014.
Un qualche seguito vi fu; negli anni successivi con le
Presidenze Craxi e De Mita si poterono realizzare alcune
riforme (sulla base della teoria del cosiddetto maggioritario
di funzionamento): si pervenne alla l. n. 400 del 1988, che
stabiliva lordinamento della Presidenza del Consiglio; alla l.
n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo; alla l. 8
343
Costituzione della Repubblica italiana
Negli stessi anni anche allinterno della sinistra
comunista non mancarono progetti di riforma relativi sia alle istituzioni il PCI per esempio torn
pi volte sul tema del bicameralismo oscillando fra
un modello di Senato delle Regioni e lipotesi pi
radicale del monocameralismo (473) sia agli
stessi principi costituzionali, fino ad ipotizzare
con una proposta lanciata da Pietro Ingrao nel
corso del XVII Congresso del PCI (Firenze, 1986)
e maturata nellambito del Centro per la riforma
dello Stato da lui presieduto un processo
costituente che avrebbe potuto portare anche alla
convocazione di unassemblea costituente (474).
giugno 1990, n. 142, sulla riforma delle autonomie locali;
infine nel 1987 al gi ricordato superamento del ricorso
generalizzato al voto segreto in Parlamento.
(473) La prima posizione fu oggetto di approfondimento in un Seminario dei gruppi parlamentari svoltosi il
19-20 gennaio 1976 (su cui v. A. BARBERA, I rapporti fra
Regioni e Parlamento, in Critica marxista, 1976, 87 ss.). La
seconda posizione fu portata avanti dal Centro per la riforma
dello Stato in un Seminario del 12 dicembre 1983 (su cui v.
Il Parlamento tra crisi e riforma a cura di A. BARBERA, P.
BARCELLONA, F.P. BONIFACIO, G. FERRARA e A. MANZELLA,
Franco Angeli, Milano, 1985). Sulle linee di politica costituzionale della sinistra v. PETTA, Ideologie costituzionali della
Sinistra italiana, cit., 169 ss.
(474) Lintervento al Congresso ora riprodotto in
INGRAO, Crisi e riforma del Parlamento, Ediesse, Roma, 2014,
175 ss. (che riporta anche uno scambio epistolare con Bobbio). Ingrao non solo auspicava una riscrittura di parti della
Costituzione non pi adeguate ai fenomeni di mondializzazione e militarizzazione e alla nuova dimensione dei
rapporti individuo e societ ma anche una riforma elettorale che consenta agli elettori di essere essi a scegliere fra
schieramenti alternativi . La posizione di Ingrao fu contestata da Norberto Bobbio in un ripetuto scambio epistolare
ospitato da Micromega (marzo 1986; poi riprodotto in Micromega, 2010, n. 2, e in INGRAO, Crisi e riforma del Parlamento, cit.), che obbiettava a Ingrao il rischio di una delegittimazione della Costituzione vigente (seconda lettera
del 15 gennaio 1986). Gi dopo il fallimento della Commissione Bozzi, ritenuta dalla sinistra radicale non allaltezza
della crisi istituzionale e sociale, Pietro Ingrao aveva lanciato
lidea di un Governo costituente , cos riportato nella
cronaca de La Repubblica, 30 ottobre 1985: Per anni la
sinistra ha svolto un ruolo conservatore sulle riforme istituzionali, e forse ne aveva motivo. Ma adesso deve farsi
promotrice di un nuovo compromesso istituzionale che consenta di portare allordine del giorno la riforma delle regole
del gioco . Analoghe posizioni saranno riprese da G. VACCA
(Per una nuova costituente, Bompiani, Milano, 1996) allepoca del varo della Commissione DAlema.
Le elaborazioni del Centro per la riforma dello Stato
sono raccolte o riassunte in Costituenti due, fasc. speciale di
Dem. dir., 1995 (e 1994, n. 4; 1995, n. 1); ivi, fra gli altri,
Pietro BARCELLONA, Una transizione pericolosa, 17 ss., che si
interroga su come le lotte sociali degli anni Sessanta e dei
primi anni Settanta, rese possibili dalla conquista della Costituzione, possano spingere verso una pi avanzata riforma
dello Stato e verso un nuovo regime sociale. Nello stesso
fascicolo: U. ALLEGRETTI, Globalizzazione e sovranit nazionale, 47 ss.; P. COTTURRI, Governabilit e rappresentanza, 67
ss., che non esclude (p. 77) riforme radicali, compresa
344
Le proposte volte a incidere anche sulla prima
parte della Costituzione rimarranno minoritarie e
confinate alle posizioni pi radicali della sinistra e
a talune posizioni portate avanti dal cosiddetto
Gruppo di Milano, coordinato da Gianfranco Miglio (475). Esse andranno progressivamente perdendo seguito (476). Agli inizi degli anni Novanta
le proposte di riforma di tutti i partiti si limiteranno sempre pi alla sola parte seconda della
Costituzione, con esplicita esclusione della parte
prima. Proprio perch i principi costituzionali si
andavano radicando nella societ italiana, trovava
sempre pi spazio lobbiettivo di accrescere la
capacit di decisione delle istituzioni, in particolare correggendone i tratti assemblearistici. In
questa direzione spingeranno da un lato le mutate
prospettive del quadro politico dopo la caduta del
muro di Berlino e dallaltro lesito dei citati referendum elettorali volti ad introdurre sistemi maggioritari e bi-polarizzanti, ritenuti in grado, se
sostenuti da talune limitate riforme costituzionali,
di favorire e incentivare forme di democrazia
immediata o di investitura. Dalla crisi dei partiti, inoltre, si traeva una ragione in pi per rafforzare le istituzioni, secondo modelli europei, ritenendo cos di poter influenzare positivamente
forme e modi della politica (477). A partire dagli
lelezione diretta del Capo dello Stato come contrappeso a
poteri forti di autogoverno territoriale ; nonch le posizioni
di dissenso di M. LUCIANI, Quindici argomenti contro linvocazione del potere costituente, 97 ss.
(475) Soprattutto nella Relazione di Giovanni BOGNETTI, Il modello economico della democrazia sociale, cit.,
243 ss.
(476) Tranne alcune proposte della sinistra indipendente nella Commissione Bozzi: v. la Relazione di minoranza
di S. Rodot, in Atti della Commissione parlamentare per le
riforme istituzionali, II, IX legislatura, doc. XVI-bis, n. 3-bis,
629 ss.
(477) Non tutti perseguivano questo risultato con le
stesse motivazioni: mentre i pi sottolineavano lesigenza di
un potere politico in grado di decidere proprio per meglio
realizzare gli obbiettivi anche sociali della Costituzione,
contrastando i troppi poteri di veto dei vari gruppi di
pressione, altri, invece, riflettevano leco della strategia neoliberista secondo la quale un rafforzamento delle istituzioni
di governo avrebbe potuto favorire una riduzione delleccesso di domande sociali. Strategia che alcuni commentatori
(addirittura dando una grottesca caratura complottista) individuavano in un Rapporto della Trilateral Commission,
pronto gi dal 1973, redatto da M. Crozier, S.P. Huntinghton e J. Watanuki. A quel Rapporto dedicata, per
esempio, una intera annata (1975) della Rivista italiana di
scienza politica, cui rinviamo, nonch la letteratura internazionale ivi citata (OConnor, Offe, Habermas).
In quel clima si inserir lenfasi sul piano di rinascita
democratica della Loggia massonica P2 trovato fra le carte
della figlia di Gelli. Vi erano in effetti due progetti di taglio
eversivo: uno per influire sulla attivit della Magistratura
attraverso lappoggio a talune correnti della stessa e laltro
Costituzione della Repubblica italiana
anni Novanta si aggiunta la ricerca di un pi
marcato decentramento regionale fino ad ipotizzare lo abbiamo visto il passaggio ad un
sistema federale (478). Entrambi gli obbiettivi
rivisitazione della forma di governo e della forma
regionale dello Stato hanno dovuto fare i conti
con lanomalo assetto bicamerale paritario cui abbiamo fatto pi volte riferimento.
A tali obbiettivi sono state dedicate ben tre
Commissioni bicamerali e numerosi dibattiti e iniziative parlamentari: la Commissione Bozzi nella
IX legislatura, nel biennio 1983-1985 (479); la
Commissione De Mita-Iotti nella XI legislatura,
nel biennio 1992-1994; la Commissione DAlema
nella XII legislatura, nel biennio 1997-1998, cui
possono aggiungersi, in sede governativa, la Commissione Speroni, costituita dal primo Governo
Berlusconi (1994) o i numerosi dibattiti che hanno
percorso diverse legislature (480).
Il lavoro di dette Commissioni non riuscito,
salve alcune eccezioni, a tradursi in iniziative legislative in grado di giungere alla loro approvazione.
Le conclusioni della Commissione Bozzi, cui peraltro erano stati attribuiti solo compiti di studio,
non ebbero effettivo seguito per il venire meno
delle condizioni politiche che avevano portato alla
per costruire un sistema di controllo dellinformazione, ma
per il resto tale piano conteneva alcuni progetti inoffensivi,
talvolta banali. Non contiene affatto, per esempio, nonostante la perdurante vulgata contraria, una proposta presidenzialista ma delinea un sistema elettorale proporzionale e
un blando cancellierato, da realizzare, come in Germania,
attraverso la elezione del Presidente del Consiglio da parte
del Parlamento.
(478) Le vicende parlamentari sono ripercorse da V.
LIPPOLIS, Le riforme istituzionali: trentanni di sterili tentativi
parlamentari e di modifiche della legislazione elettorale. Dallarticolo di Bettino Craxi del 28 settembre 1979 al discorso
programmatico di Matteo Renzi del 24 febbraio 2014, in Rass.
parl., 2014, 103 ss.
(479) La proposta iniziale appartiene al Governo Fanfani (VIII legislatura) allatto della presentazione dello stesso
alle Camere (10 dicembre 1982) prendendo spunto dalla
conclusione dei due comitati di studio (comitati Ritz e
Bonifacio) istituiti nel seno delle due Commissioni affari
costituzionali, giunti a conclusioni largamente condivise (depositate il 31 ottobre 1982); ma la fine anticipata della VIII
legislatura non consent di dare seguito alla iniziativa.
(480) La Commissione Bozzi era stata istituita con gli
ordini del giorno di Camera e Senato approvati il 14 aprile
1983; la Commissione De Mita-Iotti, inizialmente varata con
un ordine del giorno, era stata poi disciplinata dalla l. cost.
6 agosto 1993, n. 1, altrettanto la Commissione DAlema, poi
disciplinata dalla l. cost. 24 gennaio 1997, n. 1.
Numerosi i dibattiti, come dicevamo, che hanno percorso diverse legislature: il 18-19 maggio 1988 in apposita
Sessione alla Camera dei deputati o quello in entrambe le
Camere a seguito del Messaggio del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991 (Camera dei deputati, doc. I, n. 11,
trasmesso il 26 giugno 1991).
sua istituzione: la DC lamentava il mancato varo di
una proposta di riforma elettorale con premio di
maggioranza la proposta che va sotto il nome di
De Mita-Ruffilli (481) ; il PSI era poco interessato ad una riforma che non prevedeva lelezione
diretta del Capo dello Stato; il PCI era contrario
alla introduzione, proposta invece dalla Commissione, del voto palese sulle leggi di spesa. In realt
la Commissione, che pure aveva elaborato un
buon testo, esaur la propria spinta allorch la DC
di De Mita e il PCI di Berlinguer, a seguito delle
tensioni provocate dal decreto sul costo del lavoro
(il gi citato decreto di San Valentino del febbraio 1984: v. supra, 18), videro sfumare la
possibilit di una riforma elettorale che costringesse il PSI di Craxi ad una scelta preventiva delle
alleanze davanti al corpo elettorale. Il ritiro dai
lavori di una parte della sinistra indipendente e il
disimpegno del PCI, contrario allintroduzione del
voto palese nelle decisioni di spesa, rappresentarono solo la causa prossima dellinsuccesso della
Commissione. Nella Relazione conclusiva presentata il 29 gennaio 1985 e approvata dai gruppi
della maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni di destra e di sinistra ma con lastensione
del partito comunista e dei socialdemocratici
era prevista la revisione di 44 articoli della Costituzione in unottica di razionalizzazione del sistema vigente (482). A seguito della presentazione
della Relazione, furono depositate in Parlamento
da parte di vari gruppi politici proposte di revisione costituzionale che riprendevano in tutto o in
parte le conclusioni formulate dalla Commissione
(in particolare lonorevole Bozzi si fece promotore
di nove proposte di revisione costituzionale). Tali
proposte furono assegnate alla Commissione affari
costituzionali della Camera, che non ne inizi mai
lesame.
(481) V. Il cittadino come arbitro a cura di R. RUFFILLI e
P.C. CAPOTOSTI, Il Mulino, Bologna, 1988, 211 ss.
(482) La Relazione prevedeva la fiducia al solo Presidente del Consiglio; una sensibile riduzione del numero dei
parlamentari; lintroduzione di una forma di bicameralismo
ineguale; il rafforzamento dei poteri di inchiesta del Parlamento; il rafforzamento dellart. 81 cost. sul pareggio di
bilancio, laccesso della Corte dei conti alla Corte costituzionale per il sindacato sulle leggi di spesa e lintroduzione
del voto palese per la loro approvazione; labolizione del
semestre bianco e il divieto di rielezione del Presidente della
Repubblica; lintroduzione di principi di trasparenza nelle
nomine; maggiori responsabilit del Ministro della giustizia
in materia disciplinare, tenuto a riferire annualmente al
Parlamento; il divieto di incarichi extragiudiziali per i magistrati; la modifica dellart. 39 cost.; lordinamento regionale
e locale; una pi razionale disciplina delle fonti normative e
del referendum; incisive norme sulla libert di informazione,
compreso il divieto di concentrazioni.
345
Costituzione della Repubblica italiana
Nella legislatura successiva (la X, 1987-1992)
fu approvato dal Senato nel giugno del 1990, su
iniziativa di Leopoldo Elia, un testo di riforma del
procedimento legislativo (483) che non riusc a
varcare lAula di Montecitorio, ove ci si limit ad
uno stanco dibattito generale (pur mantenendo il
bicameralismo paritario esso si basava su una distribuzione del lavoro legislativo fra le due Camere, privilegiando luna o laltra sulla base di vari
criteri, cosiddetto principio della culla).
Allinizio degli anni Novanta la Commissione
De Mita-Iotti (XI legislatura, 1992-1994), costretta
a discutere di legge elettorale e di riforme costituzionali dallinaspettato successo del referendum
del 1991 e dallapprossimarsi di quello del 1993,
present una Relazione nel gennaio 1994 ma
venne politicamente delegittimata dalla determinazione del principale partito della sinistra di cogliere una vittoria che si riteneva sicura ricorrendo
alle elezioni anticipate, che si sarebbero svolte
nella primavera del 1994 (484).
Il Governo Berlusconi, appena insediato, dette
vita ad un comitato di studio, presieduto dal Ministro Speroni (aprile 1994-febbraio 1996), che
propose un testo di riforma basato, per la parte
relativa alla forma di governo, su due proposte
alternative, lelezione diretta del Primo Ministro o
la soluzione semipresidenziale, ma la crisi del
primo Governo Berlusconi (autunno 1994) fren
lulteriore avvio del progetto.
A met anni Novanta (XIII legislatura, 19962001) liniziativa torna al Parlamento che d vita,
sulla base di un accordo fra maggioranza ed opposizioni, ad una Commissione bicamerale la cui
Presidenza viene affidata al Segretario del PDS
Massimo DAlema. Essa fu immaginata, a sinistra,
(483) Proposta di legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione;
introduzione degli articoli 11-bis, 70-bis, e 95-bis , in Atti
parl. Cam., X legislatura, doc. n. 4887.
(484) La istituzione della Commissione era stata preparata dal dibattito sulle riforme promosso nella precedente
legislatura dalle due Presidenze delle Camere (18-19 marzo
1988) e da quello provocato dal Messaggio di Cossiga,
lunico messaggio in materia discusso nelle Aule parlamentari (23-25 luglio 1991).
Le conclusioni della Commissione furono comunicate
alle Camere l11 gennaio 1994 e tradotte in disegno di legge
costituzionale (in Atti parl. Cam., XI legislatura, doc. n.
9597; Atti parl. Sen., XI legislatura, doc. n. 1789). La
Relazione raccoglieva alcune proposte della Commissione
Bozzi ma si muoveva con pi decisione verso il modello del
Cancellierato tedesco prevedendo in particolare, oltre allelezione del Presidente del Consiglio a Camere riunite,
listituto della sfiducia costruttiva. Essa non escludeva una
evoluzione del sistema politico, grazie ad una riforma elettorale adeguata, che portasse a indicare preventivamente agli
elettori le alleanze di governo.
346
come modo per puntellare la coalizione dellUlivo
(o per ridare iniziativa ai partiti, secondo altre
interpretazioni) e, a destra, soprattutto come occasione per la riforma dellordinamento giudiziario. La Commissione spinse i propri lavori fino al
punto di prospettare una modifica in senso semipresidenziale della forma di governo (485) mentre,
per quanto riguarda la forma di Stato, ebbero
modo di manifestarsi improvvise vocazioni federaliste sia a sinistra sia a destra: tutte in realt tese a
disputarsi alleanze con la Lega Nord, allora in
forte ascesa elettorale (486). Ma i lavori della
Commissione non ebbero seguito a causa della
delusione di Forza Italia per le posizioni, ritenute
arretrate, assunte in tema di riforma dellordinamento giudiziario. Ebbe un seguito invece lo
abbiamo visto supra, nel 19 solo la proposta
di riforma del Titolo V che qualche anno dopo
sarebbe stata varata con la l. cost. n. 3 del 2001, ma
votata, con margine ristretto di quattro voti, dalla
sola maggioranza di centrosinistra.
Dopo la chiusura dei lavori della Commissione
fu mantenuto vivo il dibattito sulla modifica della
legge elettorale, da un lato alimentato da chi intendeva tornare a sistemi pi proporzionali, dallaltro da chi voleva invece estendere larea del
maggioritario: a questultimo fine vennero promossi due referendum abrogativi della quota proporzionale prevista dalla legge Mattarella, il primo
dei quali (svoltosi il 18 aprile 1999) ottenne il 91,7
per cento di voti favorevoli, ma manc il raggiungimento del quorum per pochi voti attestandosi al
49,7 per cento (il secondo, svoltosi il 18 maggio
(485) La Commissione aveva predisposto due testi: uno
basato sul cosiddetto premierato, laltro sulla elezione
diretta del Presidente della Repubblica. Alle fine la Lega
riusc a fare pendere la bilancia su questo secondo modello
(che avrebbe potuto favorire la soluzione federalista). Ma
si trattava di una formula di semipresidenzialismo debole,
che prendeva a modello pi che la V Repubblica le forme di
governo di Austria, Portogallo, Finlandia. Veniva mantenuto
in vita il Senato ma privato della titolarit del rapporto
fiduciario con il Governo. La Commissione non aveva il
compito di intervenire sulla legge elettorale ma non manc
lapprovazione di documenti volti ad introdurre formule a
doppio turno, o di collegio o di coalizione. Poche le innovazione per quanto riguarda lordinamento giudiziario che
giustificheranno, come detto nel testo, il disimpegno del
centrodestra.
(486) Le vocazioni federaliste avranno modo di manifestarsi nella primavera del 1995, al momento della formazione del Governo Dini e alla vigilia delle elezioni regionali.
il periodo in cui la Lega, ribaltata la alleanza con Berlusconi, diviene lago della bilancia per qualunque maggioranza di governo. Proprio in quei mesi il PDS e i popolari
abbandonano la (fino allora granitica) pregiudiziale antifederalista e abbracciano un raffazzonato federalismo. Negli
stessi mesi perfino Alleanza nazionale si scopre federalista.
Costituzione della Repubblica italiana
del 2000, vide crescere lastensionismo). Linsuccesso del referendum favor lapprovazione della
cosiddetta legge Calderoli (l. n. 270 del 2005) che
port al ritorno del sistema proporzionale, sia
pure corretto da un premio di maggioranza alla
coalizione vincitrice (mentre come abbiamo gi
detto supra, nel 19 non raggiunger il quorum
il cosiddetto referendum Guzzetta del 2009, volto
ad attribuire il premio alla lista pi votata).
Giunse ad approvazione parlamentare, invece,
nel 2005, un ambizioso progetto di riforma costituzionale (487) ma che, approvato dalla sola maggioranza di centrodestra, non riusc a superare la
successiva verifica referendaria (25-26 giugno
2006). Quella campagna referendaria fin per incentrarsi su due inattendibili parole dordine, di
significato positivo per il centrodestra, di significato negativo per il centrosinistra: devolution e
premierato forte, che resero non facile un giudizio di merito (488) ma che comunque registrarono un largo consenso al testo costituzionale.
Quellesito (successo del No , alta partecipazione degli elettori) raggel per vari anni il dibattito sulle riforme costituzionali e segn il tramonto
(o laccantonamento) dei tentativi di riforma organica della parte seconda della Costituzione.
I tentativi sono ripresi nella XV legislatura
(2006-2008). Dopo una lunga discussione il 17
ottobre 2007 viene approvato dalla Commissione
affari costituzionali della Camera un testo unificato cosiddetta bozza Violante dal nome del
Presidente della Commissione che, inviato
allAula, non riesce a completare il percorso per
lanticipata cessazione della legislatura (489). Riprova il Senato nella XVI legislatura (2008-2013):
un testo approvato dalla Commissione affari costi(487) In Atti parl. Sen., XIV legislatura, doc. n. 2544-D,
pubblicato in G.U. 18 novembre 1995, n. 269.
(488) Per i contenuti rinviamo a C. FUSARO, La riforma
costituzionale: piena di difetti ma meglio di niente, in Quaderni costituzionali, 2006, 92 ss. In quelloccasione prevalsero nei due schieramenti esasperazioni propagandiste. Da
sottolineare che il premierato riprendeva proposte fatte
proprie anche da partiti del centrosinistra (LIPPOLIS, Le
riforme istituzionali, cit., 116), con una particolare accentuazione di norme cosiddette antiribaltone volte ad evitare
cambiamenti di maggioranza in corso di legislatura, mentre
la devolution in realt correggeva alcuni eccessi del Titolo
V (ma la Lega present la riforma come una riforma finalmente federalista mentre il centrosinistra lanci lallarme
della possibile disgregazione dellunit del Paese). Comunque ampio, anche se non unanime, fu il rifiuto dei costituzionalisti: Costituzione, una riforma sbagliata. Il parere di
sessantatr costituzionalisti a cura di F. BASSANINI, Passigli,
Firenze, 2004.
(489) In Atti parl. Cam., XV legislatura, doc. n. 553 e
abb-A.
tuzionali raggiunge lAula (490), ma con un voto a
sorpresa (25 luglio 2012) viene approvato un
emendamento del centrodestra che introduce
lelezione diretta del Capo dello Stato, provocando cos il disimpegno del centrosinistra.
Nella XVII legislatura (2013-) che nella sua
fase iniziale aveva visto acuirsi la crisi per limpossibilit di dare vita ad un governo corrispondente
allesito del voto un largo schieramento a sostegno del Governo Letta (sollecitato dallo stesso
Capo dello Stato che a questo scopo incarica un
comitato di dieci saggi di operare un inventario
dei problemi aperti) manifesta il proposito di dare
vita ad un programma di riforme costituzionali ed
elettorali (mozioni del 29 maggio 2013: Camera
1-56; Senato 1-47), prevedendo a tal fine uno
speciale percorso parlamentare (491). Questo progetto sub i contraccolpi delluscita di una parte
dello schieramento di centrodestra dalla maggioranza che sosteneva il Governo Letta; ma si era
comunque prima scontrato con una violenta campagna di stampa, allarmata per le deroghe
invero assai modeste (492) alle procedure previste dallart. 138 cost. (493). Riusc a completare,
comunque, i propri lavori la Commissione istituita
dal Governo nel giugno 2013 (cosiddetta Commissione dei saggi, costituita da 35 studiosi rappresentativi di tutte le posizioni), che approv una
Relazione caratterizzata da un approccio coerente
e condiviso alle riforme della seconda parte della
Costituzione, anche se, andando nel merito, alcune proposte furono assunte allunanimit, per
altre (proprio in materia di forma di governo) fu
necessario prospettare soluzioni fra loro alternative (494). La scelta della maggioranza che ha dato
vita al Governo Renzi stata quella di mettere da
(490) In Atti parl. Cam., XVI legislatura, doc. n. 5386.
(491) Disegno di legge costituzionale recante Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali , presentato il 10 giugno 2013, in Atti parl. Sen., XVII
legislatura, doc. n. 813.
(492) Le deroghe riguardavano: la istituzione di una
Commissione bicamerale con poteri referenti (come quelle
gi varate, allora senza proteste, nel 1992 e nel 1996 per
listituzione e della Commissione De Mita-Iotti e della Commissione DAlema) da comporre, peraltro, in modo rigorosamente proporzionale, senza tenere conto del premio di
maggioranza conseguito dal partito di maggioranza relativa e
in pi prevedendo un referendum approvativo anche in caso
di votazione con maggioranza superiore ai due terzi. Veniva
inoltre ridotto lintervallo fra le due deliberazioni di ciascuna
Camera da 60 giorni a 40 (una fretta invero poco giustificata,
non meno sia consentito della forte opposizione
suscitata da questa abbreviazione).
(493) Cfr. per tutti PACE, La disapplicazione dellart.
138, cit., 2437 ss.
(494) Cfr. Ministero per le riforme costituzionali, Commissione per le riforme costituzionali, 17 settembre 2013,
347
Costituzione della Repubblica italiana
parte il tema della forma di governo e di limitarsi
ad avviare la riforma del bicameralismo paritario,
la revisione del Titolo V, la soppressione delle
Province e del Consiglio nazionale delleconomia e
del lavoro (CNEL), un percorso non ancora concluso nei giorni di questo scritto (495). Il Senato
della Repubblica, pur mantenendo la medesima
denominazione, viene trasformato in una Camera
formata da consiglieri eletti dai Consigli regionali e
da cinque personalit nominate dal Capo dello
Stato per sette anni. Il rapporto fiduciario viene
mantenuto in capo alla sola Camera dei deputati
mentre la funzione legislativa secondo un classico schema di bicameralismo ineguale viene
imperniata sul voto decisivo della Camera di diretta derivazione popolare, fatta eccezione per
talune funzioni, compresa la legislazione costituzionale, per le quali richiesta la deliberazione
paritaria. altres prevista una limitazione del
ricorso alla decretazione durgenza ma contemporaneamente la possibilit per il Governo di vedere
fissata a data certa la deliberazione di disegni di
legge urgenti. Significativo il parziale ritorno allo
schema della Costituzione del 1948 per quanto
concerne la distribuzione delle funzioni fra Stato e
Regioni, abolendo la legislazione di tipo concorrente ma ripristinando il limite dellinteresse
nazionale come presupposto per lattivazione, su
iniziativa del Governo, di una clausola generale di
preminenza della legislazione statale.
Nonostante le difficolt incontrate dai ripetuti
tentativi di riforme organiche, sono state ugualmente portate a compimento non poche puntuali
revisioni costituzionali (alcune ampiamente ricordate nelle pagine precedenti), che si sono mosse
nelle seguenti direzioni:
a) il superamento della diversa durata delle due
Camere e alcune modifiche sulla loro composizione (la l. cost. n. 2 del 1963 ha reso fisso il
numero di deputati e senatori, prima rapportato
alla popolazione; la l. cost. n. 3 del 1963 ha
equiparato a cinque anni la durata di Camera e
Senato; la l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 ha introdotto una rappresentanza in apposite circoscrizioni degli italiani residenti e votanti allestero);
b) la risposta alle ricorrenti domande di moralizzazione della vita politica (la l. cost. n. 1 del
Relazione finale, in Per una democrazia migliore (Presidenza
del Consiglio dei ministri), cit.
(495) Disegno di legge recante Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la
revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione , in Atti parl. Cam., XVII legislatura, doc. n. 2613-A.
348
1989, gi evocata, ha modificato lart. 96 cost.
abolendo la Commissione inquirente, la cui attivit aveva sollevato non poche polemiche per
taluni, veri o presunti, insabbiamenti di reati
ministeriali; la l. cost. n. 3 del 1993 ha soppresso
listituto dellautorizzazione a procedere per deputati e senatori; inoltre, onde evitare il troppo facile
ricorso ad istituti di clemenza, la l. cost. 6 marzo
1992, n. 1 ha previsto che lamnistia e lindulto
possano essere concessi solo con legge approvata a
maggioranza qualificata dei due terzi);
c) alcuni limitati aggiornamenti della prima
parte della Costituzione in materia di diritti civili
(la l. cost. 30 maggio 2003, n. 1 ha introdotto
nellart. 51 il principio delle pari opportunit
nellaccesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive; la l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ha cancellato la
pena di morte anche dalle leggi militari di guerra;
la l. cost. n. 2 del 1999 ha modificato lart. 111
introducendo vari istituti processuali, tutti improntati al principio del cosiddetto giusto processo);
d) il tentativo di dare risposta alle domande
federaliste, di rafforzamento delle Regioni (con
la l. cost. n. 1 del 1999 che ha modificato la forma
di governo regionale; e con la radicale riforma del
Titolo V, avvenuta con la l. cost. n. 3 del 2001);
e) la modifica della disciplina di bilancio (l.
cost. n. 1 del 2012) attraverso la revisione degli art.
81, 97, 119 cost. (e di una norma dellart. 117) che
ha introdotto il principio dellequilibrio di bilancio;
f) altri interventi pi limitati, infine, quali la l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2, che ridusse a nove
anni il mandato dei giudici costituzionali, e la l.
cost. 23 ottobre 2002, n. 1, che ha dichiarato
esauriti (senza cancellarli) gli effetti della XIII
disp. trans., relativa ai diritti politici dei membri di
casa Savoia (e dei loro discendenti).
Tranne la riforma del Titolo V approvata
con i soli voti della maggioranza di centrosinistra
tutte le riforme elencate sono state adottate a
larghissima maggioranza (inclusa la revisione della
XIII disposizione, che inizialmente aveva sollevato
molti contrasti, poi superati). Ma in nessun caso si
trattato di riforme che siano andate al cuore delle
questioni istituzionali. Eppure non sono mancate
nellultimo trentennio esortazioni e moniti dei Presidenti della Repubblica per passi pi coraggiosi,
da quelli particolarmente vivaci del Presidente
Cossiga a quelli del Presidente Scalfaro (in realt
solo allatto dellinsediamento), a quelli del Presidente Ciampi e a quelli frequenti e assai decisi del
Presidente Napolitano (culminati in uno sferzante
Costituzione della Repubblica italiana
discorso in occasione della rielezione e del giuramento a Camere riunite del 22 aprile 2013). Ancor
prima verano stati moniti, ed anche appositi messaggi, dei Presidenti Segni (17 settembre 1963) e
Leone (14 ottobre 1975) (496).
Perch tante difficolt nel procedere a incisive
riforme? Intanto perch non poche volte esse sono
state progettate in vista di obbiettivi politici di
breve periodo, che andavano al di l del merito
delle riforme stesse. Da qui la ricerca non tanto
della bont o della coerenza sistemica di questa o
quella soluzione istituzionale, ma della loro utilit
rispetto alle esigenze preminenti del cosiddetto
quadro politico, esigenze in genere contingenti di
partiti o coalizioni (e qualche volta di gruppi
allinterno dello stesso partito). Ad esempio la
grande riforma lanciata da Craxi (ne abbiamo
gi accennato perch avvi il dibattito sulle riforme) rest una parola dordine mai tradottasi in
proposte puntuali e si caratterizz come il tentativo di prospettare la rottura del bipolarismo consociativo (e imperfetto) fra comunisti e democristiani. Non a caso quel progetto fu in pratica
abbandonato allinizio degli anni Ottanta dopo la
scelta democristiana di riprendere la collaborazione con il PSI (nel febbraio 1980 con lapprovazione di un documento della Direzione DC conosciuto con il nome di preambolo) e di considerare superata la fase della solidariet nazionale.
Questo approccio, per lo pi strumentale, spiega i
disinvolti e subitanei passaggi delle singole forze
politiche da una soluzione istituzionale allaltra,
anche quando si trattasse di formule marcatamente diverse: per esempio, dalla grande riforma alla governabilit, dal cosiddetto premierato al sistema semi-presidenziale, dal maggioritario a doppio turno a sistemi proporzionali
con premio, dalle liste bloccate alle preferenze, dal federalismo al centralismo e al municipalismo.
(496) Entrambi i messaggi furono ignorati dalle Camere. Il messaggio di Segni era incentrato su un punto
specifico: il divieto di rieleggibilit del Presidente della
Repubblica e la conseguente abolizione del semestre
bianco. Il messaggio di Leone era incentrato su questioni
nel complesso marginali e nondimeno allepoca in grado di
provocare vivissime polemiche, soprattutto a seguito della
richiesta di dare attuazione agli art. 39 e 40 cost. con
riferimento allo sciopero nei pubblici servizi. Sulle polemiche suscitate da questultimo messaggio v. C. CEDERNA,
Giovanni Leone. La carriera di un Presidente, Feltrinelli,
Milano, 1978, 180 ss.; ivi, 177, le polemiche suscitate da
alcune interviste dello stesso Leone in cui era contenuta
laffermazione che a venticinque anni di distanza la Costituzione non poteva considerarsi intoccabile (in particolare
nellintervista a Il Giorno, 23 dicembre 1974).
Al di l delle contingenti strumentalizzazioni,
hanno altres frenato pi radicali incertezze di
cultura politica: sia allinterno dei gruppi dirigenti
dei partiti sia fra gli studiosi delle istituzioni. La
contrapposizione fra due strategie, che ha attraversato la discussione, venne ben riassunta sin
dalla Relazione di minoranza di Stefano Rodot
alla conclusione dei lavori della Commissione
Bozzi: da una parte la prioritaria attenzione ai
diritti civili, alla loro massima estensione e al
perfezionamento delle tecniche di tutela, alle garanzie, dallaltra una maggiore attenzione allorganizzazione dei poteri; da qui la attenzione degli
uni alla efficienza del sistema e la diffidenza e
lallarme degli altri per il tema della decisione
che tende a porre in posizione marginale la questione dei diritti (497). una contrapposizione a
nostro avviso incongruente ma tuttora ben presente, come ha dimostrato lesame parlamentare
della riforma del Senato proposta dal Governo
Renzi nel 2014. Mentre una parte della dottrina
giuridica e della cultura politica ritiene necessario
un adeguamento delle strutture di governo italiane
ai modelli delle principali democrazie, unaltra
parte ritiene opportuno mantenersi nel modello
(che sarebbe stato) tracciato dai Costituenti, ora
contestando i sistemi elettorali maggioritari, ora
richiedendo un anomalo bicameralismo di garanzia, ora contrastando il rafforzamento della figura
del Presidente del Consiglio, ora insistendo su
moduli assemblearistici. In particolare lipotesi di
avviare la forma di governo italiano verso modalit
di funzionamento pi vicine a quelle delle maggiori democrazie dellOccidente, riassumibili con
lespressione modello Westminster, rifiutata
da una lettura conservatrice. La rappresentanza,
cardine del costituzionalismo liberaldemocratico,
viene perseguita ricorrendo ad una statica rappresentazione delle opinioni politiche presenti
nella societ (se mai in vario modo corretta) laddove nelle altre democrazie occidentali, di ispirazione maggioritaria, la legittimazione politica deriva dal voto degli elettori a favore della pi forte
delle minoranze (498). La valorizzazione delle
leadership e le conseguenti forme di accountability
sono anchesse rifiutate dalle posizioni conservatrici perch anticamera di un decisionismo con(497) Atti della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, II, doc. XVI-bis, n. 3-bis, cit., p. 647.
(498) Riteniamo ancora valida la contrapposizione di
Maurice Duverger fra sistemi elettorali intesi come appareil
photographique [...] des opinions o come transformateur
[...] qui doit changer en dcisions politiques le prfrencens du
peuple : v. M. DUVERGER, La nostalgie de limpuissance,
Albin Michel, Paris, 1988, 72-73.
349
Costituzione della Repubblica italiana
siderato deteriore o di un ancor pi temuto presidenzialismo, tanto pi ove ritenuto suscettibile
di scivolamenti plebiscitari.
La Costituente aveva rifiutato espressamente di
costituzionalizzare il sistema elettorale proporzionale, ma lispirazione di fondo era certamente ancorata a tale sistema, meglio in grado di garantire gli
equilibri fra forze profondamente divise. Tuttavia i
referendum dellinizio degli anni Novanta, le sentenze della Corte di ammissibilit degli stessi e le
scelte legislative che ne conseguirono hanno consentito di allontanarsi da questa eredit, unevoluzione solo marginalmente messa in discussione
dalla citata sentenza del 2014 (499). Il progressivo
radicarsi, documentato in queste pagine, dei principi fondamentali della parte prima della Costituzione ha reso possibile un maggiore coraggio sulla
strada delle riforme. Ma lombra del tiranno riemerge periodicamente, impedisce le riforme e induce a non voler riconoscere al Governo italiano
ci che sarebbe normale nel raffronto con le altre
democrazie europee.
25. I vincoli europei, ovvero le metamorfosi
dellordinamento costituzionale. Mentre si accumulavano progetti e tentativi di riforma della
Carta costituzionale, in una logorante inconcludenza, procedevano profonde trasformazioni nellordinamento costituzionale, indotte dalla sempre
pi stretta integrazione europea, e da tumultuose
innovazioni culturali, captate, come si visto, non
tanto dalle istituzioni politiche quanto dalla giurisprudenza. Gli strumenti del giurista, costretto a
lavorare con le categorie della logica formale, non
sempre riescono a conoscere ci che in divenire.
Come sottolinea Sergio Bartole, nella nostra
scienza del diritto costituzionale manca lattrezzatura per cogliere i cambiamenti [...] intervenuti al
di fuori dellart. 138 (500). E in effetti, i tentativi
fin qui effettuati per cogliere i cambiamenti non
sempre appaiono convincenti. Ma, come scrive Hegel: una Costituzione , ma essa del pari essenzialmente diviene, cio progredisce nella formazione . Questo progredire, continuava, un
mutamento che non visibile, e non ha la forma del
mutamento [...] dopo lungo tempo, una costituzione giunge, a questo modo, ad una situazione del
tutto diversa dalla precedente (501).
(499) C. cost. 13 gennaio 2014, n. 1, cit.
(500) BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione, cit., 408-409, e v. anche 434.
(501) F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, trad.
it., Laterza, Roma-Bari, 1974 (nelle aggiunte ricavate dalle
lezioni compilate da E. Gans: n. 175 al 298), 448-449; v.
350
Non appare utilizzabile il concetto di transizione, cos come elaborato dalla politologia
che ha dato vita ad una nuova disciplina, la Transitology (502), ma in voga in questi anni anche
nella letteratura di diritto costituzionale (503)
perch presuppone un punto di partenza conosciuto ma anche un punto di arrivo altrettanto
conosciuto (o conoscibile). Abbiamo gi detto che
non c stato nessun passaggio ad una seconda
Repubblica n alcuna trasformazione in senso federale. Non stata toccata la forma di Stato,
mentre lordinamento costituzionale ha subito importanti trasformazioni, ma non un vero e proprio
mutamento. C stato, invece, il passaggio da un
primo sistema ad un secondo sistema di partiti, e
quindi ad un diverso sistema politico, tendenzialmente pi competitivo e meno consociativo,
che, peraltro, ha solo lambito, senza modificarla, la
forma di governo. Si pu parlare di una transizione politica, quindi, da un sistema politico ad
un altro, non di una transizione costituzionale,
riconducendo cos la categoria allambito della
scienza politica ma non escludendo quel metodo
combinatorio che ha alimentato la letteratura
francese (504).
anche, pi in generale, ID., Lezioni sulla filosofia della storia,
trad. it., La Nuova Italia, Firenze, 1947, 137 ss. ovvio
sottolineare il contesto in cui Hegel colloca quellaffermazione atteso che egli ritiene la Costituzione opera della
ragione e manifestazione dello Spirito. impossibile per
Hegel cercare linizio di un fenomeno costituente, che appartiene al ritmo processuale della storia, in cui negli stessi
punti cruciali, negata laristotelica identit, coincidono gli
opposti: il finire di essere di una Costituzione (non essere
pi) e il cominciare ad essere (ci che non ancora) della
nuova Costituzione: cfr. ID., La Costituzione della Germania,
in ID., Scritti storici e politici, trad. it., Roma-Bari, 1997, 7,
nella nota a margine.
Il cambiamento continuo delle Costituzioni uno
dei punti evidenziati da Carlo FUSARO e Dawn OLIVER, Towards a Theory of Constitutional Change, in How Constitutions Change a cura C. FUSARO e D. OLIVER, Hart Publishing,
Oxford, 2011, 424.
(502) P.C. SCHMITTER, Transitology: The Science or Art of
Democratization?, in The Consolidation of Democracy in
Latin America a cura di J.S. TULCHIN e B. ROMERO, Lynne
Rienner, Boulder, 1995, 11 ss.
(503) Cfr. V. TEOTONICO, Riflessioni sulle transizioni.
Contributo allo studio dei mutamenti costituzionali, in Rivista
AIC, www.rivistaaic.it, 2014, n. 3; A. SPADARO, La transizione
costituzionale. Ambiguit e polivalenza di unimportante nozione di teoria generale, in Studi in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi, II, Giappichelli, Torino, 2004; nonch G.
DE VERGOTTINI, Le transizioni costituzionali. Sviluppo e crisi
del costituzionalismo alla fine del XX secolo, Il Mulino,
Bologna, 1998; L. MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni
costituzionali e del consolidamento democratico, Cedam, Padova, 2003.
(504) Come uscire dalla transizione a cura di S. CECCANTI
e S. VASSALLO, Il Mulino, Bologna, 2004; v. anche per un
Costituzione della Repubblica italiana
Pi utilizzabile lantico concetto di modifiche
tacite (505)? Tali modifiche potrebbero individuarsi, come viene sottolineato in letteratura, laddove, rimanendo immutato (o pressoch tale) il
testo costituzionale, si dovesse verificare il mutamento di importanti assetti normativi per effetto
della giurisprudenza, dellattivit interpretativa,
dei comportamenti dei soggetti politici e dei mutamenti intervenuti nel sistema politico. La risposta non facile ed comunque necessaria una
duplice avvertenza: per un verso tali modifiche
sono difficili da mettere a fuoco rispetto alla fisiologica elasticit di una Costituzione, pur rigida;
per un altro verso le consuete distinzioni fra trasformazioni nella Costituzione ma non della Costituzione; fra modifiche infra-sistemiche e modifiche extra-sistemiche; fra riforme-adeguamento e
riforme-cambiamento appaiono riproporre da diversi angoli visuali il problema pi che risolverlo.
Tali categorie appaiono non in grado di riuscire a
descrivere una fenomenologia ampiamente differenziata (506) e poco utili per una impostazione, come quella da noi considerata, che pone
laccento non solo sul testo costituzionale ma sul
pi ampio ordinamento costituzionale. I vincoli
europei, come diremo, hanno modificato lordinamento costituzionale in profondit ma hanno solo
sfiorato il testo della Carta costituzionale.
Il tema comunque non merita di essere enfatizzato. La Costituzione italiana, come accade a
tutti gli organismi vitali, tuttora (anzi, come
abbiamo cercato di dimostrare in queste pagine, lo
ancora pi di prima) lelemento di coesione di
una comune cittadinanza, proprio perch ha surapido panorama delle tendenze del periodo M. OLIVETTI, La
transizione continua, in Quaderni costituzionali, 2001, 620
ss.; sul metodo combinatorio v. S. CECCANTI, Maurice
Duverger e il metodo combinatorio: una lezione ancora valida,
ivi, 2015, 227 ss.
(505) La categoria ampiamente utilizzata: v. G. GUARINO, Pubblico e privato nelleconomia. La sovranit fra costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quaderni costituzionali,
1992, 32, nonch ID., Lerosione della sovranit nazionale, in
Rass. parl., 1998, 430 ss.; F. PIERANDREI, La Corte costituzionale e le modificazioni tacite della Costituzione, ora in ID.,
Scritti di diritto costituzionale, I, Giappichelli, Torino, 1965,
137 ss. ed ivi letteratura citata; TOSI, Modificazioni tacite della
Costituzione, cit. Dette modifiche sono state collegate anche
alla elasticit di un testo: v. L. ROSSI, La elasticit dello
Statuto italiano, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano,
I, cit., 28 ss.; G. CHIARELLI, Elasticit della Costituzione, in
Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, cit.,
43 ss. La categoria utilizzata da M. LUCIANI, Governo (forme
di), in questa Enciclopedia, Annali, III, 2010, 593 s., per
traducendola con lespressione sfigurazione.
(506) Cos, anche in riferimento ad una opinione di
Crisafulli, S. GALEOTTI, Alla ricerca della governabilit, Giuffr, Milano, 1983, 314 ss.
bito quei processi di metamorfosi che consentono a tutti gli organismi attraversati da un soffio
vitale di sopravvivere adattandosi alla realt (507).
Il testo costituzionale del 1948 continua ad essere
il nucleo essenziale dellordinamento costituzionale italiano ma di un ordinamento in continua e
profonda trasformazione (508). Tale trasformazione non deriva solo dalle modificazioni dei regolamenti parlamentari, dalle leggi elettorali intervenute, da alcune revisioni costituzionali e dalla
perseverante giurisprudenza della Corte costituzionale, ma soprattutto dallingresso dellItalia nellordinamento europeo e dallassunzione di limiti
sempre pi penetranti al di fuori, peraltro, delle
procedure previste dallart. 138 cost.
Come noto, nel tentativo di rafforzare principi e valori nello Stato costituzionale si va al di l
della tradizionale rigidit delle Costituzioni liberali e si introducono limiti assoluti le cosiddette clausole di eternit alla possibilit
stessa di revisione costituzionale. Cos ha deciso la
Corte italiana nella gi citata decisione degli anni
Ottanta (509) e cos si orienta la dottrina italiana,
attentissima custode delle procedure previste dallart. 138 cost. e dei limiti sostanziali che comunque esse garantiscono. Le revisioni intervenute e
(507) Nella letteratura tedesca le espressioni di solito
usate sono Verwandlung o Vernderung; il primo nel linguaggio letterario indica i processi di metamorfosi (si
pensi alla nota opera di Franz Kafka) o di trasformazione,
il secondo nel linguaggio giuridico indica per lo pi le
modificazioni espresse. La prima espressione solo con
qualche forzatura traducibile con lespressione modifica
tacita: v. per esempio G. JELLINEK, Verfassungsnderung
und Verfassungswandlung. Eine staatsrechtliche-politische
Abhandlung, Verlag von Hring, Berlin, 1906 (poi Keip
Verlag, Goldbach, 1996), 19 ss. (trad. it. parziale di M.
CARDUCCI, Mutamento e riforma costituzionale, Pensa Editore, Cavallino-Lecce, 2004, 23 ss.).
Quanti avrebbero mai pensato al momento della sottoscrizione dei Trattati fondativi, mezzo secolo fa, che le
istituzioni europee si sarebbero occupate non solo della
libera circolazione delle merci, dei capitali e dei lavoratori
ma anche della pretesa di due cittadini britannici di vedere
riconosciuti i diritti pensionistici conseguenti al mutamento
della propria identit sessuale o, addirittura, della pretesa di
Tanja Kreil di contestare con successo la propria Costituzione che le impediva di prestare servizio militare in armi?
Per questultimo caso v. C. giust. CE 11 gennaio 2000, causa
C-285/98, Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland; per il
primo C. giust. CE 27 aprile 2006, causa C-423/04, Sarah
Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions.
(508) Ha utilizzato la categoria della trasformazione
costituzionale con riferimento alla storia costituzionale
della Repubblica M. FIORAVANTI, Le due trasformazioni costituzionali dellet repubblicana, in La Costituzione ieri e oggi
(Atti del Convegno, Roma, Accademia nazionale dei Lincei,
9-10 gennaio 2008), Bardi, Roma, 2009, 21 ss.
(509) C. cost. 29 dicembre 1988, n. 1146, cit.
351
Costituzione della Repubblica italiana
quelle progettate hanno rispettato tali limiti. Ma le
trasformazioni di gran lunga pi incisive della
Costituzione tanto da fare pensare ad una
metamorfosi della stessa sono avvenute al di
fuori delle procedure dellart. 138 cost., debolmente agganciandosi allart. 11 cost., nato per ben
altri fini. Solo nel 2001 la pi volte citata l. cost. n.
3, che ha modificato lart. 117 del Titolo V, ha
fatto per la prima volta riferimento con norma
costituzionale allUnione europea, e ai vincoli derivanti dagli obblighi assunti dallItalia con ladesione alla stessa. Ma gi prima di tale riforma e con
legge ordinaria erano stati assunti obblighi sempre
pi stringenti, a partire dalla ratifica dei Trattati
degli anni Cinquanta istitutivi delle tre Comunit
europee, con lAtto unico europeo (1986), con il
Trattato di Maastricht (1992), che fece nascere
lUnione e dette il via alla moneta comune, seguito
da quello di Amsterdam (1997), da quello di Nizza
(2001) e da quello di Lisbona (2007).
A differenza di altri Paesi che avevano provveduto alla ratifica di tali Trattati con leggi costituzionali e alle conseguenti modifiche del testo costituzionale (in alcuni casi precedute da consultazioni referendarie), lItalia ha sempre seguito la
strada della legislazione ordinaria. Sotto questo
profilo, il riferimento a modifiche tacite (o meglio
a deroghe tacite) della Costituzione non sarebbe
stato del tutto fuori luogo. In occasione della
ratifica del Trattato di Parigi del 1951 che dava
vita alla Comunit europea del carbone e dellacciaio (la CECA, cui lItalia ader con la l. 25 giugno
1952, n. 766) il Parlamento italiano aveva respinto
le richieste delle opposizioni, orientate alluso
della legge costituzionale: posizione ribadita in
occasione della ratifica dei Trattati di Roma del
1957 istitutivi della Comunit economica europea
e della Comunit europea dellenergia atomica
(CEE e CEEA: l. 14 ottobre 1957, n. 1203). Gli
interventi in Parlamento a favore della legislazione
ordinaria (per la quale si spesero nel 1952 sia il
Presidente del Consiglio De Gasperi sia i relatori
Ambrosini e Montini) si basavano sullapertura
alle organizzazioni sovranazionali contenuta nellart. 11 cost. Al di l delle motivazioni, prevalente
era il timore che, in assenza di una legislazione sul
referendum costituzionale (sarebbe stata varata,
come si visto, solo nel 1970), e dovendo ricorrere
alla maggioranza dei due terzi, lapprovazione
dello strumento di ratifica sarebbe stato reso impossibile a causa dellopposizione allintegrazione
europea dei gruppi parlamentari della destra e
della sinistra. Allinizio degli anni Ottanta, nellambito della Commissione Bozzi, le basi mate-
352
riali della costruzione europea erano gi in via di
consolidamento ma non tutti accettarono che si
sancisse in Costituzione il primato del diritto europeo, sancito invece qualche mese dopo dalla
Corte costituzionale (510). Nel complesso in quella
Commissione, nel Parlamento e tra i costituzionalisti (attenti allora ad aspetti marginali) continuava
quella disattenzione che Livio Paladin avr modo
di denunciare alcuni anni dopo, quasi che il Trattato non incidesse sullordinamento costituzionale
e sullintero sistema normativo dello Stato italiano (511).
I riflessi sullordinamento costituzionale dei
Trattati fondativi sono invece stati assai rilevanti e
numerosi. Per quanto riguarda lesercizio della
funzione legislativa basti ricordare lingresso diretto della normativa comunitaria: sia dei Trattati,
sia dei regolamenti, sia delle decisioni con
incalzante progressione dal 1963 con la sentenza
Van Gend en Loos (512) , ma talvolta anche
di talune direttive (513). Tutto ci sia in deroga
allart. 70 cost., che assegna la funzione legislativa
alle due Camere, sia in deroga alle competenze
legislative regionali. Per quanto riguarda le funzioni giurisdizionali, basta richiamare le competenze assegnate alla Corte di giustizia, in deroga
allesercizio delle funzioni giudiziarie in nome del
popolo italiano cui si riferisce lart. 101 cost.; non
solo stato affermato il carattere direttamente
vincolante delle sentenze della Corte di giustizia (514) ma, per effetto del cosiddetto rinvio
pregiudiziale, la Corte di giustizia si assunta il
compito, di fatto, di conformare anche il diritto
italiano attraverso la propria interpretazione del
diritto europeo (in pratica una funzione nomofilattica della Corte di giustizia). Funzione questa
che ebbe a disorientare gli schemi tradizionali
tanto da spingere taluni autori, in tempi fra loro
ravvicinati, a considerare la Corte di giustizia nellesercizio di tale funzione o come giudice nazionale o allopposto come giudice europeo chiamato
a giudicare gli Stati nazionali quali agenti esecutivi delle comunit (515).
(510) C. cost. 8 giugno 1984, n. 170, cit.
(511) L. PALADIN, Per una storia costituzionale dellItalia
repubblicana, Il Mulino, Bologna, 2004, 157.
(512) C. giust. CE 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van
Gend en Loos c. Ministero Finanze olandese.
(513) Per esempio, con C. giust. CE 19 novembre 1991,
causa C-6/90, Francovich c. Repubblica italiana, che ha
riconosciuto il risarcimento dei danni per la mancata attuazione di una direttiva.
(514) C. giust. CE 6 ottobre 1970, causa 9/70, Franz
Grad c. Finanzamt.
(515) una notazione di Benedetto CONFORTI, La dot-
Costituzione della Repubblica italiana
A ci si sarebbe progressivamente aggiunto il
primato del diritto europeo, non espressamente
sancito dai Trattati fondativi, ma costruito dalla
Corte di giustizia europea a partire dalla sentenza
Costa c. Enel (516). Non a caso la giurisprudenza della Corte costituzionale fu inizialmente
contraria a tale orientamento, prima collocando
sullo stesso piano le due fonti, quella europea e
quella nazionale (517) e adottando il criterio cronologico per la risoluzione delle eventuali antinomie, poi riservando a s la valutazione delleventuale contrasto fra le due normative (518). Soltanto nel 1984 con la sentenza Granital (519),
e nellindifferenza del Parlamento, dopo un conflitto con la Corte di giustizia intervenuta nuovamente con la sentenza Simmenthal (520) ,
la Corte costituzionale italiana ha accettato il principio della prevalenza del diritto comunitario e la
conseguente non applicazione del diritto italiano contrastante.
Successivamente, dal Trattato di Maastricht in
poi, si sarebbero aggiunte le deroghe alla (anzi la
privazione della) sovranit monetaria richiamata
dalle funzioni nazionali in materia di credito e
risparmio fissate dallart. 47 cost. Alle modifiche
costituzionali in particolare degli art. 81, 97,
117 e 119 si sarebbe giunti solo con la l. cost. n.
1 del 2012: con rinvio ai vincoli dellUnione europea come parametro di riferimento ai fini dellequilibrio dei bilanci e della sostenibilit del
debito pubblico. I vincoli ai bilanci delle pubbliche amministrazioni, nazionali e territoriali, anzi,
per effetto degli Accordi e delle normative europee successivamente intervenute, tra il 2011 e il
2012 (Europlus, six Pack, Fiscal Compact), non
sono pi frutto di decisioni nazionali, sia pure in
forza di obblighi europei: il legislatore italiano li
riceve dallUnione europea per effetto diretto dei
trina di diritto comunitario: questa sconosciuta, in Dir. Un.
eur., 2004, 2, riferita alle opposte tesi di Gaetano Morelli e
Giuseppe Barile (la tesi di G. MORELLI in La Corte di giustizia
delle comunit europee come Giudice interno, in Riv. dir.
intern., 1958, 3 ss.).
(516) C. giust. CE 15 luglio 1964, causa 6/64. The law
of the Union takes precedence over the Law of the member
States : questa formula stata uno degli strumenti per la
costruzione della Federazione Nordamericana. Interessanti
considerazioni in G. AZZARITI, Verso un governo dei Giudici?
Il ruolo dei giudici comunitari nella costruzione dellEuropa
politica, in Scritti in onore di Alessandro Pace, Editoriale
scientifica, Napoli, 2012, 367 ss.
(517) C. cost. 7 marzo 1964, n. 14.
(518) C. cost. 30 ottobre 1975, n. 232.
(519) C. cost. 8 giugno 1984, n. 170, cit.
(520) C. giust. CE 9 marzo 1978, causa 106/77.
nuovi vincoli costituzionali (521). Non sono trascurabili i riflessi sulla stessa forma di governo,
atteso lindebolimento della funzione del Parlamento e della collegialit del Governo e il conseguente rafforzamento della figura del Presidente
del Consiglio e del Ministro delleconomia, chiamati a partecipare alle deliberazioni dei pi importanti Consigli europei (522). Inoltre, sempre
per effetto diretto o indiretto dei vincoli europei,
gli anni Novanta sono stati caratterizzati sia da
incisive politiche di privatizzazione del settore
pubblico delleconomia (soprattutto ad opera dei
Governi Amato e Prodi) in implicita controtendenza con quanto reso possibile dallart. 43 cost.,
sia dallingresso di Autorit indipendenti, italiane
ed europee, sconosciute al modello costituzionale (523).
Di questi progressivi slittamenti federalizzanti stata consapevole la Corte costituzionale
italiana sia attraverso le resistenze iniziali cui
prima ci riferivamo sia con la individuazione dei
cos detti controlimiti nei confronti anche del
diritto europeo (524) sia con lautoesclusione, durata molti anni, dal dialogo con la Corte di giustizia e con la scelta di non utilizzare il rinvio pregiudiziale di una questione a questultima (525).
Tali indugi erano probabilmente da attribuirsi al
timore che lorgano cui concessa lultima parola,
estraneo allordinamento costituzionale italiano,
finisse con lassumere una posizione in certa misura preminente alla stessa Corte italiana.
Si deve giungere alla conclusione che siamo di
fronte ad un ulteriore trasferimento di sovranit
o solo di fronte ad una mera ridefinizione della
sovranit (526)? Di trasferimento di sovranit si
pu discutere qualora il soggetto destinatario della
stessa possa considerarsi esso stesso sovrano ma
le istituzioni comunitarie non hanno la possibilit
(521) Cfr. GIUPPONI, Il principio costituzionale dellequilibrio di bilancio, cit., 51 ss.
(522) V., da ultimo, E. RAFFIOTTA, Il governo multilivello
delleconomia. Studio sulle trasformazioni dello stato costituzionale in Europa, Bononia University Press, Bologna, 2013,
31 ss.
(523) Si parlato di una costituzione ormai silenziosa (CALISE, La costituzione silenziosa, cit., 33 ss.).
(524) Dopo C. cost. 8 giugno 1984, n. 170, cit., soprattutto con C. cost. 21 aprile 1989, n. 232.
(525) Vi acceder solo con le ordinanze C. cost. 15
aprile 2008, n. 103, e C. cost. 18 luglio 2013, n. 207.
(526) La risposta in senso positivo alla prima domanda
di R. BIFULCO, Jefferson, Madison e il momento costituzionale dellUnione. A proposito della riforma costituzionale
sullequilibrio di bilancio, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it,
2012, n. 2. Il riferimento alla mera ridefinizione di
BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione,
cit., 288 ss.
353
Costituzione della Repubblica italiana
di procedere alla revisione del loro diritto costituzionale, neanche nei suoi aspetti marginali; non
si verificato quel distacco che in altre circostanze
ha fatto trasmigrare il potere costituente dagli Stati
a una nuova entit istituzionale. Tuttavia i sintomi
che hanno portato nel passato una parte della
dottrina e la stessa Corte di giustizia a definire i
Trattati come fonte di un vero e proprio diritto
costituzionale europeo (527) si sono senza dubbio
accentuati: la prevalenza del diritto comunitario si
affermata in modo deciso ed estesa a settori
sempre pi ampi, mentre le istituzioni comunitarie
hanno acquistato sempre maggiore rilevanza, inserendosi in una struttura che ha assunto le caratteristiche proprie delle organizzazioni politico-statuali. In taluni casi, peraltro, alla limitazione di
sovranit nazionale non corrisponde una simmetrica assunzione di responsabilit europea. Lasciamo da parte pur importanti discussioni, tuttora aperte, sulla separazione o meno fra lordinamento italiano e quello europeo (ovvero sulla
legittima sopravvivenza della teoria cosiddetta
dualista) e torniamo a una delle domande prima
poste: pu dirsi che, per effetto delle incisive
innovazioni indotte dalladesione allUnione europea, siamo di fronte ad una trasformazione della
Costituzione italiana? La risposta non semplice
sia perch la stessa Costituzione ad aprire
lordinamento ai vincoli derivanti dalla partecipazione a organizzazioni sovranazionali (art. 11) sia
perch in alcuni casi le stesse formule costituzionali si prestano a letture diverse.
Quanto questo processo abbia portato a modifiche delle Costituzioni nazionali , peraltro, argomento che non riguarda solo lItalia. accaduto
ad altri ordinamenti costituzionali dellUnione che
proprio per questo hanno fatto ricorso al recepimento dei Trattati europei con leggi costituzionali
o addirittura con revisioni costituzionali o sottopongono gli obblighi assunti ad uno scrutinio
rigoroso delle proprie Corti, come si vede bene
dalla occhiuta giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht.
Accanto agli obblighi comunitari, la riforma
del 2001 introdusse anche i vincoli derivanti dagli
obblighi internazionali, previsti senza unadeguata riflessione e preparazione in letteratura e
senza un approfondito dibattito parlamentare (528). Si andati cos al di l delladegua(527) Rinviamo a A. BARBERA, Esiste gi una Costituzione
europea?, in Quaderni costituzionali, 2000, 59 ss., ma anche
a ID., Corte costituzionale e Giudici di fronte ai vincoli
europei: una ridefinizione dei confini?, ivi, 2007, 335 ss.
(528) Come subito ebbe modo di sottolineare Massimo
354
mento al diritto internazionale generale quindi consuetudinario previsto dallart. 10 della
Costituzione del 48, assai avanzato per lepoca
(ripreso dalle sfortunate Costituzioni di Weimar e
della seconda repubblica spagnola), che ha consentito alla Corte italiana lo abbiamo visto nelle
precedenti pagine di dare forza sub-costituzionale alle Convenzioni di tutela dei diritti,
in particolare alla Convenzione europea per la
protezione dei diritti delluomo e, quindi, forza
vincolante alle sentenze della Corte di Strasburgo (529).
26. Una Costituzione a virtualit multiple.
Come abbiamo cercato di evidenziare in questo scritto, i principi costituzionali si sono irrobustiti in questi ultimi decenni. Costituiscono ormai
un patrimonio comune anche se talvolta diversamente declinato sempre pi radicato nella
coscienza degli italiani grazie alla maturazione e
trasformazione delle culture politiche che erano
state (e sono) alla base del testo costituzionale. Un
processo evolutivo non sempre facile n scontato
ma nel tempo sempre pi deciso. La Carta costituzionale rimane un punto di riferimento ed un
ricco giacimento di valori e di principi che danno
identit alla Repubblica: lantifascismo della Costituzione ormai accettato anche da quanti per
anni si sono richiamati al vecchio regime; sono alle
nostre spalle le riserve di chi guardava a modelli di
democrazia sostanziale diversi da quelli del costituzionalismo liberaldemocratico; non riescono a
compiere passi convincenti quanti puntano a confusi modelli di democrazia diretta alternativi ai
LUCIANI, Camicia di forza federale, in La Stampa, 3 marzo
2001, nonch ID., Le nuove competenze legislative delle
Regioni a statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della l. cost. n. 3 del 2001 (Relazione
al Convegno su Il nuovo Titolo V della Costituzione.
Lo Stato delle autonomie , Roma, 19 dicembre 2001), in
www.associazionedeicostituzionalisti.it.
(529) La svolta effettuata con le dette decisioni si collega ad analoga svolta negli stessi anni nei confronti della
Corte europea dei diritti delluomo con le sentenze cosiddette gemelle C. cost. 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349,
cit. nonch con C. cost. 4 dicembre 2009, n. 317, cit., e C.
cost. 7 aprile 2011, n. 113 (questultima dichiara la illegittimit costituzionale dellart. 360 c.p.p. nella parte in cui
non prevede un diverso caso di revisione della sentenza
penale di condanna o del decreto penale, al fine di conseguire la riapertura del processo quando ci sia necessario per
conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea
dei diritti delluomo). Cfr. per la successiva sentenza C.
cost. 26 marzo 2015, n. 49, con cui la Corte ha sottolineato
che va in ogni caso rispettata la superiorit assiologica
della Costituzione italiana.
Costituzione della Repubblica italiana
modelli costituzionali (530); il principio dellunit
e indivisibilit della Repubblica ha resistito con
successo a insidiosi attacchi mentre si consolidato il principio autonomista dellart. 5 cost.; il
principio di laicit non solo accomuna ormai cattolici e laici ma appare oggi un punto di forza per
un non facile incontro con altre fedi e culture
mentre i principi pluralisti riescono a superare le
prove cui sottoposta la societ italiana soprattutto nelle periferie metropolitane per effetto
delle pressioni multietniche. Si aggiunga che le
libert costituzionali appartengono ormai al vissuto della societ italiana e sono ulteriormente
arricchite dalla giurisprudenza delle Corti europee; leguaglianza di genere si afferma sempre pi
e va ormai al di l del mero divieto di discriminazioni di cui allart. 3 cost. Sempre al di l dello
stesso testo costituzionale cresciuta la dimensione universalistica di fondamentali diritti sociali in sintonia con le declinazioni orizzontali del
principio di sussidiariet. A letture non sempre
coincidenti sono sottoposti vero i diritti del
lavoro, ma non tali da suscitare, oggi, laceranti
conflitti di valori costituzionali. Il principio pacifista, pur non sempre letto in modo univoco in
occasione dei ripetuti interventi militari che hanno
impegnato lItalia, riuscito, con larghi voti parlamentari, ad ancorarsi alle regole delle Carte internazionali (531). Il processo di integrazione europea, pur estraneo allimmaginario dei Costituenti, rimane un obbiettivo comune anche se i
conflitti sulle politiche europee rappresentano
oggi il pi rilevante cleavage politico.
La Carta del 48 continua dunque a costituire
memoria e progetto della Nazione; continua ad alimentare un credo repubblicano (532).
(530) Sia nelle tradizionali forme assembleari, sia in
quelle cosiddette deliberative, sia in quelle del web.
(531) Due tuttavia le letture dellart. 11 cost.: la prima,
maggioritaria, volta a non escludere interventi militari se
decisi dalle organizzazioni internazionali cui lItalia partecipa, in particolare lONU; laltra, pi radicale, contraria
comunque ad ogni intervento armato che non sia strettamente volto alla difesa del territorio italiano. Il conflitto fra
le due posizioni ebbe modo di manifestarsi in occasione
della prima guerra del Golfo, nel 1991, approvata da una
larga maggioranza parlamentare perch decisa dalle Nazioni
Unite ma contrastata da una agguerrita minoranza, che, forte
di una diversa lettura della norma costituzionale, era contraria comunque ad un intervento non meramente difensivo dei
nostri confini. Il conflitto lacer la politica italiana ed ebbe
modo di manifestarsi sulle piazze. Sul punto M. FIORILLO,
Guerra e diritto, Laterza, Roma-Bari, 2009, 91 ss.; fu allora
oggetto di discussione il volume di M. WALZER, Guerre giuste
e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche,
trad. it., Liguori, Napoli, 1990.
(532) ALLEGRETTI, Storia costituzionale italiana, cit., 130.
Assai difficilmente, tuttavia, potr costituire la base
per quel programma di riforme su cui la Costituente aveva inizialmente puntato: vissuta sempre meno come indirizzo e sempre pi come garanzia (533). Per quanto affascinante, non pare
convincente, infatti, lo sforzo di rivisitare e rilanciare il programma originario di politica economica e sociale del Costituente (534): oggi di interesse noi crediamo pi dello storico che del
giurista. Ma la Carta non solo un deposito di
valori a disposizione dei giudici; anche il legislatore pu (anzi deve) sfruttare lancora importante
giacimento di risorse programmatiche contenuto
nei vari articoli della Costituzione e non ancora
pienamente utilizzato o fin qui messo in ombra (un
esempio per tutti nellart. 34: il diritto allo studio
per capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi ).
Va tuttavia tenuto presente che questa Carta costituzionale, fin dagli anni in cui fu varato il testo, ha
dimostrato di essere compatibile con le diverse
politiche economiche e sociali di cui sono state
portatrici maggioranze fra loro diverse, e in particolare le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra che si sono alternate nellultimo ventennio. Il
dubbio sulla compatibilit fra la Costituzione e i
valori del tempo presente viene posto partendo dal
contenuto programmatico di alcune norme costituzionali (535) ma trascurando che gli obbiettivi
indicati dalla Costituzione sono stati volutamente
mantenuti a maglie larghe. vero: il mercato, che
caratterizza per tanta parte il processo di integra(533) FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale, cit.,
299. Nei primi decenni di vita della Costituzione si parlava
di Costituzione-programma: v. per tutti T. MARTINES,
Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale, in
Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, III, Milano, 1978, 805
ss. Contrario allenfatizzazione degli aspetti programmatici
G. REBUFFA, La costituzione impossibile, Il Mulino, Bologna,
1994, 20 ss.
(534) Lo hanno fatto da ultimo, in modo accurato,
ALLEGRETTI, op. ult. cit., 167 ss. e 239 ss., e M. LUCIANI, Unit
nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in Costituzionalismo e Costituzione nella
vicenda unitaria italiana (Atti del XXVI Convegno annuale
dellAssociazione italiana dei costituzionalisti, Torino, 27-29
ottobre 2011), Jovene, Napoli, 2014 (la Relazione consultabile in www.associazionedeicostituzionalisti.it), nonch S.
RODOT, Solidariet. Unutopia necessaria, Laterza, RomaBari, 2014, 128 ss. Legata ad una fase in cui era ancora
possibile parlare di un programma costituzionale, da attuare e sviluppare, era la funzione di indirizzo politicocostituzionale individuata da P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, e da G.
MARANINI, La posizione della Corte e dellautorit giudiziaria
in confronto allindirizzo politico di regime (o costituzionale)
e allindirizzo politico di maggioranza, in La giustizia costituzionale a cura di G. MARANINI, Vallecchi, Firenze, 1966.
(535) V. per esempio RESCIGNO, A proposito di prima e di
seconda repubblica, cit., 20 ss., ma opinione non isolata.
355
Costituzione della Repubblica italiana
zione europea (ne abbiamo parlato supra, nel 25),
non espressamente considerato dal Costituente
che ebbe sul punto una posizione ambigua
ma non pu dirsi che esso sia del tutto ignorato,
essendo, almeno in una sua forma essenziale, uno
dei valori posti alla base della libert di iniziativa
economica tutelata dallart. 41 cost. (536). Quel che
la Costituzione non consente che il mercato sia
privo di regole e la sua pretesa sovranit venga
opposta, come invalicabile, alla sovranit popolare,
laddove questa sia chiamata ad attuare principi e
valori costituzionali. Spesso lo si trascura, ma essa
fu votata sia da un socialista radicale come Lelio
Basso sia da un liberale come Luigi Einaudi, sia dal
solidarista Giorgio La Pira sia dal liberista Epicarmo Corbino, sia dal comunista Concetto Marchesi sia dal liberale Benedetto Croce; fu votata da
Giuseppe Dossetti ma fu anche attivamente ispirata
da Luigi Sturzo che pur della Costituente non
faceva parte (537) , cattolici entrambi ma portatori di divergenti concezioni del rapporto fra ispirazione religiosa e attivit politica. I Costituenti
furono concordi nel fissare fondamentali regole e
valori comuni ma altrettanto concordi da qui
talune disposizioni volutamente elastiche nel
tenere aperta la possibilit di perseguire indirizzi di
politica economica e sociale fra loro alternativi,
destinati a prevalere di volta in volta secondo le
scelte operate dagli elettori. Ma nel contempo fissarono limiti invalicabili, che avrebbero reso impercorribili sia politiche stataliste che dovessero
mettere in discussione le libert economiche, sia
politiche liberiste che fossero in contraddizione
con gli obbiettivi fissati negli art. 3 comma 2, 4 e 41
cost. In breve: fu adottato quel modello di economia sociale di mercato, la cui formula altre
Costituzioni hanno espressamente scolpito nel testo costituzionale (538). Mentre nessuna importante forza politica contesta pi il valore del mercato e della libert di impresa, lo sconquasso dei
mercati finanziari di questi anni sta, anzi, facendo
recuperare il valore della politica, di quelle regole
per il governo delleconomia che sono richiamate
(536) G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in Quaderni costituzionali, 1992, 7 ss., che non trascura tuttavia
dubbi e diffidenze tra i Costituenti, messi invece in maggior
risalto da LUCIANI, op. ult. cit.
(537) Lapporto di Sturzo ai lavori della Costituente,
prima sottovalutato, messo in luce in I cattolici democratici
e la Costituzione a cura di ANTONETTI, DE SIERVO e MALGERI,
cit.
(538) invece nota la critica, dalla sinistra radicale, allo
Stato assistenziale, in quanto ritenuto altra faccia del
capitalismo: in tal senso il volume di J. OCONNOR, La crisi
fiscale dello Stato, trad. it., Einaudi, Torino, 1979.
356
nel testo costituzionale (e nel costituzionalismo del
Novecento) e che unaggressiva ideologia liberista
tendeva a considerare un rottame ideologico del
passato. Leclettismo politico e culturale di cui
sono espressione i principi della Costituzione del
48 non si sono rivelati, alla fine, un limite ma hanno
consentito, al contrario, di non subire i contraccolpi della crisi delle tradizionali ideologie politiche
ed economiche.
Le trasformazioni intervenute, sollecitate dalla
sempre pi stretta integrazione sovranazionale,
pur incidendo sui lineamenti della Carta costituzionale, ne hanno progressivamente messo in luce
i caratteri europei. Lintegrazione europea dicevamo prima non era fra gli obbiettivi della
Costituente ma ad essa era ben presente lidentit
europea, quella identit che ha alimentato in tutto
lOccidente il costituzionalismo liberaldemocratico. Nonostante tale stretto collegamento per anni
si sono marcate pretese diversit, basate su invecchiati stereotipi. Diversit talvolta fondate, ma
spesso enfatizzate (539). Si voleva mantenere il
mito di una Costituzione atipica, frutto di una
diversit positiva dellItalia. Fu alimentato per i
primi decenni di vita repubblicana sia dalla sinistra, che vedeva nella Costituzione la base per la
ricerca di una terza via fra le socialdemocrazie e
i regimi comunisti, sia dalla cultura cattolico-democratica, che vedeva nelle istituzioni dello Stato
cui fino ad allora era rimasta estranea le leve
necessarie per guidare i processi economici secondo impostazioni solidaristiche (e inoltre coglieva loccasione per recuperare quei diritti di
libert che il Sillabo di Pio IX aveva combattuto
sul piano teorico e che la compromissione con il
fascismo aveva reso problematici). Quel mito
aveva alle spalle ragioni politicamente alte ma
oggi alimentato da chi teme ogni intervento riformatore, cos trasferendo le indubbie virt della
parte relativa ai principi a quelle parti dellorga(539) Fino a trascurare che in Italia i principi del costituzionalismo liberaldemocratico europeo avevano gi iniziato il loro cammino con il Risorgimento, che fu insieme
lotta per lunit dItalia e lotta per la Costituzione (non
solo nel Piemonte ma anche, con minore fortuna, negli altri
Stati preunitari). Interrottosi il cammino con la dittatura
fascista, tali principi avevano ripreso vigore con la lotta di
liberazione nazionale, non a caso definita un Secondo
Risorgimento, che port con la convocazione dellAssemblea costituente alla realizzazione di un obbiettivo fallito al
momento della unificazione sotto la dinastia sabauda. La
presenza di partiti fortemente ancorati nelle masse popolari
avrebbe colmato la debolezza del processo risorgimentale,
non impropriamente definito da Antonio Gramsci rivoluzione senza masse, e avrebbe portato le stesse, per la prima
volta, non a combattere ma a rinnovare lo Stato.
Costituzione della Repubblica italiana
nizzazione costituzionale che lo stesso Costituente
lasci volutamente incomplete o transitoriamente
delineate. Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, i richiami a taluni stereotipi sono riemersi
in questi anni, anche nel dibattito sulle riforme
istituzionali ed elettorali.
Dopo le vicende degli anni Novanta si dissolta lunit politica dei cattolici e la sinistra ha
subto i contraccolpi della fine del comunismo
realizzato: si dissolto, in breve, il vecchio
sistema dei partiti e nessuna parte politica ha
potuto credibilmente pretendere lesclusiva eredit della Costituente. Il tentativo di tradurre in
violazioni della Costituzione i dissensi sugli atti
di governo di questa o di quella maggioranza, di
invocare il sostegno del diritto costituzionale per
combattere politiche ritenute nocive, anche laddove essa lascia aperte soluzioni alternative, rischia
di veicolare lidea che la Costituzione non consente una storia e una cittadinanza comune, un
radicamento che superi le appartenenze parziali (540). Tuttavia, come abbiamo cercato di
mettere in evidenza nelle pagine scorse, lItalia ha
superato prove assai impegnative proprio perch
sostenuta da una pi condivisa e vissuta tavola
di valori, fissati dalla Costituzione repubblicana e
condivisi da un largo consenso.
Anche sotto questi profili la Carta costituzionale ha dimostrato di essere a virtualit multiple
avendo potuto conciliarsi lo anticipavamo nel
primo paragrafo sia con i sistemi elettorali a
base proporzionale sia con quelli a base maggioritaria, sia con la economia mista ereditata dagli
anni Trenta sia con una economia pi competitiva.
Ha accompagnato sia le prime caute letture dei
vincoli europei sia quelle successive, assai pi
avanzate. stata un punto di riferimento per una
Italia che ha conosciuto, tra gli anni Cinquanta e
Sessanta, pesanti fenomeni di emigrazione dei propri lavoratori, potr esserlo oggi per accogliere
invece importanti fenomeni di immigrazione.
Oggi la democrazia italiana attraversata da
contrapposizioni fra visioni conservatrici del testo
costituzionale e delegittimanti pulsioni populiste,
cui talvolta si affianca il tentativo di taluni riformatori di utilizzare le riforme costituzionali come
strumento di politica contingente. Un rafforzamento delle capacit decisionali delle istituzioni di
governo pu essere utilizzato vero per
ridurre la domanda sociale ma la prospettiva pu
essere ribaltata: un rafforzamento delle istituzioni
(540) Lo ha messo pi volte in rilevo Pietro SCOPPOLA,
La Costituzione contesa, cit., 57 ss.
di governo pu essere indispensabile per perseguire con politiche incisive gli obbiettivi costituzionali, per rendere effettiva la promozione e la
tutela dei diritti. Istituzioni robuste possono essere
succubi di poteri forti dipende dalle politiche
perseguite ma istituzioni deboli lo sono sempre
e comunque. La Costituzione italiana pu ancora
essere il binario attraverso il quale, nelle forme e
nei limiti da essa fissati, possono scorrere le varie
espressioni della sovranit popolare. Ci sono tuttavia molti modi possibili per stare dentro i principi della Costituzione. Su questi punti sia il dibattito politico sia quello fra gli studiosi lungi
dallessere concluso, soprattutto in conseguenza
delle difficolt attraversate dai sistemi bipolari in
tutta lEuropa, percorsa dallesplosione di forze
che tanto sulla destra quanto sulla sinistra contestano sia forme e modi dellUnione europea sia le
politiche di immigrazione e che tendono ad oscurare i tradizionali cleavages.
I processi di globalizzazione hanno indebolito
le classiche categorie del diritto costituzionale, fra
queste la sovranit. E non poteva essere diversamente avendo esse accompagnato la formazione
degli Stati nazionali. La sovranit dei valori
secondo autorevoli e non isolate opinioni (541)
sarebbe destinata a prendere il posto non solo
della sovranit dello Stato ma della stessa sovranit
popolare: si tratta di una formula suggestiva,
che rispecchia la seria crisi che attraversa il concetto tradizionale di sovranit, ma che non riesce
ad allontanare alcuni timori; due in particolare:
che cos si legittimino incontrollati centri internazionali di potere tecnocratico, delegittimando la
politica (542), e che tale formula si riduca a una
nuova criptica forma di sovranit di cui titolare
diventerebbe il massimo interprete di quei valori,
(541) La sovranit della Costituzione in M. KRIELE,
Einfhrung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimittsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, Rowohlt, Reinbek, 1975, e in G. SILVESTRI, Lo Stato senza
principe. La sovranit dei valori nelle democrazie pluraliste,
Giappichelli, Torino, 2005. I valori come nuovi sovrani :
cos definiti da Luigi DANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Giuffr, Milano, 2005, 271.
(542) dalle feluche alle toghe , secondo unespressione di Sabino CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Giappichelli, Torino, 2009, e ID., I
tribunali di Babele, cit. (quarta di copertina). La ratio
contrattualistica delle istituzioni della globalizzazione in
M.R. FERRARESE, Globalizzazione giuridica, in questa Enciclopedia, Annali, IV, 2011, 565 ss., e in TEUBNER, La cultura del
diritto nellepoca della globalizzazione, cit. Sul punto v. le
pagine di A. VON BOGDANDY e I. VENZKE, In Whose Name? An
Investigation of International Courts. Public Authority and
Its Democratic Justification, in Eur. journ. intern. Law, 1993,
7 ss.
357
Costituzione della Repubblica italiana
vale a dire la Corte costituzionale. Il monismo
del costituzionalismo dellOttocento rientrerebbe
cos dalla finestra, trasfigurando la iurisdictio in un
nuovo gubernaculum. In poche parole, come
stato incisivamente affermato, la Repubblica non
pu essere affidata solo ai suoi giudici (543).
Augusto Barbera
LETTERATURA. Ci limitiamo ad indicare le trattazioni
enciclopediche apparse dopo la pubblicazione di C. MORTATI, Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione
della Repubblica italiana), in questa Enciclopedia, XI, 1962, e
(543) Cos FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale,
cit., 308, che si riferisce ad un pericolo di uno stato
neo-giurisdizionale carente di legittimazione democratica .
358
ID., Diritto costituzionale (nozione e caratteri), ivi, XII, 1964,
rinviando alle note al testo per indicazioni pi specifiche: V.
CRISAFULLI, Costituzione, in Enciclopedia del Novecento, I,
Treccani, Roma, 1975; A.M. SANDULLI, Costituzione italiana,
ivi; P. BARILE, Costituzione italiana, in Nss. D.I., Appendice,
II, 1981; F. MODUGNO, Costituzione: I) Teoria generale, in
Enc. giur., X, 1988; V. COCOZZA, Costituzione: II) Costituzione italiana, ivi; S. BARTOLE, Costituzione (dottrine generali
e diritto costituzionale), in D. disc. pubbl., IV, 1989; V.
ONIDA, Costituzione italiana, ivi; P. HBERLE, Potere costituente (teoria generale), in Enc. giur., Aggiornamento, 2000;
A. SPADARO, Costituzione (dottrine generali), in Dizionario di
diritto pubblico diretto da S. CASSESE, II, Giuffr, Milano,
2006; V. ONIDA, Costituzione italiana, ivi; A. CELOTTO, Diritto
costituzionale, ivi, III; A. RUGGERI, Costituzione, in Enciclopedia filosofica, III, Bompiani, Milano, 2006; M. DOGLIANI,
Costituzione (Dottrine generali), in Il Diritto. Enciclopedia
giuridica del Sole 24 ore, IV, Gruppo 24 ore, Milano, 2007;
M. AINIS, Costituzione italiana, ivi.
Potrebbero piacerti anche
- Il diritto penale come etica pubblica: Considerazioni sul politico quale “tipo d'autore”Da EverandIl diritto penale come etica pubblica: Considerazioni sul politico quale “tipo d'autore”Nessuna valutazione finora
- LA DEVIANZA MINORILE. Il trattamento penitenziario minorile. Il ruolo della scuola nella prevenzione della devianza e la figura del CriminologoDa EverandLA DEVIANZA MINORILE. Il trattamento penitenziario minorile. Il ruolo della scuola nella prevenzione della devianza e la figura del CriminologoNessuna valutazione finora
- Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale I: Volume IDa EverandLezioni Magistrali di Diritto Costituzionale I: Volume INessuna valutazione finora
- Il valore della prova scientifica nel processo italiano e americanoDa EverandIl valore della prova scientifica nel processo italiano e americanoNessuna valutazione finora
- SANZIONI AMMINISTRATIVE I presupposti, il ricorso e il giudizio di opposizione: Le sanzioni amministrative e il covid 19Da EverandSANZIONI AMMINISTRATIVE I presupposti, il ricorso e il giudizio di opposizione: Le sanzioni amministrative e il covid 19Nessuna valutazione finora
- Carducci Diritti NaturaDocumento40 pagineCarducci Diritti NaturaMtwain WoodNessuna valutazione finora
- Appunti Diritto Penale 1 e 2Documento28 pagineAppunti Diritto Penale 1 e 2Laura Ramacciotti PicchiNessuna valutazione finora
- Rivista Di Diritto Processuale PDFDocumento326 pagineRivista Di Diritto Processuale PDFWalter Argüelles AyalaNessuna valutazione finora
- VALUTAZIONE DELLE PROVE secondo prudente apprezzamento: Dal più probabile che non alla sommatoria di proveDa EverandVALUTAZIONE DELLE PROVE secondo prudente apprezzamento: Dal più probabile che non alla sommatoria di proveNessuna valutazione finora
- FERRAJOLI - Diritto Penale Del NemicoDocumento13 pagineFERRAJOLI - Diritto Penale Del Nemicolldb07124Nessuna valutazione finora
- Esame avvocato 2020-21. CASI DI DIRITTO CIVILE: con soluzioni schematiche dimostrateDa EverandEsame avvocato 2020-21. CASI DI DIRITTO CIVILE: con soluzioni schematiche dimostrateNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Filosofia Del Diritto Per La.a. 2001-2002 (Enrico Pattaro)Documento330 pagineLezioni Di Filosofia Del Diritto Per La.a. 2001-2002 (Enrico Pattaro)maricaaaaNessuna valutazione finora
- Tutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaDa EverandTutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaNessuna valutazione finora
- Crediti per onorari avvocato: Procedimenti e strategie per il recuperoDa EverandCrediti per onorari avvocato: Procedimenti e strategie per il recuperoNessuna valutazione finora
- Tutela del software e diritto d'autore. Convergenze e interferenzeDa EverandTutela del software e diritto d'autore. Convergenze e interferenzeNessuna valutazione finora
- Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale: II EdizioneDa EverandIndottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale: II EdizioneNessuna valutazione finora
- Compendio di DIRITTO COMMERCIALE e PROCEDURA PENALEDa EverandCompendio di DIRITTO COMMERCIALE e PROCEDURA PENALENessuna valutazione finora
- Scienza Giuridica PDFDocumento43 pagineScienza Giuridica PDFCristián BahamondeNessuna valutazione finora
- Compedio pratico di Deontologia e Ordinamento Forense: Corso pratico di dirittoDa EverandCompedio pratico di Deontologia e Ordinamento Forense: Corso pratico di dirittoNessuna valutazione finora
- Elementi Del Diritto CivileDocumento252 pagineElementi Del Diritto CivileLuis M.R.Nessuna valutazione finora
- ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionaleDa EverandENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionaleNessuna valutazione finora
- Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale II: Volume IIDa EverandLezioni Magistrali di Diritto Costituzionale II: Volume IINessuna valutazione finora
- RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206Da EverandRIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206Nessuna valutazione finora
- Riassunto Informatica GiuridicaDocumento70 pagineRiassunto Informatica Giuridicaappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- Bellucci La Redazione Di Sentenze Una Responsabilità Linguistica ElevataDocumento28 pagineBellucci La Redazione Di Sentenze Una Responsabilità Linguistica Elevatavitofilos3Nessuna valutazione finora
- Bobbio KelsenDocumento25 pagineBobbio KelsenAnonymous 4L7zuPcaLNessuna valutazione finora
- Corso Completo Di Diritto Penale ComparatoDocumento328 pagineCorso Completo Di Diritto Penale ComparatoLuis M.R.Nessuna valutazione finora
- Tema LudopatiaDocumento2 pagineTema LudopatiacarlochiericiNessuna valutazione finora
- Marinucci-Dolcini - RiassuntoDocumento176 pagineMarinucci-Dolcini - RiassuntoLaura NegroNessuna valutazione finora
- Anticorruzione: modalità operative e piano triennale per gli enti locali (L.190/2012)Da EverandAnticorruzione: modalità operative e piano triennale per gli enti locali (L.190/2012)Nessuna valutazione finora
- Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale III: Volume IIIDa EverandLezioni Magistrali di Diritto Costituzionale III: Volume IIINessuna valutazione finora
- Kelsen SchmittDocumento34 pagineKelsen Schmittmissanswer100% (1)
- Riassunto Tempi Del DirittoDocumento82 pagineRiassunto Tempi Del DirittoVincenza DinoiNessuna valutazione finora
- Separazione e divorzio. Principali aspetti sostanziali e processuali.Da EverandSeparazione e divorzio. Principali aspetti sostanziali e processuali.Nessuna valutazione finora
- Aggressività e violenza maschile al tempo della globalizzazione: al tempo della globalizzazioneDa EverandAggressività e violenza maschile al tempo della globalizzazione: al tempo della globalizzazioneNessuna valutazione finora
- Papato, episcopati e società civili (1917-2019): Nuove pagine di diritto canonico ed ecclesiasticoDa EverandPapato, episcopati e società civili (1917-2019): Nuove pagine di diritto canonico ed ecclesiasticoNessuna valutazione finora
- Il Contenuto Dellobbligazione Del VenditDocumento321 pagineIl Contenuto Dellobbligazione Del VenditemilioNessuna valutazione finora
- La relazione distruttiva: Manipolazione, violenza, femminicidioDa EverandLa relazione distruttiva: Manipolazione, violenza, femminicidioNessuna valutazione finora
- De Vergottini - Diritto Costituzionale Comparato (2013)Documento392 pagineDe Vergottini - Diritto Costituzionale Comparato (2013)Raffaele De CrescenzoNessuna valutazione finora
- Contabilità Di StatoDocumento44 pagineContabilità Di StatoDavide SartianoNessuna valutazione finora
- Teoria Della Illusione FinanziariaDocumento301 pagineTeoria Della Illusione FinanziariaGu Si Fang100% (1)
- Testo Unico Pubblico Impiego MAGGIO 2017 PDFDocumento40 pagineTesto Unico Pubblico Impiego MAGGIO 2017 PDFkasparjNessuna valutazione finora
- Il concorso per qualifiche varie all'Automobile Club d'Italia (ACI): Le materie comuni ai diversi profiliDa EverandIl concorso per qualifiche varie all'Automobile Club d'Italia (ACI): Le materie comuni ai diversi profiliNessuna valutazione finora
- Compendio Di Legislazione Universitaria PDFDocumento18 pagineCompendio Di Legislazione Universitaria PDFaurora porsenna50% (2)
- Corsi Di ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO Massimo ParadisoDocumento122 pagineCorsi Di ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO Massimo ParadisoAlessia BruscianiNessuna valutazione finora
- FIORAVANTI. Costituzionalismo PDFDocumento10 pagineFIORAVANTI. Costituzionalismo PDFAknaton Toczek SouzaNessuna valutazione finora
- Riassunto Libro Manuale Di Diritto Dellinformazione e Della Comunicazione Diritto Comparato Dellinformazione e Della Comunicazione PDFDocumento92 pagineRiassunto Libro Manuale Di Diritto Dellinformazione e Della Comunicazione Diritto Comparato Dellinformazione e Della Comunicazione PDFPietro AnnunziataNessuna valutazione finora