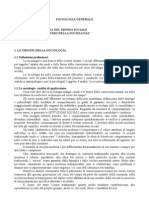Sociologia
Parte Prima - Che cosa è la sociologia
Capitolo 1
La sociologia è lo studio scienti co sel comportamento degli esseri umani in società. Esso
deriva, da un punto di vista etimologico dalle parole “socio” e “logos”. Per lo studio di
questa scienza vengono utilizzati vari metodi di ricerca empirica e approcci teorici speci ci
al ne di sviluppare una conoscenza speci ca delle azioni, delle strutture e dei processi
sociali. Lo scienziato sociale mette in discussione in modo ricorrente e metodico ciò che il
senso comune da generalmente per scontato. La sociologia viene riconosciuta come
scienza in quanto prende distanza da orientamenti prescrittivi ma descrive e spiega
sviluppando: concetti, metodi di indagine, tecniche di raccolta e analisi dei dati. In questo
senso la teoria e la ricerca si integrano reciprocamente (indipendentemente dall’uso di
metodi qualitativi o quantitativi) in quanto la teoria senza ricerca è muta e la teoria è
astratta.
La sociologia ha quindi come oggetto la società, concetto ampiamente mutato nel corso
dei secoli, e con signi cato di erente dato dall’uso comune rispetto a quello sociologico.
Il termine ‘società’ viene utilizzato nel linguaggio comune per indicare un gruppo di persone
con interessi condivisi o appartenenti alla stessa classe sociale. Esse, pero, sono utili per
comprendere e classi care i vari aspetti della società, ma non per dare una de nizione della
stessa nella sua interezza. Se in passato la società veniva identi cata in base a caratteri
principalmente geogra ci e biologici (identi candola come un gruppo di individui che vivono
all’interno dello stesso Stato), attualmente essa viene de nita secondo i caratteri di una
società moderna più complessa e frammentata. Questo approccio ottocentesco, anche
conosciuto come “nazionalismo metodologico”, viene messo in discussione a fronte della
complessità delle società moderne, sempre più variegate e ricche al loro interno di Loretta
te “micro società’”. Attualmente, quindi, con la parola società si identi ca un insieme di
individui e gruppi, uniti da relazioni di tipo morale, giuridico e culturale, che presenta vari
gradi di complessità e dimensioni più o meno ampie, non necessariamente coincidenti con i
con ni statuali, è durevole nel tempo ma sottoposta a cambiamenti, anche radicali.
Capitolo 2
La sociologia, ultima scienza sociale nata alla ne dell’Ottocento, deve le sue origini ad una
particolare situazione creatasi da tre Rivoluzioni: quella scienti ca, quella francese e quella
industriale. Nella società ottocentesca, ricca di esponenti delle scienze naturali, si stava
a ermando sempre di più una ducia nella scienza, tanto che le teorie applicate alle già
conosciute scienze naturali spinsero numerosi scienziati ad interessarsi allo studio
dell’uomo non soltanto da un punto di vista biologico/anatomico ma anche da un punto di
vista strettamente sociologico. A questo Positivismo si a ancano i principi e le necessità
legittimate dalla rivoluzione francese. Con questa, infatti, viene sdoganato il concetto di
mutabilità sociale, secondo il quale i sudditi diventano cittadini, aventi diritti inderogabili. Se
da un lato, quindi dalla Rivoluzione Francese, vengono riconosciuti diritti ai cittadini, è pur
vero che la rivoluzione industriale crea i presupposti per una mutamento della societa,
dando vita a due classi sociali contrapposte: da una parte i capitalisti e dall’altra la classe
operaia. Con il fenomeno, quindi, dell’urbanesimo si creano mutamenti che danno origine ai
problemi sociali. È da questa situazione che i sociologi si interessano e ritengono
necessario lo studio della società al ne di poter comprendere ed arginare questi problemi.
(Nascono le inchieste sociali).
Alla base della sociologia classica si pongono due scuole di pensiero contrapposte: quella
dei Positivisti (Comte e Spencer) e quella di origine Marxiana. Alla base del Positivismo c’è
la ducia nelle teorie e nei metodi utilizzati nelle scienze naturali e nel progresso. I due
esponenti principali di questa corrente furono Comte e Spencer. Su questi principi Comte
elaborò la teoria dei tre stadi, ovvero la teorizzazione di tre fasi storiche su cui si basava la
conoscenza. Il primo è lo stadio teologico, secondo il quale tutto, nel Mediovevo, era
ricondotto ai dettami religiosi e al volere di Dio. Il secondo stadio è quello meta sico, tipico
1
ff
fi
fi
fi
fi
fi
fi
ff
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
ffi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
� Sociologia
del Rinascimento, studiava in modo astratto e con una visione meta sica. L’ultimo stadio,
ovvero quello Positivo e contemporaneo a Comte, comprende e completa la conoscenza
con il metodo scienti co usato per le scienze naturali. Per Comte, quindi la sociologia è
l’ultima scienza, quella gerarchicamente superiore alle altre. Spencer si spinge oltre questa
visione, ritenendo che alla base della societa ci fosse un’evoluzione simile a quella
eleborata da Darwin. Secondo Spencer, infatti, gli individui dentro una società si adattano e
si di erenziano, dando origine ad una di erenziazione del lavoro, basata sulla capacità più
o meno ampia di adattarsi e giovare dalle mutazioni del contesto (come rivoluzione
industriale).
Al pensiero positivista, si contrappone quello Marxiano, mosso da una forte critica al
Capitallismo che si stava a ermando negli anni della rivoluzione industriale. Per Marx i
capitalisti ottengono pro tto appropriandosi indebitamente del plus-valore dato dallo
scambio lavoro/remunerazione con la classe operaia. Secondo questa diseguaglianza
economica si sarebbe generata una lotta di classe, che avrebbe dato origine ad una
mutazione della società, glia quindi non di un cambiamento di ideali, ma semplicemente
basata su meri fattori economici.
Ai due grandi pensatori alla base della sociologia è, però, necessario a ancare Alexis de
Tocqueville. La sua tesi, elaborata nella “Democrazia in America”, sostiene che la
democrazia farà il suo naturale corso con il passare dei secoli, ponendo alla base per la
coltivazione dell’ascesa sociale l’euguaglianza delle condizioni.
Capitolo 3
Con il termine Paradigma (termine elaborato da Kuhn), si intende un insieme di teorie e
metodi che caratterizzano una tradizione di ricerca all’interno della quale esiste un
consenso di tutta la comunità scienti ca. In un contesto strettamente legato alle scienze
naturali, si ha una pluralità di paradigmi che si susseguono cronologicamente. I paradigmi
legati alle scienze sociali, invece possono essere una pluralità, coesistenti tra loro nello
stesso periodo storico e a erenti ad una stessa area di studio.
Alla base della sociologia classica si pongono due fondamentali paradigmi, i quali fanno
capo l’uno alla scuola francese (paradigma oggettivista) e l’altro alla scuola tedesca
(paradigma soggettivista).
Il paradigma oggettivista, il cui padre fondatore è Durkheim, è un metodo di studio che
analizza i fenomeni sociali come aventi esistenza propria, indipendentemente da come i
singoli individui li vivono e dal senso che attribuiscono a essi. I pilastri elaborati da
Durkheim su cui si basa questo paradigma sono quattro:
- Bisogna considerare i fatti sociali come cose, quindi indipendenti dagli individui, i primi si
impongono agli ultimi
- La società viene prima degli individui, per spiegare un fatto sociale si parte da altri fatti
sociali, non si può studiare questi partendo dagli individui
- Lo scienziato sociale deve individuare le leggi di causalità che regolano e connettono i
fatti sociali
- I sociologi non operano mediante la sperimentazione diretta ma utilizzano il metodo delle
variazioni concomitanti, ovvero della comparazione di un fenomeno con le modalità con
cui si presenta in altri contesti/paesi/epoche.
Lo studio che più rende chiaro questo metodo è il suicidio di Durkheim.
Il paradigma soggettivista, invece, il cui padre fondatore è Weber, prende in esame i
fenomeni sociali partendo dal signi cato che le azioni assumono per l’individuo che le
compie. A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento la sociologia francese e quella tedesca si
opposero tra loro. Se la prima comprendeva la sociologia nella grande area delle scienze, la
seconda distingueva nettamente tra le scienze dello spirito e quelle della natura. Pertanto,
per la scuola tedesca la sociologia era analizzata come scienza a sé, in una tendenza
storicista. È da questo dibattito sul metodo che nasce il metodo comprendente di Weber,
secondo il quale le scienze sociali non rinunciano a leggi empiriche, privilegiando, però,
l’interpretazione dei fatti. Da ciò si deducono due fondamentali principi per Weber, il primo è
quello della descrizione dei tipi ideali, ovvero un insieme di fattori assunti come essenziali
nella determinazione del fenomeno oggetto di studio, il secondo è invece rappresentato
2
ff
fi
fi
fi
ff
ff
fi
fi
ff
fi
ffi
� Sociologia
dalla nozione di oggettività, ovvero l’assicurarsi che vi sia correttezza logico-metodologica
del procedimento esplicativo.
Capitolo 4.
Nella prospettiva del paradigma oggettivistico ritroviamo il funzionalismo, un modello
sistemico della società che pone le basi sul cosiddetto modello organista classico.
Secondo questo modello un insieme di parti interrelate compongono l’organismo vivente,
esse però non esistono separatamente. Le idee riconducibili, quindi, a questo modello sono
essenzialmente tre:
- il tutto va distinto nelle sue parti
- Le parti sono tutte essenziali e tra loro interrelate
- Non si può ridurre tutto alla mera somma delle parti
Il funzionalismo, pertanto, indica - con il termine funzione - l’utilità che un dato fenomeno
riveste per l’ordine e la persistenza della società in cui è inserito. Merton introduce l’analisi
funzionale in sociologia (nasce nell’antropologia culturale) facendo profonde revisioni. In
particolare critica l’idea di “indispensabilità funzionale”, ritendendo che ci possano essere
dei sostituti chiamati equivalenti funzionali (Ad esempio il volontariato organizzato può
essere un sostituto del welfare state). Inoltre lo studioso fa una distinzione tra funzioni
manifeste - ovvero quelle che un individuo compie coscientemente - e funzioni latenti - non
riconosciute o addirittura non volute dall’individuo. Nella rielaborazione delle teoria
funzionalista tradizionale troviamo un intervento di Parsons, al quale riconduciamo il
struttural-funzionalismo, un approccio caratterizzato da quattro imperativi funzionali
(essenziali per l’esistenza e persistenza del sistema):
- Adaptation, ovvero la funzione di adattamento all’ambiente esterno, consistente
nell’attingere dall’ambiente esterno le risorse necessarie in cambio di prodotti che
provengono dal sistema stesso (Questa funzione viene svolta dalle istituzioni
economiche).
- Goals attainment, ovvero la funzione di conseguimento degli scopi, consistente
nell’individuazione e nella realizzazione degli scopi necessari al funzionamento del
sistema attraverso la scelta di mezzi e caci (questa funzione viene svolta dalle istituzioni
politiche)
- Integration, ovvero la funzione di integrazione, riguardante il controllo e il coordinamento
della parti con il ne di evitare perturbazioni che minaccino la stabilità del sistema (questa
funzione viene svolta dalle istituzioni giuridiche)
- Latency, ovvero la funzione di latenza, consistente nello stabilire e di ondere le
motivazioni dell’azione (questa funzione viene svolta dalle strutture di socializzazione)
Lo strutturalismo, sebbene non sia una prospettiva unitaria, presenta quattro caratteri
comuni:
- La visione olistica (presente anche nel funzionalismo) secondo la quale le strutture sociali
possono essere comprese e studiate soltanto facendo riferimento all’insieme delle parti
che le compongono.
- Privilegia le strutture e gli elementi stabili ed invarianti, facendo uso di una metodologia
astorica che analizza un momento o un istante ben de nito
- Studia le strutture latenti, non immediatamente lampanti all’occhio del singolo individuo
- Ritengono che gli individui siano pesantemente condizionati dalle strutture latenti, dando
vita ad un comportamento non libero ma in uenzato da fattori dei quali non sono
consapevoli
Nella prospettiva soggettivista ritroviamo, invece la prospettiva dell’azione e quella
dell’interazione sociale. Queste due prospettive si muovono nell’ambito di tre principi:
- Un comportamento umano si può dire azione solo se è dotato di un signi cato soggettivo
per colui che agisce
- L’azione sociale, per essere tale, non si presenta solo con un signi cato ma deve anche
intendersi come interazione, ossia come azione intenzionalmente rivolta ad altri
- Ogni fenomeno sociale è il risultato dell’interpretazione che la società dà a quella
determinata azione (ad esempio la devianza)
3
fi
ffi
fl
fi
fi
ff
fi
� Sociologia
L’interazionismo simbolico è una corrente di pensiero che si viluppa in America e consiste
nello studiare i rapporti interpersonali degli individui, i quali non si limitano ad essere
recettori delle forze sociali ma contribuiscono a costruire la società di cui fanno parte.
Un’altra elaborazione è quella della sociologia fenomenologica, proposta dal sociologo
Schütz, secondo il quale noi costruiamo un mondo signi cativo intorno a noi attraverso un
processo di tipi cazione, ovvero attraverso schemi di pensiero dati per scontati, abitudinari.
Questo mondo di cui facciamo parte viene chiamato “il mondo della vita”.
Un altro sviluppo nel contesto fenomenologico è quello dell’etnometodologia elaborato da
Gar nkel. Esso indica lo studio dei metodi e delle pratiche impiegate dall’etno, per dare
signi cato alla vita quotidiana, mettendo a fuoco ciò che viene dato per scontato.
Secondo il modello drammaturgico elaborato da Go man, rientrante in parte
nell’etnometodologia, gli incontri fuggevoli che avvengono nella realtà vengono interpretati
come una rappresentazione teatrale. La “ribalta” è il luogo in cui si svolge la
rappresentazione davanti al pubblico, il “retroscena” quello in cui ci si prepara e rilassa.
A di erenza dei modelli sopra esaminati, per Hormans l’interazione sociale viene vista come
uno scambio razionale basato su un’analisi costi/bene ci, prendendo come modello quello
utilitarista dell’homo oeconomicus.
In ultima battuta prendiamo in esame la sociologia critica, ovvero una prospettiva che mette
al centro dei compiti della disciplina quello di migliorare la società. In questa prospettiva
distinguiamo due correnti. La prima è quella nordamericana, nata principalmente da
[Link], il quale denuncia la condizione di alienazione della classe media
americana, modellata dalle élite al comando (potere politico, economico e militare). La
seconda prospettiva è, invece, data dalla scuola di Francoforte, la quale critica la neutralità
della scienza, ritendendo fondamentale prendere in esame il condizionamento degli
individui nella societa di massa (da parte dei mass media o dell’industria del divertimento).
Alle due prospettive della sociologia originaria si contrappongono due di erenti metodi di
analisi. Al paradigma oggettivista viene associato il metodo quantitativo, a quello
soggettivista quello qualitativo. Il primo si sviluppa su quattro criteri:
- i concetti devono essere traducibili in operazioni di ricerca
- È necessario utilizzare uno strumenti di rilevazione comune con l’obiettivo di arrivare ad
una matrice dati
- Il ricercatore deve mantenere un distacco dall’oggetto della ricerca
- L’analisi delle variabili deve essere condotta atttraverso l’impiego di modelli statistici e
matematici
I quattro criteri, invece, riconducibili al secondo metodo sono:
- I concetti devono essere aperti orientativi
- Lo strumento di rilevazione deve variare a seconda dell’interesse di ricerca in gioco
- Il ricercatore tende ad essere soggettivamente coinvolto nell’oggetto di studio
- L’analisi dei dati è personale
Con i metodi quantitativi si possono avere ampie generalizzazioni ma con un modesto
livello del fenomeno preso in esame, con il metodo qualitativo si analizza un campione di
minore entità ma si giunge ad una descrizione dell’oggetto di studio più particolarista.
4
fi
ff
fi
fi
ff
fi
fi
ff