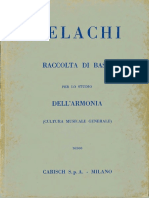Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Chironomia
Chironomia
Caricato da
Marco Berrini0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
67 visualizzazioni4 pagineTitolo originale
chironomia
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
67 visualizzazioni4 pagineChironomia
Chironomia
Caricato da
Marco BerriniCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 4
LA CHIRONOMIA
Il termine chironomia (legge della mano) indica l'arte di
dirigere un coro con gesti della mano. Di antichissima
tradizione, era una particolarita dei maestri di canto
palestinesi e degli orientali in genere.
Questa tecnica, che fa aderire l'inflessione della voce
alla espressivitaé delle mani, ha alla sua base profonde
motivazioni psicologiche e appartiene senza dubbio ai
cosiddetti "segni memorativi" di cui parlano gli studiosi
del linguaggio. L'uso di ricorrere a questi segni corri-
sponde ad un naturale bisogno della psicologia umana e lo
si pud riscontrare sin dai tempi pil antichi.
Nelle pitture egiziane del Vecchio Regno (2700 a.C.
circa) troviamo i primi tentativi di rappresentare
suoni. Esse raffigurano uno strumentista nell'atto di
suonare mentre un uomo seduto davanti a lui spiega con
segni della mano quale nota l'esecutore debba suonare.
Durante l'esecuzione dei canti liturgici gli ebrei, come
gli egiziani, davano o ricevevano suggerimenti mnemonici
in forma di cenni della mano e sappiamo dal Talmud che i
cantori ebrei usavano movimenti delle dita al principio
dell'era cristiana. Essi adottarono per il canto liturgi-
co segni simili agli accenti dei greci e la maggior parte
di questi simboli scritti si conformava alle curve dei
gesti della mano, per quanto questi segni fossero solamen-
te richiami mnemonic’ di melodie gia note e non indicasse-
ro ancora intonazioni o intervalli definiti.
L'uso della chironomia @ della massima importanza dal
31
punto di vista didattico e pedagogico poiché non solo nei
primi anni di vita ma anche molto pil tardi, il linguaggio
dei ragazzi e degli adulti & pieno di segni direttamente
espressivi ed & scientificamente dimostrato che l'atten-
zione visiva prepara l'attenzione uditiva.
Serive Giséle Calmy-Guyot nel suo libro "Pedagogia della
mano", che il linguaggio gestuale, isolato da un contesto
verbale, @ un focalizzatore d'attenzione e, utilizzato in
giuste dosi, prepara il terreno per una buona, effettiva
ricezione del messaggio verbale. Fa inoltre osservare che
Marcel Jousse (in "Antropologia del gesto") contrariamente
alla concezione che riduce il gesto a pura funzione di
accompagnamento, considera il gesto orale un momento del
gesto totale e 41 linguaggio gli appare il sostituto "ne-
erotizzato" del gestuale. Per lui il gesto non @ al
servizio del linguaggio ma attribuisce anteriorit& al
gesto sulla parola. In sostanza, dice Jousse, 1l'vomo co-
struisce la sua prima espressione con la mimesi e poiché
& proprio grazie a questa mimesi che il pensiero funziona,
il pensiero non @ altro che la coscienza della mimesi.
Anche ammettendo che si possa non condividere questa
affascinante conclusione, non si pud non essere d'accordo,
dal punto di vista pedagogico, sull'importanza relaziona-
le che 41 gesto assume tra maestro e allievi.
Cosi come il gesto, e prima della parola, anche la musica
& comunicazione diretta, nel senso che influenza tutta la
personalita senza il tramite della coscienza. Ecco perché
la fusione dei due elementi gestualita e rapporti sonori
costituisce il mezzo migliore per avviare i bambini al-
l'apprendimento della musica senza necessita di nozioni.
32
Tutti gli elementi essenziali di un brano musicale possono
essere trasmessi attraverso la chironomia:
- la linea melodica, indicata dai singoli gesti dei
suoni;
- il fraseggio, che si ottiene legando con la mano nello
spazio i gesti della linea melodica;
~ il ritmo, rappresentato da gesti pil lenti o pil veloci;
~ l'espressivita, che oltre che dal carattere del gesto,
deve naturalmente venir trasmessa da tutto l'atteggia-
mento di colui che dirige con la chironomia.
E cosi, ben al di 18 del suo aspetto di "tecnica", essa
rappresenta un modo di far "musica silenziosa" che pud
trovare la sua voce nella voce dei cantori, ma la cui
funzione dovrd innanzitutto essere quella di abituare a
"pensare con i suoni".
rr)
La chironomia usata nel metodo Kodaly, oltre ad indicare
dei rapporti sonori, ha l'insostituibile compito di dare
a ciascun segno una determinata funzione ed @ interessante
vedere come ciascuno di questi segni esprima, nella sua
gestualita, 41 "carattere" di queste funzioni:
"a" (do) con il pugno chiuso, ad indicare stabilita e fer-
mezza;
"r (re) con la mano inclinata, ad esprimere un suono di
passaggio, in discesa verso “d" o in salita
verso "m'
"m" (mi) con la mano e l'avambraceio tesi orizzontalmente,
a dare senso di relativa stabilita ma anche di
ee)
apertura;
"e" (fa) con il "pollice verso" mostra la sua particolare
sensibilit& a discendere su "m";
"s" (sol) con la mano e l'avambraccio quasi “in levare"
nel tentativo di definire il proprio carattere
"sospensivo";
"1" (1a) eon 42 polso piegato verso l'alto e la mano in
caduta, rende molto bene un certo senso di inde-
terminatezza;
"et" (si) con Ltindice puntato verso l'alto, a indicare la
sua tensione in direzione della tonica "d".
Sard bene ribadire che, come 2 stato illustrato a proposi-
to del solfeggio relativo (do mobile), ciascun segno
indica una funzione e non un suono assoluto.
rv mM s L €
Jagan’ 9 Me wh
A f
Liimmagine dei gesti chironomici, di Daniele Imperi, @ stata aggiunta al file pdf in
sostituzione delle foto originali (per alleggerire il file).
34
Potrebbero piacerti anche
- Delachi - Raccolta Di Bassi PDFDocumento96 pagineDelachi - Raccolta Di Bassi PDFMarco Berrini67% (3)
- 1558 - Zarlino, Gioseffo Le Istituzioni Armoniche - 1562 - II Edizione - VE PDFDocumento368 pagine1558 - Zarlino, Gioseffo Le Istituzioni Armoniche - 1562 - II Edizione - VE PDFMarco BerriniNessuna valutazione finora
- Kenneth Wollitz - Manuale Del Flauto Dolce (1992) (Longanesi)Documento240 pagineKenneth Wollitz - Manuale Del Flauto Dolce (1992) (Longanesi)Marco BerriniNessuna valutazione finora
- D'Agostino La Musica. La Cappella e Il Cerimoniale Alla Corte Aragonese Di NapoliDocumento36 pagineD'Agostino La Musica. La Cappella e Il Cerimoniale Alla Corte Aragonese Di NapoliMarco BerriniNessuna valutazione finora
- Rock My SoulDocumento1 paginaRock My SoulMarco BerriniNessuna valutazione finora
- Carlo Gesualdo Gli Strumenti Musicali PDDocumento72 pagineCarlo Gesualdo Gli Strumenti Musicali PDMarco BerriniNessuna valutazione finora
- 1996 - Pesci Prassi Esecutiva BCDocumento54 pagine1996 - Pesci Prassi Esecutiva BCMarco BerriniNessuna valutazione finora
- Gregoriano Stella CoeliDocumento1 paginaGregoriano Stella CoeliMarco BerriniNessuna valutazione finora
- Bertoglio Accordo Perfetto La Trinita Nella Musica, La Musica Nella TrinitàDocumento24 pagineBertoglio Accordo Perfetto La Trinita Nella Musica, La Musica Nella TrinitàMarco BerriniNessuna valutazione finora
- Zorzi Melos e Jubilus Nelle Enarrationes in Psalmos Di Agostino - Una Questione Di Mistica AgostinianaDocumento25 pagineZorzi Melos e Jubilus Nelle Enarrationes in Psalmos Di Agostino - Una Questione Di Mistica AgostinianaMarco BerriniNessuna valutazione finora
- Vinay - Giuffredi Le Tecniche Della ModulazioneDocumento70 pagineVinay - Giuffredi Le Tecniche Della ModulazioneMarco BerriniNessuna valutazione finora
- 1545 - Aaron, Pietro Lucidario in MusicaDocumento115 pagine1545 - Aaron, Pietro Lucidario in MusicaMarco BerriniNessuna valutazione finora
- 1545 - Aaron, Pietro Lucidario in Musica - (ORIG)Documento133 pagine1545 - Aaron, Pietro Lucidario in Musica - (ORIG)Marco BerriniNessuna valutazione finora
- 1540 - Del Lago, Giovanni Breve Introduttione Di Musica Misurata - (ORIG)Documento60 pagine1540 - Del Lago, Giovanni Breve Introduttione Di Musica Misurata - (ORIG)Marco BerriniNessuna valutazione finora
- Salvetti I Musicisti Italiani Di Fronte All'europa (1908 - 1915)Documento45 pagineSalvetti I Musicisti Italiani Di Fronte All'europa (1908 - 1915)Marco BerriniNessuna valutazione finora
- 1545 - (Ca) - Aron Compendiolo Di Molti Dubbi, Segreti Et Sentenze Intorno Al Canto Fermo Et FiguratoDocumento39 pagine1545 - (Ca) - Aron Compendiolo Di Molti Dubbi, Segreti Et Sentenze Intorno Al Canto Fermo Et FiguratoMarco Berrini100% (2)
- 1540 - Del Lago, Giovanni Breve Introduttione Di Musica MisurataDocumento36 pagine1540 - Del Lago, Giovanni Breve Introduttione Di Musica MisurataMarco Berrini100% (1)
- Pedron Carlo - Manuale Di Cultura Musicale Generale (Armonia), Parte Prima - Corso Teorico - CARISCH MILANO PDFDocumento95 paginePedron Carlo - Manuale Di Cultura Musicale Generale (Armonia), Parte Prima - Corso Teorico - CARISCH MILANO PDFMarco Berrini100% (1)
- 1529 - Rossetti, Blasii Libellus de Rudimentis Musices - (LAT)Documento111 pagine1529 - Rossetti, Blasii Libellus de Rudimentis Musices - (LAT)Marco BerriniNessuna valutazione finora
- Pedron Carlo - Manuale Di Cultura Musicale Generale (Armonia), Parte Seconda - Corso Teorico-Pratico - CARISCH MILANO PDFDocumento131 paginePedron Carlo - Manuale Di Cultura Musicale Generale (Armonia), Parte Seconda - Corso Teorico-Pratico - CARISCH MILANO PDFMarco Berrini0% (1)