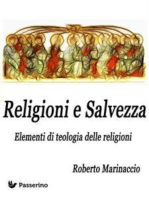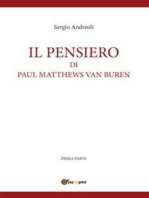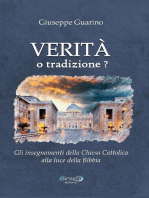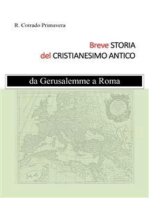Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Appunti Di Crediblilità Della Rivelazione
Caricato da
MaríaCataño0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
35 visualizzazioni9 pagineTitolo originale
Appunti di Crediblilità della rivelazione.docx
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
35 visualizzazioni9 pagineAppunti Di Crediblilità Della Rivelazione
Caricato da
MaríaCatañoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 9
PUG/20010-2011: TP1F003:
La credibilit della Rivelazione cristiana
R. D. Salvador Pi-Ninot
I. I ntroduzione: la Teologia Fondamentale:
N 1: Identit e compito della TF (1Pt 3,15): inizio come disciplina; Vaticano I (1870) e II (1962-
65); Enciclica, Fides et ratio (1988); Exhortazione Apostolica, Verbum Domini (2010); scuole
teologiche attuali: i fondamenti (scuola tedesca per la verit: Tbingen con M. Seckler, o per
il senso: Freiburg con H.J.Verweyen); la credibilit (scuola PUG: R. Latourelle, G. OCollins,
R. Fisichella, S. Pi-Ninot...); latto di fede (Milano: P.A. Sequeri)
II. Questioni di epistemologia: laccesso delluomo alla Rivelazione e la fede:
N 2: Conosci te stesso (FR introd.): luomo capax Dei, potentia oboedientialis, desiderium
naturale videndi Deum, alla ricerca del senso e della verit; riflessioni innovatrici (un autore a
scelta): B. Pascal, M. Blondel, K. Rahner, H.U. Balthasar, J. Alfaro
N 3: Loboeditio fidei (Rom 1,5; DV 5) nellAT e NT; credere Deum/Deo/in Deum; fede e ragione
nel Medioevo: Agostino, Anselmo e Tommaso; nominalismo; riforma; fideismo e razionalismo;
Vaticano I e II; rinnovamento teologico (R. Aubert, J. Alfaro, M. Seckler, A. Dulles, J.B. Libanio,
P.A. Sequeri, J. Duque, D. Hercsik)
N 4: Latto di credere come synthesis fidei: dono di Dio e ragione umana globale (sapienziale:
FR 81; aperta: J. Ratzinger; vitale: Gmez Caffarena; ordine degli affetti: P.A. Sequeri) nel
processo credente (illative sense: J.H. Newman; les yeux de la foi: P. Rousselot; opcin
fundamental: J. Alfaro; convergenza di senso: S. Pi-Ninot...); la credibilit capita come proposta
globale di senso teologica, storica e antropologica.
N 5: Luniversale concretum come categoria fondamentale della Rivelazione: Cur oeconomia
Revelationis?Cur Deus homo? Cur Ecclesia universale sacramentum salutis?
III. Proposta sistematica: Cristo-nella-Chiesa segno e testimonianza di credibilit:
N 6: Laccesso alla memoria Iesu: testimonianza di fede ed evento storico nella Cristologia
Fondamentale (At 2,32; DV 19 e 12); i criteri dautenticit (plausibilit storica; dissomiglianza, e
attestazione multipla) e i principali dati accertabili sulla vita e ministero di Ges di Nazareth
(nazareno; battezzato; proclamatore del regno di Dio; taumaturgo; convoc dodici discepoli; vicino
a Dio-Abb; critico con il tempio; fece una cena di commiato; crocifisso come re dei giudei -
titolo:INRI-; proclamato vincitore, come risorto e vivente della morte; seguito dagli iniziali
nazareni chiamati dopo cristiani e divenuti chiesa...).
N 7: Il testimonium Paschae: la testimonianza pasquale e i suoi due linguaggi nel NT (risurrezione
edesaltazione); la fides oculata come accesso allevento pasquale (Lc 24,16.31; ST III, q.55, a.2
ad1); dal corpo naturale al corpo pneumatico del Risorto (1Cor 15, 35-49: continuit e novit); i
segni e tracce del Risorto nella storia (nuovo raduno dei discepoli; incontri misteriosi con
Ges; tomba aperta; inizio, missione, testimonianza ed rapida espansione della comunit ecclesiale,
martirio degli Apostoli...).
N 8: Il mysterium Christi: la personalit di Ges e la sua pretesa ed autorit messianica (Mc
1,27; Mt 7,29); i titoli iniziali: particolarmente, Messia-Cristo e Figlio delluomo, m anche: Figlio,
Signore; la sua valenza antropologica e soteriologica universale (At 4,12; 1 Tm 2,4-5; LG 16; GS
22; RH 1).
N 9: Lecclesialit della Rivelazione come viva vox Evangelii in Ecclesia et per ipsam in mundo
(DV 8) e il Credo Apostolico (ST II-II, q.1 a.9; CEC n750); la Chiesa disegno salvifico
procedente dalla Trinit istituita da Ges Cristo (LG 2-4; lecclesiologia implicita di Ges:
Com.Teol.Internaz.-1986), nella sua tappa apostolica fondante norma per la Chiesa di tutti i
tempi (DV 4.7.18s.).
N 10: La credibilit della Chiesa: paradosso e mistero nella storia (H. de Lubac); dalla Chiesa
motivo di credibilit (Vat. I) a sacramento di Cristo (Vat. II); listituzione ecclesiale al servizio
dello Spirito di Cristo (Spiritui Christi inservit: LG 8); la testimonianza e il martirio: la Chiesa
pi credibile se d testimonianza con la propria vita (Sinodo 1985).
Testo-base: S. Pi-Ninot, La Teologia Fondamentale, Brescia 42010; La Teologa Fundamental,
Salamanca 72009; Dei Verbum religiose audiens (dispense), PUG, Roma 1999.
Complementi: R. Latourelle/R. Fisichella, edd., Dizionario di Teologia Fondamentale, Assisi
1990; vers.: sp. Ampliata da S. Pi-Ninot, 32010; fr. 1993; ingl. 1994; port. 1994; W. Kern/H.J.
Pottmeyer/M. Seckler, edd., Corso di Teologia Fondamentale 1-4, Brescia 1990; H. Verweyen, La
Parola definitiva di Dio, Brescia 2001; P.A. Sequeri, Lidea della fede.Trattato di TF, Milano 2002;
vers.sp., Salamanca 2007; S. Pi-Ninot, Eclesiologa, Salamanca 22009; vers.it., Brescia 2008;
Qu es la Iglesia?, Barcelona 2008; Cosa la Chiesa?, Brescia 2009.
La Credibilit della Rivelazione Cristiana
Testo-base: S. Pi-Ninot, La Teologia Fondamentale [= LTFital], 11-72; La Teologa
Fundamental [= LTFesp], 27-85.
Tesi n 1: Identit e compito della TF (1Pt 3,15): inizio come disciplina; Vaticano I e II; Fides et
ratio; scuole attuali: i fondamenti (scuola tedesca per la verit: Tbingen con M. Seckler; per
il senso: Freiburg con H.J. Verweyen); la credibilit (scuola PUG: R. Latourelle, G.OCollins,
R. Fisichella, S. Pi-Ninot...); latto di fede (Milano: P.A. Sequeri)
*Previa:
+la dimensione apologetica del Vangelo e della Chiesa nel primo millenio...
+inizio teologia come scienza: senza una Apologetica come disciplina (s.XII/XIII)
*1 Pt 3,15: Magna Carta della TF [LTFital: 161-165; LTFesp: 175-179]: pronti sempre a
dare risposta [apologia] a chiunque vi domandi ragione [lgos] della (fede e della) speranza che
in voi
+uso iniziale: Clemente Ales.; Origene; Eusebio; Crisostomo; Cirillo...
+da Agostino (430) alla scolastica: Anselmo OSB (1109);Tommaso OP (1274);
Bonaventura OFM (1274); con laggiunta sulla fede (solo nella, Vulgata Sixtina).
*Il contesto della nascita di questa nuova disciplina: lilluminismo (I. Kant, 1804)
*I fondatori: J.S. Drey (1853): Tbingen; G. Perrone S.J. (1876): Collegio Romano = PUG
*Vaticano I (1870): Dei Filius: doppio ordine di conoscenza di Dio: naturale per la creazione e
soprannaturale per la Rivelazione (solo un richiamo implicito a Ges Cristo: Hb 1,1!); il suo
contenuto: i misteri; la ragione illuminata dalla fede arriva a una certa conoscenza di essi per: 1)
lanalogia; 2) il nesso tra gli stessi misteri; 3) il fine ultimo delluomo. La credibilit capita
come dimostrativo-apologetica.
*Vaticano I I (1962-1965): Cristocentrismo gi dalla creazione; Ges pienezza; la Scrittura nella
Chiesa:Tradizione/Magistero (DV); Cristo-uomo/dialogo con il mondo (GS); Chiesa/sacramento
(LG)...
*Una lunga transizione fino alla Sapientia Christiana (1965-1979)
*Verso una convergenza e nuova immagine (1980-2010):
+Congresso Internazionale di TF del 1995 (PUG): convergenza: PUG e
Tbingen.
+LEnciclica, Fides et ratio (1998), n67: recupero della TF come disciplina;
+L'Exhortazione Ap. Verbum Domini (2010), 11-13: "la Cristologia della Parola"
+Momento presente...:
+scuola della PUG: teologia della credibilit : DTF/R. Latourelle, R.
Fisichella, G. OCollins, J.Wicks, C. Aparicio, C. Dotolo, D. Hercsik, S. Pi-
Ninot...+Latino-America: A.Bentu, J.B.Libanio...
+scuola tedesca: teologia dei fondamenti:
a/ verit : Tbingen con HFTh-Corso TF: M. Seckler, H. Fries, H.
Wagner, H. Waldenfels, K.H.Neufeld, J. Werbick...
b/ senso : Freiburg: H.Verweyen; cf. Kl. Mller, T. Prpper, K.-H.
Menke, S. Orth...
*area milanese: teologia della fede come coscienza credente : P.A.
Sequeri ...
Sintesi: lidentit della TF
fondare e giustificare la Rivelazione cristiana come proposta
sensata di credibilit teologica, storica e antropologica
per poter cos rendere ragione della speranza (1 Pt 3,15).
+Triplice mostrazione come proposta sensata o di senso:
Religiosa: Rivelazione e il suo accesso: uomo aperto e fede : cur oeconomia Revelationis?
Cristiana: Cristologia Fondamentale: cur Deus homo?
Cattolica: Eclesiologia Fondamentale: cur Ecclesia universale sacramentum salutis?
+Articolazione academica nei corsi istituzionali della PUG:
A/ parte dogmatica (fondativa-ermeneutica-descendente) (J.Xavier/C.Aparicio)
B/ parte apologetica (dialogale-contestuale-ascendente) (S. Pi-Ninot) +++
I.-Parte epistemologica: fides ex auditu et auditus per Verbum Christi (Rm 10,17):
laccesso delluomo alla Rivelazione ed alla fede:
dalla ricerca allaccoglimento credente della Parola di Dio.
Tesi n 2: Conosci te stesso (FR introd.): luomo capax Dei, potentia oboedientialis, desiderium
naturale videndi Deum, alla ricerca del senso e della verit; riflessioni innovatrici (un autore a
scelta): B. Pascal, M. Blondel, K. Rahner, H.U. Balthasar, J. Alfaro, J.B. Metz, H.
Verweyen...
LTFital: 73-158; LTFesp:: 89-173
*Introduzione: pistis ex akos - fides ex auditu: Rom 10,17>DV 1: Dei Verbum religiose
audiensla fede scaturisce e dipende dalla predicazione (che si ascolta)-
*Conosci te stesso: dalladagio di Delfis al socratismo cristiano (FR 1).
*Luomo capace di Dio: immagine di Dio chiamato alla visione (CCC 27 = Compedio):
-capacit recettiva: potentia oboedientialis -desiderio di Dio: desiderium naturale videndi Deum
*Riformulazioni nella teologia del secolo XX (solo un autore a scelta):
+Luomo come possibilit (M. Blondel) +Luomo, uditore della parola (K. Rahner)
+Solo lamore degno di fede (H.U. Balthasar) +Dalla questione delluomo alla di Dio (J. Alfaro)
+Larticolazione pratico-critica (J.B. Metz) +Verso un fondamento ultimo di senso (H. Verweyen).
Sintesi:
1) Riscoprire che luomo capace di conoscere la verit e anelare un senso ultimo e
definitivo:la Fides et ratio nella sua affermazione magisteriale pi solemne dice: facendo mio ci
che i Sommi Pontefici non cessano di insegnare e che lo stesso Concilio Vaticano II ha ribadito,
voglio esprimere con forza (vehementer confitemur) la convizione che luomo capace di giungere
a una visione unitaria e organica del sapere. La settorialit del sapere, in quanto comporta un
approccio parziale alla verit con la conseguente frammentazione del senso, impedische lunit
interiore delluomo contemporaneo (n85) e ribadisce: non vi oggi, infatti, preparazione pi
urgente di questa: portare agli uomini alla scoperta della loro capacit di conoscere il vero (cf. DiH
1-3) e del loro anelito verso un senso ultimo e definitivo dellesistenza (n102).
2) Luomo come movimento aperto verso il futuro (Tommaso dAquino, De Spe I ad6),
che si realizza nella rassegnazione, nella disperazione o nella speranza (CG III,48); la Fides et ratio
parla dellapertura delluomo: aprirsi alla trascendenza: n15; aprirsi alla follia della croce:
n23; una ragione aperta allassoluto: n41; limpegno filosofico almeno implicitamente aperto al
sopranaturale: n75. La fede suppone la natura e perfeziona la ragione (n43) ed per questo que
la ragione aperta diventa una via propedeutica della fede (n67; praeambula fidei) quale
condizioni di possibilit per la fede! (cf. la parabola del seminatore: il suo frutto dipende della
preparazione della terra: Mt 13,3-23).
3) Lesistenza umana vissuta a partire delle tre esperienze humane centrali:
lamore, la morte e il futuro: infatti lesperienza umana vissuta fino in fondo pu fare svelare,
nelle persone di buona volont un riferimento implicito e anomino a Cristo come quel che a vissuto
radicalmente lamore-morte-futuro portandone la pienezza (cos: K. Rahner), dato che solamente
nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero delluomo (GS 22).
Il contesto del mondo contemporaneo: auditus temporis et alterius! (qualche cenno!):
A: Il pluralismo moderno generatore della crisi di senso nella societ, porta verso la
relativizzazione con due rischi: fondamentalismo e relativismo. Conviene promuovere istituzioni
intermedie (gruppi, assoc...) fonti di senso mediatrici della societ, verso lalto (macro-istituzioni:
stato, chiesa...) e il basso (persone individuali) [cf. P.Berger/Th.Luckmann, Modernitt,1995].
B: Il pensiero postmoderno sottolinea: linteriorit e lalterit (carpe diem!).
C: La crisi della totalit dello spirito moderno viene cos a profilarsi nella forma di una
caduta di senso. In rapporto a questa situazione il pensiero escatologico si offre come
unalternativa possibile, in quanto ricerca di un senso non catturante, capace di sprigionare energie
di libert e prassi di liberazione nella storia degli uomini [B. Forte, Teol. storia, 293].
[esempii musicali: Bruce Springsteen: Everybodys got a hungry heart: Hungry Heart; U2: Mofo
+ If God will send his angels ; Drexler: 'Creo que he visto una luz al otro lado del ro; Vasco
Rossi: Voglio trovare un senso a questa vita...: Un senso...]
Tesi n 3: Loboeditio fidei (Rom 1,5; DV 5) nellAT e NT; credere Deum/Deo/in Deum; fede e
ragione nel Medioevo: Agostino, Anselmo e Tommaso; nominalismo; riforma; fideismo e
razionalismo; Vaticano I e II; rinnovamento teologico (P.Rousselot, J.Alfaro, M.Seckler, A. Dulles,
J.B.Libanio, P.A. Sequeri, J. Duque, D. Hercsik); LTFital,159-178; LTFesp, 173.192.
1: Nozione biblica: dallamen al pisteuein: adesione totale a Dio (oboeditio/hypo-ako)
2: Testi biblici tradizionali nella sua Wirkungsgeschichte [la storia degli
effetti:Pont.Com.Bibl.93]:
Is 7,9: se non crederete (nisi credideritis) non comprenderete (non intelligetis);
*locus classicus medioevale per parlare del ruolo della ragione teologica;
Eb 11,1: la fede fondamento (substantia/hypostasis) di realt che si sperano e prova
(argumentum/elenks) di realt che non si vedono;
*locus classicus tradizionale sulla definizione della fede; cf. Benedetto XVI, Spe
salvi, 7.
3: Fides Ecclesiae: Trento: fides humanae (est) salutis initium (DH 1532)
Vaticano I: +FEDE: plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium
= omaggio/sottomissione/obbedienza delle facolt dellintelletto e volont.
+MOTIVO DELLA FEDE: crediamo... a causa dellautorit testimonio- di Dio
stesso il quale non pu n ingannarsi n ingannare (DH 3008);
+rationi consentaneum confome alla ragione (DH 3008s.) e libero (DH 3035);
+i segni esterni: normalmente necessari perch la fede non sia un movimento
cieco dello spirito (DH 3010);
+lespressioni dificili: conoscere con certezza (certo conosci), provare
efficacemente (rite probari: DH 3034) e la retta ragione dimostra i fondamenti
della fede (ratio fidei fundamenta demonstret: DH 3019): gli Atti del Concilio
(edite da Mansi) spiegano che si tratta di una prova solo in qualche senso
giacch non costringente, ma che pu portare ad una certezza morale.
Vaticano II:
+DV 5: obbedienza della fede (Rom 1,5): impegno libero e totale (totum/libere)
+primato della Rivelazione cristiana sulla conoscenza a partire della creazione:
*DV 3: primato della creatio in Xto (Gv 1,3, prima che Rom 1,19s.);
*DV 6: cambio dordine del testo del Vat.I: DH 3005, previo a DH 3004.
++CEC (Catechismus Ecclesiae Catholicae), 26.144.166.181: Io credo-Noi
crediamo
++Fides et ratio:
+cap. II: Credo ut intelligam; cap III: Intelligo ut credam:
+espressioni radicate in Agostino e formulate dAnselmo
+cap.VI: Interazione tra teologia e filosofia: circolarit (n 73)
+paralellismo tra conosci te stesso (Intr.) e intelligo ut credam
(cap.III).
Cf. Tommaso: quia vero naturalis ratio per creaturas in Dei
cognitionem ascendit: fideivero cognitio a Deo in nos, e converso,
divina revelatione descendit; est autem eademvia ascensus et
descensus (CG IV,1) [testo citato in, FR n 60:Congresso].
4: La triplice formula della fede [ST II-II, q.2] e la triplice dimensione dell amen totale biblico:
a) Credere Deum [Christum] +++lamen biblico come conoscenza e confessione*
carattere Teo-centrico della rivelazione e della fede :
fides quae creditur [la fede che si crede]: il contenuto e centro della fede;
b) Credere Deo [Christo] +++lamen biblico come fiducia e sottomissione*
carattere Teo-logico della rivelazione e della fede :
fides qua creditur [la fede per la quale si crede]: il fondamento/motivo della fede;
c) Credere in Deum [in Christum] +++ lamen biblico come comunione verso la pienezza*
carattere Teo-teleologico (escatologico) della rivelazione e della fede:
fides ut via [la fede come cammino]: la finalit e termine della fede.
Tesi n 4: Latto di credere come synthesis fidei: dono di Dio e ragione umana globale ('aperta'-
'ampia': 'sapienziale' FR 41.81; J.Ratzinger; vitale: Gmez Caffarena; ordine degli affetti, P.A.
Sequeri) nel processo credente (illative sense: J.H. Newman; les yeux de la foi: P. Rousselot;
opcin fundamental: J. Alfaro; convergenza di senso: S. Pi-Ninot); la credibilit come proposta
di senso teologica, storica e antropologica. LTFital179-212; LTFesp192-225.
1: Fides Ecclesiae: gratuit, ragionevolezza e libert dellatto di credere; Il Vaticano I definisce la
gratuit soprannaturale [DH 3008; 3015] , la ragionevolezza [DH 3009] e la libert [DH 3010]
dellatto di fede; affermazioni che il Vaticano II ribadisce con una concezione pi biblica e globale
dellascolto della fede [DV 5]. Da parte sua lEnciclica Fides et ratio ha fatto una sintesi di queste
affermazioni conciliari nel cap. I sulla Rivelazione, specialmente ns.8-13 (+n 81: dimensione
sapienziale della ragione); cf. Benedetto XVI (Ratisbona:15.X.06): ragione aperta(da dove, verso
dove).
2: Il processo credente: dallanalysis alla synthesis fidei [la sintesi della (=che la) fede]:
*dalla concezione analitica (razionalista) e dialettica (fideista) alla concezione sintetica: la
fede come dono di Dio fa la sintesi giacch la causa dellatto di credere essendo la
ragione la sua condizione:
I] La Rivelazione creduta per il dono di Dio: lauto-fondazione della fede
lo Spirito Santo muove il cuore, apre gli occhi della mente (DV 5):
1) La fede come illuminazione: per lumen fidei vident esse credenda + oculata fides
(Tommaso)
2) La fede come orientamento vissuto, personale e comunicativo (DV 5.8; LG 12)
II] La Rivelazione conosciuta per la ragione storico-antropologica: la credibilit:
luomo si abbandona tutto a Dio liberamente (DV 5):
1) Praeambula fidei (preamboli della fede): via preparatoria della fede (FR 67)
2) Ratio fidei: 1) analogia; 2) nesso tra i misteri fra loro; 3) il fine delluomo (Vat I:DH
3016)
3) La ragione 'aperta' la struttura interiore -pi che previa o posteriore- dell'atto di credere:
'ragione': aperta-ampia (FR 41; J.Ratzinger); vitale (Gmez Caffarena); comunicativa
(J.Habermas); ordine degli affetti (PA.Sequeri); prattica (JB. Metz; TdL).
III] verso una sintesi:diverse formulazioni che articolano tra fede e ragione:
1) Punto di partenza: la interazione tra fede e ragione: FR cap. VI
2) Largomentazione cumulativa (Illative sense)di J. H. Newman (+A. Dulles, H.J.
Pottmeyer, W. Kasper)
3) Les yeux de la foi rendono possibile la conoscenza della credibilit di P.Rousselot
(+H.U. Balthasar, R. Fisichella)
4) Laffinit tra la rivelazione e la realizzazione piena della vita (teologia trascendentale:
K. Rahner, H. Fries, B. Welte)
5) Lopzione fondamentale dellatto di credere (personalismo: J. Alfaro, M. Seckler)
6) Conclusione: la convergenza di senso (ST III,55 a6 ad 1; S. Pi-Ninot...)
( cf. sulla certezza morale e personale della fede/credibilit: LTFital:201s./LTFesp:214s.)
3: La credibilit come proposta di senso teologica, storica e antropologica:
La credibilit come proposta di senso pieno e definitivo unisce tre aspetti: teologico,
storico e antropologico: FR 14: la Rivelazione istanza teologica- immette nella storia istanza
storica- un punto di riferimento da cui luomo istanza antropologica- non pu prescindere, se
vuole arrivare a comprendere il mistero della sua esistenza.
1-in primo luogo, conviene percepire il senso teologico pieno di una affermazione di fede
concreta: per esempio: che senso teologico ha Dio come Padre, Ges Cristo come Salvatore o la
Chiesa come Popolo di Dio?
2-in secondo luogo, bisogna analizzare il suo senso storico, cio seguendo lo stesso
esempio: come Dio-Padre, Ges-Salvatore o la Chiesa-Popolo di Dio manifestano il loro senso
nella storia attuando e essendo presenti in maniera accertabile in essa?
3-in terzo luogo, si deve vedere il suo senso antropologico, cio: come luomo resta
interpellato e pu accogliere come senso ultimo e definitivo questa rivelazione di Dio-Padre, di
Ges-Salvatore e della Chiesa-Popolo di Dio?
Cos, la credibilit mostrata attraverso questa proposta permetter trovare tale pienezza di
senso nelle affermazioni teologiche (n1) presenti nella storia (n2): la vita umana personale e
comunitaria (n3) pu diventare piena di senso se questa vita si realizza alla sua luce. Sar cos che
si potr affermare che sono degne de fede (credibilia) le tue testimonianze, Signore (Sal 93,5;
prima volta alla Bibbia!), giacch in verit credibile/affidabile [pists] il Dio che ci ha chiamato
a vivere nella comunione [koinnia] con il suo Figlio Ges Cristo, nostro Signore (1Cor 1,9)!
Tesi n 5: Luniversale concretum come categoria fondamentale della Rivelazione: Cur oeconomia
Revelationis? Cur Deus homo? Cur Ecclesia universale sacramentum salutis?
LTFital: 258-282; LTFesp:: 274-297.
1: Luniversale concretum: uso, storia e prospettive:
a-origine delluso delluniversale concretum: universale ante (previo)-post (posteriore)-in re:
[universale], questo massimo che insieme concreto [concretum] e assoluto, lo chiamamo
Ges (Niccol Cusano);
*luso nellIlluminismo tedesco e lassioma di Lessing: possibile provare una verit eterna a
partire da un fatto storico?;
*risposte: S. Kierkegaard/R. Bultmann/K. Barth/J.E. Newman/K. Rahner/H.U. Balthasar/H.
Verweyen...
b-prospettive: Fides et raio, n11s.; Dominus Iesus, n15: diverse espressioni:
unicit/universalit/assolutezza".
Universale concretum personale (Balthasar); carattere assoluto del cristianesimo (Rahner/Kasper);
sacramentale (Pi-Ninot).
2: Cur oeconomia Revelationis ?: leconomia della ricapitolazione in Cristo:
a-punto di partenza: Ef 1,10: in vista delleconomia della pienezza dei tempi: cio di ricapitolare
[ana-kefalaisis] in Cristo tutte le cose; Ireneo, Crisostomo,Tommaso, Raimondo Lullio, N.
Cusano, Teilhard de Chardin
b-riflessione teologica: lo zelo che Dio ha: Sal 69,10; 119,139 (= ted. der Eifer Gottes; spag:
el cielo de Dios; ingl: the Zeal of God; franc: le zle de Dieu), cio il suo amore (Gv 13,1)
e amicizia (Gv 14,13;DV 6: come amici), che sempre pi simpone nel corso della storia,
attraverso il desiderio di rendere palesemente esplicita quella storia della rivelazione generale che
si verifica sempre e dovunque (GS 22; LG 13.16; AG 7) e portarla alla sua pienezza giacch Cristo
la pienezza dellintera rivelazione: (DV 2; cf. 4). Per Tommaso la rivelazione porta che la
conoscenza di Dio sia pi universale, pi facile e senza errore (ST II-II,q.2 a.4c); testo ripreso dal
Vaticano I, con piccole varianti (DH 3005), e dal Vaticano II (DV 6); in pi, il Vaticano II afferma
che il plus cristiano porta alla pienezza totale, dato che solamente nel mistero del Verbo
incarnato trova vera luce il mistero delluomo (GS 22).
c-perch la Rivelazione ha tardato tanto?: novus nove venire voluit (Tertulliano); Ecclesia ab
Abel (LG 2)
3: Cur Deus homo ?: propter nostram salutem (Credo Nicenum:, anno 325) e Anselmo
a-punto di partenza: la pro-esistenza di Ges oil suo servizio agli altri (Lc 22,19/Mc 14,24 = Is
53,11s.).
b-Cristo: luniversale concretum personale: reciprocit tra solidariet divina ed umana (III, q.48,
a.2 ad 1).
c-Cristo nel pluralismo religioso: triplice modello : Comissione Teologica Internazionale,1996,
ns. 9-12: 1) esclusivista-ecclesiocentrico; 2) inclusivista-cristocentrico; 3) pluralista-
teocentrico.
d-Proposta teologica: lassolutezza-relazionale di Ges, il Cristo:
*integrativa: tutto ci che di buono e di vero si trova come preparazione evangelica:
LG 16;
*missionaria: funzioni: sanans,elevans,consumans a fin che Xto. sia capo del mondo
intero: LG 17;
+non sono escluse mediazioni partecipate di vario tipo e ordine, che attingono
significato e valore unicamente da
quella di Cristo e non possono essere intese come parellele e complementari (RMi 5;
Dominus Iesus, 14).
4: Cur Ecclesia universale sacramentum salutis ?:
la visibilit ecclesiale a servizio dello Spirito di Cristo (LG 8):
a-punto di partenza: la Chiesa come complessa realt (complexa realitas); cos come "la natura
umana assunta serve (inservit: LG 8) al Verbo, lorganismo sociale ecclesiale serve (inservit: LG 8)
allo Spirito di Cristo; questo che fa diventare la Chiesa sacramento. sacramento, perch
significando [cio: segno] causat [cio: strumento] (Tommaso): segno significativo-
manifestativo (K. Rahner/L.M. Chauvet) ed strumento causale-comunicativo (O. Semmelroth/A.
Antn), tutto verso la finalit della Chiesa che : lintima unione con Dio filiazione- e lunit di
tutto il genere umano -fraternit (LG 1).
b-Lorientamento/ordinazione alla Chiesa: alla Chiesa sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia
gli altri credenti in Xto. e tutti gli uomini (LG 13); coloro che non hanno ancora accolto il
Vangelo, sono ordinati in vari modi (LG 16); cf. LG 2: Ecclesia ab Abel; RMi 10: tutta grazia ha
una misteriosa relazione con la Chiesa; RMi 55: la Chiesa via ordinaria della salvezza.
c-La Chiesa: universale concretum sacramentale della Rivelazione: come segno una portata
universale e come strumento una efficacia storica concreta. Il valore universale della Chiesa si
fonda nell'universalit di Ges Cristo, altrimenti ci si potrebbe domandare se l'azione di Cristo
sarebbe affermabile, se non ci fosse un qualche segno storico della sua presenza. Dato che "tutto ci
che di bene il popolo di Dio pu offrire all'umana famiglia, nel tempo del suo pellegrinaggio terreno
scaturisce dal fatto che la Chiesa universale sacramentum salutis (cf. GS 45).
Potrebbero piacerti anche
- Path N. 2 - 2002 - Dominus IesusDocumento272 paginePath N. 2 - 2002 - Dominus IesusWalter PerelloNessuna valutazione finora
- Teologia Fondamentale - PatschDocumento56 pagineTeologia Fondamentale - PatschGarrett Johnson100% (1)
- AA - Vv. - Dizionario Di Spiritualità Biblico-Patristica. Gesù-Cristo Nei Padri Della Chiesa (I-III Secolo) - Vol. 24-Borla (2000)Documento305 pagineAA - Vv. - Dizionario Di Spiritualità Biblico-Patristica. Gesù-Cristo Nei Padri Della Chiesa (I-III Secolo) - Vol. 24-Borla (2000)Koiujluy HjuioupyNessuna valutazione finora
- Religioni e Salvezza: Elementi di teologia delle religioniDa EverandReligioni e Salvezza: Elementi di teologia delle religioniNessuna valutazione finora
- Mysterium Salutis PDFDocumento646 pagineMysterium Salutis PDFAntonio Mucci50% (2)
- MARCELLO SEMERARO - Mistero, Comunione e Missione - Manuale Di EcclesiologiaDocumento268 pagineMARCELLO SEMERARO - Mistero, Comunione e Missione - Manuale Di EcclesiologiaIvan Terze67% (3)
- Tradizione Fonte Di Teologia Sistematica-1Documento30 pagineTradizione Fonte Di Teologia Sistematica-1Raul Jose Sanchez CoronaNessuna valutazione finora
- Sviluppo Della Teologia Trinitaria Nei PadriDocumento22 pagineSviluppo Della Teologia Trinitaria Nei Padribrunomorabito100% (2)
- IL PENSIERO DI PAUL MATTHEWS VAN BUREN - volumetto 1Da EverandIL PENSIERO DI PAUL MATTHEWS VAN BUREN - volumetto 1Nessuna valutazione finora
- Verità o tradizione?: Gli insegnamenti della Chiesa Cattolica Romana alla luce della Parola di DioDa EverandVerità o tradizione?: Gli insegnamenti della Chiesa Cattolica Romana alla luce della Parola di DioNessuna valutazione finora
- TF Esame ItaDocumento9 pagineTF Esame ItaFr Jesmond MicallefNessuna valutazione finora
- 1.DISPENSA Teologia 1 AA. 15-16Documento150 pagine1.DISPENSA Teologia 1 AA. 15-16Sandro Del-Vitto100% (1)
- La Via Che Conduce Alla Santita: Uno studio di Colossessi e FilemoneDa EverandLa Via Che Conduce Alla Santita: Uno studio di Colossessi e FilemoneNessuna valutazione finora
- Henn - Storia Del Movimento EcumenicoDocumento21 pagineHenn - Storia Del Movimento EcumenicoMarinM12345Nessuna valutazione finora
- Commento Al Credo (L18 - L36)Documento56 pagineCommento Al Credo (L18 - L36)Fabio EliaNessuna valutazione finora
- Iniziazione CristianaDocumento98 pagineIniziazione CristianaPablo Rizo100% (2)
- 15-Stefano M. Manelli - Agiografia Corredenzionista Nel Secolo Ventesimo - Sintesi Storico-TeologicaDocumento117 pagine15-Stefano M. Manelli - Agiografia Corredenzionista Nel Secolo Ventesimo - Sintesi Storico-Teologicamaxi sasasdNessuna valutazione finora
- I Fondamenti Dell'Ordine Sociale, Di R. J. RushdoonyDocumento155 pagineI Fondamenti Dell'Ordine Sociale, Di R. J. RushdoonypcastellinaNessuna valutazione finora
- Cristologia - Parte Sistematica 2013-2014Documento84 pagineCristologia - Parte Sistematica 2013-2014deborahreali919Nessuna valutazione finora
- 7 2 PDFDocumento240 pagine7 2 PDFAnonymous WJkYAFNessuna valutazione finora
- Storia Dei Dogmi. Luomo e La Sua Salvezza. v-XVII 5411098Documento542 pagineStoria Dei Dogmi. Luomo e La Sua Salvezza. v-XVII 5411098Virginia Di Rito100% (1)
- CTI La Teologia Oggi - Prospettive, Pricipi e CriteriDocumento27 pagineCTI La Teologia Oggi - Prospettive, Pricipi e CriteriAlex MagnoNessuna valutazione finora
- Il Quinto Vangelo: secondo la Cronaca dell'AkashaDa EverandIl Quinto Vangelo: secondo la Cronaca dell'AkashaNessuna valutazione finora
- Oleksowicz Fede e Ragione in TommasoDocumento24 pagineOleksowicz Fede e Ragione in TommasocapitankonigNessuna valutazione finora
- Progetto di Dio. La creazione: Meditazioni sulla creazione e la ChiesaDa EverandProgetto di Dio. La creazione: Meditazioni sulla creazione e la ChiesaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)
- Sintesis de Pie NinotDocumento42 pagineSintesis de Pie Ninotisaias100% (2)
- Cosa può il libero arbitrio: Libertà dell’io o libertà con DioDa EverandCosa può il libero arbitrio: Libertà dell’io o libertà con DioNessuna valutazione finora
- 13 - 2 La STORICITÀ Della RISURREZIONE I DocumentiDocumento36 pagine13 - 2 La STORICITÀ Della RISURREZIONE I DocumentiPaolopiniNessuna valutazione finora
- Ecclesiologia ElaboratoDocumento12 pagineEcclesiologia ElaboratoTomi RistovNessuna valutazione finora
- Libro 7 Bi TCHDocumento180 pagineLibro 7 Bi TCHJian TG SapienzaNessuna valutazione finora
- La Visione Del Dio Invisibile Nel Volto Del CrocifissoDocumento110 pagineLa Visione Del Dio Invisibile Nel Volto Del CrocifissoDaniel Prieto DonosoNessuna valutazione finora
- Catechismo Di Heidelberg (1563)Documento61 pagineCatechismo Di Heidelberg (1563)xsonalcomputerNessuna valutazione finora
- Concilio Vaticano IiDocumento70 pagineConcilio Vaticano IiSérgio LealNessuna valutazione finora
- Corso Di EscatologiaDocumento131 pagineCorso Di EscatologiaMauro CatenazziNessuna valutazione finora
- Elementi Di Teologia FondamentaleDocumento83 pagineElementi Di Teologia Fondamentalemauriziolapuca100% (1)
- Trinità Economica e Trinità Immanente - Dibattito e Prospettive IDocumento23 pagineTrinità Economica e Trinità Immanente - Dibattito e Prospettive IMassimo BenvenutiNessuna valutazione finora
- Ottorino Pasquato, Iniziazione Pagana e Iniziazione Cristiana (I-III Sec.) Le Vie Della Salvezza PDFDocumento19 pagineOttorino Pasquato, Iniziazione Pagana e Iniziazione Cristiana (I-III Sec.) Le Vie Della Salvezza PDFPricopi VictorNessuna valutazione finora
- Andrea Lonardo - Catechesi KerygmaticaDocumento30 pagineAndrea Lonardo - Catechesi KerygmaticaDiego LopesNessuna valutazione finora
- L EucaristiaDocumento43 pagineL Eucaristiagogel26Nessuna valutazione finora
- Il Dio della fede e il Dio dei filosofi: Nuova Edizione con Postfazione di Massimo EpisDa EverandIl Dio della fede e il Dio dei filosofi: Nuova Edizione con Postfazione di Massimo EpisValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (4)
- Marcello Bordoni EscatologiaDocumento24 pagineMarcello Bordoni EscatologiaMarco MagnaghiNessuna valutazione finora
- Cozzi, La ResurrecciónDocumento27 pagineCozzi, La Resurrecciónjuanmanuel11Nessuna valutazione finora
- Aumann Spiritualita'Documento330 pagineAumann Spiritualita'Harold CamposNessuna valutazione finora
- SM 48-1 2010Documento280 pagineSM 48-1 2010gmendessjNessuna valutazione finora
- CantalamessaDocumento11 pagineCantalamessaCarlos E Reynoso TostadoNessuna valutazione finora
- Dispensa Iniziaz. Crist. Introduzione Generale Con ApparaDocumento14 pagineDispensa Iniziaz. Crist. Introduzione Generale Con ApparaPablo RizoNessuna valutazione finora
- Henn - Storia Del Movimento EcumenicoDocumento21 pagineHenn - Storia Del Movimento EcumenicoMarinM12345Nessuna valutazione finora
- Sacramentos de Iniciacion - I. (Carlos Rocetta)Documento206 pagineSacramentos de Iniciacion - I. (Carlos Rocetta)acolmenareslcNessuna valutazione finora
- Dialnet DialogoInterreligioso 5364177Documento10 pagineDialnet DialogoInterreligioso 5364177luis carboneroNessuna valutazione finora
- (Studi Biblici 71) Jacques Dupont, Giuseppe Barbaglio (Editor) - Teologia Della Chiesa Negli Atti Degli Apostoli-EDB (2015)Documento156 pagine(Studi Biblici 71) Jacques Dupont, Giuseppe Barbaglio (Editor) - Teologia Della Chiesa Negli Atti Degli Apostoli-EDB (2015)Nelson SáNessuna valutazione finora
- Latourelle, R. - RivelazioneDocumento54 pagineLatourelle, R. - Rivelazionejoaobrandaosj100% (4)
- La Coscienza Che Gesù Aveva Di Se Stesso e Della Sua Missione, 1985Documento9 pagineLa Coscienza Che Gesù Aveva Di Se Stesso e Della Sua Missione, 1985DanielNessuna valutazione finora
- Ortodossia e TeologiaDocumento3 pagineOrtodossia e TeologiaMaría CatañoNessuna valutazione finora
- Appunti Di Crediblilità Della RivelazioneDocumento9 pagineAppunti Di Crediblilità Della RivelazioneMaríaCatañoNessuna valutazione finora
- RatzingerDocumento5 pagineRatzingerMaríaCataño0% (1)
- Appunti Del PentateucoDocumento31 pagineAppunti Del PentateucoMaríaCataño100% (2)