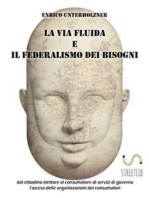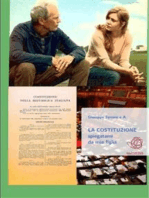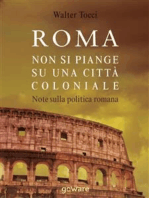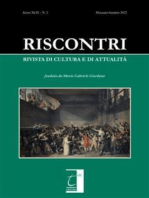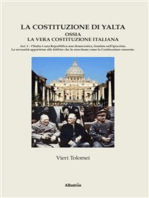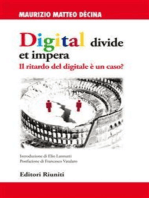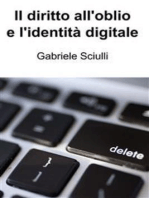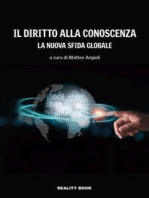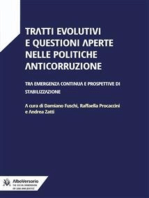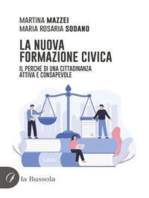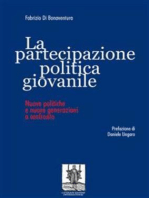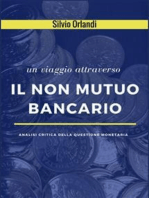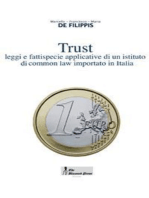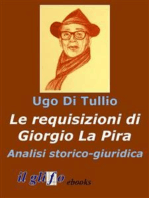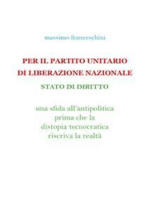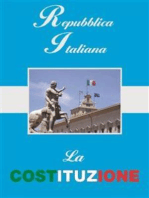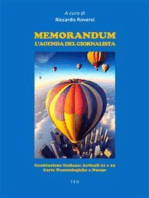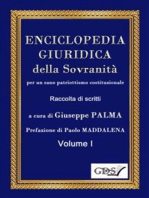Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Nessuno Tocchi I Lobbisti - Huffingtonpost - It, 26 Gennaio 2023
Caricato da
Università degli Studi di Urbino Carlo BoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Nessuno Tocchi I Lobbisti - Huffingtonpost - It, 26 Gennaio 2023
Caricato da
Università degli Studi di Urbino Carlo BoCopyright:
Formati disponibili
URL :http://Huffingtonpost.
it/
Huffingtonpost.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public
26 gennaio 2023 - 10:16 > Versione online
Nessuno tocchi i lobbisti - HuffPost Italia
Riuscire a non confondere consulenti attivi nel public affairs con criminali e faccendieri,
rappresenta un prerequisito per un sistema democratico in salute. In tal senso, le
vicende giudiziarie legate al Qatargate potrebbero rappresentare uno spartiacque per
concretizzare una legislazione realmente compiuta
26 Gennaio 2023 alle 11:10
Le indagini sono ancora in corso ed è giusto che i processi li facciano magistrati capaci e
non i media. Una cosa però possiamo già dirla: il Qatargate ha scoperto l’acqua calda.
Dov’è la novità in questo presunto caso di corruzione? Da nessuna parte. Parliamo di un
reato che esiste dall’alba dei tempi, a Bruxelles come a Strasburgo, a Parigi come a
Roma, a Doha come a Chicago. Questo non significa che non sia grave, ma è una piaga
che tutti abbiamo imparato a conoscere a nostre spese.
Un morbo che, in una certa percentuale, investe anche la politica, ça va sans dire. Al
contrario, una riflessione forse più urgente andrebbe sviscerata sull’attività di lobbying in
Italia e in Europa. Per farla occorre partire da un presupposto: i lobbisti sono una
componente fondamentale dei sistemi democratici. Chi afferma il contrario
probabilmente ignora l’attività svolta dagli specialisti delle relazioni istituzionali e
potrebbe non aver mai visto un lobbista all’opera. Rappresentare seriamente gli interessi
delle imprese, dei volontari, delle più eterogenee categorie della società civile di fronte ai
decisori, offrendo a questi ultimi il quadro completo e dettagliato su singole istanze, è
una attività non solo legittima ma anche fortemente auspicabile. I lobbisti seri fanno
questo e lo fanno alla luce del sole. I consulenti specializzati nel public affairs
dispongono di strumenti divulgativi, comunicativi, relazionali e di monitoraggio legislativo
che spesso cittadini, imprese ed altre categorie non possiedono o comunque non con
quegli standard di qualità richiesti per influenzare realmente processi complessi.
In Italia, la diffusa percezione fuorviante delle relazioni Istituzionali è riconducibile non
solo a una parziale mancanza di lucidità cronistica e di qualità analitica che investe
alcuni canali di informazione, ma anche e soprattutto alla mancata regolamentazione dei
gruppi di pressione. Su questo il legislatore ha responsabilità incontrovertibili.
I gruppi di interesse hanno tutt’altro che un’origine recente. Il concetto di lobby deriva dal
mondo anglosassone, termine che indicava l’anticamera della House of Commons in cui
era possibile incontrare i rappresentanti dei cittadini prima o dopo le divisions (votazioni).
I capostipiti della regolamentazione in tal senso sono gli Stati Uniti, universalmente
riconosciuti patria delle lobbies. Come magistralmente illustrato nella Rivista di Scienze
Giuridiche dell'Università di Urbino dai Prof. Polidori e Sestili, a cui si rimanda per
ulteriori approfondimenti, la cultura nazionale sui gruppi di interesse americani è di
origine costituzionale e si fa risalire al Primo Emendamento del 1791 che, con
un’intelaiatura nei fatti chiaramente liberale, garantiva ai cittadini e ai gruppi organizzati il
Tutti i diritti riservati
URL :http://Huffingtonpost.it/
Huffingtonpost.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public
26 gennaio 2023 - 10:16 > Versione online
diritto di far sentire la propria voce cercando di limitare contemporaneamente il potere
del Governo. Questo legittimò fin da subito la creazione delle lobbies in quanto il
principio democratico statunitense è fondato anche sul riconoscimento del diritto dei
gruppi di affari o di interessi a sottoporre un proprio problema all’attenzione del corpo
legislativo. Da lì in poi, gli Usa hanno ulteriormente implementato la legislazione sul
lobbying diventando il punto di riferimento delle grandi democrazie occidentali.
Discorso diverso vale per l’Unione Europea e per gli Stati membri. Già nel 1995 il
Parlamento Europeo si è dotato di un “Registro per la trasparenza” rivelatosi
fondamentale per il monitoraggio delle attività dei gruppi di interesse. Nel 2008 è stato
poi il turno della Commissione Europea ed entrambe le regolamentazioni sono risultate
propedeutiche per sancire l’Accordo Inter-Istituzionale che ha dato vita ad un registro
comune per Parlamento e Commissione. Questo processo ha raggiunto, nel 2016, come
risultato finale l’adozione di un registro obbligatorio per tutte le Istituzioni Europee. Nel
Vecchio Continente Francia, Regno Unito, Germania (dal 2021), Irlanda, Polonia,
Austria, Lituania ed altri già contano su una chiara legislazione in materia di
rappresentanza di interessi. In questo scenario occidentale, il quadro normativo italiano
probabilmente rappresenta quello meno edificante. Nell’aprile 2016 viene approvata la
“Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei
Deputati”, entrata in vigore a marzo 2017, la quale prevede un Registro “volontario”
attraverso cui potenzialmente gestire gli incontri all’interno di Montecitorio. Non solo i
risultati di questo Registro si sono rivelati a dir poco modesti (sono stati rilevati solo 150
incontri nei primi tre anni di vigenza) ma anche il connotato di volontarietà del Registro
suggerisce già l’incompiutezza del quadro normativo.
Uno scenario aggravato soprattutto dalla mancanza pressoché totale di
regolamentazione in materia presso il Senato della Repubblica e gli organi di governo,
con l’eccezione di alcuni Ministeri tra cui: Sviluppo economico, Lavoro e Politiche sociali,
Agricoltura, Infrastrutture, Transizione ecologica (governo Draghi). Norme assenti anche
per la maggior parte dei governi delle Regioni: solo Toscana, Calabria, Lombardia,
Molise, Abbruzzo ed in certa misura Sicilia dispongono di regolamenti (efficaci o meno)
in materia, mentre nelle altre Regioni siamo fermi, nel migliore dei casi, a delle proposte
di legge che continuano ad incontrare non pochi ostacoli anche a livello locale nazionale.
Il caso più recente è rappresentato dalla proposta di legge approvata nel gennaio 2022
dall’Assemblea della Camera, divenuta lettera morta con la crisi del governo Draghi.
Si intuisce dunque che su questa materia, così come su altri temi tra cui le “porte
girevoli” (“revolving doors” o “pantouflage”), la politica ha ormai i giorni contati. Se
davvero esiste una nota positiva relativa all’intera vicenda Qatargate è il suo indiretto
contributo a velocizzare questo processo di regolamentazione. Volendo accantonare per
un momento il Legislatore, è intellettualmente onesto affermare che anche l’opinione
pubblica non può esimersi dal fare uno scatto in avanti.
Quando abbiamo la necessità di trovare un accordo patrimoniale in famiglia ci rivolgiamo
ad un mediatore super-partes, quando dobbiamo vendere casa chiamiamo l’agente
immobiliare, se dobbiamo difendere i nostri interessi o quelli della nostra società davanti
a un giudice contattiamo l’avvocato. Allo stesso modo, quando riscontriamo la necessità
di presentare come si deve un’istanza ad un politico ci possiamo rivolgere ai lobbisti.
Attenzione: “possiamo” non “dobbiamo”. Nulla evita ad un cittadino comune di scrivere in
prima persona un articolo di giornale, una lettera ad un Ministro, di partecipare ad un
evento pubblico in cui presenziano Sottosegretari, Senatori, Consiglieri regionali e di
farsi avanti. L’efficacia, tuttavia, di questi tentativi varia in base alla complessità del
fenomeno ed alle competenze tecniche e comunicative dei singoli cittadini o dei loro
raggruppamenti. Se non possediamo determinati strumenti relazionali e conoscenze
legislative sarebbe forse più saggio chiedere un parere a chi è del settore.
Tutti i diritti riservati
URL :http://Huffingtonpost.it/
Huffingtonpost.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public
26 gennaio 2023 - 10:16 > Versione online
Riuscire a non confondere consulenti attivi nel public affairs con criminali e faccendieri
rappresenta un prerequisito per un sistema democratico in salute. In tal senso, le
vicende giudiziarie riguardanti Panzeri, Kaili, Giorgi e tutti gli indagati dell’inchiesta
“Qatargate”, se ben interpretate, potrebbero rappresentare uno spartiacque
fondamentale per concretizzare una legislazione realmente compiuta e realizzare quel
cambio di paradigma culturale su cui, rispetto ad altre grandi democrazie, registriamo
tuttora un grave ritardo.
Tutti i diritti riservati
Potrebbero piacerti anche
- E-Politics: Riflessioni per una nuova dialettica politicaDa EverandE-Politics: Riflessioni per una nuova dialettica politicaNessuna valutazione finora
- La via fluida e il federalismo dei bisogni: Stimoli per la transizione dal cittadino elettore a cittadino consumatore di servizi pubbliciDa EverandLa via fluida e il federalismo dei bisogni: Stimoli per la transizione dal cittadino elettore a cittadino consumatore di servizi pubbliciNessuna valutazione finora
- I segreti di Tangentopoli. 1992: l'anno che ha cambiato l'ItaliaDa EverandI segreti di Tangentopoli. 1992: l'anno che ha cambiato l'ItaliaNessuna valutazione finora
- Rispettare la Costituzione. Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica secondo l'Assemblea CostituenteDa EverandRispettare la Costituzione. Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica secondo l'Assemblea CostituenteNessuna valutazione finora
- Fondazioni, Associazioni, Terzo Settore e il VolontariatoDa EverandFondazioni, Associazioni, Terzo Settore e il VolontariatoNessuna valutazione finora
- Cara Ministra Madia: La Riforma della Pubblica Amministrazione - DIGITALE????Da EverandCara Ministra Madia: La Riforma della Pubblica Amministrazione - DIGITALE????Nessuna valutazione finora
- Così il digitale ci cambia la vita – Web nostrum 3Da EverandCosì il digitale ci cambia la vita – Web nostrum 3Nessuna valutazione finora
- Il diritto penale come etica pubblica: Considerazioni sul politico quale “tipo d'autore”Da EverandIl diritto penale come etica pubblica: Considerazioni sul politico quale “tipo d'autore”Nessuna valutazione finora
- Roma: non si piange su una città coloniale. Note sulla politica romanaDa EverandRoma: non si piange su una città coloniale. Note sulla politica romanaNessuna valutazione finora
- Riscontri. Rivista di cultura e di attualità: N. 2 (MAGGIO-AGOSTO 2022)Da EverandRiscontri. Rivista di cultura e di attualità: N. 2 (MAGGIO-AGOSTO 2022)Nessuna valutazione finora
- Testo 29 Luglio 2012 Senza RifDocumento197 pagineTesto 29 Luglio 2012 Senza RifValerio RubinoNessuna valutazione finora
- 1981: il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia: Come nacque la dittatura dei mercati finanziariDa Everand1981: il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia: Come nacque la dittatura dei mercati finanziariValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- CITTADINANZA DIGITALE: Come utilizzare la rete in modo consapevole ed efficaceDa EverandCITTADINANZA DIGITALE: Come utilizzare la rete in modo consapevole ed efficaceNessuna valutazione finora
- Relazione Teresa Congresso RoccellaDocumento20 pagineRelazione Teresa Congresso RoccellaTeresa PetrangoliniNessuna valutazione finora
- Digital divide et impera: Il ritardo del digitale è un caso?Da EverandDigital divide et impera: Il ritardo del digitale è un caso?Nessuna valutazione finora
- Il diritto alla conoscenza: La nuova sfida globaleDa EverandIl diritto alla conoscenza: La nuova sfida globaleNessuna valutazione finora
- Sud l'Italia che non c'è: Dall'Unità alla secessione dei ricchi?Da EverandSud l'Italia che non c'è: Dall'Unità alla secessione dei ricchi?Nessuna valutazione finora
- Caleidoscopio: Idee - pensieri - fantasie - desideri - viaggi - follie ed emozioniDa EverandCaleidoscopio: Idee - pensieri - fantasie - desideri - viaggi - follie ed emozioniNessuna valutazione finora
- Il vangelo secondo Matteo: la Costituzione di RenziDa EverandIl vangelo secondo Matteo: la Costituzione di RenziNessuna valutazione finora
- Tratti evolutivi e questioni aperte nelle politiche anticorruzione: Tra emergenza continua e prospettive di stabilizzazioneDa EverandTratti evolutivi e questioni aperte nelle politiche anticorruzione: Tra emergenza continua e prospettive di stabilizzazioneNessuna valutazione finora
- Soldi per niente? Tutte le forme di finanziamento dei partiti politiciDa EverandSoldi per niente? Tutte le forme di finanziamento dei partiti politiciNessuna valutazione finora
- Rompere gli ormeggi e navigar per l'aperto mare. Un programma di riforme per l‘ItaliaDa EverandRompere gli ormeggi e navigar per l'aperto mare. Un programma di riforme per l‘ItaliaNessuna valutazione finora
- La nuova formazione civica: Il perché di una cittadinanza attiva e consapevoleDa EverandLa nuova formazione civica: Il perché di una cittadinanza attiva e consapevoleNessuna valutazione finora
- La partecipazione politica giovanile: Nuove politiche e nuove generazioni a confrontoDa EverandLa partecipazione politica giovanile: Nuove politiche e nuove generazioni a confrontoNessuna valutazione finora
- Cittadini senza politica. Politica senza cittadiniDa EverandCittadini senza politica. Politica senza cittadiniNessuna valutazione finora
- La Terza repubblica della TV: Grillo, Celentano, Baudo e molto prima Guglielmo Giannini: quelli che fecero l'impresa. Senza saperlo.Da EverandLa Terza repubblica della TV: Grillo, Celentano, Baudo e molto prima Guglielmo Giannini: quelli che fecero l'impresa. Senza saperlo.Nessuna valutazione finora
- Alla ricerca della legalità perduta. Gioca il tuo ruoloDa EverandAlla ricerca della legalità perduta. Gioca il tuo ruoloNessuna valutazione finora
- Il non mutuo bancario: Analisi critica della questione monetariaDa EverandIl non mutuo bancario: Analisi critica della questione monetariaNessuna valutazione finora
- S.O.S. Stato di Diritto: Verso il diritto alla conoscenzaDa EverandS.O.S. Stato di Diritto: Verso il diritto alla conoscenzaNessuna valutazione finora
- Buon governo un mito? Le Regioni rosse. Perché la riforma dello Stato ne ha bisognoDa EverandBuon governo un mito? Le Regioni rosse. Perché la riforma dello Stato ne ha bisognoNessuna valutazione finora
- I quaderni dei seminari della Fondazione YMCA: Raccolta periodica di autorevoli contributi degli esperti di Fondazione YMCA ItaliaDa EverandI quaderni dei seminari della Fondazione YMCA: Raccolta periodica di autorevoli contributi degli esperti di Fondazione YMCA ItaliaNessuna valutazione finora
- 16 03 2015 Gazzetta Tricolore 34Documento18 pagine16 03 2015 Gazzetta Tricolore 34Nicola MisciaNessuna valutazione finora
- Le requisizioni di Giorgio La Pira. Analisi storico-giuridicaDa EverandLe requisizioni di Giorgio La Pira. Analisi storico-giuridicaNessuna valutazione finora
- Per Il Partito Unitario Di Liberazione NazionaleDa EverandPer Il Partito Unitario Di Liberazione NazionaleNessuna valutazione finora
- Il Federalismo Belga . L’equilibrio istituzionale federale del Regno del BelgioDa EverandIl Federalismo Belga . L’equilibrio istituzionale federale del Regno del BelgioNessuna valutazione finora
- Potere & Poteri. Il backstage della politica calabreseDa EverandPotere & Poteri. Il backstage della politica calabreseNessuna valutazione finora
- Lo Stato Deccezione Dellordinamento Giuridico ItalianoDocumento11 pagineLo Stato Deccezione Dellordinamento Giuridico ItalianoRaffaele ImbrognoNessuna valutazione finora
- ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionaleDa EverandENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionaleNessuna valutazione finora
- Un Manuale Di Difesa Contro Lusura e Lestorsione2Documento64 pagineUn Manuale Di Difesa Contro Lusura e Lestorsione2Athletic_ProjectNessuna valutazione finora
- Ritrovato Schifano " Smarrito": 7 Aprile 2023 - Edizione PesaroDocumento3 pagineRitrovato Schifano " Smarrito": 7 Aprile 2023 - Edizione PesaroUniversità degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Katia Migliori Nel Ricordo Di Massimo Raffaeli - Il Manifesto Dell'8 Aprile 2023Documento1 paginaKatia Migliori Nel Ricordo Di Massimo Raffaeli - Il Manifesto Dell'8 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Alvarez: I Laureati Devono Lavorare Qui - Il Corriere Adriatico Del 7 Aprile 2023Documento2 pagineAlvarez: I Laureati Devono Lavorare Qui - Il Corriere Adriatico Del 7 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Il Sigillo A Pagnini Eil Valore Del Dialetto - Il Resto Del Carlino Del 7 Aprile 2023Documento1 paginaIl Sigillo A Pagnini Eil Valore Del Dialetto - Il Resto Del Carlino Del 7 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Ritrovato Lo Schifano Smarrito - Il Resto Del Carlino Del 7 Aprile 2023Documento1 paginaRitrovato Lo Schifano Smarrito - Il Resto Del Carlino Del 7 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Andavamo in Colonia: Il Nuovo Libro Di Stefano Pivato - Il Corriere Della Sera Dell'8 Aprile 2023Documento4 pagineAndavamo in Colonia: Il Nuovo Libro Di Stefano Pivato - Il Corriere Della Sera Dell'8 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Campionato Nazionale Delle Lingue, Ecco I Vincitori - Vivere Marche - It, 5 Aprile 2023Documento2 pagineCampionato Nazionale Delle Lingue, Ecco I Vincitori - Vivere Marche - It, 5 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Addio A Katia Migliori - Il Metauro - It, 6 Aprile 2023Documento3 pagineAddio A Katia Migliori - Il Metauro - It, 6 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Katia Migliori, Il Ricordo Di Belfiori e Ferri - Fanonotizie - It, 6 Aprile 2023Documento2 pagineKatia Migliori, Il Ricordo Di Belfiori e Ferri - Fanonotizie - It, 6 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Addio A Katia Migliori, Intellettuale Raffinata - Il Resto Del Carlino Del 6 Aprile 2023Documento1 paginaAddio A Katia Migliori, Intellettuale Raffinata - Il Resto Del Carlino Del 6 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Tutta La Cultura in Lutto Per La Morte Di Katia Migliori - Il Corriere Adriatico Del 6 Aprile 2023Documento2 pagineTutta La Cultura in Lutto Per La Morte Di Katia Migliori - Il Corriere Adriatico Del 6 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Tumori, Molecola Capace Di Modificare L'epigenetica Delle Cellule - La Sicilia Del 1 Aprile 2023Documento3 pagineTumori, Molecola Capace Di Modificare L'epigenetica Delle Cellule - La Sicilia Del 1 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Miranda Galbusera Vince Il Campionato Delle Lingue in Spagnolo - Lecco Notizie - It, 6 Aprile 2023Documento3 pagineMiranda Galbusera Vince Il Campionato Delle Lingue in Spagnolo - Lecco Notizie - It, 6 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Francesco Al Top Dell'inglese Con La Macchina Del Tempo - L'Eco Di Bergamo Del 6 Aprile 2023Documento2 pagineFrancesco Al Top Dell'inglese Con La Macchina Del Tempo - L'Eco Di Bergamo Del 6 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Lode A Serpieri, Scienziato e Umanista - Il Resto Del Carlino Del 3 Aprile 2023Documento1 paginaLode A Serpieri, Scienziato e Umanista - Il Resto Del Carlino Del 3 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- IMAB, Azienda in Crescita Che Dà Lavoro Ai Giovani - Il Corriere Adriatico Del 3 Aprile 2023Documento1 paginaIMAB, Azienda in Crescita Che Dà Lavoro Ai Giovani - Il Corriere Adriatico Del 3 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Con La Macchina Del Tempo Francesco Sale Sul Podio Del Campionato Delle Lingue - L'Eco Di Bergamo Del 6 Aprile 2023Documento1 paginaCon La Macchina Del Tempo Francesco Sale Sul Podio Del Campionato Delle Lingue - L'Eco Di Bergamo Del 6 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Celebrazioni Di Serpieri: Astronomia Con Marica Branchesi - Il Resto Del Carlino Del 5 Aprile 2023Documento1 paginaCelebrazioni Di Serpieri: Astronomia Con Marica Branchesi - Il Resto Del Carlino Del 5 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Kevin Clark Sarà Academic Ambassador - Il Resto Del Carlino Del 5 Aprile 2023Documento1 paginaKevin Clark Sarà Academic Ambassador - Il Resto Del Carlino Del 5 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- A Kevin Clark Il Titolo Di Academic Ambassador - Il Corriere Adriatico Del 5 Aprile 2023Documento1 paginaA Kevin Clark Il Titolo Di Academic Ambassador - Il Corriere Adriatico Del 5 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Ma I Robot Tolgono o Aumentano Il Lavoro? - Il Resto Del Carlino Del 4 Aprile 2023Documento1 paginaMa I Robot Tolgono o Aumentano Il Lavoro? - Il Resto Del Carlino Del 4 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Urbino, Aperta La XIII Edizione Del Campionato Nazionale Delle Lingue - Vivere Marche - It, 3 Aprile 2023Documento1 paginaUrbino, Aperta La XIII Edizione Del Campionato Nazionale Delle Lingue - Vivere Marche - It, 3 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- IMAB, Azienda in Crescita Che Dà Lavoro Ai Giovani - Il Corriere Adriatico Del 3 Aprile 2023Documento1 paginaIMAB, Azienda in Crescita Che Dà Lavoro Ai Giovani - Il Corriere Adriatico Del 3 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Serpieri, Storia Di Un Innovatore - Il Corriere Adriatico Del 4 Aprile 2023Documento1 paginaSerpieri, Storia Di Un Innovatore - Il Corriere Adriatico Del 4 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Gli Economisti Della Banca D'italia A Urbino Per Parlare Di Robot e Occupazione - Vivere Marche - It, 4 Aprile 2023Documento2 pagineGli Economisti Della Banca D'italia A Urbino Per Parlare Di Robot e Occupazione - Vivere Marche - It, 4 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Atlante Del Giallo: Simona Di Carlo - Thrillermagazine - It, 2 Aprile 2023Documento1 paginaAtlante Del Giallo: Simona Di Carlo - Thrillermagazine - It, 2 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Atlante Del Giallo: Simona Di Carlo - Thrillermagazine - It, 2 Aprile 2023Documento1 paginaAtlante Del Giallo: Simona Di Carlo - Thrillermagazine - It, 2 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Il Professor Patrizio Bianchi Al Convegno Dei Matematici - Il Resto Del Carlino Del 1 Aprile 2023Documento1 paginaIl Professor Patrizio Bianchi Al Convegno Dei Matematici - Il Resto Del Carlino Del 1 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Rifiuti, Confindustria: Vincere Le Resistenze Dei Sindaci - Centropagina - It, 1 Aprile 2023Documento2 pagineRifiuti, Confindustria: Vincere Le Resistenze Dei Sindaci - Centropagina - It, 1 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Assorbenti Gratuiti Per Le Studentesse - Il Resto Del Carlino Del 1 Aprile 2023Documento2 pagineAssorbenti Gratuiti Per Le Studentesse - Il Resto Del Carlino Del 1 Aprile 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Maquiavel - Del Modo Di Trattare I Popoli Della Valdichiana RibellatiDocumento4 pagineMaquiavel - Del Modo Di Trattare I Popoli Della Valdichiana Ribellativicfiori402Nessuna valutazione finora
- Il Piccolo Del CremascoDocumento28 pagineIl Piccolo Del Cremascopromedia3Nessuna valutazione finora
- Le Istituzioni Politiche Ed Amministrative Nel Regno Delle Due Sicilie Dal 1815 Al 1860Documento7 pagineLe Istituzioni Politiche Ed Amministrative Nel Regno Delle Due Sicilie Dal 1815 Al 1860avivenzioNessuna valutazione finora
- MARX SchemaDocumento1 paginaMARX SchemaMarco AtzeniNessuna valutazione finora
- 2007 13 Biennale 350 Allievi MarescialliDocumento24 pagine2007 13 Biennale 350 Allievi MarescialliFlaminia House Bed and BreakfastNessuna valutazione finora