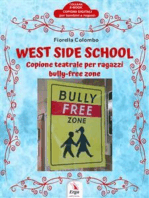Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Mix Audio in 8 Semplici Mosse
Caricato da
Alessandro FoisCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Il Mix Audio in 8 Semplici Mosse
Caricato da
Alessandro FoisCopyright:
Formati disponibili
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n.
3 - Settembre 2022
Alessandro Fois
IL MIX AUDIO
IN 8 SEMPLICI
MOSSE
Mini e-Book gratuito
Edizione n. 2 - ottobre 2022
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
INDICE
Premessa 3
1° Mossa : I MEZZI 4
ACUSTICA 4
MONITORAGGIO 6
DAW 6
2° Mossa : LA SESSIONE DI LAVORO 8
Apriamo o creiamo la sessione 8
Organizziamo le tracce 9
Editing 9
3° Mossa : EQUALIZZAZIONE PRELIMINARE 10
Squilibri tonali 10
Equalizzazione correttiva 11
Una fase da non sottovalutare 11
4° Mossa : DINAMICA MODELLANTE 12
La dinamica 12
Compressione ed Espansione 13
Modelliamo i suoni 13
5° Mossa : DINAMICA LIVELLANTE 15
Livellare le esecuzioni 15
Attacchi duri e dolci 16
Ratio e Threshold 16
6° Mossa : AMBIENTARE LE TRACCE 17
La scelta del riverbero 17
I campi sonori 18
Echo 18
7° Mossa : IL MIX ESSENZIALE 19
Scegliere le sorgenti essenziali 19
Come operare 20
8° Mossa : IL MIX CONCLUSIVO 21
Aggiungere le altre tracce 21
Regolazioni finali 22
Ascolto critico 22
Esportazione finale 22
Conclusione 24
Manuale di Audio Mixing Digitale 25
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Premessa
Carissimo/a,
grazie per aver richiesto questo piccolo manuale.
Questo volume, più che un manuale di apprendimento, è un memorandum d’azione
per chi si accinge a missare un brano.
La sua finalità, infatti, è indicare un itinerario metodologico da seguire per arrivare in
maniera ordinata ed efficace ai migliori risultati.
Per approfondire, infatti, ti suggerisco di leggere il mio completo “Manuale di Audio
Mixing Digitale” (n.590 pagine in formato A4) che puoi visionare al seguente link:
https://www.alessandrofois.com/prodotto/manuale-di-audio-mixing-digitale/
Suggerisco inoltre di dare uno sguardo alle altre mie pubblicazioni per fonici e musici-
sti, su vari argomenti di audio e di musica, collegandoti al seguente link:
https://www.alessandrofois.com/categoria-prodotto/libri/
Un caro saluto e buon lavoro!
Alessandro Fois
***
Per approfondimenti:
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
NOTE DI COPYRIGHT
La divulgazione e la duplicazione di questo eBook è libera, ma rigorosamente a condi-
zione che esso sia duplicato e divulgato in maniera integrale, senza alcun intervento al
testo, alle immagini e ai links.
E’ invece fatto divieto di pubblicare o divulgare qualunque trasposizione dei contenuti
in forme e/o supporti diversi dall’eBook digitale, ad esempio (indicativo e non esausti-
vo): siti e blog web, apps, pubblicazioni cartacee, ecc..
Ogni trasgressione sarà perseguita a norma di legge.
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
1° Mossa
:
I MEZZI
ACUSTICA
Per prima cosa dobbiamo assicurarci di disporre di una stanza con caratteristiche acusti-
che sufficientemente corrette.
Una stanza con riverberi lunghi e colorati, con risonanze su certe frequenze e carenze in
altre ci porteranno a correzioni acustiche sbagliate, che resteranno impresse nel mix nel tentati-
vo di compensare i difetti acustici del nostro ambiente di ascolto.
4
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
E’ infatti indispensabile che la risposta in frequenza della control room sia sufficiente-
mente lineare e i tempi di riverberazione brevi.
Purtroppo ogni stanza ha le sue frequenze di risonanza in funzione delle sue misure (in
una stanza a forma di parallelepipedo sono n.3: altezza, larghezza e profondità).
Consideriamo il “numero magico” 340 (che è il valore costante che si ottiene moltipli-
cando qualsiasi frequenza per la sua relativa lunghezza d’onda) e dividiamolo per ciascuna delle
suddette n.3 misure espresse in metri: si otterranno con precisione le frequenze di risonanza
statiche della stanza, chiamate onde stazionarie (ad esempio una stanza con misure m. 3 H x
m. 4 L x m. 5 P, avrà n.3 onde stazionarie primarie che risuonano rispettivamente a: 113,33 hz -
85 hz - 68 hz.
La risonanza può amplificare anche di 6 db e oltre la specifica frequenza.
In caso di stanze con n.2 misure uguali (assolutamente sconsigliata) la risonanza può risul-
tare amplificata sino a 12 db e oltre.
In una stanza cubica (assolutamente improponibile) la risonanza potrà arrivare a sfiorare
un incremento di 20 db.
I multipli e i sottomultipli di una delle misure andrebbero anch’essi non utilizzati per evita-
re rinforzi nei primi armonici.
Sono invece consigliabili, per dirla breve, proporzioni del tipo 3x4x5 oppure 3x5x7.
In ogni caso, sarà sempre possibile farsi progettare da un esperto e collocare nella con-
trol-room alcuni risuonatori acustici, al fine di ammortizzare almeno in parte le onde stazionarie
primarie e, volendo farlo, anche le secondarie (derivanti da percorsi di riflessione più lunghi).
Dislocare alcune cosiddette trappole per bassi negli angoli alti della stanza e lungo gli
spigoli verticali nonché in quelli orizzontali alti della stanza è un sistema eccellente per ammor-
tizzare le frequenze stazionarie basse più importanti.
I pannelli trappola di tipo piatto invece potranno essere dislocati dietro i monitors e sopra
e lateralmente al punto di ascolto del fonico.
La opportuna disposizione di pannelli o tendaggi assorbenti permetterà di ridurre il tem-
po di riverberazione nei punti più critici, mentre alcuni pannelli diffusori permetteranno di di-
stribuire e livellare gli squilibri tonali minori, disperdendoli uniformemente nella stanza.
Tutto ciò che non riusciremo a migliorare con le soluzioni architettoniche e di arredo do-
vrò essere infine perfezionato per mezzo di un equalizzatore, aggiunto nel solo stadio finale di
ascolto, senza quindi coinvolgere il percorso audio da cui si estrapolerà il file del mix.
Un test effettuato tramite una keyboard musicale, con un suono a timbro sinusoidale
puro, percorrendo tutta la scala cromatica udibile, potrà evidenziarci con precisione le eventuali
carenze o risonanze percepibili nel punto di ascolto del fonico.
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
MONITORAGGIO
Un paio di audio monitors da studio di buona qualità sono indispensabili per ascoltare
con precisione critica.
Il loro posizionamento dovrà essere studiato nel rispetto della triangolazione stereo, stan-
dard di ascolto, evitando massimamente le riflessioni sulle pareti, sul soffitto e sul tavolo di la-
voro.
Calcolare un’opportuna distanza dalle pareti retrostanti è pure importante per evitare con-
tro-reazioni di fase che possano attenuare alcune specifiche frequenze.
Un subwoofer è indispensabile per il controllo delle frequenze molto basse.
Esso dovrà essere perfettamente “messo in fase” rispetto alla stanza e ai monitor princi-
pali, tramite correzioni della frequenza di taglio, del volume proporzionale e della posizione di
colloccamento nella stanza e rispetto ai monitors principali.
I tweeter dei monitors dovranno puntare alle orecchie del fonico.
Un cuffia specifica da mixing/mastering, filtrata attraverso un sistema che permetta la li-
nearizzazione della sua risposta in frequenza e la simulazione di ascolto (in un ambiente neutro
pari a quello delle grandi control room professionali), permetterà di mettere a punto i dettagli
sonori evitando gli insormontabili difetti d’ascolto riscontrabili in un home studio e creando una
linearità “naturale” quasi perfetta ai vostri ascolti.
Infine è da valutare che l’ascolto critico standard è fissato a circa 85 db di pressione acu-
stica, ma sarà necessario anche un ascolto a 110 db (soprattutto per al valutazione dell’ingom-
bro dei bassi profondi) e a 60 db (soprattutto per la valutazione del corpo dei medio-bassi e per
rilevare eventuali distorsioni).
DAW
Una ottima Digital Audio Workstation è elemento essenziale per un mix digitale.
Deve poter essere impostabile con frequenze di lavoro comprese almeno tra i 44.1 khz e i
96 khz.
Il numero dei bit non dovrebbe essere mai inferiore ai 24 al fine di non penalizzare
l’escursione dinamica e il dettaglio sonoro, nel corso delle manipolazioni del suono eseguite
durante il mix.
Alcuni Hard Disc o SSD veloci dovranno corredare un computer sufficientemente potente
per sostenere l’elevato numero di tracce e di plugin da utilizzare nel mix.
I sistemi con schede DSP esterne (come Pro Tools HD) sono migliori dei sistemi che utiliz-
zano la sola CPU, in termini di qualità e di potenza del sistema.
La ottimizzazione dei parametri della Daw ci permetterà in ogni caso di ottimizzare il flus-
so di lavoro al fine di evitare intoppi.
Un sistema di backup, meglio se automatico, ci salverà da perdite accidentali di dati du-
rante il lavoro e anche in archivio.
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
***
Per approfondimenti:
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
2° Mossa
:
LA SESSIONE DI LAVORO
Apriamo o creiamo la sessione
Ora si tratta di aprire una sessione di recording effettuata con una Daw uguale o compa-
tibile, oppure di importare le tracce audio (precedentemente esportate, tutte con punto di start
nella timeline identico per tutte, al fine di poter essere poi facilmente ri-sincronizzate sulla nuo-
va timeline).
I parametri della sessione dovrebbero restare i medesimi della sessione di recording, con
eccezione del numero dei bit, che in ogni caso non dovrà mai essere impostato ad un valore
inferiore a 24.
8
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Organizziamo le tracce
Con la speranza che i nomi già scritti nelle tracce possano anticiparci il reale contenuto
(altrimenti ri-scrivetelo voi stessi correttamente), organizziamo le tracce sulla timeline, posizio-
nandole con un criterio razionale, intuitivo e comodo.
La creazione di alcuni gruppi stereo o mono, secondo i casi, potrà inoltre aiutarci a gestire
controlli generali per alcune sezioni di tracce a funzione analoga (ad esempio i toms, l’intera
batteria, le chitarre, il coro e così via).
E’ ora necessario fare un missaggio statico (senza automazioni) regolando il volume delle
tracce in maniera da ottenere un risultato sufficientemente fruibilie in termini di ascolto propor-
zionato e gradevole.
Successivamente, al fine di familiarizzare col brano, ascoltatelo interamente per almeno
n.5 volte, eventualmente mettendo in risalto temporaneamente la traccia o le tracce che attira-
no la vostra attenzione per vari motivi: criticità foniche, dettagli espressivi, irregolarità ritmiche,
errori di intonazione o di timing, rumori accidentali e quant’altro troverete.
Editing
Il lavoro di Editing è tipicamente connesso alle fasi di recording.
Ne consegue che non dovrebbero essere necessari interventi di tal tipo come premessa
per il mix.
Tuttavia, se per incuria di chi vi ha preceduto vi capitasse di notare difetti risolvibili in am-
bito di timing, tuning e cleaning, non esitate ad eseguirli al fine di arrivare al mix con un pro-
dotto pulito, levigato e, per quanto possibile, perfetto.
***
PER APPROFONDIMENTI
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
3° Mossa
:
EQUALIZZAZIONE PRELIMINARE
Squilibri tonali
A questo punto, per mezzo del tasto “SOLO”, occorrerà ascoltare le tracce ad una ad una
per rilevare la eventuale quanto immancabile presenza di risonanze a carico di singole frequen-
ze o di gruppi di frequenze.
Ogni sorgente, soprattutto quelle acustiche registrate tramite microfoni, presenta dei rin-
forzi irregolari, causati da imperfezioni dello strumento o dalla loro imperfetta messa a punto,
da esecuzioni poco precise, dall’acustica sfavorevole del luogo di ripresa, che potrebbe eviden-
ziare delle carenze o, più spesso, delle risonanze su certe frequenze o gruppi di frequenza.
10
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
In entrambi i casi è indispensabile riconoscere con precisione la frequenza, l’ampiezza e
l’intensità di tali risonanze l fine di compensarle per mezzo di una azione di equalizzazione co-
siddetta preventiva o anche correttiva, per addivenire ad una sonorità leggera e equilibrata,
equale su tutta l’estensione dello strumento.
Equalizzazione correttiva
Questa fase della equalizzazione ha quindi lo scopo di ripulire le tracce da ogni squilibrio
di tipo tonale, e di livellarle equalizzandone il volume di tutte le note musicali emesse, condi-
zione favorevole per una corretta gestione dei volumi durante il mix.
Tipica è ad esempio la difficoltà nel gestire la traccia del basso che in certi momenti ten-
de a coprire in maniera risonante le altre tracce e in altri a sparire, semplicemente in relazioni a
quali note vengono eseguite).
Una fase da non sottovalutare
Sarà bene non sottovalutare l’importanza di questa fase che risulterà determinante per
ottenere in fase preventiva suoni livellati e perfetti, perfettamente gestibili durante il mix.
Se non eseguirete queste operazioni con estrema cura il mix risulterà difficile e il risultato
potrebbe essere scadente.
Non ricercate il “bel suono” sino a che non avete prodotto un suono equilibrato.
Scoprirete quasi sempre che un suono equilibrato è anche bello.
Nei generi musicali puristi è generalmente ammesso l’utilizzo moderato della equalizza-
zione preventiva in funzione equilibrante, a condizione che non spenga le caratteristiche timbri-
che dello strumento.
***
PER APPROFONDIMENTI
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
11
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
4° Mossa
:
DINAMICA MODELLANTE
La dinamica
Per dinamica audio intendiamo:
• le curve di incremento e decremento di intensità che può assumere un suono
nella sua emissione
• quelle che può assumere una esecuzione musicale nel susseguirsi del fraseggio
espressivo.
12
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Compressione ed Espansione
Il compressore e il suo opposto, ossia l’espansore, sono i processori per mezzo dei quali
possiamo controllare alcune funzioni della dinamica.
Il compressore ha lo scopo di ridurre, comprimendola, l’escursione dinamica emessa da
una nota o nel corso di un fraseggio esecutivo.
L’espansore ha lo scopo di aumentare, espandendola, la escursione dinamica emessa da
una nota o nel corso di un fraseggio esecutivo.
Quando è nostro obiettivo modellare la dinamica delle singole emissioni sonore (in prati-
ca, delle singole note musicali) stiamo operando un controllo dinamico modellante, che inter-
viene principalmente sul rapporto di intensità tra la fase di attacco e quella di sostegno del
suono.
Quando è nostro obiettivo livellare la dinamica di una fraseggio musicale eseguito da un
performer stiamo operando un controllo dinamico livellante.
Modelliamo i suoni
Premetto che i suoni modellabili in maniera efficace sono solo quelli caratterizzati da un
attacco sufficientemente duro e un rilascio che decada più o meno velocemente (ad esempio le
percussioni e gli strumenti a corde pizzicate o percosse).
Gli strumenti ad aria, la voce umana e gli strumenti a corda strofinata, invece, non rispon-
dono in maniera sufficientemente interessante alle sollecitazioni dinamiche a scopo modellante.
Che cosa possiamo modellare nei singoli suoni ad attacco duro e decadimento progressi-
vo, quindi?
Sostanzialmente modelliamo in modo reattivo il rapporto di volume tra la fase dura di at-
tacco e quella di sostegno/decadimento.
Per ottenere risultati apprezzabili, in genere è necessario utilizzare ampi valori di ratio e
ampio range di threshold.
Col compressore, con attacco immediato e rilascio mediamente rapido, potremo dimi-
nuire l’impatto della fase percussiva del suono rispetto al volume della coda.
Aumentando il valore di ratio e accorciando i tempi di rilascio si riuscirà ad esaltare ancor
più la coda rispetto all’attacco.
Con valori di attacco e di rilascio sufficientemente lunghi (e ampio range di threshold), al
contrario, si esaspererà ancor di più il volume della percussione iniziale rispetto alla coda.
Con l’espansore sarà invece possibile, ad esempio, accorciare o tagliare il tempo di riso-
nanza di un tamburo e ottenere altri vari effetti di modellamento da sperimentare.
Nei generi musicali puristi è “assolutamente vietato” il modellamento dinamico dei suoni.
13
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
***
PER APPROFONDIMENTI
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
14
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
5° Mossa
:
DINAMICA LIVELLANTE
Livellare le esecuzioni
Come abbiamo già premesso, il livellamento dovrà avvenire non più comprimendo singoli
suoni, bensì agendo su un intero fraseggio o addirittura sulla intera esecuzione di un performer
strumentale o vocale.
Lo scopo è quello di ridurre l’escursione dinamica di una esecuzione al fine di facilitare il
mix, evitando immersioni o al contrario svettamenti troppo accentuati di una sorgente sonora
rispetto al contesto del mix stesso.
Per evitare questi eccessi di volume alternati ad altrettante carenze, dovremmo altrimenti
operare istante per istante, col controllo del volume di ogni traccia, per ottenere un risultato
ottimale.
Il livellamento viene operato per mezzo del compressore di dinamica unitamente al con-
trollo del dettaglio del volume (in automazione).
15
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Attacchi duri e dolci
Gli strumenti con attacco duro rispondono meglio a tempi di attacco immediati e ad un
rilascio sufficientemente lungo al fine di evitare il rinforzo artificioso della coda, ma abbastanza
breve da non diminuire il volume di attacco della nota successiva.
Gli strumenti con attacco dolce in genere necessitano di un tempo di attacco medio e di
un rilascio ugualmente medio.
Nei casi difficili le automazioni potrebbero permetterci una buona duttilità d’utilizzo, al
fine di mantenere sufficientemente intatta la sensazione di naturalezza che è d’uopo ottenere in
questa funzione.
Ratio e Threshold
Per il solo livellamento sono in generale da preferire threshold ad ampio range (sino a 18-
24 db per i suoni ad attacco dolce, con rapporti di compressione moderati (tra 1.5 e 3.0).
Per i suoni con attacco duro sono in generale da preferire threshold a medio range (sino a
8-12 db, con rapporti di compressione più elevati (tra 2.0 e 4.0).
In generale l’allargamento del range con diminuizione del ratio permette di ottenere ridu-
zioni di dinamica simili, mantenendo una maggiore naturalezza generale.
L’esatto contrario, invece, lascerà assolutamente intatta la dinamica naturale delle parti
espressive più delicate, ma interverrà più drasticamente sui picchi, che talvolta potrebbero ap-
parire meno naturali e richiedere un intervento in automazione
Nei generi musicali “puristi” è talvolta tollerato un lieve livellamento dinamico dei suoni,
a condizione che si applichi con valori di Threshold molto ampi (ad esempio 24 db) e valori di
ratio molto esigui (da 1.2 sino ad un massimo di 1.5).
***
PER APPROFONDIMENTI
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
16
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
6° Mossa
:
AMBIENTARE LE TRACCE
La scelta del riverbero
Si intende la scelta di un campo di risonanza sonora a simulazione ambientale, in modo
che avvolga tutte le sorgenti del brano in modo coerente.
Nei generi musicali “non puristi” sarà anche possibile diversificare il campo riverberante
di alcune sorgenti in maniera libera e creativa, ai fini di caratterizzarne il suono ed evidenziarne
la funzione speciale.
17
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
In tal senso capita spesso di voler caratterizzare in tal modo i solisti, il rullante e altri ele-
menti particolari del sound.
Qui di seguito però parleremo brevemente del campo sonoro coerente e di come diversi-
ficarlo a seconda delle funzioni della sorgente nell’arrangiamento e nel mix.
I campi sonori
Come è ovvio, evidenziare con differenti dosaggi di volume le sorgenti solistiche significa
“suggerire” all’orecchio che la sorgente in questione sia posizionata più in prossimità di chi
ascolta.
Analogamente, i parametri del riverbero andrebbero regolati affinché si propongano a chi
ascolta la gamma delle sensazioni di risonanza ambientale indotte da sorgenti più o meno di-
stanti da chi ascolta.
Per dirla meglio, elenchiamo dapprima i principali parametri del riverbero: volume, pre-
delay (ritardo), durata, risposta alle frequenza alte, tempo di decadimento delle frequenze alte,
densità, rapporto tra il volume delle Early reflection e della coda.
Tra essi, la durata del riverbero resterà identica a prescindere dalla distanza di ascolto.
Nell’avvicinarsi della sorgente all’ascoltatore, però, il riverbero: diminuisce di volume, si
allunga il predelay, aumenta il volume delle frequenze alte e si riduce il loro tempo di decadi-
mento, diminuisce la densità e aumenta l’incidenza delle Early reflection rispetto alla coda.
Nell’allontanarsi i suddetti parametri si comportano esattamente al contrario.
E’ importante saper gestire quanto sopra al fine di regolare opportunamente mandate
ausiliarie e plugin, al fine di collocare ogni sorgente in un opportuna posizione di profondità
nello spazio sonoro.
Echo
L’eco può essere utilizzata, con estrema parsimonia, come strumento espressivo per sotto-
lineare un fraseggio, ma anche per creare un’onda sonora di riempimento che, opportunamen-
te dosata con il riverbero, possa conferire profondità e ampliamento al suono.
Utilizzato come sostitutivo del riverbero e con molto halo (più ripetizioni ravvicinate) può
ricreare un effetto vintage tipicamente anni 60-70.
***
PER APPROFONDIMENTI
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
18
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
7° Mossa
:
IL MIX ESSENZIALE
Scegliere le sorgenti essenziali
Una volta che tutti i suoni risultino regolati in maniera preliminare opportuna al fine di ri-
pulirli da ogni eccesso e carenza tonale e dinamica, possiamo avventurarci nelle premesse del
mix vero e proprio, che consiste nel mettere le varie sorgenti in relazione tra di loro.
Per semplificare tale processo ritengo opportuno identificare nella orchestrazione gli ele-
menti indispensabili per definire la struttura ritmico-armonica del brano, oltre ai solisti.
Talvolta, in aggiunta, può essere opportuno comprendere anche le sorgenti ad impatto
fonico più critico, come il basso (se presente).
19
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
La scelta di tale sorgenti è sempre in funzione del genere musicale, dello stile specifico,
del carattere del brano e delle intenzioni dell’autore e dell’arrangiatore.
Un esempio
Supponiamo che la vostra scelta cada su: voce solista, chitarra acustica, batteria e bas-
so, lasciando fuori, per il momento: pianoforte, 2 chitarre elettriche, una sezione di fiati, una
tastiera con sezione archi, un set di piccole percussioni, back vocals e un piccolo coro.
Lo scopo è quello di creare temporaneamente un mix che abbia caratteristiche di comple-
tezza e di totale equilibrio, come se tale missaggio dovesse essere esportato come mix definiti-
vo.
I suoni sono stati già equilibrati in precedenza ed anche ambientati, per cui sarà facile ot-
tenere da subito ottimi risultati assemblando tale “mix essenziale”, anche grazie alla notevole
rarefazione sonora conseguente al limitato numero di sorgenti impegnate.
Come operare
Per prima cosa assegnate alle tracce le proporzioni di volume più opportune affinché tut-
to suoni bene.
A questo punto modificate eventuali posizioni di pan-pot sul fronte stereo per distribuire
opportunamente le sorgenti in una più vasta dimensione spaziale.
E’ possibile che, al fine di far meglio collimare i suoni delle sorgenti, si rendano quindi
necessari piccoli ritocchi di equalizzazione, di compressione, di ambientazione, di panpot, tutti
in funzione di reciproco adattamento.
Trattandosi delle sorgenti essenziali, consiglierei di effettuare tali ritocchi utilizzando nuovi
plugin, da installare sulle tracce, al fine di poter ripristinare senza rischi i suoni iniziali che avete
faticosamente equilibrato in fase preliminare.
Come ultima cosa, lavorate un poco con le automazioni dei volumi per meglio definire “a
grandi linee”, le proporzioni di livello tra i vari temi (è tipico ad esempio un solista troppo de-
bole nella strofa e troppo esplosivo nel ritornello) e tra i vari fraseggi (se avete operato bene
basteranno probabilmente variazioni di 2 db al massimo).
In questa fase preliminare sconsiglio di entrare nella “regolazione fina” dei volumi tramite
automazione, cosa da riservare come ultimo ritocco nella fase del mix conclusivo.
***
PER APPROFONDIMENTI
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
20
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
8° Mossa
:
IL MIX CONCLUSIVO
Aggiungere le altre tracce
A questo punto aprite ad una ad una le altre tracce, partendo dalle più importanti e pro-
cedendo verso quelle più accessorie.
All’apertura di una traccia lo scopo è quello di tentare di incastrare la nuova sorgente sen-
za modificare alcunché nel vostro bellissimo mix essenziale.
In generale sarà la nuova traccia che dovrà adattarsi al suono del mix essenziale, per cui
su di essa saranno permessi interventi più marcati in funzione del massimo adattamento.
Una variante, forse migliore, suggerisce di aprire tutte le tracce e trovare per esse la giu-
sta dimensione di volume rispetto al mix essenziale, senza modificare nulla di quest’ultimo.
21
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Solo successivamente si potrà operare sulle sole tracce aggiunte per modificare in manie-
ra più o meno marcata i parametri di eq, dyn, rev e pan-pot. al fine di creare un impasto soddi-
sfacente che non mortifichi, ma anzi esalti il mix essenziale, il progetto dell’arrangiatore e l’idea
compositiva.
Regolazioni nali
Finalmente abbiamo il nostro mix praticamente concluso, ma occorreranno ancora un piz-
zico di “correzioni di fino” per ottenere un risultato perfetto.
Ora le correzioni potranno essere effettuate a carico di qualunque sorgente, comprese
quelle del mix essenziale, avendo cura effettuare ad ogni passo un backup progressivo, al fine
di poter effettuare in qualsiasi momento critico un opportuno ripristino.
Questo è anche il momento giusto per i ritocchi di fino dei volumi, con interventi che, in
generale, dovrebbero limitarsi ad 1 db sopra e sotto.
Ascolto critico
Un ascolto alternato ai n.3 livelli standard di volume (60, 85 e 110 db) sarà utile per una
migliore valutazione delle incidenza della varie bande sonore, specialmente dei bassi e dei me-
dio-bassi.
E’ consigliabile di effettuare un ulteriore ascolto con la cuffia e con piccoli speakers di
media e bassa qualità e anche un ascolto in mono, per rilevare eventuali errori nella sovrapposi-
zione delle fasi di qualche sorgente.
Infine, provate ad ascoltare il mix in altri ambienti e con impianti audio di tutti i tipi, com-
preso l’hi-fi domestico, il “radione” portatile, l’impianto di amplificazione live e l’autoradio.
Dopodiché effettuate le piccole correzioni tonali necessarie per la migliore fruizione a
ogni volume di ascolto e ogni dimensione di speakers.
Esportazione nale
Per concludere, esportate in varie forme e per i diversi utilizzi: archivio mix, mastering,
Stem mastering, distribuzione digitale, produzione Cd o Dvd o BlueRay.
Evitate di effettuare compressioni finali al mix se dovrete effettuare postumamente un
mastering professionale.
A mio avviso sono pure da evitare o ridurre al minimo i cosiddetti bus-compression, ossia
le compressioni dei gruppi di tracce.
Buona fortuna!
22
fi
fi
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
***
PER APPROFONDIMENTI
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
23
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Conclusione
Carissimo/a, grazie per essere arrivato sin qui con la lettura.
Come anticipato in premessa, rimarco che questo volume ha la sola funzione di indicare
un itinerario metodologico, da seguire per arrivare in maniera ordinata ed efficace ai
migliori risultati nell’ambito del processo di missaggio audio.
Per approfondire, infatti, ti suggerisco di leggere il mio completo “Manuale di Audio
Mixing Digitale” (n.590 pagine ) che puoi visionare al seguente link:
https://www.alessandrofois.com/prodotto/manuale-di-audio-mixing-digitale/
Suggerisco inoltre di dare uno sguardo alle altre mie pubblicazioni per fonici e musici-
sti, su vari argomenti di audio e di musica, collegandoti al seguente link:
https://www.alessandrofois.com/categoria-prodotto/libri/
Un caro saluto e buon lavoro!
Alessandro Fois
***
PER APPROFONDIMENTI
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
Il Manuale di Audio Mixing Digitale è acquistabile:
IN VERSIONE CARTACEA
Col 15% di sconto, direttamente sul Sito dell’Autore
Su Amazon
IN VERSIONE DIGITALE
Su Apple Books
24
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
PRESENTAZIONE DEL
Manuale di Audio Mixing Digitale
MISSAGGIO PROFESSIONALE PER HOME STUDIO
Collana “Audio Engineering | Manuali Audio per il Fonico”
Volume 3
• n. 590 pagine totali (Formato circa A4: cm. 21.59 x 27.94 - Font: Avenir Book 11 - Inter-
linea: 1
• n. 10 pagine di indice articolato su 4 livelli, per trovare ogni argomento rapidament
• n. 247 immagin
• n. 4 sezioni articolate in n. 40 capitoli in total
Acquista la versione cartacea o quella digitale
• la versione cartacea su questa pagina a € 13,52 anziché € 46,14
(prezzo di lancio)
• la versione cartacea su Amazon a € 13,52 anziché € 46,14 (prezzo di
lancio)
• la versione eBook su Apple Books a € 18,99 (prezzo de nitivo)
Il Manuale di Audio Mixing Digitale è nalizzato soprattutto all’apprendimento generale dei
principi del mix, ma sarà anche utilizzabile come guida pratica da consultare durante il mixing
E’ composto di n.4 parti di cui
1. la prima è nalizzata alla acquisizione di una sommaria ma suf ciente cultura del fonico
riguardo a: nalità e criteri generali del mix, suono, attrezzature, criteri di ascolto
2. la seconda è tecnicamente la più importante, è dedicata alla descrizione dell’intero iter
operativo da seguire durante il mix, con la descrizione dei criteri e delle operazioni di
processing tonale, dinamico e ambientale sino alla nalizzazione del mix che precede il
mastering
3. la terza tratta delle operazioni speci che di messa a punto delle varie sorgenti sonore
(strumenti e voci), soffermandosi soprattutto su quelle più complesse, delicate e ricorren-
ti)
25
;
fi
fi
i
fi
fi
e
fi
:
fi
fi
;
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
4. la quarta è un elenco di piccoli “Trucchi e Consigli”, in parte elaborati dall’autore e in
parte “pescati” dal “repertorio di comune dominio” dei sound engineers e di alcune mix-
star
Prefazione
L’insegnante Zen chiedeva agli aspiranti pittori di studiare per dieci anni esercitandosi per molte
ore al giorno
Suggeriva poi di “dimenticare” tutto, smettendo di esercitarsi per mesi
Dopodiché esortava l’allievo a dipingere “veramente”, seguendo soltanto l’intuito, in quanto la
capacità tecnica sarebbe emersa naturalmente, ma senza dominare la scena
In tal senso, la medesima esortazione può essere formulata per l’arte del missaggio, suggerendo
quanto segue:
“Non seguire nessuna regola, ma prima conoscile tutte”
Sono certo che ogni fonico esperto troverà condivisibile questa affermazione
L'Autore
Introduzione
Per mixare bene occorre conoscere a fondo tutte le caratteristiche e le insidie del suono, sino a
sviluppare una sapienza intuitiva che, purtroppo, nessun manuale come questo potrà mai insegna-
re direttamente, tuttavia esso intende fornire un semplice aiuto per orientarsi nel mondo del suo-
no, chiarendone i principi e sollecitando l’allievo alla ricerca
26
.
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
INDICE DEL MANUAL
Prefazione 1
Introduzione 1
Parte A *** INTRODUZIONE AL MIXING 1
BREVE STORIA DEL MIXING 1
Orchestrazione come missaggio primordiale 1
Il missaggio nelle prime registrazioni 1
Il multitraccia e i processi di post produzione 2
Il digitale a nastro 2
Il digitale a nastro magnetico 2
Daw e home studio 2
CRITERI DI APPROCCIO AL MIX 2
De nizioni e funzioni del missaggio 2
Tecnica e arte del mix 2
Ascoltare e confrontare le diversità 2
Suono naturale e arti ciale 2
Imitazione e innovazione nel mix 3
I limiti di un manuale dedicato al mix 3
ANALOGICO E DIGITALE 3
Differenze tra i due mondi 3
Emulatori hardware 3
RUDIMENTI DI ACUSTICA 3
Rumore, suono, frequenza vibratoria 3
Fondamentale, armonici, battimento 3
Onde, altezza, polarità, fase, ciclo, periodo 3
Onde composite, inversione di polarità 4
Transiente e coda dei suoni, ADSR 4
Propagazione del suono 4
Intensità 4
27
fi
2
fi
1
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Spazialità 4
Ri essioni e assorbimento 4
Vettori di ri essione 4
Eco 4
Flutter echo 4
Riverbero 4
Presenza e prossimità 5
Volume 5
Risonanza ambientale 5
Frequenze basse 5
Frequenze alte 5
Transienti 5
ASCOLTO DI RIFERIMENTO 5
Allestimento acustico dello studio 5
Isolamento Acustico 5
Trattamento interno 5
I monitors 6
Big e near- eld monitors 6
Diffusori chiusi e re ex 6
Il subwoofer 6
Posizionamento dei diffusori 7
Posizionamento del sub e fasatura con la stanza 7
Volume del sub e sua fasatura coi diffusori 7
Posizione del punto di ascolto 7
Equalizzazione correttiva 7
La percezione acustica 8
L’inganno del volume 8
Che cosa succede a volume alto 8
Cosa succede a volume basso 8
I volumi di riferimento 8
Mix di riferimento a 85 db 8
Lavorare a 70 db 8
Confrontare a 60 e 110 db 8
Ascolto critico ai vari volumi 8
Un volume diverso di nalizzazione per ogni genere musicale 8
Non roviniamo il nostro udito 8
Altri test di ascolto 8
Monitoring in cuf a 8
Tutti i test d’ascolto 8
Evitare l’adattamento psicoacustico 8
Ascolto tecnico e ascolto di relax 8
Monitoring a banda stretta 8
28
fl
5
fi
fl
3
fi
2
fl
5
fi
0
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Monitors alternativi 9
UN MIX TRIDIMENSIONALE 9
Fronte sonoro 9
Monofonia 9
Stereofonia 9
Surround 9
Gerarchia degli elementi del mix 9
Mascheramento 9
Incastro tonale 9
Incastro dinamico 10
Rispetto della dinamica 10
Il compito della compressione 10
Campo sonoro 10
Larghezza del fronte del campo sonoro 10
Profondità del fronte sonoro 11
Parte B *** OPERATIVITA’ NEL MIX 11
ORGANIZZARE LA SESSIONE 11
Numero dei Bit 11
Frequenza di sampling 11
esportazione tracce dalla timeline di recording 11
Importare le tracce sulla nuova timeline 12
Organizzare tracce E GRUPPI 12
Organizzare le tracce 12
Organizzare i gruppi 12
Piccole operazioni preliminari 12
La coerenza di fase 12
SEQUENZA OPERATIVA NEL MIX 12
Cronologia del mix 12
Conclusione 13
ASCOLTO E LIVELLAMENTO TRACCE 13
29
4
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
GAIN STAGING NEL MIX 13
Un parafulmine per la distorsione 13
Una dinamica enorme 13
Livelli audio nelle tracce e nei gruppi 13
Il Vu meter 13
Gestire le tracce ereditate dal fonico di Recording 13
Gruppi e sottogruppi 13
Livelli di input e output nei plugins 13
Volume di consegna al mastering 13
Gain staging nel monitoring 13
LEVELING E EDITING PRELIMINARE 14
Leveling preliminare 14
Squilibri di volume 14
Squilibri tonali rilevanti 14
Squilibri causati da differenze nel suono ambientale 14
Squilibri causati da cause tonali, dinamiche e ambientali insieme 14
Editing preliminare 14
Tuning 14
Timing 14
Cleaning 15
Fading 15
ALLINEAMENTO TRANSIENTI E FASATURA 15
fasatura di traccia stereo 15
Inversione di fase 15
Ottimizzazione della coerenza di fase 15
Fasatura di una ripresa multipla 15
Sfasature da doppia microfonatura 15
Fasatura di un set multi-microfonico percussivo 16
CONTROLLO TONALE 16
Spettro armonico e analizzatore di spettro 16
Processori tonali 16
Azione dell’equalizzatore 16
Tipi di Equalizzatore 16
Equalizzatori Shelve e Peak 17
30
1
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
HPF e LPF 17
Notch ltering 17
Conformazione dei plugin di Eq 17
EQUALIZZAZIONE PRELIMINARE 17
Ottimizzazione del suono nell’era analogica 18
Perché utilizzare un equalizzatore preciso per l’Eq preliminare 18
Equalizzazione preliminare per gli strumenti melodici 18
Equalizzazione preliminare per i tamburi 18
IL MIX ESSENZIALE 19
Un mix in due mosse 19
Introduzione al mix essenziale 19
Individuazione degli elementi primari 19
Scatenare la creatività 19
IL MIX COMPLETO 19
Equalizzazione di mix 19
Finalità dell’equalizzazione di mix 19
Le operazioni tonali eseguibili nel mix 19
Mascheramento e equalizzazione risaltante 19
Equalizzazione statica contro il mascheramento 20
Equalizzazione dinamica contro il mascheramento 20
Gerarchia degli elementi nel de-mascheramento 20
Equalizzazione cosmetica 20
CONTROLLO DINAMICO 20
Processori dinamici 20
I processi dinamici 20
Controlli del Compressore e del Limiter 21
Controlli dell’espansore e del gate 21
Processori dinamico tonali 21
Tecniche base di processing dinamico 21
Gating 22
Isolare le tracce 22
Attenuare il rumore e altri disturbi 22
Limiting 22
De nizione e utilità del brickwall limiting 22
31
fi
fi
0
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Scelta del plugin 22
Operatività 22
Modeling 22
Esaltare i transienti 23
Attenuare i transienti e accentuare il sustain della coda 23
Accorciare il sustain 23
Effetti collaterali dell’espansione modellante 23
Modeling dei transienti con un Transient Shaper 23
Leveling 24
Compressione ed espansione: ruoli e rischi nel leveling 24
Azioni pre-leveling 24
Comprimere parallelamente 24
Livellamento solisti con doppia compressione 24
Livellare basso e grancassa 25
Livellare gli elementi di secondo piano 25
Livellare un gruppo 25
Livellare l’intero mix 25
Livellare passo-passo i fraseggi sommersi 25
Livellamento Side chain 25
Decomprimere una traccia troppo compressa 26
Aumentare gli accenti dinamici di una esecuzione 26
Tecniche miste 26
Modeling e leveling contemporaneo 26
Compressione parallela stressante 26
Compressione levigante 26
De-essing 26
Massimizzazione dei bassi 27
Il principio sico 27
La soluzione in un processore speci co 27
Come operare 27
Conclusione 27
ARRICCHIMENTO ARMONICO 27
Arricchimento armonico con l’Eq 27
Saturazione armonica 27
Saturazione analogica post recording col preampli 28
La saturazione coi plugins 28
Exciter tradizionali 28
Arricchitori speciali 28
32
fi
0
fi
8
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
PROCESSI DI AMBIENTAZIONE 28
Echo e Delay 28
Eco 29
Delay 29
Come installare un processore di echo-delay 29
Parametri di controllo del delay 29
Effetto del delay sul mix 29
Riverbero 29
Dry - Wet 29
Le tre dimensioni del suono ambientato 29
Riverbero a convoluzione 29
Controlli del Riverbero 30
Effetto del riverbero sul mix 30
Doppler 31
ALTRI PROCESSI E PROCESSORI 31
LA DIMENSIONI SPAZIALI NEL MIX 31
Lo spazio acustico e la mappa spaziale 31
Le dimensioni dello spazio acustico 31
Dimensioni sonore gestibili nello spazio acustico stereo 31
strumenti per la gestione della spazialità ACUSTICA 31
Gestire la larghezza del campo acustico 31
Gestire la profondità del campo acustico 32
Risorse per gestire larghezza e profondità del campo acustico 32
La terza dimensione del campo acustico 33
Esempio di distribuzione spaziale di elementi del mix 33
Il fronte posteriore 34
RIFINITURE CONCLUSIVE 34
Prendetevi una pausa 34
Ri nire il mix 34
Volume e Faders 34
Equalizzazione risaltante 34
Compressione risaltante 34
Espansione risaltante 34
Ascolto critico nale 34
33
fi
0
fi
9
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
VERSIONI DIFFERENTI DEL MIX 34
Un mix alternativo 35
ESPORTAZIONE DEL MIX 35
Destinazioni d’uso del mix 35
Uso diretto senza mastering 35
Mastering e Archivio 35
Stem Mastering 35
Basi musicali per uso live 35
Sequenze con click per uso live 35
Note per il mastering 35
Nominare correttamente i les 35
Inviare appunti 35
Revisione del Mix 35
Parte C *** TRATTAMENTO DEGLI ELEMENTI DEL
MIX 36
VOCE SOLISTA 36
Gestione iniziale del volume della voce 36
Gli squilibri ex editing 36
Squilibri performativi e leveling vocale 36
Equilibratura tonale 36
Equalizzazione preliminare 36
Levigatura dinamico-tonale 37
Livellamento dinamico 37
Doppia e tripla compressione 37
Compressione parallela 38
Compressione per la voce On face 38
Ritocchi tonali nel mix 38
Equalizzazione di mix 38
Enhancement 38
Saturazione Armonica 38
Una dimensione dinamica contestuale 39
De-Essing 39
34
1
fi
5
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Ambientazione 39
Delay e Chorus 40
Il controllo del volume per la voce solista nel mix 40
I controlli nali del volume 40
Gestione nale del volume della voce 41
BASSO E CONTRABBASSO 41
Equalizzazione preliminare 41
Equalizzazione di mix 41
Un buon incastro col basso 41
Il controllo della dinamica nel basso 42
Dyn 42
BATTERIA 42
Il Gate 42
Considerazioni sull’utilizzo del Gate 42
I controlli del Gate 42
L’uso del Gate per la batteria 43
Il Gating manuale delle tracce dei toms 43
Il gate per la grancassa 43
Il gate per il rullante 43
Il gate per i piatti ripresi coi close mics 43
Il gate nella musica purista 44
Equalizzazione Preliminare 44
Grancassa 44
Compressione parallela 44
Doppia traccia 44
Equalizzazione preliminare per la grancassa 44
Equalizzazione di mix per la grancassa 45
Controllo dinamico 45
Modellamento 46
Equilibrio dinamico tra grancassa e basso 47
Campo sonoro 47
Rullante 47
Doppia traccia 47
Equalizzazione preliminare 47
Equalizzazione di mix 48
Controllo dinamico 48
Modellamento 48
Campo Sonoro 49
Hi Hat 49
35
2
fi
6
fi
5
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Equalizzazione preliminare 49
Equalizzazione di Mix 49
TomTom e Timpano 49
Doppia traccia per ciascun tamburo 49
Equalizzazione preliminare 50
Equalizzazione di mix 50
Controllo dinamico 50
Campo sonoro 51
Over Heads 51
Ripresa dell’ambiente 51
Stressed Drums 51
PIANOFORTE 51
La funzione delle tracce 52
Criteri di mix con le tracce del pianoforte 52
Equalizzazione preliminare del piano 52
Mix delle tracce del piano 52
Compressione parallela 52
Caratteri del suono del piano ed eq di mix 52
CHITARRE 52
La regina del pop 52
Controllo delle fasi 52
Colori differenti nelle tracce 52
Equalizzazione preliminare 52
Tagliare con l’HPF 52
Eliminare le risonanze 53
Regolazione della pennata 53
Limiting preliminare 53
La compressione modellante 53
La compressione livellante 53
La chitarra nel mix in generale 53
I bassi 53
Il fango acustico 53
Il bottom 53
Il medio 53
La fascia chiara 53
Il mordente 53
La fascia argentina 53
La chitarra elettrica nel mix 53
Scelta e simulazione di ampli e cabinets 53
36
5
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
Compressione a strati 53
Gestione del Panning 54
Panning naturale 54
Generazione del panning arti ciale 54
Regolare le chitarre elettriche 54
Gli assoli elettrici 54
Le ritmiche elettriche pesanti 54
Le chitarre distorte sostenute 54
Le ritmiche rapide e “dure” 54
SEZIONI ORCHESTRALI 54
Solisti 54
Interventi preliminari 54
Interventi postumi 54
Strumenti in Sezione 55
Parte D *** SUGGERIMENTI IN PILLOLE 55
COMPRESSIONE 55
Fatti amico il side-chaning 55
FASI E TRANSIENTI 55
Veri care la presenza di problemi di fase 55
EFFETTI AMBIENTALI 55
Metti a dieta il riverbero 55
ENHANCING 55
Come bucare il muro di suono nel mix 55
37
fi
8
fi
4
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
EQUALIZZAZIONE 55
Fare economia con l’uso dell’Eq 55
MISSAGGIO 56
Volume di ascolto troppo elevato 56
Ad alto volume suona meglio? No! 56
La stanchezza dell’orecchio 56
Non darti troppo del tuo monitoraggio 56
Esegui il mix coi ltri di nalizzazione inseriti 56
Allarga la stereofonia delle tracce doppie 56
L’automazione prima della compressione 56
Gli errori del principiante nel mix 56
Consigli per il principiante del mix 57
Le voci nel mix 57
Ampliamento Stereo 57
Acustica della stanza 57
Compressione parallela 57
Suggerimenti per l’equalizzazione vocale 57
Guida alla frequenza vocale 57
Il basso nel mix 57
Elaborazione dinamica 57
Riscaldare il suono 57
Side chain tra basso e kick per mettere a punto la fascia bassa 58
Guida alle fasce di frequenza dei bassi 58
La batteria nel mix 58
Chitarre e poi chitarre 58
MONITORING 58
Ascolta con le orecchie del pubblico 58
Non abusare del tasto “Solo” 58
PILLOLE CONCETTUALI DAI GRANDI ESPERTI 58
***
38
fi
fi
2
fi
8
Alessandro Fois - Manuale di Audio Mixing Digitale - Edizione n. 3 - Settembre 2022
***
PER APPROFONDIMENTI
Manuale di Audio Mixing Digitale (n.590 pagine )
Oppure scopri tutte le Pubblicazioni
Il Manuale di Audio Mixing Digitale è acquistabile:
IN VERSIONE CARTACEA
Col 15% di sconto, direttamente sul Sito dell’Autore
Su Amazon
IN VERSIONE DIGITALE
Su Apple Books
39
Potrebbero piacerti anche
- AlmanaccoDocumento2 pagineAlmanaccosara dieciNessuna valutazione finora
- Acclamate-Al-Signore Rns Pasquale Rinaldi AccordiDocumento1 paginaAcclamate-Al-Signore Rns Pasquale Rinaldi AccordiANDREANessuna valutazione finora
- Celentano, Gaber, Tenco e Io, Cacciati Dalla Capannina Di VigevanoDocumento1 paginaCelentano, Gaber, Tenco e Io, Cacciati Dalla Capannina Di VigevanoProvincia PaveseNessuna valutazione finora
- West Side School: Copione teatrale per ragazzi bully-free zoneDa EverandWest Side School: Copione teatrale per ragazzi bully-free zoneNessuna valutazione finora
- Indice La Produzione MusicaleDocumento8 pagineIndice La Produzione MusicalefuckNessuna valutazione finora
- Tecniche Di RegistrazioneDocumento18 pagineTecniche Di RegistrazionePaolo Permeable Bug InfurnaNessuna valutazione finora
- PoesieDocumento162 paginePoesieAlessandro Fois100% (1)
- Adoro TeDocumento3 pagineAdoro TeGiuseppe IusoNessuna valutazione finora
- Va PensieroDocumento7 pagineVa PensierozozesaramagoNessuna valutazione finora
- Popoli Tutti Acclamate Accordi 41o1w686Documento1 paginaPopoli Tutti Acclamate Accordi 41o1w686alefor32Nessuna valutazione finora
- Beethoven Per Elisa GC Pianoforte 4 ManiDocumento8 pagineBeethoven Per Elisa GC Pianoforte 4 ManiClaudio AllegriNessuna valutazione finora
- Astro Del Ciel GC Pianoforte 4 Mani PDFDocumento3 pagineAstro Del Ciel GC Pianoforte 4 Mani PDFPaola GhisiNessuna valutazione finora
- Libretto Canti Nuovo 2012 ImpaginatoDocumento146 pagineLibretto Canti Nuovo 2012 ImpaginatoFrank BozNessuna valutazione finora
- Notazione Gregoriana PDFDocumento4 pagineNotazione Gregoriana PDFSabrina CenerazzoNessuna valutazione finora
- Auguri Di Buon Natale e Di Un Anno Seren Spartito Note Colorate PDFDocumento3 pagineAuguri Di Buon Natale e Di Un Anno Seren Spartito Note Colorate PDFflayNessuna valutazione finora
- Battisti MedleyDocumento1 paginaBattisti MedleyCosimoNessuna valutazione finora
- Libretto Messa Matrimonio 04Documento23 pagineLibretto Messa Matrimonio 04marghebozzaNessuna valutazione finora
- Il Signore È Il Mio Pastore Partitura - Tutto Lo Spartito PDFDocumento1 paginaIl Signore È Il Mio Pastore Partitura - Tutto Lo Spartito PDFmastrodommyNessuna valutazione finora
- DimoniosDocumento1 paginaDimoniosnaomi100% (1)
- Benedici Il Signore (M. Frisina)Documento4 pagineBenedici Il Signore (M. Frisina)Francesco LanzottiNessuna valutazione finora
- Tre Poesie Di Franco ArminioDocumento4 pagineTre Poesie Di Franco ArminioMaurizio FotiNessuna valutazione finora
- Credo in Te, Signore 4 Voci SATBDocumento1 paginaCredo in Te, Signore 4 Voci SATBDiegoNessuna valutazione finora
- Danza Spagnola #5 (Andalusa) PDFDocumento3 pagineDanza Spagnola #5 (Andalusa) PDFCurtis LongNessuna valutazione finora
- Balduzzi - Dall'aurora Al Tramonto PDFDocumento7 pagineBalduzzi - Dall'aurora Al Tramonto PDFfelonNessuna valutazione finora
- Questo È Il Mio Comandamento (Frisina)Documento1 paginaQuesto È Il Mio Comandamento (Frisina)klitocelkupaNessuna valutazione finora
- La Vita E Bella 6 HandsDocumento8 pagineLa Vita E Bella 6 HandsSarahVanRooyNessuna valutazione finora
- Viva La Libertà - FluteDocumento1 paginaViva La Libertà - FlutebrunomalinverniNessuna valutazione finora
- Messa Incoronazione AnalisiDocumento12 pagineMessa Incoronazione AnalisiNoemiCiullaNessuna valutazione finora
- Siam Qui RaccoltiDocumento1 paginaSiam Qui RaccoltiklitocelkupaNessuna valutazione finora
- Toccata e Fuga in Re Minore BWV 565 (Johann Sebastian Bach)Documento3 pagineToccata e Fuga in Re Minore BWV 565 (Johann Sebastian Bach)Raffaele1968Nessuna valutazione finora
- Oltre La Memoria Symbolum 80Documento3 pagineOltre La Memoria Symbolum 80Luca AndenaNessuna valutazione finora
- BraniDocumento9 pagineBraniVera RussoNessuna valutazione finora
- Appunti Sulle ModulazioniDocumento3 pagineAppunti Sulle ModulazioniBeatrice Tranasi MestreNessuna valutazione finora
- Manuale dx7 Italiano DemoDocumento2 pagineManuale dx7 Italiano DemoGiuseppe GalliNessuna valutazione finora
- Dragon BolDocumento1 paginaDragon BollopNessuna valutazione finora
- Beethoven Per Elisa GC Pianoforte 4 ManiDocumento8 pagineBeethoven Per Elisa GC Pianoforte 4 ManiMaurizio Francesco BarricaNessuna valutazione finora
- Nottediluce 3 VociDocumento5 pagineNottediluce 3 VociVannaNessuna valutazione finora
- Cantiamo TeDocumento1 paginaCantiamo TeAngelo BuonomoNessuna valutazione finora
- Dopotutto SpartitoDocumento2 pagineDopotutto SpartitoDamiano BettoniNessuna valutazione finora
- Joplin Entert1 DDocumento1 paginaJoplin Entert1 Djm.sachotNessuna valutazione finora
- Anche Oggi È NataleDocumento34 pagineAnche Oggi È NataleAngelantonio DitolveNessuna valutazione finora
- Abbi Cura Di Te LevanteDocumento2 pagineAbbi Cura Di Te LevanteNicole BrandiniNessuna valutazione finora
- Bach Johannes Passion BWV 245Documento19 pagineBach Johannes Passion BWV 245LOMONESA100% (1)
- L'amore Del PadreDocumento3 pagineL'amore Del Padregianvy46Nessuna valutazione finora
- Musica Matrimonio AlessandriaDocumento5 pagineMusica Matrimonio AlessandriadsdffsdNessuna valutazione finora
- Interprete PDFDocumento37 pagineInterprete PDFGiuseppe CamilleriNessuna valutazione finora
- Saggio Finale 22.05.10Documento2 pagineSaggio Finale 22.05.10ninino1996Nessuna valutazione finora
- Innalzate Nei CieliDocumento2 pagineInnalzate Nei CieliGiuseppePagliaroNessuna valutazione finora
- Al Tuo Santo AltarDocumento1 paginaAl Tuo Santo AltarAnnamaria BaldanNessuna valutazione finora
- La Bella Tartaruga Che Cosa MangeràDocumento1 paginaLa Bella Tartaruga Che Cosa Mangeràplinski1999Nessuna valutazione finora
- GBaby Maggio 2021Documento54 pagineGBaby Maggio 2021Mind genixNessuna valutazione finora
- LAZZARI FELICI WWW - Tinocarugati.itDocumento3 pagineLAZZARI FELICI WWW - Tinocarugati.itstefano.sabloneNessuna valutazione finora
- Non M'innamoro PiùDocumento1 paginaNon M'innamoro PiùDavideCaprariNessuna valutazione finora
- Gustate e Vedete SPARTITODocumento2 pagineGustate e Vedete SPARTITOChiara TomasinoNessuna valutazione finora
- Canti LiturgiciDocumento6 pagineCanti LiturgiciAlessandro GallaratiNessuna valutazione finora
- Manuale Uso Sufa Pellet MAIA ItaDocumento34 pagineManuale Uso Sufa Pellet MAIA ItaMichele DardanoNessuna valutazione finora
- Wagner Lohengrin Marcia Nuziale Arpa Sul PalcoDocumento2 pagineWagner Lohengrin Marcia Nuziale Arpa Sul PalcoAlice CaradenteNessuna valutazione finora
- Magnifica Il Signore Anima MiaDocumento1 paginaMagnifica Il Signore Anima MiaCosp CospNessuna valutazione finora
- 25 - Christus Vincit PDFDocumento1 pagina25 - Christus Vincit PDFGabriella CostaNessuna valutazione finora
- INPS - SR131 - TFR - Cessionari - ModuloDocumento2 pagineINPS - SR131 - TFR - Cessionari - ModuloAlessandro FoisNessuna valutazione finora
- Memorandum Sistema Pensionistico Lavoratori SpettacoloDocumento14 pagineMemorandum Sistema Pensionistico Lavoratori SpettacoloAlessandro FoisNessuna valutazione finora
- Pozzoli - Il Mio Primo Bach 01 PDFDocumento20 paginePozzoli - Il Mio Primo Bach 01 PDFAlessandro Fois100% (1)
- Giardinaggio PDFDocumento5 pagineGiardinaggio PDFAlessandro FoisNessuna valutazione finora
- CESI-MARCIANO - Antologia Pianistica - Fascicolo 1Documento36 pagineCESI-MARCIANO - Antologia Pianistica - Fascicolo 1Klodiana KociNessuna valutazione finora
- Siepi PDFDocumento27 pagineSiepi PDFAlessandro FoisNessuna valutazione finora
- MasteringDocumento4 pagineMasteringAntonio Lo FiegoNessuna valutazione finora
- Tracce Mono o Stereo Nel MixDocumento1 paginaTracce Mono o Stereo Nel MixFibro_Nessuna valutazione finora
- Tutorial Vu-Meter OZONE Rel. 3.0 VSTPLUGINDocumento3 pagineTutorial Vu-Meter OZONE Rel. 3.0 VSTPLUGINDanieleDiStasiNessuna valutazione finora
- Missaggio - 1Documento2 pagineMissaggio - 1Simone NoiaNessuna valutazione finora
- Tecniche Registrazione StereofonicheDocumento8 pagineTecniche Registrazione StereofonicheGetracco La SticcaNessuna valutazione finora
- SMIM EnsembleDocumento5 pagineSMIM EnsembleAnonymous d6ZhVZwNessuna valutazione finora
- Percorso Del Segnale in CubaseDocumento1 paginaPercorso Del Segnale in CubaseEnricoLucaNessuna valutazione finora
- Romanza - BeethovenDocumento19 pagineRomanza - BeethovenMassimo NasorriNessuna valutazione finora
- Risult at I 2016Documento8 pagineRisult at I 2016Nóra AntóniaNessuna valutazione finora
- mg06x It Om c0 PDFDocumento2 paginemg06x It Om c0 PDFiomega973Nessuna valutazione finora
- Piccola Stella Accordi Ultimo, PDFDocumento3 paginePiccola Stella Accordi Ultimo, PDFCassano RomeoNessuna valutazione finora
- PDFDocumento31 paginePDFAngeloNessuna valutazione finora
- Manuale Uso DaaDDocumento63 pagineManuale Uso DaaDRiccardo ParraviciniNessuna valutazione finora
- Lezioni Flauto - Lezione N. 27 - Jazz Flute EquipmentDocumento9 pagineLezioni Flauto - Lezione N. 27 - Jazz Flute EquipmentMicmac53Nessuna valutazione finora
- THE EDGE SOUND (Ita)Documento11 pagineTHE EDGE SOUND (Ita)Giangregorio SuraceNessuna valutazione finora
- Wiggle PDFDocumento8 pagineWiggle PDFMichael Jefferson T. ValdezNessuna valutazione finora
- Dispensa Scrittura Per Percussioni Orchestrazione I LivelloDocumento28 pagineDispensa Scrittura Per Percussioni Orchestrazione I Livellofds1dataNessuna valutazione finora
- Graduatoria ConcorsoMusicaleVimodrone 2022Documento6 pagineGraduatoria ConcorsoMusicaleVimodrone 2022Carmelo farandaNessuna valutazione finora