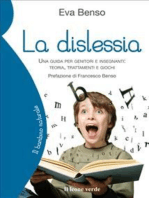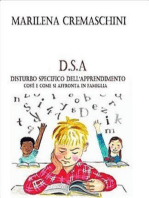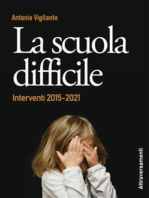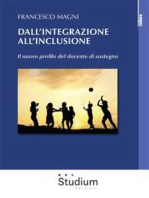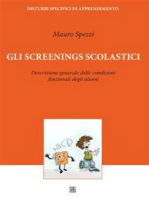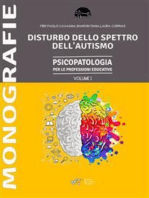Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Tesina Sindrome Di Down
Caricato da
Marta Barbabietola100%(1)Il 100% ha trovato utile questo documento (1 voto)
1K visualizzazioni4 pagineBreve tesina sulla sindrome di down con esperienza personale.
Titolo originale
TESINA SINDROME DI DOWN
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoBreve tesina sulla sindrome di down con esperienza personale.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
100%(1)Il 100% ha trovato utile questo documento (1 voto)
1K visualizzazioni4 pagineTesina Sindrome Di Down
Caricato da
Marta BarbabietolaBreve tesina sulla sindrome di down con esperienza personale.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 4
Tesina Neuropsichiatria
Marta Barbabietola Matricola: 295341
LA SINDROME DI DOWN
La sindrome di Down (SD), definita anche “trisomia 21”, venne descritta nel 1862 dal
medico inglese John Langdon Haydon Down, che lavorava in un centro per individui con
ritardo mentale in Inghilterra. In un articolo del 1866, individua una somiglianza fisica tra i
soggetti con la sindrome di Down e la popolazione mongola. Nel 1959 il genetista Jerome
Lejeune scoprì che la sindrome down era un disturbo genetico provocato dalla presenza di un
cromosoma in più. Tale cromosoma venne identificato come il ventunesimo e la sindrome
definita “trisomia del cromosoma 21”.
Per scoprire un eventuale trisomia, è possibile effettuare una prevenzione secondaria,tramite
una diagnosi prenatale che prevede l’uso di tre tecniche:
-l’amniocentesi
-la villocentesi
-tri-test.
L’amniocentesi è consigliato alle donne al di sopra di 35 anni,e consiste nel prelevare una
certa quantità di liquido amniotico utile ad effettuare l’analisi cromosomica su alcune cellule
del feto. La villocentesi consiste nel prelievo dei villi coriali tra l’ottava e la dodicesima
settimana di gestazione, cioè delle cellule dalle quali si sviluppa la placenta. Infine il Tri-test
consiste in un prelievo tra la quindicesima e la diciassettesima settimana di gestazione,per
rilevare sostanze che vengono prodotte dalla placenta.
Caratteristiche fisiche
Le persone con la sindrome di down presentano alcune caratteristiche fisiche: occhi a
mandorla,il collo ampio e corto, la bocca è protrusa tra le labbra a causa dell’ipotonia dei
muscoli facciali,il viso piatto e slargato, con orecchie e bocca piccole, e la lingua grossa. La
statura risulta inferiore rispetto alla media, le mani sono corte e larghe, i padiglioni auricolari
presentano malformazioni. La rima palpebrale è ridotta ed obliqua dall’interno all’esterno, e
l’angolo interno delle palpebre è caratterizzato da una plica cutanea,definita epicanto. La cute
è ruvida e secca,con tendenza alla desquamazione. Oltre a presentare tratti dismorfici, le
persone affette da sindrome di down, possono presentare alcune malformazioni a carico degli
organi interni e alterazioni del sistema immunologico. La sindrome di down è associata alla
malattia cardiaca congenita, e addirittura nei primi due anni di vita, possono andare incontro
alla morte a causa di essa. La maggior parte dei soggetti, con la sindrome di down,
presentano una maggiore prevalenza di ipotiroidismo congenito e disfunzione tiroidea, e ciò
impedisce il flusso di informazioni tra le cellule, provocando sovrappeso e obesità.
Disabilità intellettiva
La sindrome può presentare, nei soggetti, anche una disabilità intellettiva, che può essere
lieve ( con QI tra 70 e 50), moderato (con QI tra 50 e 35), e grave nei casi rari (con QI tra 35
e 20). Il ritardo mentale, in realtà, è provocato dal deficit di un sistema cognitivo
complesso,caratterizzato da varie componenti indipendenti che sono connesse tra di loro,
anche se è più adeguato parlare di disabilità intellettiva o deficit cognitivi. Le aree
maggiormente colpite sono la percezione, la soluzione dei problemi, l’astrazione e la
memorizzazione.
I bambini con la sindrome di down hanno prestazioni inferiori nei compiti verbali e
visuo-spaziali della memoria di lavoro,in particolare in quelle attività che necessitano di un
elevato grado di controllo rispetto ai bambini della stessa età mentale. Il QI tende a subire un
rapido declino con l’avanzare dell’età,vi è una debolezza più rapida delle componenti verbali
dell’intelligenza rispetto a quelle non verbali. L’area maggiormente compromessa nella
sindrome di down è il linguaggio rispetto alle competenze motorie,sociali e visuo-spaziali.Le
difficoltà che interessano la produzione fonologica e l’articolazione verbale fonatoria causano
un linguaggio telegrafico che è caratterizzato da una bassa fluenza verbale,da molte pause,e
da omissioni di fonemi e sillabe. Le prime parole si sviluppano con un ritardo di circa un
anno; intorno ai 4 anni i bambini sono capaci di mettere insieme due o più parole, con un
ritardo di 2 anni rispetto ai bambini con uno sviluppo tipico. Con l’adolescenza e l’età adulta
il linguaggio dal punto di vista morfosintattico è povero, invece il contenuto è ricco,si
riscontra un divario tra la forma e il contenuto. La morfosintassi e la fonologia rimangono i
punti di debolezza,la pragmatica e la semantica rappresentano i punti di forza. La
comprensione del brano appare ridotta, la lettura di parole risulta essere migliore in confronto
alle non parole, ciò è dovuto ad una comprensione della lettura che interessa i processi
fonologici. Anche le abilità di scrittura risultano inferiori rispetto a quelle di lettura,ciò è
provocato da una difficoltà nel controllo dei movimenti essenziali allo sviluppo della
scrittura.
Lo sviluppo delle capacità linguistiche, delle competenze motorie, per il benessere e il senso
di auto-efficacia ,che vanno ad influire sullo sviluppo delle capacità cognitive dipendono
dalla relazione che si instaura tra madre e bambino. Numerose ricerche hanno dimostrato il
tipo di interazione che si stabilisce tra le madri con i figli Down rispetto alle madri con
bambini normodotati,le madri di bambini con sindrome di Down presentano un linguaggio
semplice e utilizzano un interazione più direttiva rispetto alle madri di bambini con uno
sviluppo tipico con la stessa età cronologica. Il modo in cui le mamme percepiscono i figli
Down, influenza il loro atteggiamento nei confronti dei quest’ultimi, le donne che vedono i
propri figli come comunicativi,tenderanno ad assumere un atteggiamento stimolante e
partecipativo nei confronti dei figli, invece le madri oppressive non tengono conto delle
capacità del bambino, ignorano i loro bisogni, provocando problemi relazionali. I genitori nel
momento in cui ricevono la diagnosi sono attraversati da una moltitudine di sensazioni ed
emozioni quali disperazione,rifiuto, desiderio di poter cancellare quello che è avvenuto e
rimuoverlo dalla propria memoria,spesso la comunicazione viene fatta ad un unico
genitore,che deve comunicare la notizia al proprio coniuge. L’accettazione avviene quando i
genitori riconosceranno i bisogni del bambino e troveranno i modi utili al loro
soddisfacimento, e in questo obiettivo deve collaborare anche la scuola, in vista di una cultura
inclusiva.
Il ruolo della scuola
La scuola è definita inclusiva quando garantisce un libero accesso a tutti gli studenti, anche a
quelli che hanno disabilità sia fisiche che intellettive. Il modello inclusivo rispetta l’unicità di
ogni alunno, nell’ottica di una formazione che distingue le differenze e i bisogni di ciascuno
in maniera positiva. L’inclusione da parte degli insegnanti, dovrebbe comprendere la
valutazione delle differenze tra insegnanti ed alunni come preziose risorse,la partecipazione e
la collaborazione tra insegnanti e studenti. L’inclusione sociale,scolastica e poi anche
lavorativa deve includere principi essenziali come la libertà di accesso alle risorse
comunitarie,la comprensione e il sostegno degli altri; si ritiene necessario anche il sostegno a
favore delle famiglie di bambini e adulti con la sindrome di Down. I diritti delle persone sono
uguali, è differente il modo in cui i diritti vengono esercitati, si ritiene che la società debba
modificare le regole adattando le opportunità di lavoro a favore delle persone con disabilità.
La disabilità non è un attributo della persona, ma è il risultato di una relazione disomogenea
tra l'individuo e l'ambiente in cui vive, che deve essere valutato progettando la vita quotidiana
di tutti gli individui.
Ho scelto di prendere in analisi la sindrome di Down, in quanto è stata oggetto di
osservazione peiochè mio cugino di secondo grado Daniele ne è affetto.
Daniele è nato nell’Agosto 1996 da parto naturale. Mia zia mi ha raccontato che il primo
periodo di gravidanza è stato caratterizzato da difficoltà e da minaccia di aborto verso il 3°
mese e di non aver fatto alcun tipo di srcreening neonatale in quanto al tempo aveva 29 anni.
La diagnosi di Sindrome di Down è stata fatta alla nascita. I miei zii mi hanno spiegato di
aver reagito bene alla comunicazione e di essere stati molto sostenuti dalle loro rispettive
famiglie. Mi hanno raccontato poi di aver intrapreso subito dopo la nascita dei percorsi
riabilitativi incentrati inizialmente nell’area psicomotoria; poi all’entrata nella scuola
primaria sono stati avviati anche trattamenti logopedici. Verso i dieci anni però a causa della
scarsa trattabilità di Daniele i trattamenti sono stati sospesi con un invio per un nuovo
trattamento psicomotorio che tenesse conto delle criticità della fase adolescenziale.
Daniele si era progressivamente richiuso in se stesso, era quasi sempre passivo, e aveva
peggiorato anche le vecchie stereotipie: manipolazione di un fazzoletto da cui non si staccava
mai, e l’uso del linguaggio verbale era quasi del tutto sparito.
Nell’ambito scolastico mia zia mi ha riferito che per tutto il periodo di frequenza Daniele ha
usufruito di un insegnante di sostegno e di un accudiente e di essersi sempre trovata bene con
le diverse insegnanti di sostegno che si sono succedute negli anni.
Nella scuola media e superiore aveva avuto un buon inserimento: con i pari c’era una
relazione di accettazione.
Mia zia mi ha descritto com’è ora Daniele dicendomi che si trova in una fase che lei ha
definito “di stallo”: tende a chiudersi di fronte ai cambiamenti, è più oppositivo con la
madre, ascolta di più i fratelli e fa le cose che chiedeva il papà. Il fatto che non parla molto
crea delle difficoltà e si innervosisce se gli si chiede di esprimersi; lo fa invece attraverso i
gesti. Guarda spesso la televisione, usa il registratore, e usa diverse ore il cellulare. Non ama
le attività creative; nè sporcarsi né dipingere.
Nel corso degli anni non ho avuto molto modo di conoscere Daniele, in quanto, essendo
parenti “alla lontana” non sono state molte le occasioni per conoscerci. Sono comunque
andata a trovarlo durante le feste natalizie e oggi Daniele appare un ragazzo di corporatura
media, dai tratti contraddistinti della Sindrome di Down. E’ molto restio e indietreggia se gli
viene rivolta parola. E’ un po’ curvo su se stesso, mugugna tenendo il suo fazzoletto per una
delle punte, lo sguardo un po’ basso rivolto verso la porta di uscita. Guarda il viso delle altre
persone solo di nascosto, non interagisce e risponde solo con risposte secche se glie viene
fatta qualsiasi tipo di domanda.
Potrebbero piacerti anche
- Musica... Autismo... La violenza delle istituzioniDa EverandMusica... Autismo... La violenza delle istituzioniNessuna valutazione finora
- ADHD e Scuola: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-5/2021Da EverandADHD e Scuola: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-5/2021Nessuna valutazione finora
- Sindrome Di DownDocumento60 pagineSindrome Di Downcc1436270% (1)
- INSEGNARE A COMUNICARE FRASI ED EMOZIONI AL BAMBINO CON AUTISMO. Aspetti Educativi nei Bisogni SpecialiDa EverandINSEGNARE A COMUNICARE FRASI ED EMOZIONI AL BAMBINO CON AUTISMO. Aspetti Educativi nei Bisogni SpecialiNessuna valutazione finora
- Luigi D'alonzo - La Differenziazione Didattica Per L'inclusione - RiassuntoDocumento20 pagineLuigi D'alonzo - La Differenziazione Didattica Per L'inclusione - RiassuntoCamilla Totti100% (1)
- Disabilità IntellettivaDocumento5 pagineDisabilità IntellettivasilviaNessuna valutazione finora
- A scuola dopo la Covid-19: Non torniamo indietro, andiamo avanti! Riflessioni e idee per una scuola a misura di bambini e ragazziDa EverandA scuola dopo la Covid-19: Non torniamo indietro, andiamo avanti! Riflessioni e idee per una scuola a misura di bambini e ragazziNessuna valutazione finora
- ADHD, Strategie educative per gli insegnanti: Pratico manuale per docentiDa EverandADHD, Strategie educative per gli insegnanti: Pratico manuale per docentiNessuna valutazione finora
- Disturbi Specifici d'Apprendimento (DSA): Il ruolo della famiglia e della scuola nel percorso di riabilitazione dell'alunno con DSADa EverandDisturbi Specifici d'Apprendimento (DSA): Il ruolo della famiglia e della scuola nel percorso di riabilitazione dell'alunno con DSANessuna valutazione finora
- AutismoDocumento29 pagineAutismoMartina ZampedriNessuna valutazione finora
- La dislessia: Una guida per genitori e insegnanti: teoria, trattamenti e giochiDa EverandLa dislessia: Una guida per genitori e insegnanti: teoria, trattamenti e giochiNessuna valutazione finora
- Dislessia e Musica - Bufano n.4Documento28 pagineDislessia e Musica - Bufano n.4Michael VaughnNessuna valutazione finora
- 3 - Disabilità IntellettivaDocumento8 pagine3 - Disabilità IntellettivaStefaniaNessuna valutazione finora
- La normalità dell'essere speciale: Dalla dislessia in età evolutiva alla dislessia in età adultaDa EverandLa normalità dell'essere speciale: Dalla dislessia in età evolutiva alla dislessia in età adultaNessuna valutazione finora
- Dislessia Vademecum TermineDocumento159 pagineDislessia Vademecum TerminersueuropawoolfNessuna valutazione finora
- Tesi Persone DownDocumento113 pagineTesi Persone DownlcucininaNessuna valutazione finora
- Autismo E Comunicazione FacilitataDocumento50 pagineAutismo E Comunicazione FacilitataRaffaella Ma100% (1)
- Storia dell’Inclusione scolastica in Italia: Lettura pedagogica della normativaDa EverandStoria dell’Inclusione scolastica in Italia: Lettura pedagogica della normativaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- BES e DSA Dalle origini ai nuovi approcci terapeuticiDa EverandBES e DSA Dalle origini ai nuovi approcci terapeuticiNessuna valutazione finora
- Bes e attività motorie inclusive: Proposte didattiche operativeDa EverandBes e attività motorie inclusive: Proposte didattiche operativeNessuna valutazione finora
- Bes e Dislessia Significato e Strategie Didattiche PDFDocumento35 pagineBes e Dislessia Significato e Strategie Didattiche PDFSara Vitale0% (1)
- Dall'integrazione all'inclusione: Il nuovo profilo del docente di sostegnoDa EverandDall'integrazione all'inclusione: Il nuovo profilo del docente di sostegnoNessuna valutazione finora
- La pedagogia inclusiva di Sergio Neri: Le colonie, la CharitasDa EverandLa pedagogia inclusiva di Sergio Neri: Le colonie, la CharitasNessuna valutazione finora
- Gli Screenings Scolastici: Descrizione generale delle condizioni funzionali degli alunniDa EverandGli Screenings Scolastici: Descrizione generale delle condizioni funzionali degli alunniNessuna valutazione finora
- Verso una società inclusiva: Attraverso la scuolaDa EverandVerso una società inclusiva: Attraverso la scuolaNessuna valutazione finora
- Metodologie e tecniche dell'insegnamentoDa EverandMetodologie e tecniche dell'insegnamentoNessuna valutazione finora
- Insegnante Di Sostegno Majorana Genzano PDFDocumento53 pagineInsegnante Di Sostegno Majorana Genzano PDFAlma MiaNessuna valutazione finora
- Cottini - Autismo e IntegrazioneDocumento11 pagineCottini - Autismo e Integrazionetina_dollyNessuna valutazione finora
- Problemi Di Comportamento e Relazione Di AiutoDocumento52 pagineProblemi Di Comportamento e Relazione Di AiutoLiborio ScavoneNessuna valutazione finora
- La musicoterapia quale didattica applicata ai disturbi dello spettro autisticoDa EverandLa musicoterapia quale didattica applicata ai disturbi dello spettro autisticoNessuna valutazione finora
- Erickson BES A ScuolaDocumento20 pagineErickson BES A Scuolaalessandro cuboniNessuna valutazione finora
- AUTISMO - Linee Guida SinpiaDocumento82 pagineAUTISMO - Linee Guida SinpiatifososscnapoliNessuna valutazione finora
- Disturbi Specifici Dell'Apprend - Concetta FratantonioDocumento19 pagineDisturbi Specifici Dell'Apprend - Concetta FratantonioconcratNessuna valutazione finora
- Mi sento meglio: Esperienze di applicazione di musica elettronica in musicoterapia per l'educazione dell'orecchio con Ic, dsa, sindrome di Down e autismoDa EverandMi sento meglio: Esperienze di applicazione di musica elettronica in musicoterapia per l'educazione dell'orecchio con Ic, dsa, sindrome di Down e autismoNessuna valutazione finora
- LG Autismo DefDocumento116 pagineLG Autismo DefAurora AchilleNessuna valutazione finora
- Pedagogia Speciale, Medicina, Tecnologia. Territori comuni, specificità e intrecciDa EverandPedagogia Speciale, Medicina, Tecnologia. Territori comuni, specificità e intrecciNessuna valutazione finora
- Elaborato finale dell’attività di tirocinio. Progettazione di un percorso educativo-didattico in: sicurezza stradale a carattere inclusivoDa EverandElaborato finale dell’attività di tirocinio. Progettazione di un percorso educativo-didattico in: sicurezza stradale a carattere inclusivoNessuna valutazione finora
- L' ansia da performance musicale: Esibirsi con più frequenza aiuta a ridurre il livello d'ansia?Da EverandL' ansia da performance musicale: Esibirsi con più frequenza aiuta a ridurre il livello d'ansia?Nessuna valutazione finora
- 23.approccio TeacchDocumento23 pagine23.approccio TeacchPerla BelloneNessuna valutazione finora
- La bocca del bambino: introduzione alla disprassia orale in età evolutivaDa EverandLa bocca del bambino: introduzione alla disprassia orale in età evolutivaNessuna valutazione finora
- 347.8 Mura. Diversità e InclusioneDocumento156 pagine347.8 Mura. Diversità e InclusioneBarbara GalaffuNessuna valutazione finora
- Didattica InclusivaDocumento9 pagineDidattica InclusivaTommaso ImperioNessuna valutazione finora
- Programmi Di Intervento in AutismoDocumento8 pagineProgrammi Di Intervento in Autismoshoppo shoppiniNessuna valutazione finora
- Relazione EducativaDocumento15 pagineRelazione EducativaDario MariottoNessuna valutazione finora
- Vademecum Per Docenti Di Sostegno PDFDocumento14 pagineVademecum Per Docenti Di Sostegno PDFPaola LanternaNessuna valutazione finora
- AdhdDocumento186 pagineAdhdAlessandro CecchiniNessuna valutazione finora
- Elenco Delle Principali Norme Di Legislazione ScolasticaDocumento7 pagineElenco Delle Principali Norme Di Legislazione ScolasticaTommaso ImperioNessuna valutazione finora
- NORMATIVA INCLUSIONE - Prof RedavidDocumento23 pagineNORMATIVA INCLUSIONE - Prof RedavidSergio FabianoNessuna valutazione finora
- Dispensa Minorazioni Visive e Nuove TecnologieDocumento27 pagineDispensa Minorazioni Visive e Nuove Tecnologiesal_mi72Nessuna valutazione finora
- Il Profilo Dei Docenti Inclusivi IANESDocumento15 pagineIl Profilo Dei Docenti Inclusivi IANESMargherita SolaroNessuna valutazione finora
- COSE IL PDP e Come CompilarloDocumento40 pagineCOSE IL PDP e Come CompilarloGabriele1883100% (1)
- MULTICULTURALISMO NELL'EDUCAZIONE MUSICALE (S.Facci) RIASSUNTODocumento4 pagineMULTICULTURALISMO NELL'EDUCAZIONE MUSICALE (S.Facci) RIASSUNTOHera GuglielmoNessuna valutazione finora