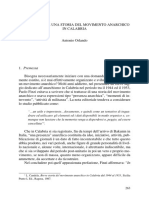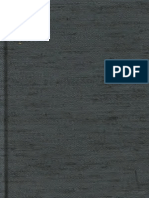Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Italia 5
Italia 5
Caricato da
provaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Italia 5
Italia 5
Caricato da
provaCopyright:
Formati disponibili
L'et� moderna
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Italia
rinascimentale.
L'Italia nel 1494
Diversi fattori impediscono tuttavia la nascita di uno Stato unitario come avviene
nel resto d'Europa: al timore del Papato di veder sorgere una potenza statale in
grado di compromettere la sua autonomia, si aggiunge la suddivisione in tanti
piccoli Comuni, che lentamente si tramutano in Signorie, rette da importanti
famiglie, come i Medici a Firenze, i Visconti e gli Sforza a Milano, i Della Scala
a Verona e gli Este a Ferrara. I capi politici italiani devono supplire con
l'intelligenza strategica alla superiorit� di forze degli stati nazionali europei.
Un esempio � Cosimo de' Medici, tra i maggiori artefici del Rinascimento
fiorentino, la cui politica estera sapr� individuare nella concordia italiana
l'elemento chiave per impedire agli stati stranieri di intervenire in Italia
approfittando delle sue divisioni.[37]
La strategia di Cosimo, proseguita dal suo successore Lorenzo il Magnifico, non
viene compresa dagli altri pr�ncipi italiani, e si conclude con la morte di Lorenzo
nel 1492. Da allora l'Italia diventa il teatro di numerose invasioni straniere:
dapprima da parte francese per opera di Carlo VIII e Luigi XII, poi delle truppe
spagnole di Carlo V. L'inizio della dominazione straniera si deve quindi al ritardo
del processo politico di unificazione, ma fa anche registrare episodi di
patriottismo, come il gesto di Ettore Fieramosca nella disfida di Barletta.[38]
Fortificazione all'italiana
L'et� Moderna � anche il periodo dell'evoluzione bellica, con la comparsa della
polvere da sparo e di nuovi mezzi militari (cannoni, moschetti ecc.). Ci� modific�
anche la faccia di molte citt� italiane, costrette a evolvere le proprie difese
militari: nasce la Fortificazione alla moderna, detta anche "Fortificazione
all'italiana", proprio perch� i primi esempi di mura moderne compaiono nelle citt�
italiane (classico esempio � quello delle Mura di Lucca).
Cosimo de' Medici, Pater Patriae. (Galleria degli Uffizi)
Nella seconda met� del Cinquecento comincia il tramonto della vitalit�
rinascimentale, indebolita anche dalle nuove tensioni religiose dovute all'avvento
della riforma protestante in Europa, che avevano portato a episodi luttuosi come il
sacco di Roma del 1527 a opera dei Lanzichenecchi. Soltanto la repubblica di
Venezia manterr� una certa prosperit� e autonomia politica. Il Seicento � invece un
secolo di crisi per tutto il paese: la Chiesa, che ha sub�to la perdita dell'unit�
cristiana dei fedeli, cerca con la controriforma di rafforzare la sua presenza nei
paesi rimasti cattolici, sia con iniziative educative e assistenziali, sia
isolandoli dall'influsso degli stati protestanti. L'Italia viene cos� salvaguardata
dai conflitti religiosi che si accendono in Europa, ma � soggetta ugualmente a
carestie, spesso seguite da epidemie.[39] Scoppiano perci� numerose rivolte contro
la dominazione spagnola, di cui la pi� nota avviene a Napoli nel 1647 per opera di
Masaniello, ma non portano a nessun cambiamento.
All'inizio del Settecento finisce il periodo di pace e di torpore: a seguito dei
trattati di Utrecht e Rastatt, gli Asburgo d'Austria si impossessano di vari domini
italiani subentrando agli spagnoli.[37] Tornata la pace in tutta la penisola, dalla
seconda met� del secolo, la diffusione dell'illuminismo fa s� che anche l'Italia
venga investita da importanti riforme, che coinvolgono in particolare il Ducato di
Milano sotto Maria Teresa d'Austria e Giuseppe II d'Asburgo, il Granducato di
Toscana sotto Pietro Leopoldo di Lorena, che nel 1786 con il codice leopoldino
abolisce, per la prima volta nella storia, la pena di morte e il Regno di Napoli,
animato dal vivace dibattito dei pensatori. Di rilievo le figure degli
intellettuali Giambattista Vico, Gaetano Filangieri, Cesare Beccaria, Mario Pagano,
Alessandro e Pietro Verri[40].
Potrebbero piacerti anche
- Le Religioni Nell'Italia Che CambiaDocumento13 pagineLe Religioni Nell'Italia Che CambiaMarioNessuna valutazione finora
- Maestri e Allievi Nella Fisica Italiana Del NovecentoDocumento67 pagineMaestri e Allievi Nella Fisica Italiana Del Novecentofisica_musicaNessuna valutazione finora
- Il Mondo Della Radio. Dal Transistor Ai Social Network - MenduiniDocumento20 pagineIl Mondo Della Radio. Dal Transistor Ai Social Network - MenduiniAnonymous lJ1mSZWX1DNessuna valutazione finora
- Liste Varietali CiliegioDocumento10 pagineListe Varietali CiliegioscienziatoNessuna valutazione finora
- Il Peperoncino Rosso Febbraio 2016Documento16 pagineIl Peperoncino Rosso Febbraio 2016IlPeperoncinoRossoNessuna valutazione finora
- Programma A1, A2, B1Documento16 pagineProgramma A1, A2, B1Raffaella de AntonellisNessuna valutazione finora
- Coppa Italia Open U11Documento10 pagineCoppa Italia Open U11Centro Formazione CalcioNessuna valutazione finora
- Il Piccolo Del CremascoDocumento28 pagineIl Piccolo Del Cremascopromedia3Nessuna valutazione finora
- Feltrinelli A40anni PDFDocumento32 pagineFeltrinelli A40anni PDFXenia Oktogon100% (1)
- Il Sommelier Veneto n.1 - Marzo 2013Documento37 pagineIl Sommelier Veneto n.1 - Marzo 2013Paolo ColomboNessuna valutazione finora
- Orlando LineamentiDocumento15 pagineOrlando LineamentiFrancescoNessuna valutazione finora
- I.C. Ponte Di Nona Vecchio Lunghezza Roma Graduatoria - Ata - Definitiva - PrivacyDocumento334 pagineI.C. Ponte Di Nona Vecchio Lunghezza Roma Graduatoria - Ata - Definitiva - Privacyrsueuropawoolf8793Nessuna valutazione finora
- ElleDocumento370 pagineEllejelzb087318100% (1)
- Corriere Cesenate 17-2019Documento24 pagineCorriere Cesenate 17-2019settimanale Corriere CesenateNessuna valutazione finora
- AdHoc - Riepilogativo 2009Documento29 pagineAdHoc - Riepilogativo 2009JonDoeNessuna valutazione finora
- Corde Violino PeruffoDocumento59 pagineCorde Violino PeruffoMarco Vinicio BazzottiNessuna valutazione finora
- Brigantaggio PostunitarioDocumento6 pagineBrigantaggio PostunitarioDylanILoveYouNessuna valutazione finora
- Elenco Pubblicazioni Di Giulio TagliaviniDocumento11 pagineElenco Pubblicazioni Di Giulio TagliaviniGiulio TagliaviniNessuna valutazione finora
- Cronache Di Napoli 10 Aprile 2010Documento33 pagineCronache Di Napoli 10 Aprile 2010stefanoNessuna valutazione finora
- Selezione Officer Comitati Regionali - Modulo Di Conferma PreferenzeDocumento2 pagineSelezione Officer Comitati Regionali - Modulo Di Conferma PreferenzeDaniele MirabellaNessuna valutazione finora
- BibliografiaDocumento9 pagineBibliografiaLu GreenNessuna valutazione finora
- Le Grammatiche Della Lingua ItalianaDocumento14 pagineLe Grammatiche Della Lingua ItalianaFranklin BedoyaNessuna valutazione finora
- Riassunto MarazziniDocumento27 pagineRiassunto MarazziniMarina Beltrame0% (1)
- Garibaldi Poema AutobiograficoDocumento145 pagineGaribaldi Poema AutobiograficoEmanuele GiustiniNessuna valutazione finora
- La Svolta Di GiottoDocumento162 pagineLa Svolta Di GiottoEnrico GalavottiNessuna valutazione finora
- Heyd Colonie Italiane Nel Levante 1Documento469 pagineHeyd Colonie Italiane Nel Levante 1Marco CaboaraNessuna valutazione finora
- Itacat Versione RidottaDocumento24 pagineItacat Versione RidottaMichel GalassoNessuna valutazione finora
- LIBRO Su ArbëreshëDocumento98 pagineLIBRO Su Arbëreshëmargarition100% (2)
- Catalogo Zecchini EditoreDocumento36 pagineCatalogo Zecchini Editorelubas2Nessuna valutazione finora
- Mi Consenta. Metafore, Messaggi e Simboli: Come Silvio Berlusconi Ha Conquistato Il Consenso Degli Italiani PDFDocumento172 pagineMi Consenta. Metafore, Messaggi e Simboli: Come Silvio Berlusconi Ha Conquistato Il Consenso Degli Italiani PDFElmo RNessuna valutazione finora