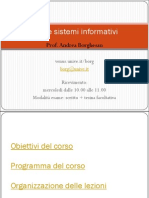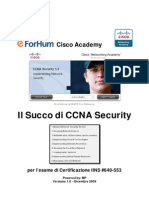Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
278 visualizzazioni12 pagineLe Architetture Di Reti
Il documento descrive le architetture di reti, in particolare la storia dello sviluppo delle reti locali (LAN) e delle loro topologie principali come bus, anello, stella e albero. Vengono introdotti anche i concetti di protocolli di comunicazione, reti geografiche più estese come le WAN e la classificazione di queste ultime in intranet, extranet e VPN.
Caricato da
Gianluca ManzoCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
278 visualizzazioni12 pagineLe Architetture Di Reti
Il documento descrive le architetture di reti, in particolare la storia dello sviluppo delle reti locali (LAN) e delle loro topologie principali come bus, anello, stella e albero. Vengono introdotti anche i concetti di protocolli di comunicazione, reti geografiche più estese come le WAN e la classificazione di queste ultime in intranet, extranet e VPN.
Caricato da
Gianluca ManzoCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd