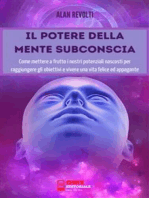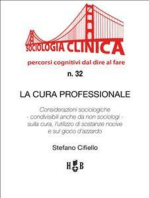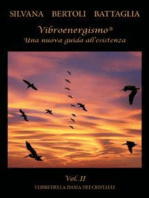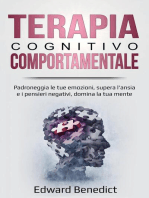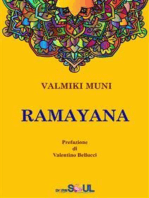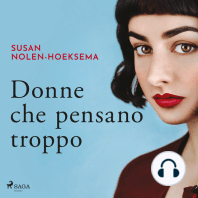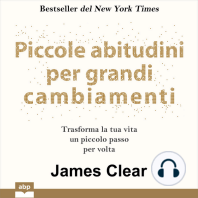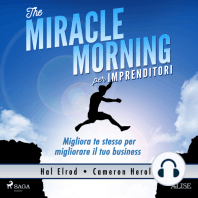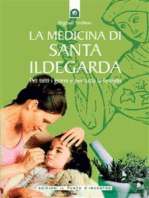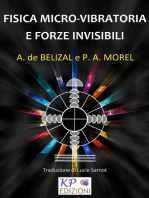Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Contributo Della Mindfulness Nella Pratica Clinica
Caricato da
Eleonora De Medici Lombardi0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
797 visualizzazioni74 pagineLa tesi che ho proposto è divisa in tre macrocapitoli che esplorano la Mindfulness da punti diversi, nel tentativo di trattarla nella sua integrità.
Il primo capitolo tratta delle origini della Mindfulness, ovvero la sua evoluzione dalle radici buddiste fino ai primi trattamenti in ambito psicologico. Ho descritto come la pratica di meditazione Vipassana sia stata il punto di partenza per la stesura di programmi meditativi in ambito clinico, delineando in che modo essa sia stata applicata per la prima volta da Kabat-Zinn. Sono passata alla definizione dell’orientamento filosofico in vista dell’applicazione e le teorie cognitive sottostanti alla pratica, per illustrarne meglio la funzione al giorno d'oggi.
Nel secondo capitolo ho trovato utile approfondire degli elementi di psicologia biologica, per poter osservare più da vicino gli effetti cerebrali determinati da una pratica di attenzione sostenuta come la mindfulness. In questa parte sono state descritte le varie dinamiche nervose dei processi attentivi negli studi che hanno confrontato soggetti che praticano regolarmente esercizi meditativi con chi non né fa uso. Infine, sono stati espressi sia il ruolo dei neuroni specchio nella mindfulness, che i circuiti cerebrali dediti ai compiti attentivi.
E’ stato osservato come il fattore biologico abbia un ruolo importante nella pratica mindfulness sia perché questa possa essere intrapresa, sia per osservarne gli effetti benefici.
Il terzo capitolo affronta in modo approfondito le principali applicazioni mindful. Essendo una realtà particolarmente vasta, mi sono concentrata su quelle pratiche che hanno maggiormente avuto un impatto nella realtà terapeutica attuale. La letteratura che ho ispezionato per poter comprendere le applicazioni mindful in ambito clinico è stata divisa a seconda dei programmi meditativi e successivamente per varie tipologie di disturbi e malattie.
In questo capitolo sono stati esposti i maggiori ambiti applicativi del programma Mindfulness-Based Stress Reduction, di Kabat-Zinn come ad esempio: dolore cronico, ansia, psoriasi e cancro. Seguono poi il programma della Dialectical Behavior Therapy, rivolta a soggetti con disturbi di personalità borderline; il programma vicentino per il disturbo ossessivo-compulsivo ed infine la Mindfulness Based Cognitive Therapy nell’uso alla recidività e ricaduta depressiva di Teasdale e collaboratori.
In sintesi, gli argomenti che mi sono proposta di trattare sono stati selezionati per approfondire ogni sfaccettatura della mindfulness, da quella storica, a quella prettamente pratica, passando anche dagli aspetti biologici.
Sperando che chi si presta a leggere questo elaborato scopra la stessa passione che ho personalmente vissuto nell' esplorare questo vasto ed interessante argomento in continua evoluzione, auguro una buona lettura.
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoLa tesi che ho proposto è divisa in tre macrocapitoli che esplorano la Mindfulness da punti diversi, nel tentativo di trattarla nella sua integrità.
Il primo capitolo tratta delle origini della Mindfulness, ovvero la sua evoluzione dalle radici buddiste fino ai primi trattamenti in ambito psicologico. Ho descritto come la pratica di meditazione Vipassana sia stata il punto di partenza per la stesura di programmi meditativi in ambito clinico, delineando in che modo essa sia stata applicata per la prima volta da Kabat-Zinn. Sono passata alla definizione dell’orientamento filosofico in vista dell’applicazione e le teorie cognitive sottostanti alla pratica, per illustrarne meglio la funzione al giorno d'oggi.
Nel secondo capitolo ho trovato utile approfondire degli elementi di psicologia biologica, per poter osservare più da vicino gli effetti cerebrali determinati da una pratica di attenzione sostenuta come la mindfulness. In questa parte sono state descritte le varie dinamiche nervose dei processi attentivi negli studi che hanno confrontato soggetti che praticano regolarmente esercizi meditativi con chi non né fa uso. Infine, sono stati espressi sia il ruolo dei neuroni specchio nella mindfulness, che i circuiti cerebrali dediti ai compiti attentivi.
E’ stato osservato come il fattore biologico abbia un ruolo importante nella pratica mindfulness sia perché questa possa essere intrapresa, sia per osservarne gli effetti benefici.
Il terzo capitolo affronta in modo approfondito le principali applicazioni mindful. Essendo una realtà particolarmente vasta, mi sono concentrata su quelle pratiche che hanno maggiormente avuto un impatto nella realtà terapeutica attuale. La letteratura che ho ispezionato per poter comprendere le applicazioni mindful in ambito clinico è stata divisa a seconda dei programmi meditativi e successivamente per varie tipologie di disturbi e malattie.
In questo capitolo sono stati esposti i maggiori ambiti applicativi del programma Mindfulness-Based Stress Reduction, di Kabat-Zinn come ad esempio: dolore cronico, ansia, psoriasi e cancro. Seguono poi il programma della Dialectical Behavior Therapy, rivolta a soggetti con disturbi di personalità borderline; il programma vicentino per il disturbo ossessivo-compulsivo ed infine la Mindfulness Based Cognitive Therapy nell’uso alla recidività e ricaduta depressiva di Teasdale e collaboratori.
In sintesi, gli argomenti che mi sono proposta di trattare sono stati selezionati per approfondire ogni sfaccettatura della mindfulness, da quella storica, a quella prettamente pratica, passando anche dagli aspetti biologici.
Sperando che chi si presta a leggere questo elaborato scopra la stessa passione che ho personalmente vissuto nell' esplorare questo vasto ed interessante argomento in continua evoluzione, auguro una buona lettura.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
797 visualizzazioni74 pagineIl Contributo Della Mindfulness Nella Pratica Clinica
Caricato da
Eleonora De Medici LombardiLa tesi che ho proposto è divisa in tre macrocapitoli che esplorano la Mindfulness da punti diversi, nel tentativo di trattarla nella sua integrità.
Il primo capitolo tratta delle origini della Mindfulness, ovvero la sua evoluzione dalle radici buddiste fino ai primi trattamenti in ambito psicologico. Ho descritto come la pratica di meditazione Vipassana sia stata il punto di partenza per la stesura di programmi meditativi in ambito clinico, delineando in che modo essa sia stata applicata per la prima volta da Kabat-Zinn. Sono passata alla definizione dell’orientamento filosofico in vista dell’applicazione e le teorie cognitive sottostanti alla pratica, per illustrarne meglio la funzione al giorno d'oggi.
Nel secondo capitolo ho trovato utile approfondire degli elementi di psicologia biologica, per poter osservare più da vicino gli effetti cerebrali determinati da una pratica di attenzione sostenuta come la mindfulness. In questa parte sono state descritte le varie dinamiche nervose dei processi attentivi negli studi che hanno confrontato soggetti che praticano regolarmente esercizi meditativi con chi non né fa uso. Infine, sono stati espressi sia il ruolo dei neuroni specchio nella mindfulness, che i circuiti cerebrali dediti ai compiti attentivi.
E’ stato osservato come il fattore biologico abbia un ruolo importante nella pratica mindfulness sia perché questa possa essere intrapresa, sia per osservarne gli effetti benefici.
Il terzo capitolo affronta in modo approfondito le principali applicazioni mindful. Essendo una realtà particolarmente vasta, mi sono concentrata su quelle pratiche che hanno maggiormente avuto un impatto nella realtà terapeutica attuale. La letteratura che ho ispezionato per poter comprendere le applicazioni mindful in ambito clinico è stata divisa a seconda dei programmi meditativi e successivamente per varie tipologie di disturbi e malattie.
In questo capitolo sono stati esposti i maggiori ambiti applicativi del programma Mindfulness-Based Stress Reduction, di Kabat-Zinn come ad esempio: dolore cronico, ansia, psoriasi e cancro. Seguono poi il programma della Dialectical Behavior Therapy, rivolta a soggetti con disturbi di personalità borderline; il programma vicentino per il disturbo ossessivo-compulsivo ed infine la Mindfulness Based Cognitive Therapy nell’uso alla recidività e ricaduta depressiva di Teasdale e collaboratori.
In sintesi, gli argomenti che mi sono proposta di trattare sono stati selezionati per approfondire ogni sfaccettatura della mindfulness, da quella storica, a quella prettamente pratica, passando anche dagli aspetti biologici.
Sperando che chi si presta a leggere questo elaborato scopra la stessa passione che ho personalmente vissuto nell' esplorare questo vasto ed interessante argomento in continua evoluzione, auguro una buona lettura.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 74
SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE DELLEDUCAZIONE
SAN GIOVANNI BOSCO
Affiliata alla FSE dellUniversit Pontificia Salesiana
Corso di Laurea in Psicoloia dellEduca!ione
IL CON"RIBU"O DELLA #IND$ULNESS
NELLA
PRA"ICA CLINICA
"esi di Laurea di% Eleonora Lo&'ardi
Anno Accade&ico ()*(+()*,
INDICE
Introduzione...1
CAPI"OLO *- La Mindfulness............4
1. Le origini della Mindfulness......4
2. La Mindfulness oggi...6
2.1 Modalit del fare e dellessere.............7
2.1.1 Modalit del fare...........7
2.1.2 Modalit dellessere..........8
2.2 Capacit e coprensione..8
2.2.1 Il potere della relativit.....!
2.2.2 Non rinunciare a vivere il dolore1"
#. $alidit scientifica% &erso un epiriso a pari erito....11
CAPI"OLO (. Il cer&ello indful......1#
1. Meditazione e cer&ello.....1#
1.1 Corteccia frontale e giro cingolato.....1#
1.2 'alao....14
1.# ()(L * Lo+o Latero (ostero )uperiore.1,
1.4 -igdala ed ippocapo.1,
1., Lipotalao....16
1.6 Lattenzione nel cer&ello indful......17
#. .euroni specc/io e Mindfulness......18
CAPI"OLO ,. La Mindfulness nelluso terapeutico..2"
1. Mindfulness e terapia cogniti&a.......2"
2. Mindfulness 0ased )tress 1eduction...................2"
2.1 M0)1 e dolore cronico..2"
2.2 M0)1 ed ansia...21
2.# M0)1 e psoriasi.....22
2.4 M0)1 e cancro..2#
#. Il prograa +ase in atto oggi.24
#.1 (ratic/e forali..2,
#.2 (ratic/e inforali...26
4. Il distur+o 0orderline di personalit.....26
4.1 Insta+ilit affetti&a......27
4.2 Il distur+o cogniti&o.. ....28
4.# La psico+iologia.....2!
,. 2istur+o 0orderline e 2ialectical 0e/a&iour '/erap3.....2!
,.1 'rattare il distur+o..#"
,.1.1 Labilit della mente saggia................#1
,.1.1 Labilit di contenuto (what skills)..#1
,.1.# bilit formali.#2
6. Il distur+o 4ssessi&o5Copulsi&o 624C7...... ##
6.1 'erapia faracologica....#4
6.2 La psicoterapia...#4
7. 2istur+o 4ssessi&o5Copulsi&o e Mindfulness..#,
7.1 Il prograa esso in atto a $icenza per il distur+o 24C......#,
7.2 )truttura del prograa sul 24C..........#6
8. Il pro+lea della 2epressione..#7
8.1 'rattaento faracologico....#8
8.2 'rattaento psicoterapeutico.........#!
!. 2epressione e M0C'.......4"
1". Il la&oro della M0C'.....4"
1".1 Metacognizione41
1".2 1uinazione.....41
1".# 8&itaento4#
1".4 Il pilota autoatico...4#
1"., 1icordi c/e si atti&ano in +ase alluore.....44
11. Le sedute di M0C'....44
12. Contenuti delle sessioni settianali...4,
12.1 (ria settiana * Il pilota autoatico.....4,
12.2 )econda settiana 5 9estire le difese...4,
12.# 'erza settiana 5 Mindfulness del respiro...46
12.4 :uarta settiana * 1estare ;ui ed ora..46
12., :uinta settiana * -ccettare<accogliere<lasciar essere....47
12.6 )esta settiana * (ensieri non fatti..47
12.7 )ettia settiana * Coe prendersi cura di s=....48
12.8 4tta&a settiana * >sare ci? c/e @ stato appreso anc/e in futuro...4!
1#. 8sercizi del prograa M0C'.....4!
1#.1 Lu&a passa..4!
1#.1.2 Leserci!io.....4!
1#.1.# "inalit......................................................................,"
1#.2. 0od3 scan....,1
1#.2.1 Leserci!io.,1
1#.2.2 "inalit..,2
1#.#. (ratica forale ed inforale a casa....,2
1#.#.1 La pratica formale.,2
1#.#.2 La pratica informale..,#
1#.4 8sercizio dei pensieri e delleozioni.,#
1#.4.1 Leserci!io ,#
1#.4.2 "inalit..,#
1#., La editazione seduta 5 consape&olezza sul respiro e sul corpo.....,4
1#.,.1 Leserci!io.,4
1#.,.2 "inalit..,4
1#.6. )pazio di respiro di tre inuti.....,,
1#.6.1 Leserci!io.,,
1#.6.2 "inalit..,,
1#.7 (ratica del o&iento indful * AalBing editation,6
1#.7.1 Leserci!io.,6
1#.7.2 "inalit..,6
Conclusioni...,7
0i+liografia...6"
)itografia..6!
IN"RODUZIONE
)ono sepre riasta affascinata dal funzionaento del corpo uanoC in noi non esiste
niente di di&erso da tutto ci? c/e c@ in natura. Luoo @ una acc/ina straordinariaente
coplessaC respira% si uo&e% si nutre% sepre in un continuo e norale ca+iaento.
Le particelle dello spazio cosico sono le stesse c/e ci copongono coe organisi
&i&enti e c/e ci circondano coe per i ateriali inaniatiC fino ad oggi% tutto ci? c/e in
scienza @ conosci+ile si uo&e sotto le stesse leggi fisic/e e c/iic/e. La ateria ci
copone e ci a++andona continuaente coe succede per tutte le cose c/e sono presenti
nelluni&erso.
8ppure% risulta facile iaginare c/e lessere uano sia ordinato da ;ualcosa di piD
grande c/e lo renda in ;ualc/e odo ;ualitati&aente di&erso dalla ateria di cui @
coposto.
>n cer&ello uano pesa circa 14"" grai% lo si pu? solle&are con un palo%
ciononostante% pur essendo fatto da couni ateriali organici% @ in grado di +adare al suo
funzionaento e di contenere e rappresentare luni&erso c/e lo circonda% creandosi una sua
realt interna.
:uesta realt personale @ il oti&o per cui i sono da sepre interessata alla psicologiaC
ogni indi&iduo @ portatore di un suo particolare ondo interiore c/e pu? essere
difficilente indaga+ile anc/e per la persona stessa c/e lo contiene.
La realt interiore esercita sul nostro +enessere una forza coerciti&a estreaente potente%
c/e pu? essere causa di gioia e sofferenza% di li+ert e prigionia.
La indfulness @ il &eicolo esplorati&o grazie al ;uale luoo pu? coprendersi nei suoi
dinaisi intii% @ un ezzo per cui gli &iene offerto un odo di a+itare la propria
persona coe un osser&atore c/e guarda aore&olente il proprio paesaggio psicologico.
La pratica indful insegna ad essere consape&oli di se stessi e del ondo c/e ci circondaC
rende in grado di percepire i propri confini do&e la finitudine uana @ interpretata coe
una possi+ilit e non una liitazione. :uesta tecnica educa ad essere accoglienti e pazienti
di fronte alle a&&ersit ed al dolore e &a riattri+uendo alluoo la sua genuina capacit di
padroneggiare se stesso.
Il nucleo della indfulness @ ;uello di ricordare ad ogni indi&iduo c/e non pu? n= sapere%
n= scegliere la natura degli e&enti c/e inco+ono nella &ita% a c/e pu? decidere ;uale
atteggiaento utilizzare di fronte ad essi.
1
La indfulness non /a uno scopo pratico se non ;uello di educare i praticanti ad essere%
colti&ando un odello di funzionaento sano.
:uesta tecnica editati&a ad oggi risulta una delle piD iportanti inno&azioni nella+ito
scientificoC nata coe connu+io intelligente fra tradizione +udd/ista e psicologia% /a
diostrato sin dallEinizio una grande &ariet di applicazione ed efficacia in di&erse
patologie. )e++ene la indfulness offra uno scenario estreaente &asto e in continuo
utaento ed apliaento% in ;uesto scritto tenter? di darne una panoraica coplessi&a
ed esausti&a% sofferandoi sulla concettualizzazione della pratica ed i relati&i effetti
cere+rali% le teorie di riferiento e le applicazioni in a+ito clinico.
Coe precedenteente detto% la indfulness @ uno studio in e&oluzioneF nascono
continuaente nuo&e applicazioni pratic/e e nuo&i studi sulle sue potenzialit. LEenore
&astit dei casi a cui pu? essere applicata la rende un argoento di studio particolarente
interessante c/e offre sia ai terapeuti c/e ai pazienti nuo&e soluzioni. La c/ia&e di lettura
inno&ati&a della tecnica indful @ ;uella di saper spingere il praticante a prestare
attenzione nel Ghic et nuncH del proprio s=% accettando sensazioni% ipulsi% percezioni e
pensieri della propria interiorit in odo non giudicante.
La tesi c/e /o proposto @ di&isa in tre acrocapitoli c/e esplorano la Mindfulness da punti
di&ersi% nel tentati&o di trattarla nella sua integrit.
Il prio capitolo tratta delle origini della Mindfulness% o&&ero la sua e&oluzione dalle
radici +uddiste fino ai prii trattaenti in a+ito psicologico. Io descritto coe la pratica
di editazione $ipassana sia stata il punto di partenza per la stesura di prograi
editati&i in a+ito clinico% delineando in c/e odo essa sia stata applicata per la pria
&olta da Ja+at5Kinn. )ono passata alla definizione dellorientaento filosofico in &ista
dellapplicazione e le teorie cogniti&e sottostanti alla pratica% per illustrarne eglio la
funzione al giorno dEoggi.
.el secondo capitolo /o tro&ato utile approfondire degli eleenti di psicologia +iologica%
per poter osser&are piD da &icino gli effetti cere+rali deterinati da una pratica di
attenzione sostenuta coe la indfulness. In ;uesta parte sono state descritte le &arie
dinaic/e ner&ose dei processi attenti&i negli studi c/e /anno confrontato soggetti c/e
praticano regolarente esercizi editati&i con c/i non n= fa uso. Infine% sono stati espressi
sia il ruolo dei neuroni specc/io nella indfulness% c/e i circuiti cere+rali dediti ai copiti
attenti&i.
2
8 stato osser&ato coe il fattore +iologico a++ia un ruolo iportante nella pratica
indfulness sia perc/= ;uesta possa essere intrapresa% sia per osser&arne gli effetti
+enefici.
Il terzo capitolo affronta in odo approfondito le principali applicazioni indful. 8ssendo
una realt particolarente &asta% i sono concentrata su ;uelle pratic/e c/e /anno
aggiorente a&uto un ipatto nella realt terapeutica attuale. La letteratura c/e /o
ispezionato per poter coprendere le applicazioni indful in a+ito clinico @ stata di&isa a
seconda dei prograi editati&i e successi&aente per &arie tipologie di distur+i e
alattie.
In ;uesto capitolo sono stati esposti i aggiori a+iti applicati&i del prograa
Mindfulness50ased )tress 1eduction% di Ja+at5Kinn coe ad esepioF dolore cronico%
ansia% psoriasi e cancro. )eguono poi il prograa della 2ialectical 0e/a&ior '/erap3%
ri&olta a soggetti con distur+i di personalit +orderlineC il prograa &icentino per il
distur+o ossessi&o5copulsi&o ed infine la Mindfulness 0ased Cogniti&e '/erap3 nelluso
alla recidi&it e ricaduta depressi&a di 'easdale e colla+oratori.
In sintesi% gli argoenti c/e i sono proposta di trattare sono stati selezionati per
approfondire ogni sfaccettatura della indfulness% da ;uella storica% a ;uella prettaente
pratica% passando anc/e dagli aspetti +iologici.
)perando c/e c/i si presta a leggere ;uesto ela+orato scopra la stessa passione c/e /o
personalente &issuto nellE esplorare ;uesto &asto ed interessante argoento in continua
e&oluzione% auguro una +uona lettura.
#
#IND$ULNESS
IL CON"RIBU"O DELLA #IND$ULNESS NELLA PRA"ICA CLINICA
#$empora sunt tria% praeteritum% praesens et futurum% sed fortasse proprie diceretur&
tempora sunt tria% praesens de praeteritis% praesens de praesentibus% praesens de futuris'
(
.
#$re sono i tempi% il passato% il presente e il futuro% ma forse sarebbe meglio dire& tre sono
i tempi% il presente del passato% il presente del presente% il presente del futuro'.
6-gostino% )onfessioni% Li+er. LI5267
CAPI"OLO *
LA #IND$ULNESS
*- LE ORIGINI DELLA #IND$ULNESS
La tradizione +udd/ista possiede +en oltre i 26"" anni di &ita e /a dato i natali alla tecnica
editati&a $ipassana% da cui deri&a la indfulness. Il terine indfulness pu? essere
tradotto in s&ariati odi. La lingua pali 6adottata negli antic/i testi +udd/isti7% utilizza a
riguardo le parole sati o sampa*a++a% o&&ero attenzione consape&ole e c/iara attenzione%
c/e sono gli eleenti fondaentali di essa 6)/apiro% Carlson% 2"1#7.
La indfulness discende direttaente dalla tecnica editati&a ,ipassana% applicata nella
scuola $herav-da% originariaente diffusa nell-sia eridionale e nel sud5est asiatico.
Con ,ipassana si intende la Mc/iara &isioneN del ;ui ed ora% la consape&olezza dello
scorrere dei oenti 6Montano% 2""77C @ un esercizio in cui un indi&iduo &iene allenato a
prendere coscienza del presente in tutta la sua coplessit% tra stioli sensoriali e
cogniti&i. - differenza di altre tecnic/e editati&e% la $ipassana% non si occupa di portare
lindi&iduo in una sorta di trance o in una diensione astratta% a colloca il soggetto nel
oento% facendo porre attenzione alla sua corporeit e allentit del suo pensiero in odo
non giudicante. Con ;uesto esercizio lindi&iduo interrope il pensiero deforato a causa
del +agno eoti&o in cui @ ierso e pu? odellarsi sulla reale natura delle cose% con
sforzo etacogniti&o 6Aillia% et al. 2"1"7.
1
)ant-gostino% )onfessioni. L-;uila% 1ea 8dizioni% 2"12% LI526.
4
La scuola $herav-da% riconosce una grande iportanza anc/e ai coportaenti uani%
siano intenzionali o eno% poic/= tutto nella &ita di un indi&iduo de&e essere uno sforzo
consape&ole nel perseguiento dellottuplice sentiero Oriportate in fig. 1P% o&&ero le otto
strade utilizzate per raggiungere lilluinazione% 6Laparelli% 2""87.
Ottuplice
Sentiero
Italiano Pli
I 1etta &isione .amm- dit / t / hi
II 1etta intenzione
.amm- sam/ kappa
III 1etta parola .amm- v-c-
I$ 1etta azione .amm- kammanta
$ 1etta sussistenza .amm- -*0va
$I 1etto sforzo .amm- v-1-ma
$II 1etta presenza entale .amm- sati
$III 1etta concentrazione .amm- sam-dhi
Ofig.1P
La editazione orientale% @ nata in un contesto filosofico% nel ;uale lindi&iduo de&e
preferire il copiere azioni +uone piuttosto c/e catti&e% nelle;uili+rio delle forze opposte
6Laparelli% 2""87.
Intorno agli anni Q7"% ;ueste preziose pratic/e editati&e si sono diffuse olto anc/e in
8uropa e in -erica% fino ad oggi% do&e la indfulness @ il prodotto di ;uesto sincretiso
tra presenza% intenzionalit ed assenza di giudizio 6Montano% 2""77.
(- LA #IND$ULNESS OGGI
,
)econdo Ja+at5Kinn 61!!!7% la Mindfulness non pu? a&ere altro significato se non ;uello
di porre attenzione al oento presente in odo consape&ole e non giudicante. La
consape&olezza eerge dallessere desti e &igili% nella coprensione del proprio
coportaento ;ui ed ora. La tendenza dellessere uano @ ;uella di creare delle profezie
o fantasie su un oento futuro ed e&entuale% tutta&ia non rientra nelle capacit uane il
poter predire landaento reale delle cose. In ;uesta azione di pre&isione del futuro% ci?
c/e @ presente di&enta passato e di conseguenza non &iene &issuto. Le persone possono
arri&are a farsi scorrere la &ita da&anti% cullandosi e costringendosi nel passato o sperando
c/e giungano deterinate &aria+ili a ca+iargli il destino fantasticato. Il oento @
difficile da cogliere% a @ indispensa+ile allindi&iduo affinc/= coprenda di essere
ierso in un continuo ca+iaento% in +alia di cause e condizioni% e c/e il &i&ere @
legato allattio 6Ja+at5Kinn% 2"",7.
)econdo Ja+at5Kinn 62"",7 ;uesta consape&olezza% non @ altro c/e attenzione
intenzionale% ri&olta ad oggetti c/e di&ersaente neeno notereo.
La indfulness% sostanzialente% @ linsegnaento allessere &igili% c/e si pu? ac;uisire
grazie alla pratica della stessa. 'ale tecnica attra&erso un eccaniso sisteatico% /a la
capacit di poter far affiorare nel praticante% uno stato di c/iara consape&olezza. Ci? pu?
a&&enire sia grazie a pratic/e forali di indfulness coeF il bod1 scan% la editazione
seduta% la editazione indfulC c/e inforali% nellattenzione ;uotidiana al presente
6Crane% 2"127. La consape&olezza @ il prodotto di ;uello c/e @ concentrazione ed
attitudineC o&&ero lesercizio alla presenza.
La pratica editati&a indful concerne ;uella dinaicit grazie alla ;uale il risultato
nelloperante sia una ;uieta attenzione discernente e non reatti&a% centrata sullassenza di
giudizio e nellosser&azione di ci? c/e si presenta oento per oento.
La profondit dellattenzione @ nella sua dure&olezza% differenteente dallattenzione
a+ituale c/e &iene continuaente spostata da stiolo a stiolo 6)/apiro% Carlson% 2"1#7.
'utta&ia nella pratica della indfulness non +asta essere capaci di porre attenzione% a @
essenziale la ;ualit della concentrazione c/e &iene prestata. 2i fronte ad un e&ento% anc/e
portatore di dolore% il soggetto de&e essere c/iaato a &i&erlo con curiosit% nellascolto di
ci? c/e in lui pro&ocaC sia da un punto di &ista psic/ico c/e fisico. Lapertura @ deterinata
coe ;uella capacit di coprendere i propri o&ienti interni e per ;uesto accettarli.
Infine% lultia capacit ric/iesta @ ;uella dellaore nei propri riguardi. La gentilezza nei
propri confronti @ il passo c/e d lenergia necessaria a superare ;uei pattern lesi&i c/e si
innescano nelle condizioni di difficolt% 6)iegel% 2""!7.
6
)econdo )iegel 62""!7% il corretto ipiego dellattenzione indful @ ;uello c/e possiede
caratteristic/e ;ualiF curiosit% apertura entale% accettazione ed aoreC lautore sintetizza
;uesto insiee di propriet +asilari con lacronio C4-L.
(restare attenzione senza C4-L% significa trasforare lattenti&it in un esercizio
giudicante% in grado di condannare alla negati&it lesperienza interna o esterna 6)/apiro%
Carlson% 2"1#7. (erc/= &i sia lesperienza indful @ necessario il anteniento di
attitudini adeguate% affinc/= si possa entrare in relazione con le cose% aldil della natura di
cui esse sono coposte 6Ja+at5Kinn% 2"",7.
(-* #ODALI"A DEL $ARE E DELLESSERE
(er rendere piD coprensi+ile cosa signific/i Qindfulness e ;uali o++ietti&i si proponga
di ottenere% @ necessario copiere una distinzione tra due odelli cogniti&i o&&ero la
odalit del Qfare e la odalit di Qessere 6Ja+at5Kinn% 2"",7.
#234 5uanto stabilisce la differen!a nella sorte dei mortali si pu6
ricondurre a tre determina!ioni fondamentali. 7sse sono&
(. ci6 che uno 8& ossia la personalit% nel senso pi9 vasto. ,i sono
compresi la salute% la for!a% la belle!!a% il temperamento% il carattere
morale% lintelligen!a e la sua educa!ione.
:. )i6 che uno ha& ossia la propriet ed il possedere in ogni senso.
;. )i6 che uno rappresenta& con tale espressione sintende comunemente
5uello che uno 8 nella rappresenta!ione altrui% dun5ue propriamente
come viene rappresentato dagli altri
:
'.
6)c/open/auer% 1!!4% 277.
2.1.1 Modalit del fare
:uesto tipo di odalit @ essa in atto tutte le &olte c/e un indi&iduo si tro&a in una
condizione di &ita differente da ;uella c/e desiderere++e% oppure ;uando le proprie
aspettati&e sul futuro &engono deluse. La discrepanza c/e si anifesta coe una tensione
c/e non &iene sfogata% pu? essere in grado di produrre s&ariati effetti. 'ra ;uesti /a la
capacit di procurare sentienti negati&i% ;ualiF la deoralizzazione% la frustrazione% o
langoscia. (er ;uesto oti&o un soggetto risponder ettendo in atto delle
2
-. )c/open/auer% 61!!47. forismi sulla sagge!!a di vivere. MilanoF Mondadori% 27.
7
sc/eatizzazioni entali finalizzate alla riduzione di ;uesti sentienti indesiderati
6Montano% 2""77.
'utta&ia ;uesti o&ienti cogniti&i% riescono solo ad alle&iare in odo +lando e
teporaneo i disagi procurati dalla discrepanza. La ente di conseguenza continuer in
odo ripetiti&o ad ispezionare le cause della discrepanza stessa% fino a ;uando i pensieri
non ac;uisteranno un sistea disfunzionale. >naltra caratteristica di ;uesta Qodalit del
fare% @ la concezione c/e lindi&iduo /a nei riguardi dei propri pensieri% infatti% ;uesti
essendo reiterati continuaente% pria o poi &engono considerati coe reali 6)egal%
Aillia% 'easdale% 2""67.
2.1.2 Modalit dellessere
La Qodalit dellessere @ ;uella capacit c/e la indfulness si propone di far ottenere
allindi&iduo. 2i +ase @ la+ilit c/e una persone possiede nel riuscire a rianere
concentrata sul presente in odo non giudicante e conteplati&o 6Montano% 2""77.
)econdo lapproccio indful% non esiste la necessit di tenere sottocontrollo i &issuti
esperienziali% per stiare la presenza o eno di discrepanzeC a @ auspica+ile accedere
allesperienza in odo li+ero ed iediato 6Ja+at5Kinn% 2"",7. Con la editazione @
possi+ile apprendere coe con;uistare uno spazio dedicato alla cura del proprio s=%
nutrendo la ;uiete e laccettazione% c/e sono il fondaento dellapertura% e dellanalisi
interiore 6Montano% 2""77.
(-( CAPACI"A E CO#PRENSIONE
'ale pratica /a la caratteristica di poter far sorgere nel soggetto sia spontaneaente c/e con
lesercizio s&ariate caratteristic/e ;uali laa+ilit% la curiosit e la presenza entale
6Crane% 2"127. Lessere presenti nell/ic et nunc% rende il praticante cosciente dei
sentienti dellaltro con cui si relazionaC per ;uesto la sensi+ilit ac;uisita si restituisce
con la capacit di epatizzare con le persone. :uesto odo di iedesiarsi nellaltro
&iene c/iaato sintonizzazione ed @ il fulcro di ogni relazione interpersonale% c/e iplica
il rispetto aore&ole del prossio 6)iegel% 2""!7.
.ella storia 0udd/ista% la tecnica della indfulness @ consegnata ai posteri coe la c/ia&e
c/e perette di riconoscere nella sofferenza uana una eleento intrinseco alla sua natura.
(er ;uesto la sofferenza essendo iprescindi+ile dalluoo de&e solo essere ela+orata in
odo c/e non si trasfori in dolore. Infatti uno degli o++ietti&i nella indfulness @ ;uello
8
diparare a non perpetuare ;uei pattern di pensiero e conseguenteente di
coportaento% c/e prolungano le condizioni di dolore psic/ico 6Crane% 2"127.
(-(-* Il potere della relativit
:uello c/e la indfulness cerca di passare nei praticanti @ lessere consape&oli c/e tutto @
un eterno di&enire% coe dire++e 8raclitoF
Pantar!ei
# chi discende nello stesso fiume sopraggiungono ac5ue sempre
nuove'. O12 2iels5Jranz P
#Noi scendiamo e non scendiamo nello stesso fiume% noi stessi siamo e
non siamo'. O4!a 2iels5Jranz P
#Non si pu6 discendere due volte nel medesimo fiume e non si pu6
toccare due volte una sostan!a mortale nel medesimo stato% ma a causa
dell<impetuosit e della velocit del mutamento si disperde e si
raccoglie% viene e va
;
'. O !1 2iels5Jranz
4
P
.ella aggior parte delle &olte il ca+iaento per lessere uano @ fonte di dolore.
.onostante la trasforazione sia una coponente intrinseca della natura% il tentati&o della
aggior parte delle persone riane sepre ;uello di cercare di ferare il tepo e di
opporsi alle perdite c/e esso coporta. 'utta&ia il ca+iaento non pu? essere c/e la
strada adatta a far sR c/e le sofferenze cessino. Il dolore non @ seplice da accettare%
poic/= dal oento in cui si anifesta% la percezione delluoo @ ;uella c/e ;uesto non si
esaurisca piDC il tepo speso a soffrire se+ra sepre piD lungo del tepo trascorso nella
piace&olezza 6)iegel% 2"127.
'anto c/e -l+ert 8instein% alla doanda su cosa fosse la relati&it rispose c/eF
#
0ertagni% 9. 7raclito% "rammenti del =>?@ ABC>DE (sulla Natura).
/ttpF<<SSS.gianfranco+ertagni.it<ateriali<filosofiaantica<eraclito./t
4
2egli scritti presocratici% sono sopra&&issuti solo poc/i fraenti. :ueste poc/e citazioni sono state a+ilente raccolte
nellEedizione Fie "ragmente der ,orsokratiker% del LIL sec.% grazie allEoperosit di I. 2iels ed ai redattori successi&i
coe A. Jranz.
!
GGuando un uomo sta con una bella raga!!a per unora% gli sembra
che sia trascorso solo un minuto. Ma fatelo sedere su di una stufa
accesa per un minuto e 5uel minuto gli sembrer lungo unora. La
relativit 8 5uestaH
,
.
La paura del dolore e della sofferenza non fanno altro c/e intensificare lesperienza
negati&aC per ;uesto risulta facile coprendere in c/e odo la indfulness possa essere di
grande aiuto alle persone c/e presentino sia una sofferenza psicologica c/e fisica.
Mantenere unattenzione nel presente seppur dolorosa non aggiunge connotati ulteriori
allesperienza stessa. La consape&olezza conferisce alluoo ;uella li+ert per cui pu?
percepirsi capace di continuare a &i&ere la propria &ita nonostante lincon&enienti
spiace&oli 6)iegel% 2"127.
(-(-( "on rinunciare a vivere il dolore
(raticare la indfulness significa iparare a tollerare gli affettiC o&&ero riuscire a &i&ere la
totalit delle eozioni senza rifuggirle con eccanisi di e&itaento o negazione. In piD
grazie a ;uesta tecnica editati&a @ possi+ile riuscire a percepire ogni sensazione in tutta
la sua coplessit. :uando la ente @ li+era una persona non sente piD il +isogno di essere
sepre alla ricerca spasodica di gratificazioni edonistic/e.
I tentati&i di e&itare il dolore non possono c/e earginare lindi&iduo da una piena &ita
sociale. Lin&estiento affetti&o sul prossio% porta in s= anc/e la paura della perdita% con
;uesto% una persona c/e non accetta la+i&alenza della relazione% pu? considerarla una
inaccia al suo +enessere e finire con le&itare i legai affetti&i% in fa&ore di ;uelli
superficiali.
:uello c/e la aggior parte delle persone cercano di fare @ di non anifestare le proprie
&ulnera+ilitC tutta&ia ;uesto stato di difensi&a non coporta altro c/e un auento della
fragilit stessa e conseguenteente anc/e un isolaento aggiore 6)iegel% 2"127.
GHensiamo che essere adulti significhi essere indipendenti e non aver
bisogno di nessuno. 7cco perchI stiamo tutti morendo di solitudine
J
'.
,
MirsB3% ). 62""27. 8insteins /ot tie. )cientific -erican% 287% 6#7% 81. 'rad. da inglese% p. 1F KLhen a man sits with a
prett1 girl for an hour% it seems like a minute. Mut let him sit on a hot stove for a minute and it<s longer than an1 hour.
$hat<s relativit1.K
6
0uscaglia% L. 61!!67 $i&ere% aarsi% capirsi. MilanoF Mondadori. 1accolto dal sito di C/iara (agliariniF
T/ttpF<<SSS.nontoglieriilsorriso.org<drupal<recensioni<leo5+uscaglia5&i&ere5aare5capirsiU
1"
60uscaglia% 1!!67.
La fragilit @ una parte integrante delluoo e la indfulness si occupa di dare un &alore
di&erso a ;uesta coponente cosR teuta. Iparare a riconoscere la &ulnera+ilit coe
una parte di s=% la rende piD failiare e gesti+ile. Lessere cosR sensi+ili ai ca+iaenti e
allo scorrere interiore delle eozioni rende luoo capace di connettersi in odo sincero
al prossio 6)iegel% 2"127.
2,1. GNel separarsi. .on nel odo in cui unania si accosta allaltra%
a nel odo in cui se ne allontana% riconosco la sua parentela e affinit
con laltraH.
6.ietzsc/e% 1878% 2!77
7
#. VALIDI"A SCIEN"I$ICA. VERSO UN E#PIRIS#O A PARI #ERI"O
'ipicaente la scienza ufficiale respinge lidea di prendere in considerazione tecnic/e
editati&e per uso terapeutico. La concezione piD diffusa riguardo a tale tea @ c/e non si
possa raggiungere una &alidazione teorica c/e sia anc/e razionalente accetta+ile. La
edicina odierna continua a respingere ;uesti etodi coe non scientifici% anc/e ;uando
;uesti posseggono re;uisiti c/e soddisfano le attuali definizioni di scienza. Infatti tali
approcci etodologici sono concretaente% razionalente concettualizzati e coerenti fra di
loro% tanto da poter essere utilizzati per fare predizioni circa fenoeni oggetti&aente
&erifica+ili 6Loizzo% 0lacB/all% 1!!87.
- tale riguardo% /a a&uto occasione di espriere un pensiero anc/e il leader spirituale% )ua
)antit il 2alai Laa% rappresentante della counit esiliata del 'i+et. Le considerazioni in
erito al etodo scientifico da lui esposte furono tali da puntualizzare lassoluta siilarit
tra etodi scientifici standard e ;uelli +uddisti. 2ifatti i procedienti per ottenere la
conoscenza di un fenoeno sonoF lesperienza% la ragione e la testionianza. Leleento
centrale @ lesperienza% ci? significa c/e nelle tradizioni in&estigati&e +uddiste% le&idenza
epirica so&rasta ;ualsiasi altro tipo di conoscenza o autorit scritturale 693atso% 2"",7.
'utta&ia anc/e i piD scettici non possono fare a eno di osser&are c/e nelle scienze di +ase
&i siano s&ariati ca+iaenti. Ci? @ legato sia alla concezione coune di scienza c/e &ige
oggigiorno% sia per le&oluzione c/e sta a&endo il etodo scientifico. $i @ una crescente
7
V. .ietzsc/e% 61!7!7. >ano troppo uano. 1oaF .eSton Copton% 2!7.
11
counicazione interculturale e perci? interdisciplinare nella scienza. 9li studi delle
neuroscienze stanno su+endo una &era e propria ri&oluzione% grazie alla odifica
dellatteggiaento del ondo scientifico c/e si tro&a a scontrarsi con le applicazioni
editati&e 6Murp/3 e 2ono&an% 1!!!7.
12
CAPI"OLO (
IL CERVELLO #IND$ULL
*- #EDI"AZIONE E CERVELLO
.egli ultii trentEanni% olti ricercatori /anno esplorato gli effetti +iologici della pratica
editati&a sul corpo uano. Lo++ietti&o di studi neuroscientifici @ la coprensione di
;uali siano i sistei neuronali c/e &engono essi in atto durante una pratica editati&a e
se &i siano degli effetti teporanei o peranenti sullatti&it o la struttura del cer&ello
6'readSa3% Lazar% raccolto inF 2idonna% 2"127
8
.
9razie alle nuo&e tecnologie di neuroimaging
N
% si sono aperte nuo&e strade per lEindagine
delle atti&azioni neuronali e la possi+ilit di osser&are gli effetti&i ca+iaenti c/e ;uesta
pratica apporta al cer&ello.
Le tecnic/e di neuroimaging ipiegate in tali studi includono la 'oografia a 8issione
di (ositroni (8'% 6Ierzog % Lele% JuSert et al.% 1!!"7% la 'oografia ad eissione di
fotone singolo )(8C'% 6.eS+erg% -la&i% 0aie et al.% 2""17 e la 1isonanza agnetica
funzionale VM1I% 6Lazar% 0us/% 9ollu+ et al.% 2"""7.
4gnuna di ;ueste tecnic/e di indagine offre sia &antaggi c/e s&antaggi nello studio delle
pratic/e editati&e. Infatti lEutilizzo dei acc/inari ric/iesti pu? ipedire ad un soggetto
di entrare in uno stato editati&o profondo% a causa della posizione scorretta c/e de&e
sostenere o del ruore dei dispositi&i in funzione. La scelta del acc/inario da utilizzare
per la isurazione% de&e essere ponderata a seconda del tipo di editazione c/e si &uole
osser&are 6.eS+erg% I&ersen% 2""#7.
*-* COR"ECCIA $RON"ALE E GIRO CINGOLA"O
8 stato reso noto% orai da olti anni% c/e le regioni cere+rali aggiorente atti&e
durante le pratic/e editati&e sono innanzitutto ;uelle legate allEattenzione.
8
Il li+ro GManuale clinico di indfulnessH di V. 2idonna% raccoglie un ele&ato nuero di contri+uti
scientifici c/e riguardano la indfulness. .el io scritto &erranno segnalati gli studiosi c/e si sono occupati
di specifici argoenti.
!
Il neuroiaging @ uno struento% olto utilizzato% in grado di isurare il flusso eatico allEinterno del
cer&ello grazie ad un tracciante c/e rende &isi+ile tutte le atti&azioni neuronali. :uesto struento /a dato la
possi+ilit di far luce su coe funzionasse il cer&ello ed /a aperto una strada su coe isolare alcune serie di
sistei cere+rali adi+iti a specific/e ansioni 6(oldracB% 2""!7. T/ttpF<<+rainfactor.it<indeW.p/pX
optionYcoZcontent[&ieSYarticle[idY177Fneuroiaging5le5proesse5e5le5
illusioni[catidY2Fneuroiagine[IteidY#U.
1#
La corteccia prefrontale% ad esepio% si atti&a durante atti&it c/e ric/iedono attenzione
&olontaria ed intensa% in particolar odo si pu? notare una aggiore intensit nellEeisfero
destro 6Vrit/% Vriston% Liddle% et al.% 1!!1C (osner e (etersen% 1!!"C (ardo% VoW% 1aic/le%
1!!17. Il giro del cingolo inoltre se+ra contri+uire e partecipare allattenzione focalizzata
6Ierzog% Lele% JuSert et al.% 1!!"C .eS+erg et I&ersen% 2""#C Lazar% 0us/% 9ollu+ et al.%
2"""7.
La editazione ric/iede un fuoco intenso di attenzione% dun;ue appare appropriato
sostenere c/e durante atti editati&i &i siano atti&azioni nella corteccia prefrontale% cosR
coe nel giro del cingolo. 'ale teoria tro&a sostegno grazie alle osser&azioni di brain
imaging su soggetti c/e attuano sedute editati&e c/e concernono luso dellattenzione
6Ierzog% Lele% JuSert et al.% 1!!"C .eS+erg% -la&i% 0aie et al.% 2""1C Lazar% 0us/%
9ollu+ et al.% 2"""7.
.eS+erg e I&ersen 62""#7% durante uno studio su otto ti+etani +uddisti% /anno potuto
conferare ;ueste osser&azioni traite etodo sperientale.
-i partecipanti era stato iniettato un tracciante per il flusso sanguigno cere+rale sia pria
c/e durante la editazione% in odo da ottenere unEiagine a riposo di baseline ed
unEaltra unEora dopo dallEinizio dello stato editati&o% pertanto le analisi ;uantitati&e /anno
potuto cosR diostrare latti&azione della corteccia prefrontale e ;uella del giro cingolato%
coe riportato precedenteente.
*-(/"ALA#O
)tudi eseguiti su aniali /anno osser&ato c/e allEatti&azione della corteccia prefrontale
coincide ;uella del nucleo reticolato del talao. Il talao go&erna il flusso di inforazioni
sensoriali traite le sue interazioni col genicolato laterale e i nuclei laterali posteriori
6CornSall% (/illipson% 1!887. I nuclei genicolati laterali rice&ono le inforazioni dal tratto
&isi&o c/e lo trasettono alla corteccia striata per il processaento. I nuclei laterali
posteriori del talao in&iano al lo+o latero postero superiore ()(L% lEinforazione
sensoriale necessaria per deterinare lEorientaento spaziale del corpo 69azzaniga% 2"""C
-ndreSs% Ialpern% (ur&es% 1!!77. :uando il nucleo reticolato si atti&a% li+era il
neurotrasettitore ini+itorio acido \5acido aino+utirrico 69-0-7.
Il 9-0- &iene rilasciato nei nuclei posteriori e laterali e ini+isce il ()(L in proporzione
allEatti&azione del reticolo 62esteW/e% Contreras% )teriade% 1!!87. 2urante la editazione%
ad un auento dellEatti&it della corteccia prefrontale% coincide unEatti&azione dei nuclei
del talao. )e++ene studi di brain immagin non a++iano conferato ;uesta osser&azione%
14
lEuso della )(8C' /a peresso di osser&are un increento generale dellEatti&it talaica.
Inoltre% @ stato osser&ato un auento del 9-0- c/e ini+ire++e la percezione degli stioli
esterni distraenti 6.eS+erg% I&ersen% 2""#7.
*-, PSPL 0 Lo'o La1ero Pos1ero Su2eriore
Il Lo+o Latero (ostero )uperiore% ()(L% /a un ruolo fondaentale nellEanalisi degli stioli
&isi&i% uditi&i e soatici. Coe precedenteente osser&ato% colla+ora con la corteccia
prefrontale e il talao per creare lEiagine tridiensionale del s= nello spazio
6)teinetz% Motter% 2uff3 et al.% 1!87C L3nc/% 1!8"7.
.onostante gli studi% il rapporto reale tra il lo+i parietali e teporali% in terini di
rappresentazione spaziale riane lacunosoC .eS+erg ed I&ersen 62""#7 ipotizzano c/e se si
&erifica una deafferentazione
1"
del ()(L traite i 9-0-energici% un indi&iduo pu? a&ere
delle difficolt a definire spazialente gli oggetti e potre++e perdere la capacit di
orientarsi.
Con ci?% durante i processi editati&i% lEatti&it del ()(L si riduce allEauentare di ;uella
del 'alao. LEiagine del )= non &iene eliinata% +ensR alterata perettendo stati
editati&i piD profondi.
*-3 A#IGDALA ED IPPOCA#PO
La regione ippocapale del cer&ello odula e odera lEeccitazione corticale. 8E ricca di
interconnessioni con la corteccia prefrontale% lEaigdala e lipotalao 6]osep/% 1!!67.
La capacit dellEippocapo di oderare il li&ello di eccitazione corticale @ do&uta al
sistea glutaato principale neurotrasettitore eccitatorio e al sistea 9-0- il
aggiore neurotrasettitore ini+itorio 69azzaniga% 2"""7.
8ssendo lEippocapo unEarea forteente connessa con le zone corticali arruolate durante la
editazione% la sua atti&azione inter&iene per oderare i li&elli di eccitazione delle aree
interessate.
LEippocapo inoltre influenza note&olente lEaigdala ed assiee concorrono nei processi
attenti&i ed eozionali.
8ntra+e le aree influenzano la odulazione prefrontale eozionale e durante la fase
editati&a si @ osser&ata una loro grande atti&it 6.eS+erg ed I&ersen% 2""#7.
1"
Dea44eren1a!ione% azione eccanica o c/iica finalizzata a soppriere% teporaneaente o sta+ilente% il decorso
degli ipulsi ner&osi sulle fi+re afferenti 6centripete7. 2aF /ttpF<<SSS.treccani.it<enciclopedia<deafferentazione<
1,
*-5 L6IPO"ALA#O
Il sistea li+ico precedenteente descritto @ interconnesso con lEipotalao. )i @
osser&ato c/e una stiolazione della area laterale destra dellEaigdala porti ad
unEatti&azione della porzione &entroediale del talao e successi&aente al sistea
parasipatico periferico 62a&is% 1!!27.
Il sistea parasipatico controlla olteplici funzioni autonoe dellEorganiso% tra cui il
+attito cardiaco e la respirazione c/e &anno incontro ad una riduzione durante la fase
editati&a 6]e&ning% Aallace% 0eide+ac/% 1!!27 .
2urante la editazione 6e in ;ualsiasi e&ento per cui si /a una diinuzione del +attito
cardiaco e della respirazione7% il nucleo paragingatocellulare del idollo interrope il
contatto con il locus coeruleus e col ponte 6Voote% 1!877. Il locus coeruleus in ;uesta
situazione riduce il rilascio di noradrenalina% un neurotrasettitore c/e influenza la
percezione degli stioli sensoriali. >na riduzione di noradrenalina influisce sullEatti&azione
del lo+o latero postero superiore e sulla percezione di stioli sensoriali 6Aater/ouse%
Moises% AoodSard% 1!!87.
0assi li&elli di noradrenalina /anno inoltre un ipatto sulla produzione di corticotropina da
parte del nucleo para&entricolare del 'alao. La corticotropina influenza la produzione
dellEorone adenocorticotropo 6-C'I7 da parte dellEipofisi anteriore. >n a++assaento
dei li&elli di noradrenalina porta ;uindi ad una riduzione di -C'I il ;uale stiola la
produzione di cortisolo
11
da parte delle g/iandole surrenali.
- confera di ;uanto detto% nelle urine e nel plasa di soggetti in stato editati&o sono
stati osser&ati +assi li&elli di cortisolo 6Aalton% (ug/% 9elderloos% et al.% 1!!,C )udsuang%
C/entanez% $elu&an% 1!!1C Kiegler% Cass% Ieran% 1!!!C Li&ese3% 8&ans% Mulligan et al.%
2"""C 2a&ies% Je3on% Vraser% 1!8,7.
Il sistea parasipatico influisce anc/e sulla pressione sanguigna. 2urante le pratic/e
editati&e il calo di pressione sanguigna porta a un rilassaento dei +arocettori arteriosi
12
e a far decrescere lEini+izione 9-0-5ergica nel nucleo supraoptico dellEipotalao.
In siili circostanze il nucleo supraoptico sintetizza una aggior ;uantit di arginin5
&asopressina 6-$(7 per riportare la pressione arteriosa a li&elli standard 61enaud% 1!!67.
.el plasa dei soggetti in stato editati&o @ stato osser&ato un grande auento di -$(
11
2etto anc/e idrocortisone% orone particolarente atti&o nel eta+oliso dei car+oidrati e nella regolazione del rito
dori &eglia. (rodotto nella corteccia surrenale in special odo durante il giorno. O)tellone% L. 61!!67 2izionario
Medico. 1oaF .eSton [ CoptoP
12
1ecettore sensi+ile alla pressione sanguigna. Il suo copito @ per la aggior parte ;uello di regolare la pressione
sanguigna nel +re&e terine 6inuti e ore7. /ttpF<<SSS.treccani.it<enciclopedia<+arocettoreZ68nciclopedia5della5)cienza5
e5della5'ecnica7<
16
64Ialloran% ]e&ning% Ailson et al.% 1!8,7C ;uesto contri+uisce al anteniento generale
di eozioni positi&e 6(ietroSsB3% 0raun% Ve/ et al.% 1!!17% alla diinuzione della fatica
percepita e al consolidaento dellEapprendiento 6Aeingartner% 9old% 0allenger et al.%
1!817.
(- LA""ENZIONE NEL CERVELLO #IND$UL
Lattenzione @ il processo con il ;uale &iene eseguito il controllo di &ari stioli. La
consape&olezza indful /a il potere ropere il processaento di pensiero autoatico e di
potenziare lattenzione esecuti&a. Innanzitutto lattenzione risulta coposta da +en tre reti
neurali distinte funzionalenteF lallerta% lorientaento ed infine lattenzione esecuti&a
6(osner% 1ot/+art% 2""77.
-. Aller1aF iplica unattenzione ele&ata% antenuta e di &igilanza. $i sono s&ariati
studi di brain imaging c/e sostengono di poter localizzare ;uesta funzione
soprattutto nelleisfero destro% nelle regioni frontali e parietali% atte a antenere
lallerta. La corteccia prefrontale dorsolaterale tiene sottocontrollo i li&elli di
atti&azione e li regola sottofora di attenzione esecuti&a 6)iegel% 2""!7.
0. Orien1a&en1oF @ il processo di scelta dello stiolo sensoriale sul ;uale
concentrarsi% rispetto una gaa di input di distur+o. :uesto sistea @ stato
associato alle regioni cere+rali posteriori% copreso il lo+o parietale superiore% la
giunzione parietale teporale% i capi &isi&i frontali% e collicolo superiore. La
corteccia parietale superiore se+ra essere addetta alla funzione di spostaento del
focus attenti&o 6Vossella et al. 2""27.
C. A11en!ione esecu1i7aF @ la capacit di un indi&iduo di super&isionare e di sciogliere
i conflitti tra sentienti% pensieri e coportaenti 6Vossella et al. 2""27. Indagini
eseguite con il brain imaging /anno deterinato la corteccia del cingolato anteriore
6-CC7 coe fulcro dellattenzione esecuti&a 6)iegel% 2""!7.
Ca/n e (olic/ 62""67% /anno potuto osser&are coe la editazione indful sia la fautrice
dellatti&azione della -CC. Le isure elettroencefalografic/e rile&ate durante la pratica
17
indful% /anno segnalato un auento delle onde alp/a e t/eta c/e se+rano essere alla
+ase della sensazione di cala e sta+ilit 6)iegel% 2""!7. Inoltre @ stato possi+ile osser&are
un auento eatico in &arie regioni cere+rali% segnalanti una di&ersa allocazione
dellattenzione. 'utti ;uesti dati non fanno altro c/e conferare coe la indfulness possa
essere causa di odific/e nella corteccia cingolata anteriore e delle aree dorsolaterale
prefrontale 6Ca/n e (olic/% 2""67. 2un;ue le regioni neurali possono essere stiolate dalla
pratica della indfulness e rice&ere in risposta utaenti plastici 6)iegel% 2""!7.
,- NEURONI SPECC8IO E #IND$ULNESS
9razie alla scoperta dei neuroni specc/io si @ reso possi+ile coprendere in c/e odo il
cer&ello dellessere uano pu? riuscire a rappresentare ;uello dei suoi siili. 4gni persona
@ connessa allaltra in odo reciproco in uno sca+io rispecc/iante 6)iegel% 2""!7. I
neuroni specc/io o mirror neurons% &ennero scoperti allinizio degli anni Q!" dalle;uipe di
1izzolatti 61izzolatti et al. 1!!6C 9allese et al. 1!!67. :uello c/e @ stato possi+ile
osser&are grazie alla ricerca @ stata latti&azione di neuroni c/e erano locati nella corteccia
preotoria dei acac/iC ;uesti infatti spara&ano ogni &olta c/e la sciia era ipegnata
nellesecuzione di una azione% a anc/e ;uando do&e&a solo osser&arla 69allese et al.
2""67. :uesto fa capire coe il neurone della zona preotoria% c/e @ coin&olto nelle
azioni% sia connesso anc/e alle aree percetti&e legate al sistea &isi&o 6)iegel% 2""!7.
:uesta scoperta /a potuto far luce sui funzionaenti uani% ;ualiF lepatia% la
personificazione% la pre&isione delle intenzioni altrui% e olto altro ancora.
2a un punto di &ista neurologico% @ possi+ile dire c/e esistono da&&ero dei eccanisi
neurodinaici% in grado di rendere il soggetto capace di &i&ersi un rispecc/iaento
allinterno di s= 69allese% Migone% 8agle% 2""67.
'utta&ia la scoperta non risulta interessante solo per le considerazioni sopra citate% +ensR
per il coin&olgiento c/e ;uesti neuroni a&re++ero nel copiento o coprensione di
unazione intenzionale. Infatti una ca&ia di la+oratorio non /a atti&azioni preotorie alla
&ista di o&ienti ;ualsiasi% +ensR solo a ;uelli c/e /anno uno scopo 6)iegel% 2""!7.
Le intenzioni allinterno di un cer&ello ;uando finalizzate ad un o++ietti&o% &engono
decodificate ed apprese grazie al la&oro s&olto dai neuroni specc/io e dalle regioni
teporali superiori. 9razie anc/e a ci? c/e @ registrato in eoria% un cer&ello @ in grado
di predire la finalit di unazione% o la sua esecuzioneC pu? eseguire &arie associazioni% c/e
18
sono a loro &olta un ezzo per unire cluster neuronali largaente spartiti nel cer&ello
stesso.
.el oento in cui un cer&ello apprende% uno stiolo pu? essere organizzato in pattern di
significato c/e rendono la persona capace di a&ere intuizioni.
Con ci? @ possi+ile proporre coe ;ueste anticipazioni autoatic/e c/e copie il cer&ello%
possa auentare la coerenza tra lanticipazione stessa e la appa cogniti&a c/e &a
forandosi ogni &olta c/e il soggetto esperisce realente lazione intuita. :uesto @ un
a+ito c/e sollecita la indfulness% o&&ero% nellessere consape&olente ;ui ed ora%
esperendo il oento nella seplicit in cui si presenta 6)iegel% 2""!7.
1!
CAPI"OLO ,
#IND$ULNESS NELLUSO "ERAPEU"ICO
*- #IND$ULNESS E "ERAPIA COGNI"IVA
2a olti anni% gli scienziati c/e osser&ano gli effetti delle pratic/e editati&e sul corpo% si
tro&ano generalente daccordo circa i +enefici ottenuti da tale tecnica. La indfulness
se+ra a&ere un grandissio potenziale rispetto allutilit riscontrata sul trattaento di
psicopatologie e non solo.
Le terapie +asate sulla indfulness% non possono altro c/e affondare le radici nella terapia
cogniti&o5coportaentale 6'CC7C ;uesto orientaento terapico% intrapreso da -aron
0ecB 61!7!7 e da -l+ert 8llis% @ forteente diffuso o&un;ue% soprattutto nel ondo
anglosassone e /a dato i natali ad un nuo&o uso della editazione 6Crane% 2"127.
In ;uesto capitolo &erranno esposti i aggiori orientaenti indfulness nelluso
terapeutico.
(- #IND$ULNESS+BASED S"RESS REDUC"ION
Il prograa Mindfulness50ased )tress 1eduction
1#
6M01)7 @ lapproccio incentrato
sulla tecnica editati&a ela+orata dalleerito professore in edicina ]on Ja+at5Kinn.
Coe fondatore della )tress 1eduction Clinic intraprese sin da su+ito a sperientare gli
effetti della terapia da lui sostenuta. 2ando una s&olta alla tradizione della $ipassana%
riuscR a raccogliere olti partecipanti% senza c/e ;uesti do&essero essere necessariaente
aderenti ad alcun tipo di culto religioso% en c/e eno +uddisti. - seguito delleffetti&o
successo% &enne da lui aperto anc/e il Center of Mindfulness in Medicine% Iealt/ Care% and
)ociet3. Lo scalpore suscitato da tale no&it /a stiolato i ricercatori rispetto alla
correlazione ente5corpo e la reciprocit di ;uesti rispetto alla salute.
(-* #BSR E DOLORE CRONICO
Ja+at5Kinn 61!827 e&idenzi? i risultati a&uti dal suo prograa coportaentale% la
indfulness in ;uesto caso% a&e&a lo scopo di educare i pazienti allautoregolazione del
dolore cronico.
1#
(er riferiento% dora in poi per indicare la Mindfulness50ased )tress 1eduction% &err utilizzato solo
lacronio M0)1.
2"
.ello studio del 1!82 riuscR ad esporre il funzionaento e gli effetti del prograa da lui
sostenuto. I partecipanti c/e erano stati selezionati da Ja+at5Kinn per il prograa M0)1
&ennero scelti in ;uanto non a&e&ano rice&uto alcun iglioraento durante il trattaento
fornito dallassistenza sanitaria tradizionale. I soggetti nonostante le cure continua&ano a
riferire &arie tipologie di dolore cronico% tra le ;uali &i erano in gran parteF cefalea%
torcicollo% dolore alle spalle e alla sc/iena% dolore facciale% angina pectoris% dolore toracico
e dolori addoinali.
I risultati ottenuti% a seguito di tale inter&ento% furono estreaente interessanti% la
aggioranza dei pazienti e++e un note&ole iglioraento rispetto la condizione di
partenza entro le 1" settiane di training% in piD gli effetti positi&i raggiunti si sono
antenuti considere&olente anc/e nel periodo di folloS5up.
Ja+at5Kinn 61!827 trasse la conclusione c/e% nella aggior parte dei suoi pazienti% i li&elli
del dolore e le condotte correlate si erano odificati. 4ltre a ci?% fu in grado di osser&are
c/e il ca+iaento si estende&a anc/e nelle attitudini entali e coportaentali% un
segno c/e la pratica editati&a a&e&a operato una grande trasforazione. I suoi pazienti
risulta&ano capaci di osser&are e&enti entali e fisici coe il dolore% con un pacifico
distacco ed unauentata consape&olezza. In piD la consape&olezza delle situazioni
stressogene% se+ra&a a&er reso i partecipanti allesperiento adatti a superare le a&&ersit
con successo.
.egli studi successi&i Ja+at5Kinn% suppose c/e la rigorosa autodisciplina alla
consape&olezza raggiungi+ile con la editazione% potesse essere in grado di prouo&e
coportaenti positi&i. :uesto perc/= la indfulness a tuttoggi @ considerata in grado di
e&ocare un odello di percezione +asato sullattenzione intenzionale% oento per
oento% ed @ per ;uesto attua+ile anc/e in &ari aspetti del ;uotidiano.
Il ca+iaento pu? a&&enire% interiorizzando un autoatiso &irtuoso% per ;uesto la
indfulness pu? incidere sulla percezione del dolore% delle esperienze soggetti&e di
sofferenza e sulla reatti&it allo stress 6Ja+at5Kinn et al.% 1!867.
(-( #BSR ED ANSIA
Il prograa M0)1 di ]. Ja+at5Kinn% c/e era nato coe trattaento per il dolore cronico%
oggi si @ diffuso soprattutto per il trattaento di distur+i coportaentali ed eoti&i%
6Ja+at5Kinn% C/apan5Aaldrop% 1!88C Ja+at5Kinn% C/apan% e )alon% 1!!77.
.el 1!!2 Ja+at5Kinn et al. condussero uno studio pilota per la &alutazione dellefficacia di
tale trattaento perfino sullansia.
21
I 22 partecipanti c/e &ennero inclusi% furono ;uelli c/e% pre&io screening con inter&ista
clinica% soddisface&ano i criteri 62)M5III517 perF 9-2 6distur+o dansia generalizzato7%
attacco di panico con agorafo+ia% attacco di panico senza agorafo+ia. :ueste persone
&ennero tutte sottoposte ad un prograa M0)1 della durata di 8 settiane. I dati per la
&alutazione sono stati raccolti la settiana pria del trattaento e nel oento in cui si
s&olge&a la pratica editati&a. )uccessi&aente &ennero fatti altri test &alutati&i ensili
per il periodo di # esi del folloS5up. I dati raccolti dalle isure ripetute /anno diostrato
c/e &i @ stata una diinuzione significati&a dellansia% su 2" dei 22 partecipanti. (er i
soggetti c/e presenta&ano anc/e sintoatic/e legate agli attacc/i di panico% @ stato
possi+ile osser&are un note&ole calo nella fre;uenza. :uesti effetti si sono antenuti anc/e
nei esi successi&i al folloS5up.
In definiti&a il prograa di Ja+at5Kinn pu? ridurre efficaceente i sintoi di ansia e di
panico. Inoltre /a diostrato c/e la indfulness @ un ezzo con il ;uale i soggetti si
educano allosser&azione distaccata dei propri pensieri% un etodo c/e perette di
rispondere in aniera congrua agli stioli a+ientali% piuttosto c/e reagire
autoaticaente in odo ansioso. >n indi&iduo istruito a riconoscere la natura dei propri
pensieri% riesce a coprendere c/e ;uesti non sono sepre in rapporto con la realt e per
;uesto pu? ottenere il controllo sulla propria &ita.
Lo studio sopra riportato /a anc/e ostrato le riduzione significati&a nei punteggi della
depressione dei pazienti ansiosi% il c/e suggerisce c/e gli inter&enti c/e tengono in
considerazione la correlazione ente<corpo possono essere efficaci anc/e nel ridurre i
sintoi di altre tipologie di disagio entale
14
.
(-, #BSR E PSORIASI
9li studi effettuati sul dolore cronico% aprono una luce rispetto le potenzialit c/e &i sono
nella persona. Il odo di affrontare il dolore in tutti gli aspetti c/e lo coprendono% siano
;uesti fisici o psicologi% @ deterinante per lindi&iduo. :uesto rende la pratica della
indfulness uni&ersale% applica+ile in tutti i settori% siano ;uesti clinici o eno.
0ern/ard% Jristeller e Ja+at5Kinn 61!887% /anno potuto indagare gli effetti della
indfulness anc/e su alattie psicosoatic/e coe la psoriasi. In uno studio sono stai
capionati #7 partecipanti% con una gra&it patologica &aria+ile% gra&e o oderata. I
14
:uesta intuizione di Ja+at5Kinn successi&aente /a dato il &ia alla stesura di oltissii prograi +asati
sulla indfulness tra cui il M0C' 6Mindfulness50ased Cogniti&e '/erap37 nelluso della recidi&it e
ricaduta depressi&a 6)egal et al.% 2""67.
22
soggetti erano tutti in cura fototerapica 6>$-7 o foto c/eioterapica 6(>$-7% dopo una
selezione randoizzata sono stati assegnati a due tipi di curaF luno% con un inter&ento di
M0)1 fatto attra&erso registrazioni audio durante il trattaento di luce% entre laltro 6il
gruppo di controllo7% /a rice&uto esclusi&aente il trattaento di luce tradizionale. I
risultati sono stati significati&i% nel gruppo in cui &i era stato il trattaento con M0)1%
ediaente &i era stata% in soli 6, giorni% una effetti&a riarginazione delle lesioni
psoriasic/e. Laltro gruppo% di&ersaente% /a potuto riscontrare +enefici solo intorno al !7^
giorno.
In ;uesto caso una seplice registrazione di M0)1% /a potuto far ottenere un iglior tasso
di risoluzione anc/e in pazienti affetti da psoriasi.
I successi ottenuti fanno coprendere ;uanto sia iportante porre attenzione ai li&elli di
ansia e stress correlati ad una condizione patologica 6Montano% 2""77.
-stin% )/apiro% 8isen+erg% e Vor3s% 62""#7 ritengono c/e &i siano pro&e crescenti a fa&ore
delle terapie di tipo editati&o. (er ;uesta ragione locc/io dei clinici do&re++e essere
ri&olto anc/e sulle ;uestioni +io5psicosociali e non eraente su ;uelle +iologico5
genetic/e% nellinteresse della salute uana. In piD di&iene sepre piD e&idente coe la
correlazione ente5corpo sia alla +ase del funzionaento sano dellorganiso.
(-3 #BSR E CANCRO
2i&ersi studi clinici concordano sullefficacia della M0)1 anc/e sui pazienti affetti da
&arie tipologie di cancro% sia in a+ito psicologico c/e +iologico.
9li studi pioneristici sui alati affetti da cancro e luso della M0)1% si de&ono per la
aggior parte a Carlson e colleg/i% c/e in Canada nel 2""" effettuarono un prio
esperiento 6)/apiro% Carlson% 2"1#7.
Lo studio coprende&a !" pazienti% affetti da s&ariate tipologie di cancro. :uesti &ennero
assegnati a rando a due gruppiC luno al trattaento M0)1% laltro ad una lista dattesa. Il
prograa dura&a 7 settiane e coprende&a una seduta di editazione della durata di
unora e ezza a settiana. I pazienti sono stati sottoposti sia pria% c/e dopo linter&ento
al (rofile of Mood )tates 6(4M)7 ed alla )3ptos of )tress In&entor3 6)4)I7% per
&alutare gli effetti&i ca+iaenti. I partecipanti c/e erano stati coin&olti nel prograa
M0)1% /anno riscontrato dei iglioraenti significati&i sia nelluore 66,_7% c/e nello
stress 6#1_7% rispetto al gruppo di controllo 6)peca et al. 2"""7. Lo studio coun;ue a&e&a
la liitazione di non essere soggetto a un folloS5up nei periodi successi&i al trattaento e
per sopperire a ;uesta ancanza% Carlson nel 2""1% /a condotto uno studio siile a ;uello
2#
precedenteente riportato% effettuando anc/e un folloS5up di 6 esi. >tilizzando sepre
due gruppi% uno con trattaento di M0)1 e laltro di controllo% /a assegnato ai
partecipanti anc/e un prograa di M0)1 da condurre a casa.
I iglioraenti riscontrati e antenuti nel folloS5up% sono stati di grande interesse%
soprattutto nelle sottoscale della depressione% della ra++ia e dellansia% essendo ;uesti i
sintoi c/e si presentano con aggior fre;uenza nei alati di cancro. Carlson et al. 62""17
/anno anc/e osser&ato coe i partecipanti a&essero eno distur+i delluore nonostante
fossero affetti da cancro in stadio a&anzato. Ci? @ stato attri+uito al fatto c/e i soggetti
consape&oli della propria alattia% riescono ad affrontare eglio la preoccupazione nei
riguardi della propria salute.
C/arlson% )peca% (atel e 9oode3 62""#7% in pazienti affetti da cancro al seno ed alla
prostata% /anno potuto riscontrare iglioraenti nella propriet del sonno% una
diinuzione delle sintoatic/e relati&e allo stress ed un iglioraento nella percezione
della ;ualit della propria &ita.
In piD lo studio /a esainato e registrato &ari paraetri sul funzionaento del sistea
iunitario 6con pre5test e post5test7. La conta dei linfociti e dei &ari sottoinsiei
cellulari% @ riasta inalterata% a si @ annotato una &ariazione nella produzione di
citoc/ine. Le cellule ' 6linfocitarie7 /anno auentato la produzione della citoc/ina IL54
6interleuc/ina7 ed @ diinuita ;uella dellinterferone IV.5\. Infine le cellule .J 6natural
Biller7 /anno ridotto la produzione di IL51". :ueste &ariazioni del sistea iunitario
sono deterinate dal passaggio dei soggetti dalla&ere un profilo depressi&o ad uno piD
norale
1,
.
In &ista dei risultati ottenuti% sono stati intrapresi successi&aente olteplici studi sui
alati di cancro e la loro risposta psicologica e fisica% tra ;uesti @ presente anc/e lo studio
di 'acon et al. 62""47% su donne con cancro al seno.
,- IL PROGRA##A BASE IN A""O OGGI
'ale tipo di terapia% coe detto precedenteente &enne s&iluppata per colare il &uoto
+urocratico in cui cade&ano ;uei pazienti c/e soffri&ano di dolore cronico o di distur+o
dansia% c/e non rispondendo ai trattaenti clinici% fini&ano col non essere piD accolti nelle
strutture. :ueste persone c/e a&e&ano finora riscontrato solo insuccessi in altri inter&enti%
tro&arono +en presto soluzione ai propri disagi 6)/apiro et Carlson% 2"1#7. Il prograa
1,
'ali alterazioni sul sistea iunitario in soggetti depressi ed affetti da cancro sono apliaente descritti
in letteratura% tra ;uesti lo studio di 1eic/e et al. 62""47 se+ra essere un esepio c/iarificante.
24
/a una durata coplessi&a di 8 settiane ed accoglie gruppi di #, partecipanti circa. 9li
incontri sono costruiti per linsegnaento della tecnica editati&a c/e /a una durata di due
o tre ore ciascuna. Infine% &iene fatto un ritiro di silenzio di 6 ore nel SeeBend c/e casca tra
la sesta e settiana lezione% c/iaato t/e Fa1 of Mindfulness 6Montano% 2""77.
.ello specifico% durante il corso &engono insegnate alcune strategie. LM0)1 @ un
prograa intenso do&e &engono insegnate pratic/e forali ed inforali.
,-* PRA"IC8E $OR#ALI
Mod1 scanF o&&ero un esercizio della durata di 4, inuti% nel ;uale @ ric/iesta
lanalisi della propria corporeit. Il partecipante de&e andare in esplorazione del
corpo entre @ supino ed ad occ/i c/iusi% focalizzando la propria attenzione in
ogni parte del suo corpo in odo progressi&o ed ascoltando consape&olente le
sensazioni c/e ;uesta azione pro&oca in lui 6Montano% 2""77 .
.itting meditationF i partecipanti in ;uesto caso &engono preparati a stare seduti
in odo coposto% a rilassato e% tenendo gli occ/i c/iusi% &engono c/iaati a
concentrarsi sulla propria respirazione 6Montano% 2""77.
Ooga hathaF una tecnica di 3oga atta a rendere i partecipanti consape&oli della
loro corporeit e dei o&ienti essi in atto durante ;uesta pratica. Infatti% per
sollecitare deterinate sensazioni fisic/e% &iene ric/iesto di rianere io+ili
in posizioni di stiraento del corpo 6Montano% 2""77. Lin&ito fatto @ ;uello di
esplorare il proprio fisico in &ista dei liiti percepiti durante gli esercizi%
accettarli gentilente e di non cadere preda alla tentazione di prestarsi coe
ezzo di paragone con altri 6)/apiro et Carlson% 2"1#7.
Lalking meditationF in ;uesta tecnica &iene ric/iesto ai partecipanti di
cainare% sia in odo &eloce c/e rallentato% facendo loro porre attenzione a
tutti i &ari o&ienti c/e &engono essi in atto durante la falcata e le rispetti&e
sensazioni. :uesto tipo di editazione risulta olto adatta ai neofiti% in ;uanto
possono tro&are difficolt nel copiere esercizi in cui &iene ric/iesta una
2,
postura statica e per la ;uale possono pro&are stanc/ezza o sentienti di
ner&osiso 6)/apiro et Carlson% 2"1#7.
,-( PRA"IC8E IN$OR#ALI
'ecnic/e inforaliF etodo per cui &iene incoraggiata la indfulness nelle azioni a+ituali
di tutti i giorni coe ad esepio% angiare% la&are le sto&iglie% interagire con gli altri
6)/apiro et Carlson% 2"1#7. In +re&e ettere in oto una Mpratica non strutturataN per
auentare lutilizzo della indfulness e farne un odo di &i&ere 6Montano% 2""77.
3- IL DIS"URBO BORDERLINE DI PERSONALI"A
#La base di ogni volere 8 bisogno% mancan!a% ossia dolore% a cui l<uomo 8
vincolato dall<origine% per natura.
,enendogli invece a mancare oggetti del desiderio% 5uando 5uesto 8 tolto
via da un troppo facile appagamento% tremendo vuoto e noia l<opprimono&
cio8 la sua natura e il suo essere medesimo gli diventano intollerabile
peso. La sua vita oscilla 5uindi come un pendolo% di 5ua e di l% tra il
dolore e la noia% che sono in realt i suoi veri elementi costitutivi'.
6-. )c/open/auer% Il mondo come volont e rappresenta!ione% 181!7
16
Con il terine Gdistur+o +orderlineH 620(7 si intende una patologia per la ;uale un
indi&iduo /a tendenza ad oscillare tra un ;uadro ne&rotico ad uno psicotico.
La scoperta di tale patologia pu? essere fatta risalire gi a partire dallinizio del secolo
scorso% ;uando &ennero indi&iduati dei alati psic/iatrici c/e non presenta&ano un
distur+o entale +en definito e non eglio categorizza+ile coe psicotico 60leuler% 1!11%
in Cotugno% 0enedetto% 2"""7.
'utta&ia% linteresse &ero e proprio% &erso ;uesto distur+o% nasce intorno agli anni Q4"%
;uando nel tentati&o di cogliere ;uesta condizione clinica% Ioc/ e (olatin 61!4!7
propongono di considerare ;uesto tipo di patologia coe una sc/izofrenia caratterizzata da
sintoatologie di panne&rosi% panansiet e pansessualit.
16
)c/open/auer% -. Il mondo come volont e rappresenta!ione. $ol. II% T/ttpF<<SSS.aforisario.it<art/ur5
sc/open/auer5!./tU
26
:uesti prii studiosi si tro&a&ano ad osser&are una tipologia di sindroe non +en
colloca+ile allinterno dei ;uadri clinici preesistenti.
2ifatti% olto tepo dopo 9rinBer e colla+oratori 61!687 sta+ilirono lesistenza di ;uattro
sottogruppi di soggetti +orderline. )e+ra&a c/e ;uesti pazienti andassero distri+uendosi
lungo un continuu c/e &aria&a dal G&ersante psicoticoH 6tipo I7% fino al &ersante ne&rotico
6tipo I$7. In ;uesta oscillazione si presenta&ano una predoinanza di sentienti negati&i%
le relazioni interpersonali risulta&ano costanteente fallientari 6tipo II7% oppure pote&ano
presentarsi difficolt ad a&ere una sta+ilit nella propria identit con la conseguente
necessit di assor+ire identit altrui 6tipo III7% 69rinBer% 1!687.
La pria definizione diagnostica del distur+o &enne concettualizzata nel 2)M III nel
1!8".
- tuttoggi il 2)M5I$5'1 6-(-% 2""27 @ il anuale a cui si pu? fare riferiento per a&ere
una definizione esausti&a di tale patologia.
Il distur+o di personalit +orderline @ un disordine entale olto serioC in odo
particolare risulta caratterizzato da un ancato controllo degli ipulsi% insta+ilit nella
regolazione affetti&a% tendenza ad a&ere relazioni interpersonali coplesse ed una
iagine particolarente distorta del s=.
La coor+ilit del distur+o +orderline% con altri distur+i @ generalente piuttosto ele&ata.
Il piD delle &olte tali pazienti% nel 2)M risultano soddisfare i criteri anc/e per distur+i
dell-sse I% coeF depressione aggiore% distur+o da stress post5trauatico% altri distur+i
dansia e distur+i alientari 64ld/a% )Bodol% Jellan% et al.% 1!!,C Mc9las/an% 9rilo%
)Bodol% et al. 2"""7.
3-* INS"ABILI"A A$$E""IVA
Le persone c/e sono affette da un distur+o di ;uesto tipo sono soggette ad entrare
fre;uenteente in uno stato disforico% ;uesto pu? anifestarsi in una oltitudine di
sentienti ed eozioni% coe ad esepioF ra++ia% tensione% &ergogna% panico% terroreC tutta
una dinaicit eoti&a c/e contiene sepre un sottofondo di &uoto e solitudine 6Kanarini%
VranBen+urg% 2eLuca% et al.% 1!!8C )tigla3r% )/apiro% )tieglitz% et al.% 2""17.
>n +orderline se+ra trascorrere tutta la sua &ita nella spasodica e logorante ricerca di
una relazione di tipo diadico% profonda% do&e non ci sia il risc/io di perdere o essere
a++andonati dallaltro. 'utta&ia la or+osit affetti&a di tali soggetti tende ad allontanare le
persone di cui desiderano la &icinanza% e danno cosR il &ia ad un odello caratterizzato
dalla ricerca e dalla++andono c/e perpetreranno per tutta la loro esistenza. Inoltre nel
27
oento stesso in cui% un +orderline /a un legae% tendono ad insinuarsi in lui due
tipologie di fo+ie relazionali. 2a una parte sorge il terrore di essere rifiutati e non aati in
;ualsiasi oento% dallaltro &i @ unancestrale paura di fusione con il partner% sia ;uesto
aoroso% o aicale 69a++ard% 1!!#C 9a++ard% AilBinson% 1!!47. .el prio caso &i @ una
ricerca estenuante dellaltro% in una &icinanza fisica o eoti&a. .el secondo c@ una
tendenza a tentare di c/iudere i rapporti in odo draatico e tur+olento% per tentare in un
secondo oento un ria&&icinaentoC inoltre &engono esse in atto strategie coplesse%
&olte a colpire laltro ed a stiolarne cosR sentienti negati&i 6Lie+% Kanarini% )c/a/l% et
al.% 2""47.
(er proteggersi dalle angosce ;uesti pazienti possono arri&are ad autoutilarsi o copiere
atti autolesi&iC ;uesto pu? essere utilizzato coe ezzo esplicito o iplicito per ric/iaare
lattenzione e fare le&a sullaltro% sperando di essere in ;ualc/e odo sal&ati dal partner di
cui tanto +raano la &icinanza% 69a++ard% 1!!#C 9a++ard% AilBinson% 1!!47.
3-( DIS"URBO COGNI"IVO
:uesto gra&e distur+o oggi se+ra essere colloca+ile coe distur+o pre&alenteente
cogniti&o% i +orderline ostrano +en tre li&elli di sintoatologia cogniti&a% 6Kanarini%
9underson% VranBen+urg% 1!!"7F 17 preoccupazioni ricorrenti% a non di tipo psicoticoF
credenza relati&a ad un s= catti&o% esperienze di depersonalizzazione e derealizzazione%
sospetto con relati&e ideazioni riferiteC 27 deliri e sintoi ;uasi5psicoticiF o&&ero transitori%
circoscritti e collegati a realt allucinatorieC #7 &eri deliri e &ere allucinazioniF ;uesto
spesso a&&iene ;uando @ presente una coor+ilit alla depressione% 6Kanarini% 9underson%
VranBen+urg% 1!!"C (ope% ]onas% Iudson% Co/en% 'o/en% 1!8,7.
'utto se+ra a&ere unorigine nelle false credenzeC ad esepio una persona pu? tro&are un
oggetto aa+ile in un oento e detesta+ile nellaltro.
In piD @ iportante notare ;uanto lipulsi&it sia una delle altre caratteristic/e presenti in
tale patologia
17
.
Coe detto precedenteente i pazienti &olgono tutte le loro azioni sia reali c/e inacciate
in odo deli+erataente autodistrutti&o ed irriflessi&oC le fore piD couni di ;ueste
anifestazioni sonoF la+uso di sostanza% lesplosioni &er+ali% lo s/opping copulsi&o%
17
I pazienti 20(% potre++ero odellare nel ).C una circuitazione paleo5arc/i5corticale% c/e tro&andosi
sepre in stato di preallare% risultere++e costanteente pronta a rispondere a inacce reali o
iaginate. :uesto tipo di aggressi&it protetti&o5difensi&a% /a uno scopo e&oluti&o% poic/= @ stiolata da
inacce a+ientaliC un paziente +orderline% a causa di e&enti trauatici su+iti nellinfanzia potre++e a&er
rafforzato ;uesto tipo di percorso neuronale c/e potre++e essere una delle cause di ipulsi&it 6Manna%
2"1"7.
28
distur+i alientari di &ario genere e tentati&i o intiidazioni di suicidio 6Lie+% Kanarini%
)c/a/l% Line/an% 0o/us% 2""47.
3-, PSICOBIOLOGIA
8siste un odello psico+iologico della personalit +orderline% ideato da Cloninger e
colla+oratori 61!!#7% ;uesto propone classificazioni del teperaento e del carattere.
(er ;uesti studiosi il teperaento 6c/e pu? a&ere una +ase genetica7% pu? essere distinto
in s&ariati odi% o&&eroF la ricerca della no&it% le&itaento del danno% dipendenza dalla
ricopensa e la persistenza a dispetto di frustrazioni e fatica.
Il carattere% &ice&ersa% &iene considerato coe il prodotto di circostanze a+ientali% le
diensioni c/e &engono indi&iduate sono di tre tipiF 17 in prio luogo &i @
lautodire!ionalit intesa coe capacit dellindi&iduo ad assuersi le proprie
responsa+ilit% rispetto a coportaenti od o++ietti&i e scopi nella &itaC 27 la cooperativit
&ista coe in&estiento sullaltro e nellaccettazione socialeC #7 lautotrascenden!a% coe
identificazione dellindi&iduo in ;ualcosa c/e si tro&a oltre al )=.
Cloninger et al. 61!!#7 /anno potuto indi&iduare c/e nel paziente +orderline &i sia una
scarsa efficacia nella cooperati&it e nellautodirezionalit 6coe nella aggior parte dei
distur+i di personalit7. In piD tali autori /anno potuto osser&are coe ;uesti pazienti si
distinguessero dagli altri% per la loro continua tendenza alla ricerca di no&it% a anc/e
alle&itaento del danno. (er ;uesto% le caratteristic/e del +orderline si anifestano
nellipulsi&it% la ra++ia ed unansia estrea.
5- DIS"URBO BORDERLINE E DIALEC"ICAL BE8AVIOUR "8ERAP9
Mars/a Line/an% gi a partire dai prii anni no&anta /a ideato uno dei aggiori
prograi per il trattaento del distur+o +orderline di personalitF la 20'% o&&ero la
2ialectical 0e/a&ior '/erap3% un approccio cogniti&o5coportaentale unito alla pratica
indful 6Montano 2""77.
Line/an 61!!#C 2""17% /a costituito ;uesto approccio rispetto ad una &isione dialettica del
ondo. Il ondo% o eglio la realt delle cose% @ una pluralit di forze opposte. La sintesi
di ;ueste forze contrarie produrre++e a sua &olta una realt consistente di altre forze
opposte. Il tutto in un continuo utaento.
Lo++ietti&o della 20' @ ;uello di stiolare nel soggetto la capacit di sintetizzare in
odo alc/eico laccettazione ed il ca+iaento. Il +orderline &iene incoraggiato ad
2!
accettarsi in tutte le a+i&alenze% attuando% nel frattepo% una sisteatica
riprograazione della propria &ita% per riuscire a garantirsi una tran;uillit.
I +orderline secondo la Line/an sono naturalente predisposti% proprio per le loro
caratteristic/e% a ettere in discussione le loro esperienze% tanto da risultare aggiorente
sensi+ili alle strategie di ca+iaento.
La 20' effetti&aente trae origine dalla teoria +iosociale della personalit% proprio per
;uesto oti&o% nel prograa si pensa alla predisposizione +iologica% ai &issuti trauatici
e non fa&ore&oli ed allincapacit di odulare le eozioni 6Ca&iglia% Iuliano% (errella%
2"",7.
Considerando tutte ;ueste coponenti% la 20' allena lindi&iduo a scoprire le;uili+rio
delle cose% cercando di renderlo in grado di odulare il suo coportaento e dargli odo
di eliinare la dicotoia. In +re&e un soggetto pu? potenziare le sue relazioni% di&enendo
consape&ole degli aspetti a+igui dellaltro c/e sono ine&ita+ili 6Montano% 2""77.
I +orderline sono descritti dalla Line/an 61!!#C 2""17 coe persone c/e &i&ono una &era e
propria fo+ia delleozione. (recoceente ;uesti indi&idui /anno iparato ad ini+ire le
proprie eozioni e non /anno appreso coe sopportare le esperienze trauatic/e e
dolorose c/e la &ita presenta. La loro paura principale @ ;uella di soffrire.
:uesto e&itaento porta ad una disregolazione dellaffetti&it c/e pro&oca a sua &olta
insta+ilit coportaentale e cogniti&a. La studiosa ritiene c/e losser&azione continuati&a
di pensieri e sensazioni del presente% pu? facilitare leliinazione delle&itaento. Inoltre%
il poter osser&are consape&olente le dinaic/e del proprio )=% rende e&idente ;uanto%
pensieri e sentienti non possono essere altro c/e un rispecc/iaento distorto della realt.
5-* "RA""ARE IL DIS"URBO
Il trattaento clinico di tale distur+o% a&&iene traite lutilizzo di s&ariate procedure
cogniti&e e coportaentali. La indfulness in ;uesto caso risulta coe un ezzo per
raggiungere la tolleranza allo stress% riuscire a regolare gli affetti e potenziare le relazioni
interpersonali.
)olitaente tale prograa 20'% &iene costituito per gruppi di otto pazienti circa% c/e
&engono seguiti da 2 facilitatori. Le sessioni sono settianali% ed /anno una durata c/e
oscilla dalle 2 alle 2 ore e ezza.
Le sessioni di 20' usufruiscono di principi zen per suscitare nei pazienti laccettazione
della realt in odo non giudicanteC la pratica s&olta @ olto intensa e i olteplici esercizi
da copiere sono scelti dal partecipante stesso 6Montano% 2""77.
#"
.el prograa della 20' i soggetti &engono addestrati ad ac;uisire sette a+ilit speciali.
:ueste capacit sonoF a7 la mente saggia% +7 losservare% c7 il descrivere% d7 il partecipare%
e7 lassuere un atteggiamento non giudicante% f7 concentrarsi su una cosa alla volta% e g7
lessere efficaci.
5-*-* $a%ilit della &ente sa''ia
Il odello 20' contiene una cognizione di +ase per la ;uale ;ualsiasi soggetto possiede
interiorente un assunto di saggezza% coe risultato della sintesi di altri due eleenti% la
mente emotiva e la mente ra!ionale.
La mente emotiva @ una ente c/e go&erna i pensieri e i coportaenti sotto linflusso
delleozioneC entre la mente ra!ionale @ ;uella c/e si occupa di dirigere il soggetto
perseguendo la logica e la ragione. 1isulta cosR c/e lalc/iia di ;ueste due coponenti
sia la mente saggia% c/e contiene le caratteristic/e igliori di entra+i gli opposti.
Con la pratica @ possi+ile scoprire una +uona eulsione tra ;uesti due costituenti antitetici
e poterne a&ere un li+ero accesso nella &ita di tutti i giorni 61iz&i% Aelc/% 2iid`ian% inF
2idonna% 2"127.
5-*-( A%ilit di contenuto ()!at s*ills+
Le a+ilit di contenuto sono tutte operazioni c/e possono essere esse in atto ;uando &iene
praticata la indfulness e sonoF losservare% il descrivere ed il partecipare. (osso essere
realizzate solo separataente% leffettuare luna esclude laltra.
La pria% losservare% si riferisce al porre attenzione allesperienze concrete% senza c/e
;ueste &engano connotate di altre caratteristic/e iesse dal soggetto. (er facilitare ;uesto
copito% c/e risulta olto difficile% &iene suggerito ai soggetti di notare le sensazioni date
dai cin;ue sensi sepliceente per coe si presentano.
>n indi&iduo% tende a+itualente a rispondere ad uno stiolo sensi+ile% con un pensiero
concettualizzante% c/e &iene a sua &olta &alutato in odo giudicante. 4&&ero% un concetto
pu? sorgere naturalente allinterno di una persona anc/e a fronte di uno stiolo neutro.
Il descrivere% @ unazione ri&olta allosserva!ione% c/e una &olta eseguita% de&e essere
esplicata da un punto di &ista contenutistico. I partecipanti della 20' &i&ono i propri
pensieri coe fatti prettaente oggetti&iC il tentare una descrizione dei propri processi
interni% significa attri+uire loro effierit ed una locazione eraente entale.
#1
Lazione del partecipare% @ ;uel tentati&o da parte del soggetto di entrare dentro
lesperienza concreta. Il soggetto a dispetto delle azioni c/e copie% tende ad assegnarsi
interiorente dei feedback negati&i% c/e influenzano la essa in atto dellazioni
successi&e.
1isulta e&idente c/e il risultato di ;uesta dinaicit sia un coportaento totalente
disorganizzatoC per ;uesto oti&o nella 20' &iene ric/iesto ai partecipanti di a++andonare
i pregiudizi per dedicarsi sepliceente alle atti&it del prograa.
5-*-, A%ilit for&ali (!o) s*ills+
Le a+ilit forali sono le ultie tre capacit da ac;uisire e sonoF lassunzione di un
atteggiamento non giudicante% concentrarsi su una attivit alla volta e lessere efficaci.
'ra tutte le a+ilit% sicuraente lassunzione di un atteggiamento non giudicante risulta la
piD fondaentale. Lo scopo di tale a+ilit @ ;uello di rendere il soggetto capace di farsi
sci&olare di dosso tutti i giudizi% siano ;uesti positi&i o negati&i. >n +orderline tende ad
a&ere una forte reattanza a tale sollecitazione% in ;uanto percepisce tale operazione coe la
sospensione di un argine nel ;uale orientarsi per rice&ere appro&azioni.
Il concentrarsi su una cosa alla volta% @ una+ilit c/e consente di dirigere la propria
attenzione su una singola cosa. I +orderline tendenzialente /anno coe unesplosione di
pensieri internaC ;uesto pu? creare delle pro+leatic/e% in ;uanto un pensiero caotico% pu?
rendere difficile lindi&iduazione di pensieri disorganizzati c/e riangono latenti% c/e
&anno a sollecitare il riuginio.
La+ilit dellessere efficace @ una tra le piD difficili da far ottenere ad una persona con un
distur+o del genere.
I pazienti de&ono iparare a ettere in atto coportaenti c/e funzionano a dispetto di
;uelli c/e ritengono giusti. Lo sforzo c/e &iene ric/iesto @ ;uello di focalizzarsi
sullo++ietti&o +raato in&ece c/e porre uneccessi&a attenzione al suscitare negli altri
appro&azione 61iz&i% Aelc/ e 2iid`ian% raccolto inF 2idonna% 2"127.
#2
:- IL DIS"URBO OSSESSIVO+CO#PULSIVO ;DOC<
#)ogito ergo .um'
G(enso dun;ue )onoH
61. Cartesio% Fiscorso sul metodo% 16#77
18
Il distur+o ossessi&o5copulsi&o
1!
624C7% @ una alattia psic/iatrica per la ;uale in un
soggetto si anifestano% ossessioni e copulsioni. Le ossessioni &engono &alutate coe
tipologie di pensiero c/e ricorrono persistenteente in un soggettoC entre le copulsioni
sono i coportaenti c/e si anifestano in odo rigido e ripetiti&oF i rituali 6-l+asi%
2""!7. I sintoi c/e si presentano in ;uesti soggetti sono raggruppa+ili in , categorie
principaliF a7 rituali a scopo di &erifica% +7 rituali di pulizia e igiene% c7 ossessi&it nel
pensiero senza anifestazione di copulsioni% d7 lentezza ossessi&a% e7 ritualistica ista
69a++ard% 2""77.
.el soggetto 24C si pu? riconoscere la coparsa di teatic/e legate al controlloC una
delle preoccupazioni aggiori di un soggetto affetto da tale distur+o% sono ;uelle di non
riuscire a gestire laggressi&it% o i propri sentienti di &ergogna. Il coportaento
copulsi&o /a lo scopo di annullare retroatti&aente% coportaenti o pensieri
considerati in odo negati&o dal soggetto e per i ;uali &i&e un sentiento di colpa e
&ergogna 6-l+asi% 2""!7.
Il 24C &iene considerato un distur+o del pensiero% in ;uanto le ossessioni% &issute coe
intrusi&e% sono la caratteristica +ase della patologia. Inoltre ;uesta sindroe rende il
soggetto incapace di a&ere una relazione funzionale con la propria esperienza internaC
risultano infatti alteratiF le percezioni sensoriali% gli stati eoti&i% le cognizioni e le
sensazioni fisic/e.
La pre&alenza del distur+o ossessi&o5copulsi&o nella popolazione generale risulta
oscillare tra l1%!_ e il #_ % con ci? risulta un distur+o psic/iatrico ad epideiologia
piuttosto ele&ata. La reissione 6post trattaento faracologico e<o psicoterapico7 se+ra
essere riscontra+ile solo nel ,"56"_ dei casi. (er ;uesto% un gran nuero di pazienti
necessitere++e di trattaenti ulteriori per poter raggiungere un li&ello di funzionaento
adeguato 6-guglia% -l+ert% 2e Cori% et al.% 2"117.
18
2escartes% 1. 61!!#7. Fiscorso sul metodo% MilanoF Mondadori. T/ttpF<<SSS.aforisario.it<cogito5ergo5
su./tU
1!
(er riferiento% dora in poi per indicare il distur+o ossessi&o5copulsi&o% &err utilizzato solo lacronio
24C.
##
:-* "ERAPIA $AR#ACOLOGICA
La faracoterapia se+ra essere un trattaento olto funzionante in casi di 24CC da anni
@ di&enuta prassi la soinistrazione di faraci antidepressi&i e serotoninergici.
$i sono olti studi in cui &iene attestato un gran successo alla cloipraina ed alla
flu&ozaina 69oodan% (rice% 1asussen% et al.% 1!8!C (erse% 1!887. Coun;ue non tutti i
soggetti c/e aderiscono al trattaento se+rano a&ere delle risposte positi&eC infatti i
iglioraenti% sono riscontra+ili in un range c/e &aria dal 4" al 6"_ 62idonna% 2"127.
- tuttoggi% trattare il 24C appare olto difficoltoso% poic/= risultano essere olto
fre;uenti le ricadute a causa della sospensione della cura faracologica. Inoltre s&ariati
pazienti non sono disposti ad assuere faraci
2"
% oppure i trattaenti faracologici
possono a&ere degli effetti collaterali% o in altri casi i soggetti possono non rispondere in
odo soddisfacente al trattaento 6(icardi e 0iondi% 2""47.
:-( LA PSICO"ERAPIA
La psicoterapia se+ra a&ere effetti a lungo terine ciononostante i pazienti non se+rano
essere sepre disposti ad iniziarla 6(icardi e 0iondi% 2""47. Molti soggetti affetti da 24C
se+rano essere olto GattaccatiH ai loro sintoi% in ;uanto s&olgono una funzione
tran;uillizzante.
)pesso% infatti la sintoatologia legata a tale distur+o s&olge una funzione protetti&a ed
oeostatica del soggetto% tutelandolo dalla disgregazione del proprio )@ 6Cornfield e
Malen% 1!787.
In piD% alla coparsa di sintoatologie arcate ;uali ansia o depressione% di&iene risc/ioso
effettuare un trattaento unicaente psicologico. (oic/= i +enefici otteni+ili dal
trattaento faracologico e ;uello psicologico risultano di&ersi tra loro% la loro
associazione sare++e auspica+ile% a spesso @ di difficile attuazione 6(icardi e 0iondi%
2""47.
=- DIS"URBO OSSESSIVO CO#PULSIVO E #IND$ULNESS
2"
(ro+a+ilente per la necessit di a&ere un forte controllo sia su di s= c/e sulla+iente% il paziente 24C%
potre++e &edere il faraco coe un agente estraneo in grado di agire in odo latente sulla propria persona.
(er ;uesto oti&o la cura faracologica potre++e essere &ista coe una inaccia e potre++e essere esso in
atto dal paziente un e&itaento fo+ico.
#4
La indfulness inter&iene nel distur+o 24C allinterno di un prograa cogniti&o5
coportaentale% nel ;uale lo scopo @ ;uello di riportare la persona nel oento presente
e spostare il focus attenti&o dal passato e dal futuro. Ci? a&&iene la&orando non sul
contenuto cogniti&o del paziente% +ensR sul odo in cui ;uesto si relaziona ad esso. Il
etodo c/e &iene utilizzato @ ;uello del decentraento e la disidentificazione% dei propri
pensieri 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
La ruinazione in soggetti sia sani% c/e con distur+i clinici 24C% @ un etodo strategico
per alle&iare il disagio do&uto dalla discrepanza tra lo stato interno e ;uello anelato. 8 un
eccaniso di pro+le5sol&ing c/e nel gergo indful &iene c/iaato odalit del GfareH
6)egel% Aillias% 'easdale% 2""67. (er i soggetti affetti da 24C% la ruinazione /a un
effetto paradossalente calante% pur antenendo uno stato di sofferenza psic/ica
62idonna% 2"127.
La indfulness iplica trattaenti per i ;uali &iene addestrata la persona a odificare la
percezione dei propri pensieri e le relati&e risposte% c/e in ;uesto particolare distur+o sono
le ossessioni e le copulsioni. Inoltre un soggetto &iene facilitato a rispondere a stioli
negati&i con strategie di&erse da ;uelle delle&itaento.
I pazienti affetti da 24C /anno la caratteristica di &i&ere il proprio )= con unestrea
rigidit% tra sc/ei ed atteggiaenti cronicaente inflessi+ili. (er ;uesto la indfulness
pu? essere di grande aiuto% in ;uanto @ capace di stiolare nel paziente laccettazione% la
presenza e la responsi&it% piuttosto c/e la reazione. Lincenti&azione della odalit
dellessere anzic/= del fare pu? rendersi utile alleliinazione di rituali e di
neutralizzazioni 62idonna% 2"127.
=-* IL PROGRA##A #ESSO IN A""O A VICENZA PER IL DIS"URBO DOC
Il prograa indfulness per il distur+o ossessi&o copulsi&o% nasce dallunione della
psicoterapia cogniti&o5coportaentale ed un approccio +asato sulla tecnica editati&a.
:uesto etodo /a unorigine piuttosto recente% tutta&ia &iene esso in atto a $icenza
21
%
nell>nit per i distur+i d-nsia e dell>ore% con ottii risultati. Il prograa usato @
strutturato in tre li&elli.
Pri&o li7ello+ Es2ressione del 2ro'le&a
21
L>nit per i 2istur+i d-nsia e dell>ore @ a tuttoggi sotto coordinaento dello psicoterapeuta Va+rizio
2idonna. :uesta unit /a lo scopo di trattare in un contesto ospedalizzato pazienti affetti da s&ariate fore di
distur+i clinici con prograi indfulness-
#,
:uesta fase coprende il periodo iniziale del prograa% nel ;uale il paziente ed il
terapeuta possono iniziare a concettualizzare i fattori c/e innescano e antengono
il distur+o ossessi&o5copulsi&o. 1iuscire a concretizzare il pro+lea rende il
paziente capace di coprendere ;uali siano i propri eccanisi disfunzionali e
;uali strategie ettere in atto per risol&erli.
Secondo li7ello + Addes1ra&en1o nelle a'ili1> &ind4ul
I pazienti &engono istruiti traite un prograa +en strutturato% c/e pu? essere
eseguito indi&idualente o in gruppo. C/iaraente il prograa pu? essere esso
in atto anc/e in gruppi do&e &i sono soggetti c/e presentano altre tipologie di
distur+i. Coun;ue &iene preferito un gruppo oogeneo di pazienti 24C% in odo
da poter la&orare su di loro con un procediento irato e potergli consegnare
specific/e sc/ede dinforazione sulla propria patologia. I pazienti /anno odo
cosR di a&ere delucidazioni sul proprio funzionaento% sia nel eccaniso delle
ossessioni% c/e nelle relati&e copulsioni. In piD &engono illustrati i etodi
indful per sollecitare la odifica degli atteggiaenti disfunzionali.
"er!o li7ello + In1era!ione della 2rocedura EPR con la &ind4ulness
La procedura 8(1 6esposizione e pre&enzione della risposta7 @ un trattaento c/e
se+ra a&er a&uto una grande efficacia sul distur+o 24C. L8(1 @ una tecnica
nella ;uale il soggetto &iene esposto ad uno stiolo ansiogeno soppriendo la
risposta copulsi&a suscitata. 9razie a ;uesto trattaento @ possi+ile calare le
ossessioni e di conseguenza estinguere lansia 6Lalla% 1!!87. 'utta&ia% a causa della
sua forza ansiogena% non @ olto indicato per soggetti c/e anifestano idea!ione
sopravvalutata ed ossessioni senza copulsioni 62idonna% 2"127. Lintegrazione
con la indfulness @ a&&enuta spingendo il soggetto% durante lesposizione% a
rianere in contatto con la sua interiorit anc/e a fronte di eozioni spiace&oli% in
odo consape&oleC ;uesta &ariante dell81( &iene c/iaata esposi!ione
consapevole 62idonna% 2"127.
=-( S"RU""URA DEL PROGRA##A SUL DOC
Le sedute indful per soggetti 24C% iniziano sepre con un esercizio forale% coeF la
editazione seduta% la consape&olezza del respiro% o il bod1 scanC ;uesto /a lo scopo di
age&olare il soggetto% di sta+ilizzarsi ed iniziare il la&oro attenti&o. Vinita la pratica
#6
forale% a&&iene lesposizione consape&ole% c/e pu? essere effettuata in &i&o o
iaginata. Il soggetto &iene esposto a stioli ansiogeni e infastidenti% in odo da potersi
esercitare a rianere ancorato allattenzione ed alla consape&olezza% pu? utilizzare il
respiro coe gancio al oento presente.
Con un atteggiaento non giudicante un indi&iduo pu? riuscire ad esplorare i propri
pensieri% sensazioni ed eozioni% sepliceente per coe si presentano. Lassenza di
giudizio pone il &ia allaccettazione. (er s&iluppare ;uesta capacit possono essere esse
in atto strategie di decentraento e disidentificazioneC il fine di ;uesti esercizi non @ ;uello
di con&ertire il contenuto del pensiero% +ensR accettarlo. Il ruolo del terapeuta @ ;uello di
age&olare i soggetti ad e&itare coportaenti di neutralizzazione% esigendo dal paziente
una rassegna sisteatica delle proprie dinaic/e interne. )e &i @ la coparsa di un ;ualc/e
segnale di neutralizzazione% il terapeuta inter&iene esortando il soggetto a tornare al
oento presente% c/iedendo poi di riferire ;uali siano i suoi li&elli dansia su una scala
c/e &a da " a 1"".
)olo ;uando i li&elli dansia riangono controllati in un range di li&ello c/e &a da " a #"%
si pu? ritenere terinato lesercizio dellesposizione 62idonna% 2"127.
?- IL PROBLE#A DELLA DEPRESSIONE
#I dolori degli uomini sarebbero minori se essi 234 non si affaticassero
con tanta for!a di immagina!ione a risuscitare i ricordi del male passato%
piuttosto che sopportare un presente privo di cure'.
6]. A. 9oet/e% I dolori del giovane Lerther% 17747
22
La depressione @ un distur+o delluore capace di causare una note&ole sofferenza
psic/ica e di creare forti disa+ilit% siano ;ueste personali% interpersonali% la&orati&e o
coportaentali.
.elle nazioni occidentali tale distur+o risulta estreaente ele&atoC grazie allo studio di
(a3Bel% 0rug/a e Vr3ers 62"",7 @ stato osser&ato coe in 8uropa lepideiologia per la
2epressione Maggiore sia del +en ,_% con una pre&alenza piD ele&ata suF donne% persone
di ezza et e gruppi s&antaggiati.
22
]. A. 9oet/e% 62""27. I dolori del giovane Lerther. MilanoF Mondadori.
T/ttpF<<SSS.aforisario.it<`o/ann5Solfgang5goet/e52./tU
#7
La 2-La 62isa+ilit3 -d`usted Life aears )cales7 @ una scala c/e /a la capacit di isurare
la gra&it di una alattia in +ase agli anni c/e un soggetto /a perduto a causa di essa% la
disa+ilit c/e ne /a rice&uto% o la orte preatura c/e ne @ stata pro&ocata. L4M)% grazie
a tale struento /a calcolato c/e in 8uropa ;uesta patologia risulti essere la ;uarta causa
principale di ortalit e disa+ilit% e c/e nel futuro 2"2" sci&oler al secondo posto in
graduatoria 6Murra3% Lopez% 1!!67. :uesta escalation progressi&a @ legata al fatto c/e
ancora ad oggi la depressione &iene al diagnosticata% poco trattata o trattata ale.
La 2epressione Maggiore @ un distur+o clinico tra i piD coproettentiC un indi&iduo c/e
ne @ affetto% anifesta olteplici disregolazioni fisic/e e s&ariate sintoatic/e.
Il soggetto depresso tende a &i&ere la propria &ita coe se fosse per&asa dalla negati&it%
tanto da pitturare il suo passato% presente e futuro coe pereati di caratteristic/e
spiace&oli. 1isulta e&idente c/e dallaltro lato% lanedonia e la perdita di interesse% a++iano
un ipatto catastrofico anc/e sul funzionaento sociale% indi&iduale e +iologico.
>n depresso @ a+itualente di&iso tra laspettati&a c/e agognere++e per il proprio s= ed il
suo effetti&o alfunzionaento% c/e &iene a sua &olta perpetrato da strategie di coping
fallientari e la essa in atto di tecnic/e di e&itaento. (er di piD il continuo stillicidio di
pensieri ruinati&i% ripetiti&i ed analitici% auentano esponenzialente la pro+a+ilit del
soggetto di a&ere una coplicazione nel tono delluore 60arn/ofer e Crane% raccolto inF
2idonna% 2"127.
?-* "RA""A#EN"O $AR#ACOLOGICO
(er ;uanto riguardano i trattaenti sulla depressione% ;uello faracologico @ sicuraente
il piD diffuso. La cura faracologica per i distur+i delluore si @ diffusa allinizio degli
anni Q," ed /a a&uto su+ito larga diffusione per i +enefici riscontrati.
Lo scopo della aggior parte di ;ueste edicine% @ ;uello di far auentare nei soggetti
depressi la ;uantit di neurotrasettitori% coe ad esepio la serotonina e la norepinefrina
per le sinapsi 6.at/an% Musselan% )c/atz+erg et al.% 1!!,7. 'utta&ia% non tutti i soggetti
depressi possono a&ere le risorse% sia personali c/e econoic/e per accedere a deterinati
ser&izi di cura e per ;uesto risc/iano di rianere esclusi da ;uesto tipo di trattaento.
- Manto&a e a $erona% in Italia% @ stato condotto uno studio sperientale a edicina
generale ed i risultati ottenuti /anno e&idenziato c/e rispetto alle persone +isognose del
trattaento% solo il #!%#_ usufrui&a di cura faracologica 60ellantuono et al.% 2""27.
.onostante i riscontri +enefici nella essa in atto di ;ueste terapie% non si pu? fare a eno
di parlare della recidi&it e delle ricadute della alattia 6]udd% -BisBal% Keller et al.% 2"""7.
#8
Le attuali profilassi% c/e irano ad e&itare le ricadute e la recidi&it% sono efficaci fintanto
c/e i soggetti riangono sotto trattaento% e purtroppo solo un 4"_ di ;uesti aderisce
realente alla cura 60ocBting% 2oessc/ate% )pi`Ber et al.% 2""87.
?-( "RA""A#EN"O PSICO"ERAPICO
4ltre alle pro+leatic/e suddette% +isogna ricordare c/e esistono persone per cui un
trattaento faracologico @ sconsigliato. -d esepio nel caso di gra&idanze o allergia ai
faraciC oppure pu? capitare c/e soggetti depressi siano anc/e dipendenti da alcol e<o
drog/e e per ;uesto oti&o una soinistrazione faracologica a++inata a tali sostanze
pu? dare effetti collaterali dannosi. Inoltre nei trattaenti a lungo terine% un soggetto @
portato a anifestare una sensi+ilizzazione al faraco per cui ne de&e essere sospeso
lutilizzo. (er alcuni di ;uesti pazienti la psicoterapia pu? essere una soluzione 6VranB%
Jupfer% (erel et al.% 1!!"7.
La terapia cogniti&a 6C'7% introdotta da 0ecB e colleg/i intorno agli anni Q6"% /a ostrato
risultati estreaente proettenti nel trattaento del distur+o di depressione aggiore
60ecB% 1!7!7. Il trattaento da lui ideato era estreaente strutturato e dalla durata
presta+ilita. Lattenzione principale di ;uesto studioso era ri&olta alle teatic/e di pensiero
c/e ricorre&ano piD fre;uenteente nei suoi pazienti.
I contenuti del pensiero% c/e erano espressi nellindegnit% nel rifiuto% nella perdita e nel
falliento% se+ra&ano essere coe un otore sottostante al funzionaento depressi&o.
Infatti% la depressione @ prodotto di pensieri disfunzionali% certaente ;uesti sono anc/e ci?
c/e alienta la depressione stessa. Linsorgere di un pensiero negati&o% ;uindi pu?
di&entare il concatenarsi e il perpetrarsi di pensieri piD coplessi c/e possono trasforare
lepisodio depressi&o in ;ualcosa di piD duraturo 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67. Inoltre
pensieri e atteggiaenti disfunzionali possono odificare i coportaenti% ed essere
infine la causa di profezie autoa&&eranti 6Merton% 1!487.
-d esepio se un soggetto pensa costanteente di non a&ere aici o c/e nessuno lo ai%
sar eno predisposto ad accettare un in&ito o a ri&olgersi ad un aico affinc/= lo consoli
6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
:uesti sc/ei sono pro+a+ilente ac;uisiti olto presto% durante lo s&iluppo
dellindi&iduo% e se &engono reiterati anc/e in et adulta% predispongono il soggetto al
distur+o delluore. 2eterinati sc/ei sono identifica+ili coe odelli psicologici e
possono rappresentare la diensione cogniti&a della personalit dellEindi&iduo coe
incline alla depressione 6Jo&acs% 0ecB% 1!787. La terapia di 0ecB 6per i oti&i sopra
#!
riportati7% ric/iede&a ai pazienti la trascrizione dei propri pensieri c/e do&e&ano essere poi
riportati in terapia% do&e sare++ero stati soppesati insiee al terapista rispetto ai pro e i
contro 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
@- DEPRESSIONE E #BC"
.egli studi intrapresi da 'easdale% )egal% [ Aillias 61!!,7% si @ esainato coe sia stato
possi+ile integrare gli approcci classici della terapia cogniti&o5coportaentale alla
indfulness% per superare o pre&enire le ricadute depressi&e.
Ci? c/e /a spinto tali ricerc/e ed applicazioni @ stato la pro+leatica legata alle ricadute
dei loro pazienti dopo gli iniziali iglioraenti. La M0C' @ strutturata in +ase ad un
odello cogniti&o per il ;uale la &ulnera+ilit soggetti&a @ il fulcro delle relapses
2#
. 9li
indi&idui c/e /anno a&uto episodi depressi&i risultano piD fragili rispetto ad altri soggetti%
poic/= di fronte a stioli per cui si tro&ano in uno stato di lie&e disforia% sono piD
predisposti a riettere in atto pattern disfunzionali% c/e ne pro&ocano lepisodio depressi&o
6Montano% 2""77.
(er gli autori @ fondaentale dare spazio alla pre&enzione% educando i soggetti ad
alientare uno stato eutiico. :uesto stato di +enessere lo si pu? ottenere solo grazie
allunione della Mindfulness50ased )tress 1eduction e il controllo sullattenzione di
stapo cogniti&oC un sincretiso c/e /a prodotto la M0C'.
'easdale et al. 62"""7% descri&ono coe in uno studio clinico condotto su 14, pazienti
depressi% le ricadute siano state del 66_ per il gruppo di controllo sottoposto a trattaento
standard% entre per ;uello sottoposto a trattaento M0C' siano state del solo #7_.
*)- IL LAVORO DELLA #BC"
(er ottenere ;uesti risultati% la M0C' la&ora su specific/e disfunzioni dellindi&iduo e
conteporaneaente &a potenziando le peculiarit positi&e del paziente. .ei successi&i
paragrafi &erranno esposti il funzionaento cogniti&o depressi&o e le relati&e strategie di
odifica.
*)-* LA #E"ACOGNIZIONE
2#
1elapsesF ricadute depressi&e.
4"
>no dei &antaggi c/e fornisce la indfulness @ il potenziaento della consape&olezza
eta5cogniti&a. 'easdale et al. 62""27 forniscono una specifica distinzione tra
consape&olezza eta5cogniti&a e con&inzione eta5cogniti&a.
La con&inzione eta5cogniti&a si riferisce alla credenza c/e /a un soggetto rispetto alla
&alidit concettuale dei propri pensieri sulla realt 6fusione cogniti&a7% do&e gli e&enti
entali &engono assunti con coponenti giudicanti e preditti&e% in uno sca+io diretto con
il ondo.
La consape&olezza eta5cogniti&a% in&ece% si riferisce alla &alutazione dei pensieri coe
e&enti eraente entali.
La pratica della presenza entale age&ola ;uesto processo di dis5identificazione% il ;uale @
in grado di far alle&iare i sintoi dei distur+i 6Aillias% 2uggan% Crane% [ Vennell% 2""67.
Lauento dellattenzione sui processi interni fa&orisce la capacit di riconoscere e
coprendere lentit del proprio pensiero 6Iailton% Jitzan% 9u3otte% 2""67. In un +re&e
lasso di tepo la nostra attenzione pu? focalizzare e processare solo un nuero liitato di
inforazioniC la risorsa cogniti&a @ liitata% dun;ue unattenzione dispersa riduce la
coprensione dellesperienza diretta 6Crane% 2"127.
'easdale 61!!!7 /a &alutato le due distinzioni di con&inzione e consape&olezza eta5
cogniti&a% e /a tro&ato ;uanto ;ueste incidessero sulla ricaduta o la recidi&it della
depressione.
)econdo tale autore esistono sottosistei cogniti&i alla +ase del distur+o depressi&o. Le
sue ricerc/e si focalizzano sulla odifica dei pattern cogniti&i e la odalit in cui
rispondono e si innescano i pensieri correlati e coe &engano &issuti dal soggetto.
*)-( RU#INAZIONE
Il training M0C' /a lo scopo di rendere i partecipanti in grado di riconoscere e s&elare i
propri pattern a+ituali di GindlessnessH
24
. )appiao da autori coe (apageorgiou e Aells
62""17 c/e i pensieri negati&i autoatici sono &alutazioni iediate sulle situazioni
esperite dal soggetto legate ad un giudizio di perdita e falliento% la cui continua
reiterazione dare++e origine agli atti ruinati&i. :uesto o&iento cogniti&o @ ri&olto
&erso il proprio s= in odo ciclico e ripetiti&o% s&ilente per la persona% c/e pu? di&entare
causa di depressione Ofig. 2P 6)paso`e&ib% -llo3% 2""17.
24
MindlessnessF @ un terine traduci+ile con inconsape&olezza. In ;uesto caso @ riportato coe contrario di
indfulness in a+ito editati&o.
41
)ircuito autoperpetrante che stabili!!a e mantiene lo stato depressivo. Ofig.2P
La indfulness rende possi+ile laccesso ai set eta5cogniti&i e per ;uesto d la possi+ilit
di la&orare sul pensiero. - differenza dei odelli cogniti&i c/e &anno a la&orare sul
pensiero noci&o sostituendolo con uno salu+re e funzionante% la tecnica editati&a opera
sullatteggiaento entale c/e si /a &erso il odello stesso. Latteggiaento c/e &orre++e
indurre la indfulness @ ;uello di rendere la persona predisposta ad accogliere i sentienti
e i pensieri c/e la in&estono% lasciando c/e ;uesti ci siano% senza reprierli o odificarli. Il
tentati&o di far affrontare reatti&aente un pro+lea ad una persona% pu? risultare lesi&oC
nella aggior parte dei casi lintuizione soggetti&a @ ;uella c/e% eliinato il pro+lea%
tutto si possa risol&ere. :uesta atti&it non funge altro c/e da stiolo allatti&it
ruinati&a% c/e ceentifica il soggetto nella condizione dalla ;uale tanto +raa fuggire
6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67. )pesso i pensieri si uo&ono su eozioni e ric/ieste
non soddisfatte o c/e non si possono soddisfare. .ella lotta interiore +isogna e&itare di
essere tra&olti restando in disparte ad osser&are 6Ja+at5Kinn% 1!!!7.
Lindi&iduo de&e essere spronato al decentraento e allaccettazione di tutte le esperienze%
in odo c/e gli sia consentito di &i&ersi direttaente e garantirsi una olteplicit
dingressi allesperienze difficili 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
)i /a la possi+ilit di iparare a relazionarsi con tutto ci? c/e @ allinterno ed al di fuori
del )=% piuttosto c/e rianere perduti ed iprigionati in un la+irinto di pensieri e
2-'I )8.)41I-LI
6stato corporeo7
8VV8''4
C41(4184
,EP-ESSIO"E
#ODELLO
SC8E#A"ICO
DEPRESSOGENO
;i&2lica!ionale<
SIGNI$ICA"O
SPECI$ICO
NEGA"IVO
;Pro2osi!ionale<
)I9.IVIC-'4
)(8CIVIC4
.89-'I$4
6(roposizionale7
(8.)I814
->'4M-'IC4
.89-'I$4
)
e
n
s
o
r
3
L
o
o
p
C
o
g
n
i
t
i
&
e
L
o
o
p
42
riattri+uire alla ente il ruolo di luogo saggio% do&e @ possi+ile fare scelte e poter
prendersene cura 6Crane% 2"127.
Il costrutto Gatteggiaento entale
2,
H 6(M7 @ strettaente correlato alla consape&olezza
eta5cogniti&a% coe coscienza dei propri sentienti% pensieri e coportaenti. 60eitel%
Verrer% Cecero% 2"",7.
*)-, EVI"A#EN"O
Le&itaento @ un costrutto c/e negli ultii anni @ oggetto dattenzione per olti studiosi.
Con tale terine si intende il tentati&o da parte di un soggetto di repriere% controllare o
negare lesistenza di sensazioni fisiologic/e% sentienti e pensieri 6)loan% 2""47. 'ale
azione entale @ essa in atto soprattutto nelle esperienze negati&e ed @ causa e
perpetuazione di distur+i di tipo psicologico 6Ia3es% Ailson% 9ifford% et al.% 1!!67.
.onostante il risultato estreaente disagiante% gli indi&idui continuano a ipegnarsi
nelle&itaento esperienziale% poic/= gli effetti iediati% ad una situazione di pena% sono
di un illusorio sollie&o 6Aenzlaff% Aegner% 2"""7.
Le persone c/e rispondono con e&itaento agli stioli esterni non solo &i&ono le
esperienze in odo distaccato o nel tentati&o di reprierleC a con&i&ono con una
generale sensazione di soffocaento% passi&it e depersonalizzazione% incapaci di reagire
in odo adeguato alle sollecitazioni esterne.
La pratica della indfulness sprona lindi&iduo a &i&ersi anc/e nel dolore% indi&iduando
nei pattern delle&itaento lostacolo al raggiungiento del +enessere. La liitazione
dellesperienza% rende poco percepi+ile la sofferenza% a affoga allo stesso odo la
capacit di gioire delle piccole cose 6Crane% 2"127.
*)-3 IL PILO"A AU"O#A"ICO
Con la concezione Gpilota autoaticoH si intendono tutti ;uegli stati entali per i ;uali
lindi&iduo intraprende unazione in odo non consape&ole% senza intenzionalit. La non
consape&olezza pu? essere anc/e &incolata al odo in cui un soggetto percepisce le
sensazioni in un deterinato oento. :ueste azioni autoatic/e possono essere sia di
tipo fisico c/e psicologico e sono contraddistinte nella specificit dallottundiento della
coscienza. Il odo c/e /a lessere uano di riuscire ad innescare il pilota autoatico @
forteente e&oluti&o% tale attitudine gli /a conferito la possi+ilit di ettere in atto
2,
(s3c/ological indset 6(M7% @ un costrutto con il ;uale si indicano tutti i &ari processi cogniti&i ed affetti&i
c/e si legano ad un deterinato concetto.
4#
eccanisi coplessi% a allo stesso tepo @ anc/e il centro della sua sofferenza e
&ulnera+ilit eoti&a 6Crane% 2"127. :uando si innesca lautoatiso% i fraenti di
pensiero c/e /anno connotazioni negati&e non &engono distinti c/iaraente% di&entano un
ruore di sottofondo% c/e accopagnano le atti&it del soggetto senza c/e ;uesti se ne
renda conto. -l oento in cui deterinati pensieri di&engono troppo in&adenti per
passare inosser&ati% /anno gi ac;uistato unintensit tale da essere difficile da affrontare
6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*)-5 RICORDI C8E SI A""IVANO IN BASE ALLU#ORE
.egli ultii anni sono stati effettuati olti studi sullipatto c/e /anno gli stati eoti&i
sulla persona. >na delle aggiori scoperte fatte sulle eozioni% riguardano la loro capacit
da fungere da contesto per la riatti&azione di ricordi. -l oento in cui una persona &i&e
uneozione negati&a% ;uasi siultaneaente si riatti&a il ricordo di una situazione
passata% nella ;uale a&e&a sperientato uno stesso disagio eoti&o 68ic/% 1!!,7. )e
deterinate esperienze eoti&e /anno a&uto uno spazio consistente nella nostra &ita%
risulta pro+a+ile c/e deterinati sc/ei di pensiero continuino a riatti&arsi anc/e nel
presente% stiolati da e&enti sfa&ore&oli 60ennett59olean% 2""17. .on @ possi+ile
controllare ;uesto eccaniso% per? @ possi+ile odificare il proprio coportaento in
risposta a deterinate sollecitazioni 6Aillias% 'easdale% )egal% Ja+at5Kinn% 2"1"7.
**- LE SEDU"E DI #BC"
Il prograa M0C'% @ coposto da otto incontri settianali% ognuno organizzato secondo
una propria struttura e /anno una durata di circa due ore ciascuno. Le diensioni del
gruppo &ariano% a oscillano sepre intorno ai 12 partecipanti 60arn/ofer% Crane% raccolto
inF 2idonna% 2"127. .ato per i pazienti c/e /anno sofferto di depressione% il prograa
de&e uo&ersi tra nuerosi &incoli. (azienti c/e /anno a&uto cure faracologic/e
possono essersi costruiti un odello +iologico rispetto alla propria alattiaC per ;uesto
do&ranno essere essi a conoscenza% con un collo;uio preliinare% degli aspetti non solo
+iologici% a anc/e psicologici% c/e fa&oriscono% o perpetrano la loro alattia. Inoltre
risulta iportante far sapere ai partecipanti al prograa% degli e&entuali s+alzi ed
alterazioni di uore c/e potre++ero pro&are% tro&andosi in fase di reissione e di
prenderne cosR coscienza. >n prio collo;uio &iene coun;ue sostenuto con ogni
partecipante ed /a lo scopo non solo dinforare il cliente dei contenuti c/e si terranno nel
44
prograa% a soprattutto di far conoscere a tutti listruttore% al ;uale potranno sepre
ri&olgersi per e&entuali delucidazioni 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*(- CON"ENU"I DELLE SESSIONI SE""I#ANALI
In ;uesta parte andreo ad esainare su ;uali aspetti disfunzionali del paziente la&ora la
M0C'. - seguito dei pattern critici analizzati% le settiane nel prograa si strutturano su
un la&oro graduale e +en definito finalizzato a igliorare lo stato di salute psicofisica dei
pazienti recidi&i o in fase di reissione.
*(-* PRI#A SE""I#ANA 0 Il 2ilo1a au1o&a1ico
>no degli aspetti piD iportanti di ;uesta pria sessione% risulta ;uello di costruire un
a+iente adatto alle pratic/e c/e &erranno effettuate dai partecipanti 6Crane 2"127. Il
prio o+ietti&o @ ;uello di far riconoscere alla persona i eccanisi alla +ase del proprio
dispositi&o funzionale% o&&ero il pilota autoatico. Infine ;uali siano gli effetti pro&ati una
&olta c/e ne @ stata raggiunta la consape&olezza 60arn/ofer e Crane% raccolto inF 2idonna%
2"127. Le pratic/e c/e do&ranno essere s&olte in ;uesta pria settiana sono di tre
tipologieF lesercizio dellu&a passa% il bod1 scan e le pratic/e inforali e forali da
s&olgere a casa.
*(-( SECONDA SE""I#ANA+ Ges1ire le di4ese
-llinizio della seconda settiana i partecipanti sono oraai a++astanza pratici delle
tecnic/e indful% tra le ;uali il +od3 scan. :uesto esercizio ad esepio% pu? a&er gi
esso in atto un processo di s&elaento nella personaC le &oci entali potre++ero
di&entare piD anifeste 6Crane% 2"127. Latteggiaento coune dei partecipanti% @
tendenzialente ;uello di sentirsi inadeguati% o incapaci di portare a terine la pratica
indful. In piD possono sorgere sensazioni dolorose durante il +od3 scan e potre++e essere
posticipato allinfinito per lincapacit di tro&are un oento adeguato per eseguirlo.
2un;ue in ;uesta settiana% listruttore si do&r ipegnare a ricordare ai partecipanti di
accettare i propri pensieri in tutti i loro autoatisi% per far prendere loro la
consape&olezza. La+ilit c/e cerc/er di far apprendere sar ;uella del GdisipegnoH a
dispetto di tutto ci? c/e una persona reputa negati&o su di s= e &erso ci? c/e la circonda e
lesercizio necessario per ;uesta ac;uisizione @ ;uello dei Gpensieri ed eozioniH% al
terine del ;uale &err condotta una +re&e editazione sul respiro% nella ;uale i
4,
partecipanti do&ranno porre attenzione sullespirazione e inspirazione 6)egal% Aillias%
'easdale% 2""67.
*(-, "ERZA SE""I#ANA+ &ind4ulness del res2iro
In ;uesta sessione &engono introdotte insiee alla editazione del respiro anc/e pratic/e
piD dinaic/e. Lo scopo principale @ ;uello di ettere piD in contatto il partecipante con il
suo corpoC &alorizzare e stiolare la capacit di antenere unattenzione sostenuta sul
fisico ed a s&iluppare una aggior capacit di concentrazione. 8ssendo alla terza settiana
ogni partecipante% in ;ualc/e odo /a gi s&iluppato delle strategie per riconoscere ed
essere consape&ole dei propri pensieri. (er ;uesto oti&o% la+ilit successi&a da
apprendere% @ nel riuscire a ano&rare lattenzione e saper riportare la ente ai copiti
intrapresi% ogni &olta c/e &i @ una distrazione dinterferenza 60arn/ofer% Crane% raccolto inF
2idonna% 2"127. (resa consape&olezza del &agare della ente% un partecipante a ;uesto
punto do&r ipegnarsi a scoprire in c/e odo ;uesta si uo&a ed accettare i contenuti dei
propri pensieri in odo non giudicante.
9li esercizi designati allo s&iluppo di ;ueste capacit sono la medita!ione seduta% lo 3oga
stretc/ing% walking meditation e lo spazio di respiro di tre inuti 6)egal% Aillias%
'easdale% 2""67.
*(-3 AUAR"A SE""I#ANA 0 res1are Bui ed ora
.ella ;uarta settiana% lo++ietti&o da raggiungere @ ;uello di scoprire ed apprendere la
capacit di relazionarsi a pensieri% sensazioni ed eozioni 60arn/ofer% Crane% raccolto inF
2idonna% 2"127. (er fare ci? sar necessario indi&iduare ;uei Gluog/iH della ente% nei
;uali il soggetto 6tra azioni di riuginio ed e&itaento7 si perde aggiorente. 1iuscire in
;uesto copito d la possi+ilit al soggetto di iparare a rispondere in odo adeguate alle
situazioni spiace&oli della &ita 6Crane% 2"127. In ;uesta settiana gli esercizi c/e de&ono
essere s&olti per potenziare tale capacit% sono la medita!ione seduta ed una sua estensione%
o&&ero la medita!ione sul vedere ed il sentire% do&e sepliceente &iene ric/iesto al
soggetto di percepire deterinati stioli 6coe la lettura di una poesia7 in odo non
giudicanteC in piD &i sono anc/e degli esercizi forali ed inforali da condurre a casa
6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67. -lla fine della sessione &i @ la soinistrazione di un
;uestionario sui pensieri autoatici% c/e analizza le sintoatologie della 2epressione
Maggiore secondo il 2)M5I$ 60arn/ofer% Crane% raccolto inF 2idonna% 2"127. 'ale
struento @ l-utoatic '/oug/ts :uestionnaire 6Iollon et Jendal% 1!8"7 c/e una &olta
46
eseguito% &iene restituito ai partecipanti ed /a lo scopo di rendere i soggetti consape&oli
della propria alattia e della sua entit.
(er apliare ulteriorente la consape&olezza dei partecipanti sul distur+o% &iene anc/e
esainato insiee allistruttore le sintoatologie incluse nel 2)M I$5'1 sul distur+o
depressi&o 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*(-5 AUIN"A SE""I#ANA 0 Acce11areCaccoliereClasciar essere
9iunti alla ;uinta settiana i partecipanti de&ono a ;uesto punto iparare ad esplorare
lesperienze con accettazione 60arn/ofer% Crane% raccolto inF 2idonna% 2"127. -ccettare
significa coprendere le cose per coe sono% senza tentare di odificarle o di odificare
se stessi per &i&erle. :uesta attitudine @ un odo gentile per prendersi cura di s=% la
consape&olezza rende il soggetto li+ero di esplorarsi in tutta la sua totalit senza
cristallizzarsi sul desiderio di odificare ci? c/e @ ipossi+ile ca+iare.
:uello c/e &uole regalare ;uesta sessione @ la coscienza delle discrepanze di cui si in&este
un indi&iduo esperendo un oggetto entale o fisico e coportandosi in odo del tutto
incongruo ad esso 6Crane% 2"127.
Il soggetto grazie alle pratic/e intraprese pu? coinciare a considerare la possi+ilit di
tenersi in contatto con tutto ;uellinsiee di pensieri% eozioni% ricordi e sensazioni fisic/e
c/e sono difficili 60arn/ofer% Crane% raccolto inF 2idonna% 2"127. 9li esercizi designati a
;uesto scopo sono la medita!ione seduta% c/e pu? essere guidata o eno e lo spa!io di
respiro di ; minuti% s&olti in gruppo o autonoaente 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*(-: SES"A SE""I#ANA 0 2ensieri non 4a11i
Il passo c/e si propone di copiere ;uesta sessione @ ;uello di incoraggiare il partecipante
a scindersi dai propri pensieri% ropendo ;uella catena di identificazione con essi% per
poterli &alutare coe e&enti eraente entali 60arn/ofer% Crane% raccolto inF 2idonna%
2"127. Molti pensieri% per i soggetti c/e pratica&ano indfulness a casa% risulta&ano
&eraente irresisti+ili. -lcuni pensieri pote&ano essere cosR negati&i c/e fare un esercizio
di consape&olezza di&eni&a sin troppo coplesso.
'utta&ia @ possi+ile apprendere coe osser&are i pensieri% senza essere coin&olti e riuscire
a considerarli esclusi&aente coe lenti c/e possono distorcere la realt delle cose. (er
facilitare ;uesto tipo di apprendiento &engono date da fare pratiche di medita!ione
seduta guidata o eno e lo spa!io di respiro di ; minuti. 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67
47
*(-= SE""I#A SE""I#ANA 0 co&e 2rendersi cura di sD
:uesta sessione affronta un tea olto delicato% o&&ero coe iparare a prendersi cura di
s=. I partecipanti de&ono coinciare a riconoscere i segnali della ricaduta depressi&a% in
odo da pre&enirne le gra&i conseguenze. Le persone c/e /anno a&uto storie di
depressione alle spalle o sono in fase di reissione% tro&ano grande difficolt a riuscire ad
a&ere +ene&olenza con se stessiC la tendenza c/e ostrano @ ;uella di non sentirsi degni
daore e per ;uesto finiscono col ricercare s&ariate oti&azioni per eritarsi tran;uillit
o per fare ;ualcosa c/e possa dare loro gratificazione. (er ;uesto oti&o il copito del
trainer @ ;uello di indi&iduare insiee al partecipante% ;uali siano le atti&it c/e ;uesti
reputa non essere associa+ili alla depressione. )uccessi&aente% &engono prescritte
inserendole nellatti&it routinaria.
Laspetto piD interessante c/e @ stato osser&ato dai terapeuti nei pazienti depressi% @ c/e
;uesti ri+altano totalente i processi oti&azionali. 4&&ero% un soggetto sano% per ettere
in atto un coportaento attende uno stioloC un soggetto depresso% ette in atto un
coportaento sforzandosi pria di essere stiolato. In piD un altro aspetto da tenere in
considerazione% @ la continua sensazione di stanc/ezza e spossatezza c/e perea
costanteente il paziente depresso. (er ;uesto oti&o @ essenziale c/e un indi&iduo c/e
presenta tali caratteristic/e% continui nonostante lo sforzo a partecipare al prograa. (er
sollecitare i soggetti a prendere atto della loro situazione% la seduta /a inizio con la lettura
della poesia di Mar3 4li&er G9iorno destateH% per poi proseguire con le pratic/e
editati&e forali.
Lo scopo di ;uesta sessione di M0C' @ di rendere i pazienti capaci di poter affrontare i
periodi in cui il tono delluore @ olto +asso% sfruttando lesperienza ;uotidianaC in
;uesto caso le strategie usate possono essere ;uelle di indurre il paziente ad una riflessione
circa la sua ;uotidianit. (er facilitare ;uesta operazione% a seguito della respirazione in tre
inuti% possono essere assegnati dei fogli do&e annotare gli ipegni e le atti&it
;uotidiane.
)uccessi&aente il paziente @ sollecitato ad assegnare una &alutazione alle atti&it scritte%
c/e &erranno coentata con listruttore. Lo scopo @ ;uello di rendere consape&ole la
persona del odo in cui spende il proprio tepo e se ottiene da ;uesto delle gratific/e o
frustrazioni. Infine &engono organizzati dei piccoli gruppi nei ;uali @ possi+ile discutere
insiee su ;uali strategie adottare per igliorare la propria situazione 6)egal% Aillias%
'easdale% 2""67.
48
*(-? O""AVA SE""I#ANA 0 usare ciE cFe G s1a1o a22reso ancFe in 4u1uro
Lotta&a sessione @ la parte conclusi&a dellintero prograaC lo scopo di ;uesto settiana
@ ;uello di poter trarre una stia dellesperienze fatte e renderle riutilizza+ili in futuro.
Le sedute di M0C' c/e erano state aperte con la pratica di bod1 scan tro&ano in ;uesto
esercizio la sua conclusione. I partecipanti c/e a&e&ano pro&ato disagio o noia &erso ;uesta
pratica% dopo +en sette settiane% non se+rano a&er ca+iato le considerazioni a
riguardoC tutta&ia a differenza di coe a&&eni&a allinizio non se+rano essere interessati
alle sensazioni disagianti pro&ocate% ;uanto allesplorazione dellesperienza in s=% c/e
&iene &ista coe un ezzo dinsegnaento.
4ltre alla pratica forale &iene c/iesto ai partecipanti di copilare dei fogli con riflessioni
personali circa il prograa. Inoltre traite un ;uestionario i partecipanti de&ono
assegnare con un punteggio c/e &a da 1 a 1" 6da Gper niente iportanteH ad Gestreaente
iportanteH7 il prograa c/e /anno s&olto.
Le a+ilit c/e &engono apprese in ;uesto ultio percorso sono di rendere il partecipante
capace di perseguire i suoi o++ietti&i anc/e dopo la fine del prograa% nella pratica di
&ita% e renderlo consape&ole c/e la pratica indful @ sepre pratica+ile e soprattutto% c/e
pu? essere sepre eseguita 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*,- ESERCIZI DEL PROGRA##A #BC"
In ;uesta parte dello scritto &erranno analizzati nello specifico i copiti ric/iesti ai pazienti
c/e partecipano al prograa M0C'. In particolare ogni esercizio &err approfondito sia
nella sua attuazione pratica c/e nello++ietti&o per cui @ prefissato.
*,-* LUVA PASSA
Lesercizio dellu&etta @ perfetto per i neofiti delle pratic/e editati&e e c/e sono appena
usciti dalla depressione 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67. Il copito da eseguire @
seplicissioF durante la pria sessione indful% linsegnante consegna ai partecipanti un
acino du&a passa% ;uesti a loro &olta /anno il copito di esplorarlo coe se fosse la pria
&olta c/e entrano in contatto con un oggetto del genere 6Crane% 2"127.
*,-*-( $eserci.io
Il prio passo da copiere @ di raccogliere tra le ani il c/icco du&a% tenendolo
delicataente tra indice e pollice% in odo c/e roteandolo sia possi+ile unaccurata
esplorazione &isi&a. Losser&azione a&&iene esainando le zone del frutto in tutta la
4!
totalit delle caratteristic/eF le zone di luce e di o+ra% la rugosit% le sfuature del colore%
ed altro. .el frattepo% linsegnante% attende c/e le persone si siano ipegnate in ;uesto
esercizio per il tepo necessario e c/iede loro di antenere la concentrazione
sullesplorazione. - ;uesto punto loggetto &iene posto sotto il naso ed odorato con
accuratezza% listruttore fa c/iudere le palpe+re e solo dopo di&erse inspirazioni% sollecita i
partecipanti a riaprire gli occ/i. In ;uesto oento lacino @ pronto per essere esso in
+occa% senza per? essere su+ito orso% o deglutito. 2i nuo&o de&e a&&enire
unesplorazione delloggetto% nella sua consistenza e saporeC lazione c/e de&e essere
s&olta @ anc/e ;uella di rendersi consape&oli della odalit in cui la +occa @ allenata a
raccogliere del ci+o. )olo ;uando la persona si sente pronta% pu? ordere lacino
lentaente% asticandolo con cura e facendo attenzione alle sensazioni gustati&e ed agli
aspetti fisiologici c/e &engono stiolati% coe ad esepio la sali&azione. Infine lu&etta
&iene ing/iottita e listruttore c/iede ai partecipanti di notare le sensazioni date
dalloggetto c/e scende nel loro corpo e delle conseguenze c/e ;uesto a coportato nel
proprio organiso 6Ja+at5Kinn% 2"",7.
-d ogni azione copiuta dal passaggio delluso di un senso ad un altro% &engono effettuate
delle pause di 1" secondi 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67% ;uesto ser&e per dare il tepo
ai partecipanti di prendere confidenza e stiolare latteggiaento di curiosit ed interesse
6Crane% 2"127.
*,-*-, Finalit
- seguito di ;uesta esperienza il gruppo @ in&itato ad espriere le proprie eozioni e
sensazioni. Linsegnante a&r il do&ere di age&olare le persone in ;uesto copito di
condi&isione% apertaente e consape&olente. Coe detto precedenteente lesercizio
dellu&etta @ perfetto per fare a&ere ai neofiti un prio assaggio di cosa sia la indfulness%
incoraggiando sin dallinizio lattitudine alla curiosit e allinteresse. 9i alla pria seduta
un partecipante coprende c/e prendere consape&olezza di un oggetto% in ;ualc/e odo lo
rende di&erso% peggiore o igliore% a in un odo ai &issuto pria. (er i partecipanti @
relati&aente seplice associare lesperienza fatta con lu&etta con le esperienza di &ita
personali% per ;uesto coinciano a riflettere sulla loro tendenza a ricadere in stati
depressi&i. I +enefici non si esauriscono ;ui% con la pratica dellu&etta coprendono coe
esista un pilota autoatico c/e gestisce la essa in atto delle loro azioniC un autoatiso
nel ci+o e &ice&ersa uno nelle anifestazioni depressi&e 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
8siste nellessere uano uninterconnessione tra la sfera sensoriale e ;uella dellatti&it
,"
entale% soltanto c/e ;ueste interconnessioni risultano cosR rapide da passare inosser&ate
ed essere le occulte artefici dello scatenarsi di uneozione. La ente @ sepre in
ela+orazione% partendo dalla sensazione% rianda al ricordo% riportando il soggetto ai
pattern a+ituali di ruinazione e riuginio. -ttra&erso la consape&olezza @ possi+ile
osser&are da ;uale parte ci &ogliano condurre i pensieri% osser&andoli senza c/e ;uesti
prendano il sopra&&ento 6Crane% 2"127.
*,-(- BOD9 SCAN
Il bod1 scan @ lesercizio c/e &iene effettuato su+ito dopo ;uello dellu&a passa. Consiste
in una pratica editati&a della durata di 4, inuti% c/e &iene guidata da un istruttore. La
ric/iesta @ ;uella di spostare la propria attenzione sul corpo% in tutta la sua coplessit
60arn/ofer e Crane% raccolto inF 2idonna% 2"127. 9eneralente &iene eseguita sdraiandosi
sul pa&iento. 'utta&ia% ;ualora i partecipanti a&essero delle pro+leatic/e di salute c/e
non gli perettono tale posizione% possono effettuarla anc/e su una sedia 6Crane% 2"127.
*,-(-* $eserci.io
>na &olta supini &iene ric/iesto ai partecipanti di prendere contatto con il proprio respiro e
le percezioni collegate ad esso. 9radualente il partecipante de&e cercare ad ogni
espirazione% di lasciarsi andare% a rianendo &igile e ;uindi consape&ole di ci? c/e sta
pro&ando.
- ;uesto punto listruttore guider lesplorazione olto lenta e progressi&a del corpo%
ric/ieder ai partecipanti di focalizzarsi pria sulladdoe e successi&aente alle &arie
parti del corpo% coe se laria inspirata seguisse un circuito% in grado di passare da un arto
allaltro. 8 fondaentale c/e ;uesto esercizio &enga eseguito con consape&olezza e
curiosit accogliente rispetto a tutte ;uelle sensazioni fisic/e c/e si presentano. :uando un
partecipante coincia a sentire tensioni o intense sensazioni nel corpo% pu? tran;uillaente
tornare a Grespirarci dentroH% in odo da riconsolidare la cala. C/iaraente pria o poi
la persona potre++e perdere la concentrazione necessaria allatti&it c/e sta s&olgendo% in
;uesto caso con tran;uillit% esplorato il proprio pensiero% potr riportarsi sulla
respirazione.
Infine copletato tutto il circuito del corpo% &engono dedicati alcuni inuti alla
consape&olezza del proprio fisico nella sua totalit 6Ja+at5Kinn% 2"",7.
,1
*,-(-( Finalit
>no dei prii o++ietti&i di ;uesto esercizio @ ;uello di indagare con gentilezza le
sensazioni corporee per coe si presentano 6Crane% 2"127. 'ra tutta la coplessit delle
sensazioni c/e si anifestano% ;ualc/e partecipante potre++e pro&are eozioni o a&ere
pensieri associati ad esse di tipo giudicante. Vre;uenteente nella concentrazione sul corpo
accade c/e i soggetti tendano a pro&are disprezzo o disagio &erso di esso. Lo++ietti&o @
;uello di insegnare a trattare ;ueste considerazioni con curiosit ed apertura% dal oento
c/e i pensieri riangano tali e non sepre /anno a c/e fare con la realt 6)egal% Aillias%
'easdale% 2""67. Il +od3 scan @ una pratica c/e perette di iparare a irare ed orientare
lattenzione% grazie ad essa @ possi+ile focalizzare lattenzione in odo dettagliato o esteso
6Ja+at5Kinn% 2"",7. )aper guidare il respiro attra&erso le &arie parti del corpo% lo rende
ezzo su cui dirigere lattenzione 6Crane% 2"127.
*,-,- PRA"ICA $OR#ALE ED IN$OR#ALE A CASA
La indfulness non @ solo un esercizio da eseguire in gruppo% sotto le diretti&e di un
istruttore o terapeuta% @ un etodo appreso c/e ser&e a condurre la propria esistenza% @ una
pratica. (er ;uesto oti&o il principale ezzo di apprendiento non pu? c/e essere il
GfareH% dun;ue la pratica a casa risulta estreaente iportante 6)egal% Aillias%
'easdale% 2""67. La indfulness per essere appresa ric/iede una continua 6se pur dolce7
persistenza e deterinazione. 8 e&idente c/e ;uesto tipo di ipegno ric/ieda coun;ue
uno sforzo% c/e &a a sottrarre energie e tepo anc/e ad altre atti&it ;uotidiane. >na
persona con una storia di depressione alle spalle potre++e su+ire un peggioraento
iniziale% do&uto alla frustrazione% la noia e la difficolt di intraprendere la nuo&a tecnica.
Ci? nonostante una &olta ac;uisita% la indfulness non pu? c/e far altro c/e ricopensare
e nutrire la persona 6Crane% 2"127.
*,-,-* $a pratica for&ale
)olitaente ai partecipanti della M0C'% &engono assegnati dei copiti +en precisi da
s&olgere a casa. >n prio copito @ ;uello di ascoltare le indicazione registrate su C2% per
poter s&olgere delle pratic/e editati&e autonoaente anc/e senza istruttoreC il C2
contiene una registrazione di +od3 scan e due di&erse registrazioni di 3oga /at/a.
Il secondo esercizio ric/iesto @ ;uello di copilare ;uotidianaente un diario% nel ;uale
&err annotato tutto ci? c/e @ inerente alle pratic/e editati&e% o&&ero se sono state s&olte
,2
o eno% la loro durata e tutti gli stati interni c/e susciteranno nel soggetto 6)egal% Aillias%
'easdale% 2""67.
*,-,-( $a pratica infor&ale
Il senso di editare @ ;uello di apportare consape&olezza su ogni aspetto della nostra &ita%
anc/e il piD insignificante. La persona attenta ad eseguire i prograi indfulness%
do&re++e ac;uistare gradualente la capacit di essere presente anc/e entre s&olge
atti&it di tipo routinario 6Montano% 2""77. (er tale ipegno possono andare +ene ;ualsiasi
tipo di atti&it coe ad esepioF la&arsi denti% fare la doccia% portare fuori la spazzatura.
La consape&olezza oento per oento @ il lasciapassare per il disinnesco del pilota
autoatico. La +ellezza di ;uesto ipegno @ legata al fatto c/e si possa essere indful in
ogni oento% +asta decidere di prestare attenzione 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*,-3 ESERCIZIO DEI PENSIERI E DELLE#OZIONI
.el odello cogniti&o dei distur+i eozionali% &iene esplicitato ;uanto il legae tra
pensieri ed eozioni sia iprescindi+ile. (er ;uesto oti&o i partecipanti al prograa
M0C' &engono essi a conoscenza di ;uanto ;uesta relazione sia iportante per la loro
salute e +enessere.
*,-3-* $eserci.io
Lesercizio dei pensieri e delleozioni consiste nel far sedere le persone in una posizione
accogliente e con gli occ/i c/iusi% entre listruttore racconta una situazione di &ita
;uotidiana% nella ;uale ric/iede ai partecipanti di iedesiarsi.
La situazione narrata @ ;uella in cui il soggetto si tro&a a cainare per strada% fino al
oento in cui dallaltro lato non &ede una persona c/e conosceC inizia a sorridere e ad
agitare un +raccio c/iaandola% a la persona iaginata non se+ra accorgersene e
continua a cainare. )uccessi&aente listruttore c/iede al gruppo di riaprire gli occ/i e
di esporre i pensieri e le sensazioni fisic/e ed eoti&e pro&ate 6)egal% Aillias% 'easdale%
2""67.
*,-3-( Finalit
:uesto esercizio ser&e a far coprendere coe le eozioni siano la conseguenza diretta di
una situazione e uninterpretazioneC spesso il soggetto non @ consape&ole del pensiero c/e
&a ad atti&are leozione pro&ata. :uesti procedienti sono +en rappresentati nel odello
,#
dei distur+i eozionali -0C. >na persona si atti&a rispetto ad uno stiolo 6-7% e pro&a
una eozione conseguente 6C7% rianendo del tutto estranea alla credenza c/e si atti&a nel
passaggio 607. )e il pensiero @ di tipo depressi&o risulta e&idente coe possa essere
distorto% essendo uninterpretazione prettaente negati&a degli e&enti 6)egal% Aillias%
'easdale% 2""67.
*,-5 LA #EDI"AZIONE SEDU"A + consa2e7ole!!a sul res2iro e sul cor2o
La pratica della editazione seduta &iene insegnata alla fine della seconda settiana e
linizio della terza. Listruttore guida i partecipanti a portare attenzione su alcuni aspetti del
proprio s= fisico e entale% congiuntaente i partecipanti sono anc/e guidati
nellesplorazione diretta della propria ente% 6Crane% 2"127.
*,-5-* $eserci.io
(ria di iniziare la editazione i praticanti sono in&itati a sedersi ed a tro&are una
posizione c/e sia il piD conforte&ole possi+ile% in odo c/e siano age&olati alla cala ed
alla tran;uillit. -ppena tro&ano una sta+ilizzazione% possono iniziare a concentrarsi sul
respiro e sulle sensazioni corporee annesse. 2opo 1"51, inuti circa% la persona pu?
coinciare a porre consape&olezza anc/e alle sensazioni particolari del suo fisico%
cercando gradualente di prendere consape&olezza di &arie parti del proprio corpo per poi
percepirlo nella sua interezza 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
:uesto copito ric/iede un grande sforzo attenti&o% per ;uesto oti&o la ente potre++e
&agare piD &olte% ogni &olta c/e ci? accade% +asta riportare dolceente lattenzione sul
copito da s&olgere 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*,-5-( Finalit
Lo++ietti&o della editazione seduta @ ;uello di suscitare nellindi&iduo un senso di
gentilezza% accettazione e curiosit 6Crane% 2"127. Molte persone potre++ero tro&are
difficolt nel ettere in atto tale tecnica% dun;ue potre++ero sorgere in loro sentienti di
colpa o fallientoC ;uesti sono pattern a+ituali di funzionaento depressi&o 6)egal%
Aillias% 'easdale% 2""67. Lesercizio consiste proprio nel ridare alla persona la possi+ilit
di trattarsi con gentilezza e di accogliere ci? c/e generalente a&re++e disappro&ato.
>naltra a+ilit c/e &iene appresa dalla editazione seduta @ la curiosit &erso le continue
fluttuazioni del pensiero% facilitando lindi&iduazione e la rottura dei pattern ruinati&i
6Crane% 2"127.
,4
*,-:- SPAZIO DI RESPIRO DI "RE #INU"I
Lo spazio di respiro di tre inuti 6#M0)7% @ considerata coe una Gini5editazioneH c/e
nasce con lo scopo di facilitare lintroduzione della pratica editati&a nella &ita di tutti i
giorni. 'ale esercizio trae origine% nella sua organizzazione% dalla pratica della terapia
cogniti&a 6Crane% 2"12C )egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*,-:-* $eserci.io
:uesta pratica di respirazione de&e essere condotta dalla persona% aleno tre &olte al
giorno% in dei oenti +en presta+iliti.
Lo spazio di respiro @ di&iso in tre step fondaentaliF staccare il pilota autoatico% portare
attenzione al proprio respiro% rendersi consape&oli del proprio corpo. :uesto esercizio pu?
essere utilizzato per prendersi una piccola pausa staccandosi dai pro+lei c/e si incontrano
nel ;uotidiano.
(er pria cosa la posizione da utilizzare per la +re&e editazione de&e essere
conforte&ole% a sostenuta% per facilitare la &igilanzaC la persona c/e la pratica pu?
scegliere se tenere gli occ/i aperti o eno% liportante @ c/e ci? fa&orisca il
raccogliento. - ;uesto punto ci de&e essere lo sforzo di notare lentit dei pensieri e delle
sensazioni% @ un prio step c/e sgancia il pilota autoatico. >na &olta ascoltato ;uello c/e
la ente ed il corpo anifestano% &iene spostata lattenzione sui o&ienti respiratori%
;uesto @ lo step c/e ncora al oento presente. Infine% una &olta orientata la
consape&olezza% +isogna eseguire il terzo ed ultio passo% o&&ero estenderla nella totalit
della persona 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*,-:-( Finalit
Lo scopo di ;uesto esercizio @ ;uello di rendere i partecipanti capaci di s&iluppare
unattenzione flessi+ile e &olontariaC in piD perette di realizzare una connessione con
lesperienza iediata. Il #M0) ric/iede solo tre inuti di tepo per ;uesto oti&o si
presta +ene ad essere praticato tutte le &olte c/e un soggetto sente di a&erne la necessit.
2urante la giornata oltre i copiti routinari di pratica% pu? effettuare una seduta di #M0)
per ritro&are la tran;uillit o slacciare il pilota autoatico 6)egal% Aillias% 'easdale%
2""67.
,,
*,-= PRA"ICA DEL #OVI#EN"O #IND$ULL + HALIING #EDI"A"ION
La editazione cainata @ una strategia utilizzata coe pratica per di&enire piD
consape&oli delle sensazioni c/e &engano &issute dal corpo in o&ienti autoatici.
:uesta pratica risulta particolarente indicata per coloro c/e /anno delle difficolt nel
praticare tipologie di editazione c/e ric/iedono posizioni stazionarie 6Crane% 2"127.
Coloro c/e tendono ad essere agitati e con unalta atti&azione fisiologica% possono tro&are
in ;uesta tecnica un effetto sta+ilizzante e confortante 6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*,-=-* $eserci.io
:uesto esercizio pu? essere praticato in ;ualsiasi luogo% sia ;uesto aperto o c/iusoC
liportante @ c/e possa essere s&olto in tutta tran;uillit% senza la preoccupazione di
essere notati. Inizialente al soggetto @ ric/iesto di porsi a ga+e di&aricate e leggerente
flesse sulle ginocc/ia% il tronco de&e riare eretto e le +raccia de&ono sciogliersi lungo i
fianc/i. :uesta posizione do&re++e facilitare la percezione del soggetto del terreno c/e si
tro&a al di sotto dei suoi piedi e del la&oro s&olto dal proprio corpo nel sostegno del suo
peso. )uccessi&aente il +aricentro de&e essere spostato pria su una ga+a e poi su
unaltra facendo un esercizio di attenzione sulle sensazioni corporee suscitate. - ;uesto
punto &iene ric/iesto di spostare un piede in a&anti% coe in posizione di falcata% centrando
il proprio peso sul tallone del piede opposto. :uesta atti&it% s&olta gradualente e con
lentezza de&e essere fatta per tutto il percorso sta+ilito in precedenza% al terine del ;uale
&iene effettuata una sosta per prendere coscienza di ci? c/e ;uesto esercizio /a suscitato%
dopodic/= il soggetto de&e ruotare su se stesso e intraprendere nuo&aente lesercizio
6)egal% Aillias% 'easdale% 2""67.
*,-=-( Finalit
:uesta pratica &iene s&olta per rendere lindi&iduo consape&ole dellatto del cainare. 8
un esercizio c/e coe gli altri ira allunione del corpo e della ente a risulta e&idente
c/e ;uesta pratica ric/ieda una aggiore capacit attenti&a. Infatti a differenza delle
pratic/e editati&e &iste finora% &iene ric/iesto di colti&are la concentrazione ad occ/i
aperti e durante lo s&olgiento di unazione dinaica 6Montano% 2""77.
,6
CONCLUSIONI
.egli ultii anni &i @ stata una crescita esponenziale dellinteresse &erso la indfulness.
La ia copilazione /a tentato di fare luce sui punti in cui tale tecnica si focalizza.
2al oento c/e ancora esistono olti scettici a riguardo% /o &oluto cercare di
docuentare la ;ualit scientifica di ;uesta pratica% tenendo conto sia degli aspetti
neurologici c/e psicologici di cui ;uesta nuo&a prospetti&a terapica ne @ ricca.
)ono stati presentati non solo i punti centrali% a @ stato ostrato linter&ento anc/e in
odo scientifico e nella sua pratica attuazioneC partendo dalle origini della indfulness%
fino al suo s&iluppo nellEattualit.
Coe /o esposto% si presentano pur sepre dei liiti nellindagine scientifica. 'utta&ia% la
totale assenza di effetti collaterali nei pazienti c/e seguono i protocolli indfulness%
predispongono ;uesta applicazione ad interessanti ricerc/e future c/e possono essere
eseguite a discrezione dellunica creati&it dello sperientatore.
Linteresse c/e /a stiolato nel ondo scientifico ;uesta pratica% @ stato cosR forte da esser
stato da stiolo alla produzione di nuerosissie ricerc/e. Coun;ue% ;ueste non
risultano ancora sufficienti perc/= gli effetti osser&ati possano essere descritti nella loro
totalit. Coe /o gi sottolineato% &i sono ancora olte parti c/e sare++ero da indagare% sia
nei ris&olti pratici c/e nelle risposte +iologic/e al trattaento.
La indfulness aiuta efficaceente lEindi&iduo% sia ;uando ;uesto si tro&i in uno stato di
salute c/e in uno stato patologico. I +enefici si allargano a c/iun;ue si a&&icini alla pratica
indful% c/e di&iene un espediente per conoscere se stessi e per colti&are la propria
attenzione sul presente. I risultati c/e aggiorente se+ra essere stata in grado di far
ottenere ai partecipanti% sono soprattutto il forte senso di autoefficaciaC poic/= &a
insegnando alle persone coe gestire le proprie atti&it ;uotidiane. 'ale tecnica% infine%
predispone lindi&iduo ad a&ere un ca+iaento &irtuoso% c/e lo rende capace di essere
resiliente.
(er ;uesti oti&i risulta auspica+ile continuare ad effettuare degli studi sugli effetti della
indfulness. Coprenderne eglio le caratteristic/e e cercare di a&erne una panoraica
piD integrale% dare++e la possi+ilit di poterne s&iluppare ulteriori applicazioni.
-d oggi% in tutte le terapie in cui @ stata adoperata si sono osser&ati effetti positi&i
iediati% deterinati da ca+iaenti psicologici costrutti&i.
Coplessi&aente si @ potuta notare una odificazione nei odelli cogniti&i disfunzionali
a fa&ore di altri salu+ri e +en funzionantiC ne sono una pro&a gli studi eseguiti su soggetti
,7
affetti da s&ariati distur+i entali% coeF 24C% 2(0% distur+o di 2epressione Maggiore.
-ltre ricerc/e effettuate in a+ito clinico /anno diostrato coe &i siano stati degli
eccellenti progressi nella risposta percetti&a in soggetti affetti da dolore cronico% oppure di
coe &i siano state delle alterazioni nelle risposte fisiologic/e in pazienti colpiti da
s&ariate fore dansia.
In a+ito edico si @ potuto registrare un potenziaento del sistea iunitario in
soggetti alati di cancro ed una aggiore risposta positi&a ai trattaenti di fototerapia in
soggetti affetti da psoriasi.
La indfulness% oggi% potre++e essere una risposta per ;uei pazienti c/e per s&ariati oti&i
non possono seguire cure faracologic/e o non possono fare psicoterapia. 2i fatto olte
persone spesso /anno pro+lei ad a&&icinarsi alle cure psicologic/e a causa dellEele&ata
spesa da sostenere per una terapia a lungo terine. :uesta tecnica offre una risposta
alternati&a alle pratic/e classic/e% c/e ira ad integrarle e non ad escluderle% un oti&o per
cui possa essere considerata una ri&oluzione nellEattuale capo terapico.
La pratica indful potre++e essere indicata gi a partire dallEinfanzia% ;uando lEidentit ed
il )= non sono ancora aturi e do&e unEesplorazione della propria interiorit potre++e
aiutare a costruire una figura adulta aggiorente integra ed e;uili+rata.
)are++e &antaggioso introdurre ;uesta pratica anc/e in ;uei settori sia sociali c/e la&orati&i
in cui @ necessario per la persona strutturare odelli cogniti&i costrutti&i e resilienti. La
indfulness% oltre ad essere un &alida terapia nella cura dei pazienti% pu? di&enire una
pre&enzione allEinsorgenza di patologie in indi&idui pro+leatici ed una protezione per i
soggetti sani c/e si tro&ano ad affrontare delle difficolt nella &ita.
In definiti&a% ogni a+iente% potenzialente% si prestere++e allEapplicazione della
indfulnessC tale tecnica potre++e ri&elarsi una nuo&a frontiera per ;uegli studiosi e
terapeuti a++astanza coraggiosi da usarla coe struento per igliorare la ;ualit della
&ita. 8E stata scoperta solo una piccola parte di ;uello c/e potre++e essere un nuo&o odo
prendersi cura della propria persona o di trattare i pazienti in a+ito terapico.
La indfulness% c/e @ un connu+io intelligente tra tradizioni +uddiste e psicoterapia% tro&a
le sue +asi nella $ipassana. :uesta tecnica editati&a c/e /a radici antic/issie &iene
praticata a tuttoggi dai onaci e laici% i ;uali la reputano una risorsa fondaentale per il
raggiungiento di un +uono stato di salute e di e;uili+rio entale. Con ci? non do&re++e
sorprendere in c/e odo la indfulness 6c/e @ la sintesi tra conoscenze scientific/e
occidentali e tecnic/e editati&e orientali7 possa essere un prodotto c/e contenga un alto
potenziale.
,8
4rai @ noto da tepo% ;uanto i +enefici psicologici siano in grado di ripercuotersi sul
fisico igliorandone le prestazioniC un oti&o in piD per seguire un approccio c/e sorpassi
la concezione dicotoica delluoo% &isto coe di&iso tra corpo e ente.
La ricerca del +enessere @ sepre stata per lEuoo ci? c/e lE/a spinto allEe&oluzione e alla
grandezza% a allo stesso tepo anc/e al dolore ed alla patologia. I sintoi c/e si
anifestano nelle disfunzioni sono un odo per allontanare la sofferenzaC la difficolt nel
superare il dolore congela la persona in pattern cogniti&i disfunzionali% c/e tendono a
sfogare oti inconsci c/e sono difficili da accettare.
(roprio per ;uesti oti&i la figura dello psicologo nasce dalla necessit di sopperire al
+isogno delle persone di essere felici. 'utta&ia% non @ possi+ile dare una cura alla
sofferenza% poic/= essa @ una caratteristica intrinseca della natura uanaC a @ possi+ile
fare in odo c/e ;uesta non si trasfori in dolore. Colti&are le esperienze positi&e fa
ricordare alluoo c/e la &ita possiede caratteristic/e antitetic/e% o&&ero% positi&e e
negati&e. La indfulness inter&iene con linstaurare nelle persone la consape&olezza di
essere Qumani% sensi+ili ai ca+iaenti% a anc/e per ;uesto li+eri di colti&are un
atteggiaento &irtuoso in tutte le a&&ersit.
(ersonalente /o deciso di presentare la indfulness perc/= nutro la speranza c/e &enga
applicata in odo costrutti&o e c/e gli si riconosca la sua indispensa+ilit nel
raggiungiento di una societ piD ricca% e;uili+rata e sana.
,!
BIBLIOGRA$IA
-gostino 6)ant7% 62"127. Le confessioni. -;uilaF 1ea 8dizioni.
-guglia% -. 5 -l+ert >. 5 2e Cori% 2. * Maina% 9. * 0ogetto% V.% 62"117. Il trattaento del
distur+o ossessi&o5copulsi&o resistente. Guaderni Italiani di Hsichiatria% $ol. #"% 1%
16*2,.
-l+asi% C. 62""!7. Hsicopatologia e ragionamento clinico. MilanoF 1affaello Cortina
8ditore.
-erican (s3c/iatric -ssociation% 62""27. F.MPI,P$Q. Manuale diagnostico e statistico
dei disturbi mentali. MilanoF Masson.
-ndreSs% '. ]. 5 Ialpern ). 2. 5 (ur&es 2. 61!!77. Correlated size &ariations in /uan
&isual corteW% lateral geniculate nucleus% and optic tract. Rournal of Neuroscience% 17%
28,!*2868.
-stin% ]. 5 )/apiro% ). 5 8isen+erg% 2. 5 Vor3s% M. 62""#7. Mind50od3 MedicineF )tate of
t/e science% iplications for practice. merican Moard of "amil1 Hractice% 16% 1#15
147.
0ecB% -. '. * 1us/% -. ]. * )/aS% 0. V. * 8er3% 9. 61!7!7. )ognitive $herap1 of
Fepression. .eS aorBF 9uilford (ress.
0eitel% M. 5 Verrer% 8. 5 Cecero ]. ].% 62"",7. (s3c/ological indedness and aSareness of
self and ot/ers. Rournal of )linical Hs1cholog1% 61667% 7#!57,".
0ellantuono% C. * Mazzi% M. * 'ansella% M. * 1izzo% 1. * 9old+erg% 2. 62""27. '/e
identification of depression and t/e co&erage of antidepressant. Rournal of ffect
Fisorders 72 617% ,#5!.
0ennett59olean '.% 62""17. 7motional lchem1& Sow the Mind )an Seal the Seart%
Sarmon1 Mooks. .eS aorBF '/ree 1i&ers (ress.
0ern/ard% ]. 5 Jristeller% ]. 5 Ja+at5Kinn% ]. 61!887. 8ffecti&eness of relaWation and
&isualization tec/ni;ues as an ad`unct to p/otot/erap3 and p/otoc/eot/erap3 of
psoriasis. Rournal of the merican cadem1 of Fermatolog1% (N% ,725,7#.
0ocBting% C. L. 5 ten 2oessc/ate% M. C. 5 )pi`Ber ]. 5 )pin/o&en (. 5 Joeter M. A. 5 )c/ene
-. I. 62""87. 28L'- )tud3 9roup%Continuation and aintenance use of
antidepressants in recurrent depression. Hs1chother Hs1chosom 77% 1% 17526.
Ca/n% 0. 1. 5 (olic/% ]. 62""67. Meditation states and traitsF 889% 81(% and neuroiaging
studies. Hs1chological Mulletin% (;:% 18"5211.
6"
Carlson% L. * >rsuliaB% K. * 9oode3% 8. * -ngen% M. * )peca% M. 62""17. '/e effects of a
indfulness editation5+ased stress reduction progra on ood and s3ptos of
stress in cancer outpatientsF 65ont/ folloS up. .upport )are in )ancer% N% 112512#.
Ca&iglia% 9. 5 Iuliano% C. * (errella% 1. 62"",7. Il disturbo borderline di personalit. 1oaF
Carocci 8ditore.
C/arlson L. 8. 5 )peca M. 5 (atel J. 2.% 9oode3 8. 62""#7. Mindfulness5+ased stress
reduction in relation of ;ualit3 of life% ood% s3ptos of stress% and iune
paraeters in +reast and prostate cancer outpatients. Hs1chosomatic Medicine% 6,%
,715,81.
Cloninger C. 1. 5 )&raBic 2. M. 5 (rz3+ecB '. 1. 61!!#7. - ps3c/o+iological odel of
teperaent and c/aracter. In archives of Teneral Hs1chiatr1% ,"% ,8!5,!!.
Cornfield% 1. 0. * Malen% 1. L. 61!787. - ultidiensional &ieS of t/e o+sessi&e
c/aracter. )omprehensive Hs1chiatr1% &ol. 1!% 1% 7#*78.
CornSall% ]. * (/illipson% 4. '. 61!887. Mediodorsal and reticular t/alaic nuclei recei&e
collateral aWons fro prefrontal corteW and laterodorsal tegental nucleus in t/e rat.
Neurosci Lett.% 88% 121*126.
Cotugno -. 5 0enedetto -. M. 62"""7. Il pa!iente borderline. Milano% Vranco -ngeli
8ditore.
Crane% 1. 62"127. La terapia cognitive basata sulla mindfulness% caratteristiche distintive.
MilanoF Vranco-ngeli 8ditore.
2a&ies% 8. * Je3on% C. ]. * Vraser% 1. 61!8,7. '/e role of calciu ions in t/e ec/anis of
-C'I stiulation of cortisol s3nt/esis. .teroids% 4,% ,,1*,6".
2a&is% M. 61!!27. '/e role of t/e a3gdale in fear and anWiet3. nnual Qeview of
Neuroscience% 1,% #,#*#7,.
2esteW/e% -. * Contreras% 2. * )teriade% M. 61!!87. Mec/aniss underl3ing t/e
s3nc/ronizing action of corticot/alaic feed+acB t/roug/ in/i+ition of t/alaic rela3
cells. Rournal of Neuroph1siolog1% 7!% !!!*1"16.
2idonna V.% 62"127. Manuale clinico di mindfulness. MilanoF Vranco -ngeli 8ditore.
8ic/ 8.% 61!!,7. )earc/ing for Mood 2ependent Meor3. Hs1chological .cience% 6% !!5
1"4.
Vossella% ]. 5 (osner% M. I. 5 Van% ]. 5 )Sanson% ]. M.% 5 (faff% 2. A. 62""27. -ttentional
p/enot3pes for t/e anal3sis of /ig/er ental function. $he .cientific Lorld% :%2175
22#.
61
Voote% ). 61!877. 8Wtrat/alaic odulation of cortical function. nnual Qeview of
Neuroscience% 1"% 67*!,.
VranB% 8. * Jupfer% 2. ]. * (erel% ]. M. 5 Coes% C. 5 ]arrett% 2. 0. 5 Mallinger% -. 9. 5
9roc/ocinsBi% $. ]. et al. 61!!"7. '/ree aears 4utcoes for Maintenances '/erapies
in 1ecurrent 2epression. rch. Ten Hs1chiat.% &ol. 47% 1"!#5!!.
Vrit/% C. 2. 5 Vriston% J. * Liddle% (. V. * VracBoSiaB% 1. ). ]. 61!!17. Ailled -ction and
t/e (refrontal CorteW in ManF - )tud3 Sit/ (8'. Miological .cience% &ol. 244% 1#11%
2415246.
9a++ard% 9. 4. 61!!#7. -n o&er&ieS of Countertransference Sit/ +orderline patients.
Rournal of Hs1chotherap1 Hractice and Qesearch% 2% 7588
9a++ard% 9. 4. 62""77. Hsichiatria psicodinamica. Milano% 1affaello Cortina 8ditore.
9a++ard% 9. 4. * AilBinson% ). M. 61!!47. Management of )ountertransference with
Morderline Hatients. -erican (s3c/iatric (ress.
9allese% $ 5 Vadiga% L. * Vogassi% L. * 1izzolatti% 9. 61!!67. -ction recognition in t/e
preotor corteW. Mrain% 11!% ,!#56"!.
9allese% $. 5 Migone% (. 5 8agle M. .. 62""67. La siulazione incarnataF i neuroni
specc/io% le +asi neurofisiologic/e dellEintersoggetti&it e alcune iplicazioni per la
psicoanalisi. Hsicoterapia e scien!e umane% "rancongeli% &ol. #% "5#8.
9azzaniga% M. ). 62"""7. $he New )ognitive Neurosciences. Ca+ridgeF MI' (ress.
9oodan% A. J. * (rice% L. I. * 1asussen% ). -. * 2elgado% (. L. * Ieninger% 9. 1. *
C/arne3% 2. ). 61!8!7. 8fficac3 of Vlu&oWaine in 4+sessi&e5Copulsi&e 2isorderF
- 2ou+le5+lind Coparison Ait/ (lace+o. rch Ten Hs1chiatr1. 46% 1% #6544.
9rinBer% 1. 1. ]r * Aer+ler% 0. * 2r3e% 1. C. 61!687% $he borderline s1ndrome&
behavioural stud1 of egoPfunctions. .eS aorB% 0asic 0ooBs.
Iailton% .. -. 5 Jitzan% I. 5 9u3otte% ). 62""67. 8n/ancing /ealt/ and eotionF
Mindfulness as a issing linB +etSeen cogniti&e t/erap3 and positi&e ps3c/olog3.
Rournal of )ognitive Hs1chotherap1% 2" 627% 12#51#4.
Ia3es% ). C. * Ailson% J. 9. * 9ifford% 8. $. * Vollette% $. M. * )trosa/l% J. 61!!67.
8Wperiential a&oidance and +e/a&ioral disordersF - functional diensional approac/
to diagnosis and treatent. Rournal of )onsulting and )linical Hs1cholog1% &ol. 64
667% 11,251168.
Ierzog% I. * Lele% $. 1. * JuSert% '. * Langen% J. ]. 5 Jops% 8. 1. * Veinendegen% L. 8.
61!!"51!!17. C/anged pattern of regional glucose eta+olis during aoga
editati&e relaWation. Neurops1chobiolog1% 2#% 182*187.
62
Ioc/% (. * (olatin% (. 61!4!7. (seudoneurotic fors of sc/izop/renia. Hs1chiatric
Guarterl1% &ol. 2#% 2% 2485276.
Iollon% ). 2. 5 Jendall% (. 61!8"7. Cogniti&e )elf5)tateant in 2epressionF 2e&elopent
of an -utoatic '/oug/ts :uestionnaire. )ognit. $her. Qes.% &ol. 4% #8#5!,.
Lalla C.% 61!!87. (er una teoria cogniti&a sulla patogenesi e la cura del 2istur+o 4ssessi&o5
Copulsi&o. Hsicoterapia% 12.
Laparelli% C. 62""87. $ecniche della medita!ione orientale. MilanoF 4scar Mondadori.
Lazar% ). A. * 0us/% 9. * 9ollu+% 1. L. 5 Vricc/ione% 9. L. 5 J/alsa% 9. 5 0enson% I.
62"""7. Vunctional +rain apping of t/e relaWation response and editation.
Neuroreport% 11% 1,81*1,8,.
Lie+% J. * Kanarini% M. C. * )c/a/l% C. * Line/an% M. M. * 0o/us% M. 62""47. 0orderline
personalit3 disorder. Lancet% #64% 4,#*61.
Line/an% M. M. 61!!#7% .kills $raining Manual for treating borderline personalit1
disorder. .eS aorBF 9uilford (ress
Line/an% M. M. 62""17% $rattamento cognitivoPcomportamentale del disturbo borderline. Il
modello dialettico. MilanoF 1affaello Cortina 8ditore.
Li&ese3% ]. I. * 8&ans% M. ]. * Mulligan% 1. * 2onald% 1. -. 62"""7 Interactions of C1I%
-$( and cortisol in t/e secretion of -C'I fro perifused e;uine anterior pituitar3
cellsF Qperissi&e roles for cortisol and C1I. 7ndocrine Qesearch% 26% 44,*46#.
Loizzo% ].% 5 0lacB/all% L. 61!!87. 'raditional alternati&e as coplientar3 sciencesF '/e
case of Indo5'i+etan edicine. Rournal of lternative and )omplimentar1 Medicine%
4% #115#1!.
L3nc/% ]. C. 61!8"7 '/e functional organization of posterior parietal association corteW.
Mehavioral and Mrain .ciences% #% 48,*4!!.
]e&ning% 1. * Aallace% 1. J. * 0eide+ac/% M. 61!!27. '/e p/3siolog3 of editationF a
re&ieS. - SaBeful /3poeta+olic integrated response. Neuroscience U
Miobehavioral Qeviews% 16% 41,*424.
]osep/ 1.% 61!!67. Neurops1cholog1% Neurops1chiatr1% and Mehavioral Neurolog1. .eS
aorBF Aillias [ AilBins.
]udd% L. L. * -BisBal% I. ). * Keller% (. ]. * (aulus% M. * Leon% -. C. * Maser% ]. 2. *
8ndicott% ]. * Cor3ell% A. * Juno&ac% ]. L. * Mueller% '. I. * 1ice% ]. (. 5 Jeller M. 0.
62"""7. (s3c/osocial disa+ilit3 during t/e long5ter course of unipolar a`or
depressi&e disorder. rch Ten Hs1chiatr1 % ,7% 4% #7,5#8".
6#
Ja+at5Kinn ].% 61!827. -n outpatient progra in +e/a&ioral edicine for c/ronic pain
patients +ased on t/e practice of indfulness editationF '/eoretical considerations
and preliinar3 results. Teneral Sospital Hs1chiatr1% &ol. 4% ##547.
Ja+at5Kinn% ]. 5 LipSort/% L. 5 0urne3% 1. 5 )ellers% A. 61!867. Vour53ear folloS5up of a
editation5+ased progra for t/e self5regulation of c/ronic painF 'reatent
outcoes and copliance. )linical *ournal of pain % 2% #% 1,!5774.
Ja+at5Kinn% ]. 5 C/apan5Aadrop% -. 61!887. Copliance Sit/ an outpatient stress
reduction prograF 1ates and (redictors of copletion. Rournal of Mehavioural
Medicine% 11% ##5#,2.
Ja+at5Kinn% ]. 5 C/apan5Aadrop -. 5 )alon% (. 61!!77. '/e relations/ip of cogniti&e
and soatic coponents of anWiet3 to patient preference for alternati&e relaWation
tec/ni;ues. MindVMod1 Medicine% 2% 1"151"!.
Ja+at5Kinn% ]. * Massion% -. 4. 5 Jristeller ] * (eterson% L. 9. 5 Vletc/er J. * (+ert% L. *
LinderBing% A. 5 )antorelli% ). V. 61!!27. 8ffecti&eness of a editation5+ased stress
reduction progra in t/e treatent of anWiet3 disorders. merican Rournal of
Hs1chiatr1% 14!% !#65!4#.
Ja+at5Kinn% ]. 61!!!7. Fovun5ue tu vada ci sei gi. MilanoF 'ea pratica% Cor+accio.
Ja+at5Kinn% ]. 62"",7. ,ivere momento per momento. MilanoF Cor+accio.
Jo&acs% M. * 0ecB% -. '. 61!787. Maladapti&e cogniti&e structures in depression. m R
Hs1chiatr1% 1#,% ,2,5,##.
Mc9las/an% '. I. * 9rilo% C. M. * )Bodol% -. 8. * 9underson% ]. 9. * )/ea% M. '. * More3%
L. C. * Kanarini% M. C. * )tout% 1. L. 62"""7. '/e Colla+orati&e Longitudinal
(ersonalit3 2isorders )tud3F +aseline aWis I<II and II<II diagnostic co5occurrence.
cta Hs1chiatr .cand% 1"2% 2,6*64.
Merton% 1. J. 61!487. '/e self5fulclling prop/ec3. ntioch. Qeview% 8% 1!#*21".
MirsB3% ). 62""27. 8insteins /ot tie. .cientific merican% 287% 6#7% 81.
Montano% -. 62""77. Mindfulness% guida alla medita!ione di consapevole!!a% Wna terapia
per tutti. )alernoF 8coind )rl.
Murp/3% M. 5 2ono&an% ). 61!!!7. $he ph1sical and ps1chological effects of meditation.
)ausalitoF Institute of .oetic )ciences.
Murra3% C. * Lopez% -. 61!!87. '/e 9lo+al 0urden of 2isease. Nat Med% X 6117% 12415#.
.at/an% J. I. * Musselan% 2. L. * )c/atz+erg% -. V. * .eeroff% C. 0. 61!!,7. Miolog1 of
Mood Fisorders% .eeroff% C. 0. 5 )c/atz+erg% -. V. $eYt book of
ps1chopharmacolog1. Aas/ingtonF -erican (s3c/iatric (ress.
64
.eS+erg% -. 0. * -la&i% -. * 0aie% M. * (ourde/nad% M. * )antanna% ]. 5 dE-;uili% 8.
62""17. '/e easureent of regional cere+ral +lood floS during t/e copleW
cogniti&e tasB of editationF a preliinar3 )(8C' stud3. Hs1chiatr Qes
Neuroimaging% 1"6% 11#*122.
.eS+erg% -. 0 * I&ersen% ]. 62""#7. '/e neural +asis of t/e copleW ental tasB of
editationF neurotransitter and neuroc/eical considerations. Medical S1potheses
61% 2% 282*2!1.
.ietzsc/e% V. 61!7!7. Wmano troppo umano. 1oaF .eSton Copton.
4Ialloran% ]. (. * ]e&ning% 1. * Ailson% -. V. * )BoSsB3% 1. * Aals/% 1. .. * -leWander%
C. 61!8,7. Ioronal control in a state of decreased acti&ationF potentiation of
arginine &asopressin secretion. Hh1siolog1 U Mehaviour% #,% ,!1*,!,.
4ld/a% ]. M. * )Bodol% -. 8. * Jellan% I. 2. 5 I3ler% ). 8. 5 2oidge% .. 5 1osnicB% L.%
et al. 61!!,7. Coor+idit3 of aWis I and aWis II disorders. m R Hs1chiatr1% 1,2% ,71*
78.
(apageorgiou% C. 5 Aells% -. 62""17. Metacogniti&e +eliefs a+out ruination in recurrent
a`or depression. )ognitive and Mehavioral Hractice% 8 627% 16"5164.
(ardo% ]. $. 5 VoW% (. '. 5 1aic/le% M. 8. 61!!17. Localization of a /uan s3ste for
sustained attention +3 positron eission toograp/3. Nature% #4!% 61564.
(a3Bel% 8. ). * 0rug/a% '. * Vr3ers% '. 62"",7. )ize and +urden of depressi&e disorders in
8urope. 7uropean Neurops1chopharmacolog1% 1,% 411542#.
(erse% '. 61!887% 4+sessi&e5copulsi&e disorderF a treatent re&ieS. Rournal of )lin.
Hs1chiatr1% 4!% 2% 485,,.
(icardi% -. * 0iondi% M. 62""47. 'rattaento integrato se;uenziale del 2istur+o 4ssessi&o5
Copulsi&oF uno studio di folloS5up di 1# casi clinici. Qivista di Hsichiatria% #!% ,.
(ietroSsB3% 1. * 0raun% 2. * Ve/% I. L. * (ausc/inger% (. * 0orn% ]. 61!!17. $asopressin
and oW3tocin do not influence earl3 sensor3 processing +ut affect ood and
acti&ation in an. Heptides% 12% 1#8,*1#!1.
(ope% I. 9. ]r * ]onas% ]. M. * Iudson% ]. I. * Co/en% 0. M. * 'o/en% M. 61!8,7. -n
epirical stud3 of ps3c/osis in +orderline personalit3 disorder. m R Hs1chiatr1% 142%
128,*!".
(osner% M. I.% 5 (etersen% ). 8. 61!!"7. '/e attention s3ste of t/e /uan +rain. nnual
Qeview of Neuroscience% 1#% 2,542.
6,
(osner% M. I. 5 1ot/+art% M. J. 62""77. 1esearc/ on attention netSorBs as a odel for t/e
integration of ps3c/ological science. nnual Qeview of Hs1cholog1% ,8% 152#.
1eic/e% 8. M. $. 5 .unes+% ). 4. $. * Morioto% I. J. 62""47. )tress% depression% t/e
iune s3ste% and cancer. $he Lancet Zncolog1% ,% 1"% 617562,.
1enaud% L. (. 61!!67. C.) pat/Sa3s ediating cardio&ascular regulation of &asopressin.
)linical and 7Yperimental Hharmacolog1 and Hh1siolog1% 2#% 1,7*16".
1izzolatti% 9. 5 Vadiga% L 5 9allese% $. * Vogassi% L. 61!!67. (reotor corteW and t/e
recognition of otor actions. )ognitive Mrain Qesearch% &ol. #% Issue 2% 1#1*141.
)egal% K. $. * Aillias% ]. M. 9. * 'easdale% ]. 2. 62""67. Mindfulness al di l del
pensiero% attraverso il pensiero. 'orinoF 0ollati 0oring/ieri 8ditore.
)/apiro% ). L. 5 Carlson% L. 8. 62"1#7. Lrte e la .cien!a Mindfulness. ItaliaF (iccin
.uo&a Li+raria.
)c/open/auer% -. 61!!47. forismi sulla sagge!!a di vivere. MilanoF Mondadori.
)iegel% 2. ]. 62""!7. Mindfulness e cervello. $areseF 1affaello Cortina 8ditore.
)iegel% 1. 2. 62"127. Gui ed ora% strategie 5uotidiane di mindfulness. 'rentoF 8dizioni
8riBson.
)loan 2. M.% 62""47. 8otion regulation in actionF eotional reacti&it3 in eWperiential
a&oidance% Mehaviour Qesearch and $herap1% 42 12,7*127".
)paso`e&ib% ]. 5 -llo3 L. 0. 62""17. 1uination as a coon ec/anis relating
depressi&e risB factors to depression. 7motion% &ol. 1617% 2,5#7.
)peca% M. 5 Carlson% L. 5 9oode3% 8. 5 -ngen% M. 62"""7. - randoized% Saitlist controlled
clinical trailF '/e effect of a indfulness editation5+ased stress reduction progra
on ood and s3ptos of stress in cancer outpatients. Hs1chosomatic Medicine% J:%
61#5622.
)teinetz% M. -. * Motter% 0. C. * 2uff3% C. ]. * Mountcastle% $. 0. 61!877. Vunctional
properties of parietal &isual neuronsF radial organization of directionalities Sit/in t/e
&isual field. Rournal of Neuroscience% 7% 177*1!1.
)tigla3r% C. 8. * )/apiro% 2. -. * )tieglitz% 1. 2. * Li+erger% M. V. * 0o/us% M. 62""17.
8Wperience of a&ersi&e tension and dissociation in feale patients Sit/ +orderline
personalit3 disorderF a controlled stud3. R Hs1chiatr Qes% #,% 111*18.
)tellone% L. 61!!67. Fi!ionario Medico. 1oaF .eSton [ Copto
)udsuang% 1.5 C/entanez% $. * $elu&an% J. 61!!17. 8ffects of 0udd/ist editation on
seru cortisol and total protein le&els% +lood pressure% pulse rate% lung &olue an
reaction tie. Hh1siolog1 Mehaviour% ,"% ,4#*,48.
66
'acon% -. M. * Caldera% a. M. * 1onag/an% C. 62""47. Mindfulness50ased )tress
1eduction in Aoen Ait/ 0reast Cancer. "amilies% .1stems% U Sealth% &ol. 22% 2%
1!#52"#.
'easdale% ]. 2. 61!!!7. Metacognition% indfulness and t/e odification of ood
disorders. )linical Hs1cholog1 and Hs1chotherap1% 6% 14651,,.
'easdale% ]. 2. 5 )egal% K. $. 5 Aillias% M. 61!!,7. IoS does cogniti&e t/erap3 pre&ent
depressi&e relapse and S/3 s/ould attentional control 6indfulness7 /elpX Mehavior
Qesearch and $herap1% ##% 2,52!.
'easdale% ]. 2. 5 )egal% K. $. 5 Aillias% 9. 5 1idgeSa3% $. -. 5 )ouls+3% ]. M. 5 Lau% M. -.
62"""7. (re&ention of relapse<recurrence in a`or depression +3 indfulness5+ased
cogniti&e t/erap3.Rournal of consulting and clinical ps1cholog1%68647% 61,562#.
'easdale% ]. 2. 5 Moore% 1. 9. 5 Ia3/urst% I. 5 (ope% M. 5 Aillias% ). 5 )egal% K. $.
62""27. Metacogniti&e aSareness and pre&ention of relapse in depressionF 8pirical
e&idence. Rournal of consulting and clinical ps1cholog1% 7"% 2% 27,5287.
Kanarini% M. C. * VranBen+urg% V. 1. * 2eLuca% C. ]. * Iennen% ]. * J/era% 9. ). 5
9underson ]. 9.% 61!!87. '/e pain of +eing +orderlineF d3sp/oric states specicc to
+orderline personalit3 disorder. Sarv Qev Hs1chiatr1C 6% 2"1*"7.
Kanarini% M.C. * 9underson% ]. 9. * VranBen+urg% V. 1. 61!!"7 Cogniti&e features of
+orderline personalit3 disorder. m R Hs1chiatr1% 147% ,7*6#.
Kiegler% 2. 1. 5 Cass A. -. * Ieran% ]. (. 61!!!7. 8Wcitator3 influence of t/e locus
coeruleus in /3pot/alaic*pituitar3*adrenocortical aWis responses to stress. Rournal
of Neuroendocrinolog1% 11% #61*#6!.
Aalton% J. 9. * (ug/% .. 2. * 9elderloos% (. * Macrae% (. 61!!,7. )tress reduction and
pre&enting /3pertensionF preliinar3 support for a ps3c/oneuroendocrine
ec/anis. Rournal of lternative and )omplementar1 Medicine% 1% 26#*28#.
Aater/ouse% 0. 2. * Moises% I. C. * AoodSard% 2. ]. 61!!87 (/asic acti&ation of t/e locus
coeruleus en/ances responses of priar3 sensor3 cortical neurons to perip/eral
recepti&en field stiulation. Mrain Qesearch% 7!"% ##*44.
Aeingartner% I. * 9old% (. * 0allenger% ]. C. 5 )all+erg% ). -. 5 )uers% 1. 5 1u+inoS%
2. 1. 5 (ost% 1. M. * 9oodSin% V. J. 61!817. 8ffects of &asopressin on /uan
eor3 functions. .cience 211% 6"1*6"#.
Aenzlaff% 1. M. * Aegner% 2. M. 62"""7. '/oug/t )uppression. nnual review of
Hs1cholog1% ,1% ,!*!1.
67
Aillias% ]. M. 9. 5 2uggan% 2. ). 5 Crane% C. 5 Vennell% M. ]. $. 62""67. Mindfulness5
+ased cogniti&e t/erap3 for pre&ention of recurrence of suicidal +e/a&ior. Rournal of
)linical Hs1cholog1% J:627% 2"1521".
Aillia% M. * 'easdale% ]. * )egal% K. 5 Ja+at5Kinn% ]. 62"1"7. Qitrovare la serenit% come
superare la depressione attraverso la consapevole!!a. MilanoF 1affaello Cortina
8ditore.
68
SI"OGRA$IA
0ertagni% 9. 62"127 7raclito% "rammenti del =>?@ ABC>DE (sulla Natura).
[/ttpF<<SSS.gianfranco+ertagni.it<ateriali<filosofiaantica<eraclito./tU.
2escartes% 1. 61!!#7. Fiscorso sul metodo% MilanoF Mondadori.
T/ttpF<<SSS.aforisario.it<cogito5ergo5su./tU.
8nciclopedia 'reccani online. T/ttpF<<SSS.treccani.it<U.
9oet/e% ]. A. 62""27. I dolori del giovane Lerther. MilanoF Mondadori. T
/ttpF<<SSS.aforisario.it<`o/ann5Solfgang5goet/e52./tU.
93atso% '. 62"",7. .cience at the crossroads. $his article is based on a talk given b1 the
Falai Lama at the annual meeting of the .ociet1 for Neuroscience on November (:%
:\\] in Lashington F).
T/ttpF<<SSS.3oga5for5good.co<)cienceZatZt/eZCrossroadsZt/eZ2alaiZLaa.pdfU.
Manna% $. 62"1"7. Vattori eziopatogenetici del distur+o +orderline di personalit. .alus
Medicina in Qete. T/ttpF<<SSS.salus.it<psic/iatria5c4"<fattori5ezio5patogenetici5del5
distur+o5+orderline5di5personalita51464./tlU.
(agliarini% C. 62"1#7. Leo Muscaglia P ,ivere% mare% )apirsi.
T/ttpF<<SSS.nontoglieriilsorriso.org<drupal<recensioni<leo5+uscaglia5&i&ere5aare5
capirsid.>+Ir8&n"8BSU.
(oldracB% 1. -. 62""!7. Neuroimaging% le promesse e le illusioni. 0rain Vactor.
T/ttpF<<+rainfactor.it<indeW.p/pX
optionYcoZcontent[&ieSYarticle[idY177Fneuroiaging5le5proesse5e5le5
illusioni[catidY2Fneuroiagine[IteidY#U.
)c/open/auer% -. Il mondo come volont e rappresenta!ione. $ol. II%
T/ttpF<<SSS.aforisario.it<art/ur5sc/open/auer5!./tU.
6!
Rinra!ia&en1i a J
$ittorio ed 8lisa+etta% ogni parola spesa non +astere++e a descri&ere il +ene c/e &i &oglio e
la gratitudine c/e pro&o &erso di &oi.
-nna 9ensini% fortissia nonna% i /ai insegnato ad ottenere piuttosto c/e desiderare.
Matteo (apucci% grazie per tutto ci? c/e i doni solo con la tua presenza.
Massio (apucci e Maida $entisette% grazie per tutte le attenzioni c/e i a&ete regalato
accogliendoi coe una figlia.
9iada Ca&azzuti% sei una persona da&&ero +rillante% il tuo sostegno @ stato deterinante.
Vederica Cosii% per il +ene c/e ti &oglio e la stia c/e nutro &erso di te.
Crista 0ertelli% non i scorder? ai i giorni in cui i /ai fatto accedere agli arc/i&i pri&ati
dell-ccadeia della Crusca% le lettere spediteci sotto+anco e i tuoi ripro&eri in
classe per la ia continua distrazione.
9iulia 0encist% senza di te% la statistica per e sare++e ancora una strana procedura
agica.
9iancarlo 9io&annini% i /ai consentito di coprendere ;uel fantastico ondo c/e @ la
$ipassana.
J I &ie &en1ori
)ione 4lianti% una persona colta ed unica. Le lezioni s&olte sono state cosR +elle c/e
saranno difficili da dienticare ed ipossi+ili da eguagliare.
1o+erto Cuta`ar% per lairazione c/e @ in grado di suscitare ogni &olta c/e tiene una
lezione.
-lfredo ]acopozzi% un grande uoo% dal ;uale non &orrei c/iedere altro c/e iparare.
>+erto 9ali+erti% una persona c/e% sotto una pioggia incessante% con poc/e parole ed
una acc/ia dinc/iostro% i /a ca+iato la &ita.
Marianna Martinelli% la psicoterapeuta c/e un giorno &orrei tanto essereC un odello a cui
cerc/er? di fare riferiento.
8ugenio 0inini% i /a fatto ricordare c/e non si vede bene se non con gli occhi del cuore.
Caterina 2eic/eli ed -urelia 0ar+ieri% grazie per la dedizione e linteresse a&uti nei iei
confronti.
7"
Potrebbero piacerti anche
- La: "Morphogenetics Touch": Tutto ciò che non si esprime si imprime. La memoria emozionale nel corpo!!!Da EverandLa: "Morphogenetics Touch": Tutto ciò che non si esprime si imprime. La memoria emozionale nel corpo!!!Nessuna valutazione finora
- Lombardo Arcangelo AbstractDocumento22 pagineLombardo Arcangelo Abstractsiraj nullaNessuna valutazione finora
- Resilienza e Autocura - Un approccio integrato orientato alle risorseDa EverandResilienza e Autocura - Un approccio integrato orientato alle risorseNessuna valutazione finora
- Tesi Di Dottorato - MeditazioneDocumento656 pagineTesi Di Dottorato - MeditazioneStefiNessuna valutazione finora
- Sarmoung08 - L'IntuizioneDocumento17 pagineSarmoung08 - L'IntuizioneAmedeo MerlonghiNessuna valutazione finora
- Vestirsi Di Sé: Manuale di auto-massaggio consapevoleDa EverandVestirsi Di Sé: Manuale di auto-massaggio consapevoleNessuna valutazione finora
- TESI MASTER IN COUNSELING PROFESSIONALE - MCorradetti-VGDocumento84 pagineTESI MASTER IN COUNSELING PROFESSIONALE - MCorradetti-VGmarisa corradetti100% (21)
- Il potere della mente subconscia: Come mettere a frutto i nostri potenziali nascosti per raggiungere gli obiettivi e vivere una vita felice ed appaganteDa EverandIl potere della mente subconscia: Come mettere a frutto i nostri potenziali nascosti per raggiungere gli obiettivi e vivere una vita felice ed appaganteNessuna valutazione finora
- Trauma e Memoria EmotivaDocumento32 pagineTrauma e Memoria EmotivaLuigi De Michele100% (1)
- Soffio vitale brezza per l'anima. Star bene con il Counseling sistemicoDa EverandSoffio vitale brezza per l'anima. Star bene con il Counseling sistemicoNessuna valutazione finora
- Cambiare Vita È PossibileDocumento2 pagineCambiare Vita È PossibileSidre BesaNessuna valutazione finora
- Se non ora... quando?: Smettila di rimandare, impara a gestire il tuo tempo e inizia a vivere pienamente la vitaDa EverandSe non ora... quando?: Smettila di rimandare, impara a gestire il tuo tempo e inizia a vivere pienamente la vitaNessuna valutazione finora
- Ebook EFT 3.0Documento33 pagineEbook EFT 3.0Anonymous g8zT2sPtjW100% (1)
- La cura professionale: Considerazioni sociologiche - condivisibili anche da non sociologi - sulla cura, l’utilizzo di sostanze nocive e sul gioco d’azzardoDa EverandLa cura professionale: Considerazioni sociologiche - condivisibili anche da non sociologi - sulla cura, l’utilizzo di sostanze nocive e sul gioco d’azzardoNessuna valutazione finora
- Ulcer VaricosDocumento78 pagineUlcer VaricosAndreea Pintilie100% (3)
- Cuore, empatia, professionalità: Come avere successo con le persone in trattamentoDa EverandCuore, empatia, professionalità: Come avere successo con le persone in trattamentoNessuna valutazione finora
- Il Tocco Metamorfico-Trasforma Il Tuo PotenzialeDocumento67 pagineIl Tocco Metamorfico-Trasforma Il Tuo PotenzialeMarco100% (1)
- Heal Summit Workbook PDFDocumento557 pagineHeal Summit Workbook PDFLuisaNessuna valutazione finora
- Ipnosi SciamanicaDocumento155 pagineIpnosi Sciamanicamel martigan75% (4)
- Sofrologia nella vita quotidiana: Sofrologia, come armonizzare corpo e menteDa EverandSofrologia nella vita quotidiana: Sofrologia, come armonizzare corpo e menteNessuna valutazione finora
- TESI 20 Settembre 2014 Alessandra Grimaldi 1Documento97 pagineTESI 20 Settembre 2014 Alessandra Grimaldi 1rinco16Nessuna valutazione finora
- Le parole del benEssere: Percorsi di cura e autocura tra emozioni, voci e relazioni umaneDa EverandLe parole del benEssere: Percorsi di cura e autocura tra emozioni, voci e relazioni umaneNessuna valutazione finora
- Antroposofia Ed Arte EducativaDocumento20 pagineAntroposofia Ed Arte Educativatiziano.thekingsunNessuna valutazione finora
- Vibroenergismo. Una nuova guida all'esistenza vol.2Da EverandVibroenergismo. Una nuova guida all'esistenza vol.2Nessuna valutazione finora
- Corpo Come TempioDocumento60 pagineCorpo Come TempioDante CrucianiNessuna valutazione finora
- Io comando, il mio fisico obbedisce e migliora: Alla ricerca di una vita longevaDa EverandIo comando, il mio fisico obbedisce e migliora: Alla ricerca di una vita longevaNessuna valutazione finora
- Psicosintesi LessonsDocumento160 paginePsicosintesi LessonsSectio Aurea100% (1)
- Giocando con le VISUALIZZAZIONI, il potere delle IMMAGINIDa EverandGiocando con le VISUALIZZAZIONI, il potere delle IMMAGININessuna valutazione finora
- RebirthingDocumento18 pagineRebirthingMalekit6Nessuna valutazione finora
- La Biologia Delle Emozioni 9788896865422 637111Documento225 pagineLa Biologia Delle Emozioni 9788896865422 637111Elisa Osimani100% (4)
- Logos e voluntas nella sofferenza psicologicaDa EverandLogos e voluntas nella sofferenza psicologicaValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- La Meditazione Dell'unoDocumento5 pagineLa Meditazione Dell'unoD.DomenicoNessuna valutazione finora
- APRIRE IL TERZO OCCHIO - Tecnich - Anna MaiDocumento83 pagineAPRIRE IL TERZO OCCHIO - Tecnich - Anna Mail.santuNessuna valutazione finora
- Unified Knowledge SystemDocumento37 pagineUnified Knowledge SystemErica TricaricoNessuna valutazione finora
- Bio Touch NghrevDocumento49 pagineBio Touch NghrevMarinela TonuNessuna valutazione finora
- La Radionica Esoterico - Doc Versione 1Documento4 pagineLa Radionica Esoterico - Doc Versione 1polloNessuna valutazione finora
- Geobiologia e Kinesiologia Applicata:un Approccio Di Valutazione Delle Influenze Ambientali Sull'uomoDocumento78 pagineGeobiologia e Kinesiologia Applicata:un Approccio Di Valutazione Delle Influenze Ambientali Sull'uomoSergio Berti100% (5)
- Psciologia Sviluppo Universita RomaDocumento221 paginePsciologia Sviluppo Universita RomalivrosmacedoNessuna valutazione finora
- Il Metodo Silva Mind Control ITADocumento104 pagineIl Metodo Silva Mind Control ITApbianchi86% (22)
- Analisi Neurolinguistica Della Prosodia Emotiva PDFDocumento294 pagineAnalisi Neurolinguistica Della Prosodia Emotiva PDFFilippo Maria MagiNessuna valutazione finora
- La Dramatherapy Teatro Del BenessereDocumento72 pagineLa Dramatherapy Teatro Del BenessereGiorgio DegasperiNessuna valutazione finora
- Andare in ThetaDocumento8 pagineAndare in ThetaguglielmomaenzaNessuna valutazione finora
- AUTOIPNOSIDocumento94 pagineAUTOIPNOSIFelice SinibaldiNessuna valutazione finora
- Primo Capitolo NEWDocumento29 paginePrimo Capitolo NEWMatteo CesandriNessuna valutazione finora
- Quantum Memory 2018 - StampabileDocumento162 pagineQuantum Memory 2018 - StampabileAlifaxNessuna valutazione finora
- MindfulnessDocumento25 pagineMindfulnessMario SabatinoNessuna valutazione finora
- Ampiezza e Portata Della PsicosintesiDocumento4 pagineAmpiezza e Portata Della PsicosintesiEmilioEspositoNessuna valutazione finora
- Di Ieso Vincenzo - Taoismo in Uno Sguardo +++Documento113 pagineDi Ieso Vincenzo - Taoismo in Uno Sguardo +++Fabrizio Meo100% (1)
- Lifestyle Principles Ebook 2Documento48 pagineLifestyle Principles Ebook 2odontoanno1Nessuna valutazione finora
- Libro Disturbi Dello Sviluppo 2015Documento171 pagineLibro Disturbi Dello Sviluppo 2015Cipriano D'AmbrosioNessuna valutazione finora
- Visualizzazione Mentale e Tecniche ImmaginativeDocumento5 pagineVisualizzazione Mentale e Tecniche Immaginativepax20002004Nessuna valutazione finora
- I Segnali Del Corpo Comprendere La Psicosomatica Per Conoscere Il Proprio Corpo ScribdDocumento39 pagineI Segnali Del Corpo Comprendere La Psicosomatica Per Conoscere Il Proprio Corpo Scribdannamaria petrarolo0% (1)
- TESI Rachele MazzoDocumento64 pagineTESI Rachele Mazzocapitan fosforoNessuna valutazione finora
- Emoenergetica Psicologia Neochamanica Chema SanzDocumento151 pagineEmoenergetica Psicologia Neochamanica Chema SanzFacu NdoNessuna valutazione finora
- Vivere Sovrappensiero Sirimedho Stefano de LucaDocumento107 pagineVivere Sovrappensiero Sirimedho Stefano de Lucafarlocco23Nessuna valutazione finora
- Piccole abitudini per grandi cambiamenti. Trasforma la tua vita un piccolo passo per voltaDa EverandPiccole abitudini per grandi cambiamenti. Trasforma la tua vita un piccolo passo per voltaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (5)
- Anatomia della Guarigione: I sette principi della Nuova Medicina IntegrataDa EverandAnatomia della Guarigione: I sette principi della Nuova Medicina IntegrataValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)
- La dieta chetogenica per principianti: piano dietetico di 3 settimane semplice e divertenteDa EverandLa dieta chetogenica per principianti: piano dietetico di 3 settimane semplice e divertenteNessuna valutazione finora
- La musica che guarisce: Esperienze e considerazioni all'interno dei laboratori di musicoterapia didatticaDa EverandLa musica che guarisce: Esperienze e considerazioni all'interno dei laboratori di musicoterapia didatticaNessuna valutazione finora
- Le Tattiche del Cambiamento - Manuale di Psicoterapia StrategicaDa EverandLe Tattiche del Cambiamento - Manuale di Psicoterapia StrategicaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- La medicina di santa Ildegarda: Per tutti i giorni e per tutta la famiglia.Da EverandLa medicina di santa Ildegarda: Per tutti i giorni e per tutta la famiglia.Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)
- Fisica Micro-vibratoria e Forze InvisibiliDa EverandFisica Micro-vibratoria e Forze InvisibiliValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (3)