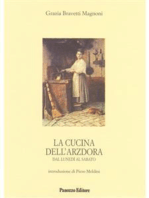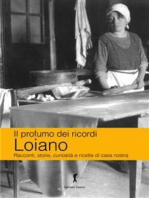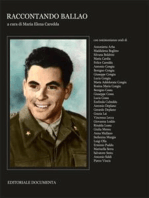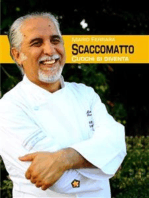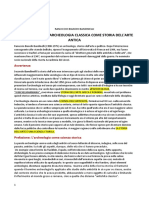Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Oblata
Caricato da
Aldo RossoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Oblata
Caricato da
Aldo RossoCopyright:
Formati disponibili
L'«oubià» è servita La riscoperta dell'antico dolce di Grana L'«oubià» è servita Poche cuoche
custodiscono il segreto della fragrante cialda Ogni famiglia un tempo aveva il suo «ferro» per
marchiarle GRANA. Il Ferragosto granose, oltre al concorso dei balconi fioriti e alla gara di
macchinine radiocomandate, offre anche la possibilità di riscoprire un dolce antico. Sono le oubià
(si legge tibia). Pare che li abbia addirittura assaggiati Napoleone dopo la battaglia di Marengo
(1800), al ritorno di alcuni suoi soldati da Grana dove, per festeggiare la vittoria, avevano innalzato
l'albero della libertà, nella piazza principale del paese. L'origine di queste cialde, presenti anche
nella tradizione toscana, non è certa; si sa comunque che il loro nome — anticamente «obbiada» —
deriva dal termine latino «oblata» (offerta, ostia). Il loro aspetto, infatti, ricorda quello di una
grande ostia; hanno un diametro di 14 centimetri per pochi millimetri di spessore; sono fatte di
farina, latte, burro, uova, zucchero e vaniglia. Per cuocerle ci vuole un apposito stampo in ferro,
formato da due dischi combacienti, tra cui viene messa la pastella, decorati all'interno in
bassorilievo, uniti da un perno ed azionati da due lunghe e sottili aste. Un tempo quasi tutte le
famiglie del paese possedevano «il ferro» per fare le oubjà, ora ne sono rimasti pochi. Ognuno era
caratterizzato da une diversa decorazione, dalla data di fabbricazione e dalle iniziali di chi li usava,
facendo così delle dolci leccornie granosi i primi biscotti firmati della storia. Il maestro Abele
Truffa (morto una decina di anni fa), attento cultore della storia di Grana, riuscì addirittura a trovare
uno stampo per oubià risalente alla seconda metà del 1700. Un altro granese, Nino Oddo ne (attuale
maestro della corale parrocchiale), ha scritto una poesia dedicata a questa «ostia andouràja, fàcja 'd
roba bouna», dolce caratteristico del paese, che un tempo le donne facevano quando in casa c'era
qualcuno da festeggiare. «L'oubjà — precisa don Gatti, parroco di Grana — è per noi il dolce
dell'amicizia, perché, oltre ad essere il protagonista di tutte le nostra feste, veniva e viene tuttora
regalato ai malati come ricostituente, in quanto molto nutriente e digeribile». Dello stesso parere
sono anche Lina e Filippa Arrobbio, due sorelle granesi che stanno imparando dalla madre
Angiolina, ormai ottantenne, «l'arte delroubjà». «Il segreto per farli buoni — commentano — sta
nella qualità degli ingredienti, nei tempi di lievitazione dell'impasto e in quelli di cottura, ma
soprattutto nella consistenza della pastella». Il procedimento è presto detto: dopo aver lasciato
lievitare la pasta se ne prende un cucchiaio, si mette tra i due dischi di ferro, già riscaldati, si fa
cuocere sul fuoco di canne e piccoli rami per un minuto o poco più, e così, una cialda alla volta, per
quattro o cinque ore di seguito. «Mia madre — continua Lina Arrobbio — ha smesso di farli perché
non riusciva più a reggere per tanto tempo il ferro che pesa circa tre chili e stare davanti al fuoco
con questo caldo è davvero una gran fatica». Brunella Ma scari no
Potrebbero piacerti anche
- Buie Nei RicordiDocumento73 pagineBuie Nei RicordiLeo RennaNessuna valutazione finora
- La cucina dell'arzdora: Dal lunedì al sabatoDa EverandLa cucina dell'arzdora: Dal lunedì al sabatoNessuna valutazione finora
- Il pane carasau: Storie e ricette di un'antica tradizione isolanaDa EverandIl pane carasau: Storie e ricette di un'antica tradizione isolanaNessuna valutazione finora
- I melicotti di Pianezza e le altre paste di meliga del PiemonteDa EverandI melicotti di Pianezza e le altre paste di meliga del PiemonteNessuna valutazione finora
- Tradizioni Di NataleDocumento2 pagineTradizioni Di Nataleivanchy333Nessuna valutazione finora
- Id 39 PDFDocumento19 pagineId 39 PDFDario zampaNessuna valutazione finora
- Pasticceria 1Documento20 paginePasticceria 1Emanuela MelisNessuna valutazione finora
- Bologna la dolce. Curiosando sotto i portici tra antichi sapori: (I Quaderni del Loggione - Damster)Da EverandBologna la dolce. Curiosando sotto i portici tra antichi sapori: (I Quaderni del Loggione - Damster)Nessuna valutazione finora
- Natale in SpagnaDocumento5 pagineNatale in SpagnaChiara Del SignoreNessuna valutazione finora
- Camporesi Il Pane e La MorteDocumento20 pagineCamporesi Il Pane e La MorteGiovanni FoisNessuna valutazione finora
- Le Tradizioni Dimenticate Carlo ParediDocumento41 pagineLe Tradizioni Dimenticate Carlo ParediNico RotaNessuna valutazione finora
- Depliant AndarinosDocumento2 pagineDepliant AndarinossagresardegnaNessuna valutazione finora
- Loiano. Il profumo dei ricordi: Racconti, storie, curiosità e ricette di casa nostraDa EverandLoiano. Il profumo dei ricordi: Racconti, storie, curiosità e ricette di casa nostraNessuna valutazione finora
- La Festa Dei Morti Nelle Tradizioni Italiane.Documento1 paginaLa Festa Dei Morti Nelle Tradizioni Italiane.Anonymous XszEnzOVHNessuna valutazione finora
- (Ebook - ITA - CUCINA) A Tavola Con Gli Hobbit PDFDocumento94 pagine(Ebook - ITA - CUCINA) A Tavola Con Gli Hobbit PDFFrancesca Akasha Ledda0% (1)
- La certezza dell'Immortalità: Veronica PalermoDa EverandLa certezza dell'Immortalità: Veronica PalermoNessuna valutazione finora
- Come le fragole a primavera: Guida sentimentale alla cucina e alte storieDa EverandCome le fragole a primavera: Guida sentimentale alla cucina e alte storieNessuna valutazione finora
- NapoliDocumento222 pagineNapolikurosp100% (3)
- La Bottega Di SpinalbaDocumento27 pagineLa Bottega Di SpinalbaKatrovarNessuna valutazione finora
- Cronologia Della PastaDocumento15 pagineCronologia Della PastaesmerildoNessuna valutazione finora
- A) Le Feste Italiane: NataleDocumento7 pagineA) Le Feste Italiane: NataleAlexandros Kastanakis100% (1)
- La Vera Storia Della BefanaDocumento4 pagineLa Vera Storia Della BefanaTesis OsgNessuna valutazione finora
- Documento Sul Culto Di Santa Cecilia A Gallico Di Bartolo Longo - Pages-To-Jpg-0002Documento1 paginaDocumento Sul Culto Di Santa Cecilia A Gallico Di Bartolo Longo - Pages-To-Jpg-0002Maurizio Bascia'Nessuna valutazione finora
- A Carnevale ogni scherzo vale!: filastrocche della tradizioneDa EverandA Carnevale ogni scherzo vale!: filastrocche della tradizioneNessuna valutazione finora
- Io, nata a Catania nel 1950,: ho respirato filastrocche, giochi, carosello...Da EverandIo, nata a Catania nel 1950,: ho respirato filastrocche, giochi, carosello...Nessuna valutazione finora
- 1 Giganti e CastagneDocumento5 pagine1 Giganti e Castagnepaola tassinariNessuna valutazione finora
- RepPA CastelbuonoDocumento2 pagineRepPA CastelbuonoGinoNessuna valutazione finora
- Radici: Vita e mangiari di un tempo nella campagna marchigianaDa EverandRadici: Vita e mangiari di un tempo nella campagna marchigianaNessuna valutazione finora
- Mario Cianfanelli. Un OmaggioDocumento60 pagineMario Cianfanelli. Un OmaggioAntonio Dal MutoNessuna valutazione finora
- Progetto BacoliDocumento15 pagineProgetto Bacoliernesto brando100% (1)
- Corso Rhino 2015-2016 STAMPA-3D 6lezione LASTDocumento7 pagineCorso Rhino 2015-2016 STAMPA-3D 6lezione LASTLeonelloNessuna valutazione finora
- Civilta Nuragica (1) - ConvertitoDocumento18 pagineCivilta Nuragica (1) - ConvertitoMarco PioppoNessuna valutazione finora
- Tabel Rina Mentinere VerdeDocumento6 pagineTabel Rina Mentinere VerdeCatalina AnghelNessuna valutazione finora
- Galea, Caravella e GaleoneDocumento2 pagineGalea, Caravella e GaleoneSelene__100% (1)
- Argon Italia It v77279Documento2 pagineArgon Italia It v77279morphelyaNessuna valutazione finora
- Metodo Di Canto GregorianoDocumento6 pagineMetodo Di Canto GregorianoMaría Rilke100% (1)
- Serenata Capriccio ScoreDocumento8 pagineSerenata Capriccio ScoreStefanoNessuna valutazione finora
- ArcheologiaDocumento26 pagineArcheologiafloranoceraNessuna valutazione finora
- Marin Sanudo Il GiovaneDocumento3 pagineMarin Sanudo Il GiovaneporzelNessuna valutazione finora