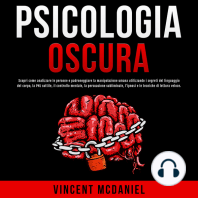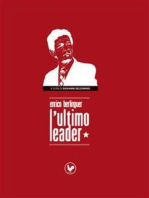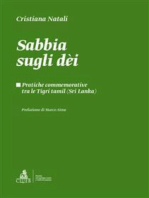Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Documento PDF
Caricato da
giulia0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni5 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni5 pagineDocumento PDF
Caricato da
giuliaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 5
I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE
Il presupposto politico della Costituzione: l’antifascismo
La Costituzione italiana è una costituzione compiutamente antifascista: per voltare
definitivamente pagina rispetto alla triste esperienza del fascismo e della guerra, i costituenti
sentirono il bisogno di rovesciare completamente le categorie che avevano caratterizzato il
fascismo.
Il fascismo si era caratterizzato per lo spirito di fazione e sulla discriminazione, i Costituenti
assunsero l’uguaglianza e l’universalità dei diritti dell’uomo come fondamento
dell’ordinamento.
Il fascismo aveva soppresso il pluralismo, perseguendo una visione totalitaria del potere, i
Costituenti concepirono una struttura istituzionale fondata sulla divisione, distribuzione,
articolazione e diffusione dei poteri.
Il fascismo aveva celebrato una politica di potenza, abbinata al disprezzo del diritto
internazionale e alla convivenza con la guerra, i Costituenti riconobbero la supremazia del
diritto internazionale e ripudiarono la guerra.
L’antifascismo della Costituzione non sta solo nella XII disposizione transitoria e finale – che
vieta la riorganizzazione del disciolto Partito fascista – ma sta nei fondamenti e nell’architettura
del sistema. I principi fondamentali sono antitetici rispetto a quelli proclamati o praticati dal
fascismo e l’architettura del sistema costituzionale impedisce che, qualora giungano al governo
forze politiche caratterizzate da cultura antidemocratica, queste forze possano realizzare una
trasformazione autoritaria delle istituzioni, aggredendo il pluralismo istituzionale o il sistema delle
autonomie individuali o collettive (libertà di espressione del pensiero, libertà di associazione, diritto
di sciopero, ecc..). La Costituzione rende impossibile ogni forma di dittatura della maggioranza.
I beni pubblici repubblicani: i principi fondamentali
La Costituzione si compone di 139 articoli. È divisa in due parti (Parte I “Diritti e doveri dei
cittadini”; Parte II “Ordinamento della Repubblica”). La Parte I è preceduta da una sezione
denominata “Principi fondamentali” composta da 12 articoli.
I principi fondamentali che consentono di identificare la forma di Stato e i caratteri della
democrazia italiana possono essere considerati cinque:
- Il principio democratico (art.1)
- Il principio personalista (art. 2 art.3)
- Il principio lavorista (art. 1 art. 4)
- Il principio pluralista (art. 2)
- Il principio internazionalista (art. 10 art. 11)
Il principio personalista
I principi fondamentali non sono separabili tra di loro (sono combinati ed interagiscono insieme in
modo armonioso). Il principio personalista può essere considerato il punto di partenza, il principio a
fondamento di tutto. Tale principio, che informa di sé tutto l’edificio costituzionale e che trova
espressione soprattutto negli articoli 2 e 3, consiste in un superamento di una visione solamente
individualistica ed esclude una visione totalitaria; l’Italia democratica deve riconoscere la
precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi
bisogni non solo materiali, ma anche spirituali); la necessaria socialità di tutte le persone; e
l’esistenza dei diritti fondamentali.
Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”
La persona umana è un valore storico-naturale, un valore originario, che l’ordinamento deve
riconoscere e rispettare in ogni circostanza; per questo i diritti fondamentali sono inviolabili (NON
possono essere sovvertiti o modificati neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi
costituzionali).
Sempre in nome del principio personalista è stata ripudiata la guerra (art.11), perché si tratta di
un’attività che può compiersi solo attraverso la distruzione di persone umane. Per questo non è
ammessa la pena di morte e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità (art. 27) e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Il principio personalista pone delle limitazioni ontologiche all’esercizio del potere politico;
nell’ambito del principio personalista rientrano due valori supremi della Costituzione, il principio di
uguaglianza e il principio di laicità.
Il principio di uguaglianza
Se ogni uomo è un valore è chiaro che questo valore non può essere discriminato e non possono
esistere gerarchie tra le persone nel godimento dei diritti.
Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzioni
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”:
L’uguaglianza nei diritti e nei doveri, con la conseguente uguaglianza di fronte alla legge
(uguaglianza formale), è una delle fondamenta dell’intero edificio costituzionale. Tuttavia,
l’uguaglianza formale non basta per promuovere l’emancipazione sociale; è fondamentale il
secondo comma dell’art. 3, il quale impone alla Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
In tema di uguaglianza, la Costituzione è andata oltre la concezione liberale dell’uguaglianza
formale dei soggetti che partecipano al contratto sociale. Assieme alla concezione statica (formale)
dell’eguaglianza, è stata assunta una concezione dinamica (sostanziale), per cui la Costituzione
NON si limita ad affermare dei principi fondamentali ma pone anche un progetto per svilupparli e
realizzarli nella concretezza della realtà economico-sociale. Indica un percorso verso un modello di
democrazia inclusivo ed emancipatorio, ponendo una perenne sfida all’economia, alla politica, alle
istituzioni.
Si riconosce che le disuguaglianze non derivano solo dal diritto, ma affondano le loro radici
soprattutto nei rapporti sociali, nelle condizioni materiali ed economiche; e le disuguaglianze
economiche pregiudicano il diritto allo sviluppo della persona, alla parità davanti alla legge, alla
partecipazione democratica. L’uguaglianza reale non esiste e i diritti potranno diventare veri solo
quando per tutti ci sarà un’istruzione adeguata, un lavoro non precario, una casa, un’adeguata
assistenza sanitaria, ovvero le condizioni per un’esistenza libera e dignitosa.
Questo articolo è rivoluzionario perché costituisce una critica alla realtà sociale esistente ed una
critica al carattere formale ed astratto del diritto. La nostra Repubblica riconosce che NON basta
proclamare un diritto in astratto per tranquillizzare la nostra coscienza democratica, ma è necessario
che le istituzioni si impegnino per rendere tale diritto effettivo e concreto (principio di effettività:
non basta proclamare un diritto, ma occorre realizzarlo nei fatti).
Come afferma P. Calamandrei “il progetto di Costituzione non è l’epilogo di una rivoluzione già
fatta, ma il preludio, l’introduzione, l’annunzio di una rivoluzione nel senso giuridico e legalitario
ancora da fare”.
Il principio di laicità
Il principio di laicità emerge dagli articoli 2,3,7,8,19 e 20 ed esso implica non solo indifferenza
dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa
in un regime di pluralismo confessionale e culturale.
I valori della libertà dello Stato dalla Chiesa, della libertà di coscienza, della libertà ed uguaglianza
di tutte le confessioni religiose e della non discriminazione concorrono a strutturare il principio di
laicità, ma non ne costituiscono il fondamento, il fondamento è ancora una volta il principio
personalista (dignità della persona, la persona come valore).
Dal principio personalista discende anche l’attenzione alla famiglia (art. 19 e 20), comunità
intermedia prediletta della Costituzione, ma ciò non toglie che la Costituzione debba garantire
anche altre comunità intermedie (coppie di fatto, coppie omosessuali).
Il principio lavorista
Ancora strettamente collegato al valore della persona, è il riconoscimento della dignità del lavoro,
cioè di tutte le attività che concorrono al “progresso materiale o spirituale della società”. Il lavoro è
addirittura posto a fondamento della Repubblica:
art. 1 “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Il lavoro come diritto-dovere riconosciuto a tutti i cittadini, la Repubblica ha il dovere di renderne
effettivo l’esercizio (art. 4)
Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme”.
Su questa base, il valore sociale del lavoro, è stato edificato l’edificio dei “Rapporti economici”,
regolato dal Titolo III della Parte II (art. da 35 a 47), in cui viene delineata la Costituzione
economica, che regola i rapporti economici, i diritti degli uomini e delle donne lavoratrici, i limiti e
le funzioni del diritto di proprietà e si pongono i capisaldi dell’intervento dello Stato nell’economia.
Si tratta di uno degli aspetti più innovativi della Costituzione italiana, nel quale si è sviluppata una
concezione del fenomeno economico che equilibra la logica di mercato e della proprietà con le
funzioni sociali.
Compromesso tra la concezione comunista e quella liberista ancora oggi mostra la sua attualità.
Il principio internazionalista o supernazionale
Il principio internazionalista, fondato sugli art. 10 e 11, rappresenta una delle innovazioni principali
della Costituzione e uno dei punti di massima discontinuità rispetto allo stato fascista. La
Costituzione opera un’innovazione decisiva anche rispetto allo statuto albertino invadendo il campo
della politica estera (che l’Ottocento aveva considerato dominio del sovrano) e lo fa promulgando il
ripudio della guerra e la costruzione della pace e della giustizia tra le nazioni.
Si stabilisce la supremazia del diritto internazionale sull’ordinamento interno e consentendo
limitazioni alla sovranità nazionale: è stato questo principio a costituire la porta attraverso cui
l’Italia è entrata in Europa.
Il principio pluralista e l’equilibrio dei poteri
Anche il principio pluralista trova il suo fondamento nell’art. 2 che riconosce i diritti dell’uomo non
solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità. Le formazioni
sociali sono la famiglia, il sindacato, le confessioni religiose, i partiti politici (prese in
considerazione dalla Costituzione) e tutte le altre forme di aggregazione riconosciute dall’art. 18
(diritto di associazione) come il volontariato. Il pluralismo che ne deriva fonda una società civile
ricca, complessa ed articolata.
La Costituzione, che ha ripudiato la concezione monista del potere propria del regime fascista, è
andata oltre la dottrina classica liberale della separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e
giudiziario) ed ha adottato il principio della distribuzione e diffusione del potere tra una pluralità di
soggetti distinti che interagiscono in un sistema di pesi e contrappesi.
La distribuzione dei poteri è per lo più di tipo orizzontale, ed in essa rientra anche il sistema delle
autonomie territoriali (Titolo V della Parte II) che sono articolate in Regioni, Province, Comuni, ne
rispetto del principio dell’inscindibile unità del popolo e della sua espressione statale, la Repubblica
italiana.
La separazione dei poteri è soprattutto di tipo verticale e riguarda il potere legislativo, esecutivo e
giudiziario e i contrappesi reciproci. In questo ultimo ambito i due punti fondamentali sono:
l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere e la sottoposizione dell’attività
legislativa al controllo di legalità costituzionale esercitato dalla Corte costituzionale.
Per quanto riguarda il rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo la divisione è più sfumata,
perché si tratta di poteri che concorrono con ruoli diversi a determinare l’indirizzo politico. Il
principio che regola i rapporti tra i due poteri è quello della supremazia del Parlamento, che si
esercita mediante lo strumento della fiducia (art. 94 “Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere), che può essere dal Parlamento liberamente revocata senza che ciò comporti la decadenza
dell’Assemblea o inevitabili elezioni anticipate.
Vi sono poi i poteri di garanzia del Presidente della Repubblica (competenze in tema di formazione
delle leggi e scioglimento delle Camere).
L’elemento più forte di garanzia è rappresentato dalla Corte Costituzionale, organo indipendente la
cui funzione principale è verificare la conformità alla Costituzione delle leggi ordinarie
(ridimensiona il potere legislativo e di conseguenza esecutivo, il cui esercizio non costituisce un
potere assoluto, ma assoggettato alla Costituzione).
Il principio democratico
Il principio democratico si fonda sul primo e secondo comma dell’art. 1:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
E sull’art. 49: “Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Il cuore del principio è che la sovranità appartiene al popolo e quindi la sovranità popolare
rappresenta la fonte del potere politico. Tuttavia, non significa che la sovranità popolare sia
onnipotente, perché deve essere esercitata secondo le forme e i limiti della Costituzione (secondo
comma).
Il principio democratico postula la democrazia rappresentativa, temperata dall’unica forma di
democrazia diretta ammessa nel nostro ordinamento: il referendum abrogativo (art. 75).
Potrebbero piacerti anche
- Sfida Ai Dirigenti Della TelevisioneDocumento1 paginaSfida Ai Dirigenti Della Televisioneapi-358184037Nessuna valutazione finora
- Grido Ad ManghinotDocumento176 pagineGrido Ad ManghinotEnrico GalavottiNessuna valutazione finora
- Lettere Di Condannati A Morte Della Resistenza ItalianaDocumento27 pagineLettere Di Condannati A Morte Della Resistenza ItalianagabrielakvacekNessuna valutazione finora
- Giuseppe Perri Stato D'eccezioneDocumento113 pagineGiuseppe Perri Stato D'eccezioneRoberto GalloNessuna valutazione finora
- Pasolini e Il Ptere Della Lingua PDFDocumento22 paginePasolini e Il Ptere Della Lingua PDFDiego BentivegnaNessuna valutazione finora
- Nicoletta Stradi: Servizio Sociale Storia ScuoleDocumento14 pagineNicoletta Stradi: Servizio Sociale Storia ScuoleFulvia AntonelliNessuna valutazione finora
- Modelli Letterari Russo-Sovietici Del Romanzo Neorealista - Pavese, Calvino e Viganò PDFDocumento620 pagineModelli Letterari Russo-Sovietici Del Romanzo Neorealista - Pavese, Calvino e Viganò PDFKit MarloweNessuna valutazione finora
- Ducato Speciale GuerraDocumento16 pagineDucato Speciale GuerraIl DucatoNessuna valutazione finora
- Le Età Delle Costituzioni Relazioni D.P .P0020Documento24 pagineLe Età Delle Costituzioni Relazioni D.P .P0020Giuseppe CiardulloNessuna valutazione finora
- Delle Vedove La Donna Nel Fascismo Tra Segregazione e MobilitazioneDocumento151 pagineDelle Vedove La Donna Nel Fascismo Tra Segregazione e Mobilitazionespidoskizzo100% (1)
- Mirco CasalecchioDocumento92 pagineMirco CasalecchiovecchiohenryNessuna valutazione finora
- Storia Del Diritto Penale e Della GiustiziaDocumento24 pagineStoria Del Diritto Penale e Della GiustiziaFederica Lorenza PerpignanoNessuna valutazione finora
- Fascismo PDFDocumento2 pagineFascismo PDFAllande Francesco de AngelisNessuna valutazione finora
- Storia 5amDocumento12 pagineStoria 5ammusicNessuna valutazione finora
- Notiziario ANPI Chioggia n.74Documento11 pagineNotiziario ANPI Chioggia n.74Enrico VeroneseNessuna valutazione finora
- Bottai I.pochi.e.i.molti (1924) (Democrazia)Documento3 pagineBottai I.pochi.e.i.molti (1924) (Democrazia)Franco Savarino RoggeroNessuna valutazione finora
- NATTA-la Scissione Di LivornoDocumento6 pagineNATTA-la Scissione Di LivornopaoloercoliNessuna valutazione finora
- Esde09 PDFDocumento357 pagineEsde09 PDFMonica MoresiNessuna valutazione finora
- Julius Evola: Sintesi Di Dottrina Della RazzaDocumento105 pagineJulius Evola: Sintesi Di Dottrina Della RazzaVittorio Fincati100% (3)
- STRATEGIATENSIONEdocumento DSDocumento125 pagineSTRATEGIATENSIONEdocumento DScosimo81Nessuna valutazione finora
- Vintila Horia, L'esule Che Fece Di Ovidio Un Eroe ModernoDocumento1 paginaVintila Horia, L'esule Che Fece Di Ovidio Un Eroe ModernoAlberto SamonàNessuna valutazione finora
- Seconda Guerra MondialeDocumento6 pagineSeconda Guerra MondialeChiara FrisciaNessuna valutazione finora
- GentileDocumento10 pagineGentilepipu789Nessuna valutazione finora
- Domande Storia Per EsameDocumento11 pagineDomande Storia Per EsameAli BelhaylaNessuna valutazione finora
- Conoscerli Per Isolarli PDFDocumento40 pagineConoscerli Per Isolarli PDFRioken NakanoNessuna valutazione finora
- Lastoriabambina PDFDocumento188 pagineLastoriabambina PDFRaymundo TNessuna valutazione finora
- Lezione Storia 10032023Documento2 pagineLezione Storia 10032023ANTON ANDREA MOSCATELLINessuna valutazione finora
- Ricerche Storiche 2006Documento216 pagineRicerche Storiche 2006margheritinaNessuna valutazione finora
- FERROL - 1936 (Julio Sas I Tomás Fuentes) PDFDocumento99 pagineFERROL - 1936 (Julio Sas I Tomás Fuentes) PDFBiblioteca Municipal Son GotleuNessuna valutazione finora
- Giuseppe Bottai, Fascista PDFDocumento314 pagineGiuseppe Bottai, Fascista PDFὈδυσσεύς ΟὐδείςNessuna valutazione finora
- Psicologia Oscura: Scopri come analizzare le persone e padroneggiare la manipolazione umana utilizzando i segreti del linguaggio del corpo, la PNL sottile, il controllo mentale, la persuasione subliminale, l'ipnosi e le tecniche di lettura veloce.Da EverandPsicologia Oscura: Scopri come analizzare le persone e padroneggiare la manipolazione umana utilizzando i segreti del linguaggio del corpo, la PNL sottile, il controllo mentale, la persuasione subliminale, l'ipnosi e le tecniche di lettura veloce.Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (6)
- Manipolazione: Padroneggia tecniche di persuasione altamente efficaci, controllo mentale e influenza emotiva utilizzando la psicologia oscura, come analizzare le persone, il linguaggio del corpo, i segreti della PNL e dell'ipnosi!Da EverandManipolazione: Padroneggia tecniche di persuasione altamente efficaci, controllo mentale e influenza emotiva utilizzando la psicologia oscura, come analizzare le persone, il linguaggio del corpo, i segreti della PNL e dell'ipnosi!Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (4)
- Miti, storie e leggende: I misteri della genesi dal Caos a BabeleDa EverandMiti, storie e leggende: I misteri della genesi dal Caos a BabeleNessuna valutazione finora
- Emma la regina del Chapo e le altre signore del NarcotrafficoDa EverandEmma la regina del Chapo e le altre signore del NarcotrafficoValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Sostenibilità digitale: Perchè la sostenibilità non può prescindere dalla trasformazione digitaleDa EverandSostenibilità digitale: Perchè la sostenibilità non può prescindere dalla trasformazione digitaleNessuna valutazione finora
- Apprendimento e competenze nelle metodologie didattiche innovative: i laboratori inclusivi: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-4/2021Da EverandApprendimento e competenze nelle metodologie didattiche innovative: i laboratori inclusivi: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-4/2021Nessuna valutazione finora
- Worlds Beyond The Poles: Physical Continuity Of The UniverseDa EverandWorlds Beyond The Poles: Physical Continuity Of The UniverseNessuna valutazione finora
- L'Assurdità dei Sacrifici. Elogio della spesa pubblicaDa EverandL'Assurdità dei Sacrifici. Elogio della spesa pubblicaNessuna valutazione finora
- Concorsi pubblici - La redazione di un atto amministrativo: Per la preparazione alla prova scrittaDa EverandConcorsi pubblici - La redazione di un atto amministrativo: Per la preparazione alla prova scrittaNessuna valutazione finora
- Riassunto di Economia Politica: Sintesi e Ripasso per Superare l'Esame UniversitarioDa EverandRiassunto di Economia Politica: Sintesi e Ripasso per Superare l'Esame UniversitarioNessuna valutazione finora
- Sabbia sugli dèi: Pratiche commemorative tra le Tigri tamil (Sri Lanka)Da EverandSabbia sugli dèi: Pratiche commemorative tra le Tigri tamil (Sri Lanka)Nessuna valutazione finora