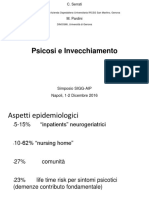Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Gli Antipsicotici Atipici Nei Disturbi Gravi Di Personalita'
Caricato da
Kreshnik IdrizajTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Gli Antipsicotici Atipici Nei Disturbi Gravi Di Personalita'
Caricato da
Kreshnik IdrizajCopyright:
Formati disponibili
Gli antipsicotici atipici nei disturbi gravi di personalita'
Dr. Pierpaolo Di Giuseppe
Dirigente medico psichiatra CSM Poggio Mirteto – ASL Rieti
I disturbi gravi di personalità e il disturbo borderline in particolare, presentano molto spesso difficoltà di
trattamento, sia in campo psicologico che farmacologico.
La farmacoterapia viene molto spesso utilizzata nei disturbi borderline e nella maggior parte dei casi consiste
nella associazione di più molecole.
I farmaci di prima scelta sono tradizionalmente i serotonergici e gli stabilizzanti dell'umore, come indicato
anche dalle linee guida della APA, ma è anche frequente l'uso degli antipsicotici tradizionali. Nel corso degli
ultimi anni gli studi esistenti in letteratura sui neurolettici nel BDP indicano una risposta scarsa e una bassa
compliance dovuta alla particolare incidenza dei sintomi sedativi ed extrapiramidali in questi soggetti.
Le quattro dimensioni principali della sintomatologia borderline riguardano l’affettività, i disturbi cognitivi
positivi (esperienze dissociative, paranoia, episodi psicotici transitori), impulsività e instabilità delle relazioni
interpersonali. I farmaci neurolettici, secondo diversi lavori riportati in letteratura, mostrano discreti risultati
solo sulla dimensione dei sintomi psicotici positivi. Le altre dimensioni spesso non migliorano ed in alcuni casi
possono aggravarsi.
Gli antipsicotici atipici, rispetto ai precedenti, mostrano una maggiore attività di blocco postsinaptico dei
recettori serotonergici, una diversa intensità di blocco dei recettori D1 e D2 e un blocco dopaminergico
prevalentemente operante nel territorio mesolimbico.
Gli studi sugli antipsicotici atipici nel disturbo borderline di personalità al momento sono pochi e non ancora
condotti su grandi numeri, ma dalla revisione della letteratura esistente sembrano emergere diversi vantaggi:
L’attività di blocco serotonergico post sinaptico permette un controllo dei sintomi affettivi quali irritabilità,
disforia, depressione
L’azione dopaminergica prevalente sul territorio mesolimbico, con scarso interessamento della aree prefrontali,
nigro striatali e tubero infundibolari permette di limitare l’appiattimento affettivo, i sintomi extramidali ed
endocrini. Viene comunque ottenuta una azione sui sintomi cognitivi sovrapponibile ai neurolettici.
Alcuni recenti studi relativi al trattamento dei pazienti schizofrenici hanno evidenziato il miglioramento della
consapevolezza di malattia indipendentemente dalla presenza di sintomi psicotici. Se tale effetto fosse
dimostrabile anche nei pazienti del cluster B, potrebbe portare ad un ulteriore facilitazione della cura spesso
compromessa dallo scarso insight.
Nella seguente revisione dei lavori esistenti in letteratura sui singoli antipsicotici atipici non sono stati presi in
considerazione gli studi sulla clozapina, di cui esiste una efficacia evidente, ma limitata dalla gravità dei
possibili effetti collaterali. Sono inoltre stati esclusi i single case.
QUETIAPINA: Il profilo recettoriale della molecola è caratterizzato dalla alta affinità ai recettori alfa1, H1 e
dalla relativamente bassa affinità ai recettori 5HT1a 5HT2a, M1, D2
Dose Scale non Effetti
Autori Pubblicaz. Placebo Studio Campione Scale migliorate
media migliorate collaterali
Progr.in
Perrella, neuro Depressione, ostilità, Transitoria
Open 14 femm,
Schifan psychoph.an No 540 sospettosità, trombocitopenia,
label 9 maschi
o d biol psych. funzionamento lieve sedaz.
2007
Globale,Impulsività,
Bellino, J. Clin. Open 6 femm, Relaz interpers, Sonnolenza,
No 309 aggressività,
Bogetto Psych. 2006 label 5 maschi autolesionismo, xerost., vertigini
psicoticismo, ansia
Impulsività, ostilità,
Villeneu
J. Clin. Open 25 femm, depressione, ansia, Sentimenti di
ve, No 251 Aumento di 2kg
Psych. 2005 label 9 maschi funzionamento inaiutabilità
Lemelin
sociale
World j.
Hilger, Open Impulsività,
Biol. Psych. No 2 femmine 600
Kasper label funzionamento
2003
OLANZAPINA: Il profilo recettoriale della molecola è caratterizzato dalla alta affinità ai recettori M1, H1,
5HT2a, 5HT2c e dalla relativamente bassa affinità D2 e ALFA1
Dose Scale Scale non Effetti
Autori Pubblicaz. Confronto Studio Campione
media migliorate migliorate collaterali
Miglior. Glob,
Psicoticis.,
Shulz, Open 9 femm, Aumento
Biol. Psych. 1999 7,7 depress, relaz
Jesberger label 2 maschi di peso
interp.,
impuls., rabbia
Rapporti inst.,
Zanarini, J. Clin. Psych. Double Femmine, Aumento
Placebo 5,33 ansia, aggress, Depressione
Frankenburg 2001 blind 19 + 9 di peso
paranoia
Human Depress, ansia,
Zullino, Open 8 uomini, Aumento
Psichopharmacol. 11,2 impulsività,
Stigler et al. label 2 femmine di peso
2002 aggressività
Comb migliore
Fluo
Olanzap vs 14 fluo, su disf e Aumento
Zanarini, J. Clin. Psych. Open 15
fluoxet vs 16 olanz, impul, olan di peso con
Parachini 2004 label Olanz.
combinazione 15 comb migliore su olanz.
3,3
depress
Miglioramento
Aggressività,
Bogenschutz, J. Clin. Psych. Double 25 femm, globale Aumento
placebo 6,9 ansia, depress.
Nurnberg 2004 blind 15 mas. significativo di peso
Non signific
dalla 4 settim
Globali,
Aumento
Am. J. of Psych. Double 25 femm, Depres, Ansia, Autolesionismo
Soler, Perez Placebo 8,8 di peso e di
2005 blind 15 maschi impulsiv, non signif.
colesterolo
aggress.
Olanz. E
Pascual, Pharmacopsych. Open
Ziprasidone 20 Agitazione
Perez 2006 label
i.m. in P.S.
Arch Iran Med Open Apparente
Shoja, Shafti 20
2006 label miglioramento
25 tra
Gen Hosp Psych. Olanzap. I.m. Open 10mg
Damsa, Allen femm e Agitazione
2007 in P.S. label i.m.
maschi
RISPERIDONE: Il profilo recettoriale della molecola è caratterizzato dalla alta affinità ai recettori 5HT2a,
Alfa1, D2 e dalla relativamente bassa affinità 5HT2c e H1
Dose Scale non Effetti
Autori Pubblicaz. Placebo Studio Campione Scale migliorate
media migliorate collaterali
27 tra Sensib.interpers.,
Shulz, Schizophrenia Double
Si maschi e psicotic,aggressiv.,
Jesberger research 1999 blind
femm. sospettos.
Lievi:
Globale, insonnia,
Rocca, J. Clin. Psych. Open 9 uomini,
No 3,2 Aggressività, Psicoticismo agitazione,
Bogetto 2002 label 6 femmine
depress. ansia,
cefalea
Risp
European Risperidone 36 tra
Cvjetkovic, Open 1mg Globali,
Neuropsychoph. vs maschi e
Zaric label Flufen depressione
2005 flufenazina femmine
2,5
ARIPIPRAZOLO: Il profilo recettoriale della molecola è caratterizzato dalla attività antagonistica e agonistica
parziale sui recettori D2, l'alta affinità di blocco 5HT2a e l'attività agonistica sui 5HT1a
Dose Scale Scale non Effetti
Autori Pubblicaz. Confronto Studio Campione
media migliorate migliorate collaterali
Mobascher, Pharmacopsych. Open Risult.
3 femm
Malevani 2006 label Incerti
Depress,
ansia, Cefalea,
21 femm, 5
Am. J. Psych. Placebo Double ossessioni, insonnia,
Nickel, Gil maschi, 26 15 Somatizzazioni
2006 controlled blind aggress, nausea,
placebo
fobie, stipsi, ansia
sospettosità
ZIPRASIDONE: Il profilo recettoriale della molecola è caratterizzato dal'agonismo 5HT1a e l'antagonismo
5HT2a - 5HT2c - 5HT1b - 5HT1d. Inoltre ha una attività di inibizione del reuptake di serotonina e
noradrenalina
Dose Scale Scale non Effetti
Autori Pubblicaz. Confronto Studio Campione
media migliorate migliorate collaterali
Pascual, Ziprasidone Open
J. Clin. Psych. 2004 9 - Agitazione
Soler i.m. in P.S. label
Olanz. E
Pascual, Pharmacopsych. Open
Ziprasidone 20 - Agitazione
Perez 2006 label
i.m. in P.S.
CONCLUSIONI: Tutti gli studi esistenti ad oggi indicano una buona efficacia degli atipici nel BDP, pur
avendo evidenti limitazioni relative a:
1) Scarso numero del campione,
2) Assenza del double blind e del confronto con placebo.
3) Mancano confronti diretti tra atipici, ssri e stabilizzanti.
4) Hanno tutti dosaggi flessibili, per cui non esistono strategie uniformi.
5) Hanno quasi tutti durata non superiore a 12 mesi.
6) I pazienti erano volontari, per cui i più gravi non erano inclusi.
7) Trattamenti psicologici e psicosociali contemporanei spesso non erano considerati.
Potrebbero piacerti anche
- QEEG NFB LocandinaDocumento2 pagineQEEG NFB LocandinaKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Ordine Bologna Rebecchi 19112016 ApplicazionedistrumentidivalutazionediesitoDocumento51 pagineOrdine Bologna Rebecchi 19112016 ApplicazionedistrumentidivalutazionediesitoKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Neuropsicologia Dei Lobi Frontali: Prof. Luigi Trojano, Dipartimento Di Psicologia, Seconda Università Di NapoliDocumento27 pagineNeuropsicologia Dei Lobi Frontali: Prof. Luigi Trojano, Dipartimento Di Psicologia, Seconda Università Di NapoliKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Manuale Di NeuropsicofarmacoterapiaDocumento537 pagineManuale Di NeuropsicofarmacoterapiaSamueleNessuna valutazione finora
- Lezione 3Documento27 pagineLezione 3Kreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Psichiatria Lezione 8 Prima Parte 15-04-2015Documento13 paginePsichiatria Lezione 8 Prima Parte 15-04-2015Kreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- 16 Di Berardino 30052013 1Documento49 pagine16 Di Berardino 30052013 1Kreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Elettroencefalografia Standard e Prove Di Attivazione.Documento33 pagineElettroencefalografia Standard e Prove Di Attivazione.Barbara PirasNessuna valutazione finora
- Sebastiani CBTDocumento53 pagineSebastiani CBTKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Demenza LiberDocumento68 pagineDemenza LiberKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Farmaci Antipsicotici: Ipotesi DopaminergicaDocumento18 pagineFarmaci Antipsicotici: Ipotesi DopaminergicaKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Farmaci Antipsicotici: Categoria Terapeutica Principi Attivi Orale E.V. I.M. AntipsicoticiDocumento9 pagineFarmaci Antipsicotici: Categoria Terapeutica Principi Attivi Orale E.V. I.M. AntipsicoticiKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- 000447645Documento8 pagine000447645Kreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- 000461443Documento7 pagine000461443Kreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Psichiatria Lezione 8 Prima Parte 15-04-2015Documento13 paginePsichiatria Lezione 8 Prima Parte 15-04-2015Kreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- La NeuropsicologiaDocumento22 pagineLa NeuropsicologiaKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- I Disturbi Dell'Umore: PsichiatriaDocumento14 pagineI Disturbi Dell'Umore: PsichiatriaKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Psichiatria Lezione 8 Prima Parte 15-04-2015Documento13 paginePsichiatria Lezione 8 Prima Parte 15-04-2015Kreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Spettro DepressivoDocumento10 pagineSpettro DepressivoKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Teorie e Tecniche Psicologia ClinicaDocumento117 pagineTeorie e Tecniche Psicologia ClinicaMilady Ugenia100% (1)
- La NeuropsicologiaDocumento22 pagineLa NeuropsicologiaKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- L'utilizzo Dei Test Per La Valutazione Del Funzionamento IntellettivoDocumento73 pagineL'utilizzo Dei Test Per La Valutazione Del Funzionamento IntellettivoKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- 969 Attestato Ecm IdrizajDocumento1 pagina969 Attestato Ecm IdrizajKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- 000461443Documento7 pagine000461443Kreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- L'utilizzo Dei Test Per La Valutazione Del Funzionamento IntellettivoDocumento73 pagineL'utilizzo Dei Test Per La Valutazione Del Funzionamento IntellettivoKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- 64 SerratiDocumento27 pagine64 SerratiKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Farmaci Antipsicotici: Ipotesi DopaminergicaDocumento18 pagineFarmaci Antipsicotici: Ipotesi DopaminergicaKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Disturbi PersonalitaDocumento72 pagineDisturbi PersonalitaKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Classificazione, Diagnosi Ed ICD-10. II - Le Sindromi SchizofrenicheDocumento14 pagineClassificazione, Diagnosi Ed ICD-10. II - Le Sindromi SchizofrenicheKreshnik IdrizajNessuna valutazione finora
- Possibili Interazioni Tra Succo Di Pompelmo e FarmaciDocumento3 paginePossibili Interazioni Tra Succo Di Pompelmo e FarmaciHeather PerryNessuna valutazione finora
- Lista MedicamenteDocumento213 pagineLista MedicamenteJason Chaney100% (1)
- Tramo P.O 7Documento15 pagineTramo P.O 7Carl Martin Lendio FusileroNessuna valutazione finora
- L'Acido Bempedoico Riduce Il Colesterolo Senza Influenzare Il Controllo GlicemicoDocumento3 pagineL'Acido Bempedoico Riduce Il Colesterolo Senza Influenzare Il Controllo Glicemicomedia4healthNessuna valutazione finora
- 16 - AntiulceraDocumento42 pagine16 - AntiulceraTeresa IlariaNessuna valutazione finora