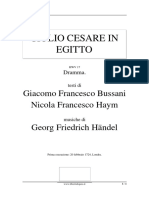Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Foscolo, Dei Sepolcri
Foscolo, Dei Sepolcri
Caricato da
infamissimo0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
8 visualizzazioni6 pagineTitolo originale
Foscolo, Dei sepolcri
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
8 visualizzazioni6 pagineFoscolo, Dei Sepolcri
Foscolo, Dei Sepolcri
Caricato da
infamissimoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 6
Dei sepolcri.
Carme di Ugo Foscolo
Dal punto di vista dell’appartenenza di genere, i Sepolcri sono un’epistola in
versi, che Foscolo indirizza all’amico Ippolito Pindemonte.
Chiamandola, con voce desueta, carme (il titolo nell’editio princeps, stampata a
Brescia da Niccolò Bettoni nel 1806, è Dei sepolcri. Carme di Ugo Foscolo) Foscolo
volle ripristinare il significato originario di questo termine (col quale nella tradizione
latina più antica erano designati inni di carattere rituale o propiziatorio) per indicare
una poesia solenne e celebrativa.
In questa forma, solenne e celebrativa, Foscolo intendeva cantare il tema delle
sepolture. La poesia sepolcrale, in voga in Europa dalla seconda metà del Settecento
e fino agli inizi dell’Ottocento, consisteva in meditazioni di carattere morale e
religioso sul tema della morte e delle tombe, e aveva diffuso il suo gusto anche in
Italia soprattutto grazie alle traduzioni dei Night thoughts di Edward Young, delle
Meditations among the tombs di James Hervey e dell’Elegy written in a Country
Churchyard di Thomas Gray. Tuttavia non è in questo solco che si innesta
l’esperimento foscoliano.
Nella Lettera a Monsieur Guillon, nella quale replicava al letterato francese che in
una recensione aspramente critica dei Sepolcri comparsa sul «Giornale italiano»
aveva toccato anche il punto del confronto con i poeti sepolcrali inglesi, Foscolo
scriveva:
«Per censurare i mezzi d’un libro bisogna saperne lo scopo. Young ed Hervey
meditarono sui sepolcri da cristiani: i loro libri hanno per iscopo la rassegnazione alla
morte e il conforto d’un'altra vita; [...] Gray scrisse da filosofo; e la sua elegia ha per
iscopo di persuadere l’oscurità della vita e la tranquillità della morte; [...] L’autore
[Foscolo] considera i sepolcri politicamente; ed ha per iscopo di animare
l’emulazione politica degli italiani con gli esempi delle nazioni che onorano la
memoria e i sepolcri degli uomini grandi: però [perciò] dovea [...] predicare non la
resurrezione de’ corpi, ma delle virtù».
Nel carme, dunque, i sepolcri sono considerati nella loro funzione politica di
monumenti che, tenendo vivo il culto delle virtù degli «uomini grandi», instaurano e
tramandano la memoria collettiva della nazione. Culto e memoria che Foscolo vuole
suscitare in primo luogo negli italiani.
Questo intento altamente civile è perseguito secondo una modalità che Foscolo
afferma di avere desunto dal modo di fare poesia dei Greci:
«Ho desunto questo modo di poesia da’ Greci i quali dalle antiche tradizioni
traevano sentenze morali e politiche presentandole non al sillogismo de’ lettori, ma
alla fantasia e al cuore».
In questa frase (che apre le note da lui apposte al testo) è condensata la poetica che
guida Foscolo nella stesura dei Sepolcri, poetica che è l’approdo di una riflessione
condotta a partire dal 1803, quando, chiusa con la pubblicazione della raccolta delle
Poesie la stagione dell’effusione lirica del proprio io, si era dedicato a un complesso
lavoro su Lucrezio, rimasto incompiuto, e alla traduzione e commento della Chioma
di Berenice, il poemetto di Callimaco, noto attraverso la versione latina di Catullo.
Nei quattro discorsi intorno all’origine e al senso della poesia che Foscolo affianca
alla traduzione della Chioma si profila l’idea che la poesia sia una delle istituzioni
costitutive del vivere associato, perché è capace di «accendere gli animi al valore, gli
uomini alla civiltà, le città all’indipendenza, gl’ingegni al vero ed al bello». Per
conseguire questo scopo, la poesia non deve essere ragionatrice e astratta, ma deve
prima colpire i sensi e poi l’intelletto. Gli antichi autori di poemi, infatti,
raggiungevano questo scopo raccontando storie avvincenti, e percuotendo le menti
col meraviglioso e il cuore con le passioni.
Quando Foscolo afferma di avere costruito i Sepolcri nel modo praticato dai Greci
intende rivendicare a se stesso il ruolo che aveva in antico il poeta: quello di custode
dei miti e delle tradizioni fondative delle civiltà, e di trasmettitore, in forme che
parlassero alla immaginazione e ai sentimenti, dei principi utili alla vita civile (le
«sentenze morali e politiche»).
Questa concezione della poesia presiede alla costruzione del carme, alla sua
tessitura, come la definisce l’autore nella lettera a Monsieur Guillon, indicando con
questa parola l’intreccio dei fili che collegano tra di loro le diverse sequenze. Al
critico francese, così come a molti altri lettori, erano infatti sembrati incomprensibili,
poco giustificati, i passaggi (le «transizioni») da un argomento all’altro.
La tessitura del carme si articola invece in un percorso che, come ancora spiegava
Foscolo nella lettera, conduce passo passo il lettore «da un principio affettuoso ad
una fine veemente». Cerchiamo di individuare le tappe di questo percorso,
segnalandone le «transizioni»:
1. (vv. 1-22): il carme si apre con due interrogazioni retoriche, con le quali il poeta
evidentemente si riallaccia ad un discorso avviato in precedenza con l’amico
Pindemonte: le tombe, confortate dal pianto di chi resta, rendono forse meno
doloroso il sonno eterno della morte? e che consolazione potrà darmi una pietra
sepolcrale che rechi il mio nome quando col cessare della vita saranno per me spenti
per sempre i piaceri dell’amicizia, della poesia, dell’amore? La legge della Natura
vuole che il tempo trionfi sul destino dell’individuo, che non è altro che materia
destinata a entrare nel circolo della perpetua trasformazione che investe tutte le
reliquie.
2. (vv. 23-50): la transizione è introdotta dalla particella fortemente avversativa
Ma: «Ma perché l’uomo dovrebbe privarsi, anticipando l’azione devastatrice del
tempo, dell’illusione che lo trattiene sulla soglia del regno dei morti?». Dalla
considerazione della legge della Natura, che non consente alcuno scampo, si passa
così all’affermazione della legittimità psicologica dell’illusione, coltivata a livello
privato: illusione di una sopravvivenza intesa come rapporto che continua a sussistere
tra il defunto e i suoi cari viventi. Per potersi realizzare, questa illusione ha bisogno
della tomba, collocata nella terra natale, che accolga maternamente le spoglie e le
preservi dall’azione insultante delle intemperie e dal calpestio profanatorio degli
sconosciuti; una tomba che rechi il nome del defunto e che sia posta al riparo di un
albero che ne consoli le ceneri col profumo dei suoi fiori e con la sua ombra.
Tuttavia questa funzione consolatoria del sepolcro può esplicarsi solo a condizione
che chi muore lasci un’eredità di affetti. La tomba di un uomo malvagio è inutile.
Senza corrispondenza d’amorosi affetti, intorno alla sua tomba c’è solo terreno
incolto e selvaggio. E nessuno raccoglie il sospiro di richiamo che la Natura (stavolta
la natura benefica che reclama l’attenzione da parte dei vivi) lascia affiorare dal
tumulo.
3. (vv. 51-90): «Pur nuova legge»: Eppure una nuova legge... La particella
avversativa, che introduce la nuova transizione, pone in antitesi il termine Natura, sul
quale si era chiuso il quadro precedente, col termine «nuova legge», con il quale
Foscolo allude al decreto di Saint Cloud, già applicato in Francia e da poco introdotto
in Italia, che proibiva, per ragioni igieniche, il seppellimento dei cadaveri nelle zone
urbane e prescriveva che le lapidi fossero addossate alle mura di cinta dei cimiteri
anziché essere poste sopra il luogo dove era seppellito il defunto: ciò allo scopo di
lasciare il terreno libero per ulteriori inumazioni. Foscolo deplora questo istituto che
contrasta con le ragioni profonde, antropologiche, che presiedono al culto dei morti, e
porta a esempio il caso di Parini, che, sepolto secondo le nuove disposizioni, non ha
una tomba che lo renda riconoscibile e distingua la sua identità di uomo moralmente
e civilmente integerrimo, preservandolo dal possibile contatto con il corpo di un
qualsiasi ladro mandato al patibolo. Alla descrizione di questo genere di cimiteri,
abbandonati alla dimenticanza dei vivi, sono dedicati i vv. 77 e seguenti («Senti
raspar fra le macerie...»), nei quali si accampano scene macabre, immagini di un
mondo non rischiarato da quel sentimento di pietà che ai morti è dovuto.
4. (v. 91-150): in questa sezione del carme la prospettiva nella quale è inquadrato il
tema si allarga alla dimensione sociale e storica del rito della sepoltura.
Rifacendosi al pensiero di Giambattista Vico, Foscolo ricorda come l’instaurarsi
del culto dei morti sia, insieme all’istituzione del matrimonio, delle leggi e della
religione, un principio fondativo del patto sociale: uno dei fenomeni che segnano il
superamento dello stato ferino, nel quale i cadaveri restavano insepolti, abbandonati
alle fiere e alla legge naturale che, con moto incessante, dissolve e trasforma la
materia.
A partire dal v. 104 Foscolo passa poi in rassegna vari tipi di sepolture,
polemizzando in primo luogo (vv. 104-114) contro quelle forme di culto cristiane che
presentavano la morte unicamente in aspetto lugubre e spaventoso, e ad esse
contrappone le tradizioni funebri pagane (vv. 114-129) nelle quali predomina un
senso di serenità: la tomba è collocata al centro di un locus amoenus simboleggiante
l’idea della vita che rinasce dalla morte (dalla «funebre zolla» sbocciano» amaranti e
viole»), e intorno ad essa gli amici del defunto compiono gesti rituali di purificazione,
di compassione e di accompagnamento. La stessa «pietosa insania» (vv. 130-136),
(ovvero: follia dettata da pietà, illusione indotta dall’affetto provato per i defunti)
guida le giovani britanne nei camposanti delle periferie cittadine per pregare sulla
tomba delle loro madri defunte, in quegli stessi luoghi dove hanno pregato anche per
il ritorno dell’ammiraglio Nelson (che si era fatto scavare la bara dell’albero della
nave da lui vinta in battaglia).
La descrizione della realtà inglese, dove i sentimenti privati e quelli pubblici si
fondono tra di loro, spinge Foscolo a paragonarla con quella della Lombardia del suo
tempo. Il passo è di nuovo introdotto da un Ma fortemente avversativo: «Ma ove
dorme il furor d’inclite gesta...» (vv. 137-145): laddove, come a Milano, sia spenta la
volontà di compiere gesta eroiche, i monumenti funebri sono inutili. Alludendo ai tre
collegi elettorali («il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo») istituiti da Napoleone,
Foscolo prende le distanze dalla classe dirigente del regime, che, immersa
nell’adulazione, è già morta vivendo. Chiede quindi per sé pace e serenità dopo la
morte, quella pace e serenità che il destino non gli ha concesso in vita, e dichiara di
lasciare in eredità agli amici non ricchezze, ma affetti autentici e l’esempio di una
poesia libera (vv. 145-150). I Sepolcri sono appunto il «liberal carme» cui Foscolo
affida la memoria del suo nome.
5. (vv. 151-225): prende avvio con questi versi famosi («A egregie cose...») la
transizione al tema delle tombe dei grandi uomini («l’urne de’ forti»). La ripetizione
enfatica di forte («il forte animo ... l’urne de’ forti»), la ripresa del vocativo («o
Pindemonte») e la collocazione del verbo («accendono») in clausola conferiscono a
questi versi una marcata intonazione solenne, che ben si addice alla volontà di
configurare una religione civile, nella quale si celebrano «l’itale glorie» raccolte in un
«tempio»: la chiesa di Santa Croce a Firenze, che accoglie le spoglie Nicolò
Machiavelli, di Michelangelo e di Galileo Galilei, e che è ospitata nella città in cui
Dante compose i primi versi della Commedia, la stessa città che diede a Petrarca i
genitori, e la lingua con la quale cantò l’amore verecondo. Il tempio dell’itale glorie
costudisce l’unica ricchezza, la memoria, cui la nazione può ancora attingere, dopo
che è stata depredata di tutto dagli stranieri. Cosicché, quando alcuni spiriti
coraggiosi si accenderanno di desiderio di gloria e estenderanno questo desiderio a
tutto il popolo italiano («ove speme di gloria agli animosi / intelletti rifulga ed
all’Italia»), proprio da qui («quindi») [noi italiani] trarremo gli auspici. Trarre gli
auspici significa compiere un rito sacro di divinazione del futuro. In questo caso:
trarre esempio e ispirazione per il proprio futuro riscatto politico e morale. Segue
l’esempio di Alfieri, che adirato contro gli dei protettori della patria per non averla
difesa, trovava nei morti di Santa Croce, e non tra i suoi contemporanei, i propri
interlocutori. Alfieri è per Foscolo il “maestro di Libertà»”: il poeta civile, la cui
missione è quella di tenere viva la memoria del passato per fondare su di essa la
speranza nel futuro (speranza che infatti si affaccia sul volto del poeta vicino a morte:
«e avea sul volto / il pallor della morte e la speranza»). Le sue ossa, ora accolte
anch’esse in Santa Croce, «fremono amor di patria». Da questa affermazione, con una
repentina transizione, Foscolo collega idealmente la memoria dei grandi Italiani alla
memoria degli eroi Greci morti a Maratona per difendere la patria dai Persiani
invasori.
Lo spostamento nello scenario greco prepara l’epilogo del carme, avviandolo verso
la «fine veemente» di cui il poeta parlava a Monsieur Guillon. Nella parte conclusiva
dei Sepolcri il centro della rappresentazione sarà occupato dal racconto di miti. I miti
sono quelle favole allegoriche nelle quali i poeti antichi, a cominciare da Omero,
avevano depositato i principi fondamentali della politica e della morale sui quali si
fondano le società umane. Come aveva scritto Giambattista Vico, «dentro le favole
com’in embrioni o matrici si è discoverto essere stato abbozzato tutto il sapere
risposto». A questo assunto si rifà Foscolo quando afferma che la poesia ha lo scopo
di trasmettere, attraverso il linguaggio della fantasia e del cuore, «sentenze morali e
politiche».
Al ricordo indelebile della battaglia di Maratona segue l’esempio di Aiace, vittima
della frode di Ulisse, al quale gli dei resero giustizia postuma, trasportando sulla sua
tomba le armi di Achille che gli spettavano; episodio che conferma come il sepolcro
possa essere anche lo strumento di un risarcimento dell’ingiustizia patita in vita: «a’
generosi / giusta di glorie dispensiera è morte».
6. (vv. 226-295): la transizione si apre con E me, da porre in relazione oppositiva
con Felice te del v. 213, con il quale il poeta si era nuovamente rivolto a Pindemonte.
E me rimarca l’antitesi tra il destino dei due amici, che per Foscolo è contrassegnato
dall’«ir fuggitivo»: mentre le peregrinazioni per mare di Ippolito sono state per lui
occasione di conoscenza, i viaggi di Foscolo sono stati sempre una fuga forzata, nel
contesto di una vita di esilio e di dolore (più volte esibita nei sonetti). A partire da
questa condizione, Foscolo si pone sulla scia dei poeti antichi e si candida a
riprenderne il ruolo di celebratore degli eroi («me ad evocar gli eroi chiamin le
Muse»).
Le Muse sono le custodi dei sepolcri. Si oppongono alla legge del tempo, che
distrugge inesorabilmente la materia. La loro voce continua a risuonare anche
laddove il tempo ha spazzato via le rovine e fatto il deserto dove sorgevano i
monumenti funebri. La loro voce è immortale. La poesia trasmette il racconto della
vicenda della morte di Elettra, al cui corpo e alla cui tomba Giove accorda la propria
protezione. La tomba di Elettra diventa il luogo sacro intorno al quale si raccolgono
gli antichi eroi: da Dardano a Erittonio a Ilo. Davanti a quella tomba Cassandra
predice ai giovani Troiani il loro destino futuro.
Tutta la parte conclusiva del carme (vv. 263-295) è costituita dalla solenne
profezia di Cassandra: Troia sarà distrutta, ma «i Penati di Troia avranno stanza in
queste tombe». Le tombe conserveranno i numi protettori della patria, e un giorno
racconteranno la storia di «Ilio raso due volte e due risorto / splendidamente su le
mute vie» (Troia, prima di essere rasa al suolo dagli Achei, fu distrutta da Ercole). E
sarà Omero, venuto in queste stanze funebri ad abbracciare le urne, instaurando con
esse un affettuoso colloquio, a rendere eterni, «col canto», i prìncipi greci («i prenci
argivi») in tutti i luoghi della terra («per quante / abbraccia terre il gran padre
Oceàno»). Ma non soltanto i vincitori saranno ricordati per sempre. Anche Ettore,
uno sconfitto, avrà «onore di pianti», laddove («ove») il sangue versato per la patria
continuerà ad essere considerato sacro e degno di lacrime («santo e lagrimato»), e
finché il sole risplenderà sulle sciagure umane.
La chiusa del discorso di Cassandra, che si fa voce di Foscolo, è pessimistica: la
memoria di Ettore vivrà solo laddove l’amor di patria, benché sconfitto dalla storia,
sia considerato un valore; questa affermazione si inserisce nel quadro più ampio di
una visione cosmica, in cui il sole, simbolo del principio vitale che anima il mondo,
appare indifferente verso le dolorose vicende umane.
[Dall’amor di patria e di libertà di Foscolo a quello di oggi, 25 aprile 2020]
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto FoscoloDocumento4 pagineRiassunto FoscoloGiordano Dal Bon100% (1)
- Carry On Versione Italiana I - Rainbow RowellDocumento414 pagineCarry On Versione Italiana I - Rainbow RowellClaudio Stefania Scassacocchie80% (5)
- Favola Del PiacereDocumento4 pagineFavola Del PiacereinfamissimoNessuna valutazione finora
- Ultimo Canto Di SaffoDocumento4 pagineUltimo Canto Di SaffoinfamissimoNessuna valutazione finora
- Sogni, e FavoleDocumento2 pagineSogni, e FavoleinfamissimoNessuna valutazione finora
- Promessi Sposi, XXXVIIIDocumento4 paginePromessi Sposi, XXXVIIIinfamissimoNessuna valutazione finora
- Aida Finale Atto IIDocumento1 paginaAida Finale Atto IIinfamissimoNessuna valutazione finora
- Principia Apocrypha ITADocumento32 paginePrincipia Apocrypha ITAinfamissimoNessuna valutazione finora
- Haendel - Giulio Cesare LibrettoDocumento48 pagineHaendel - Giulio Cesare LibrettoinfamissimoNessuna valutazione finora
- Guida Barcellona by UnknownDocumento19 pagineGuida Barcellona by UnknowninfamissimoNessuna valutazione finora
- 16 diariodiCelestePaoliDocumento23 pagine16 diariodiCelestePaoliinfamissimoNessuna valutazione finora
- Tolstimm Tolstimm 2021 07 23 ItDocumento2 pagineTolstimm Tolstimm 2021 07 23 ItinfamissimoNessuna valutazione finora
- BARTOCCINI Renato 1926. Le Antichità Della TripolitaniaDocumento49 pagineBARTOCCINI Renato 1926. Le Antichità Della TripolitaniaLuiz Alberto MarchioriNessuna valutazione finora
- Petronio - Matrona Di EfesoDocumento1 paginaPetronio - Matrona Di Efesoeliafuma03Nessuna valutazione finora
- L Arte Etrusca 1Documento7 pagineL Arte Etrusca 1Papa RobertoNessuna valutazione finora
- Ser Ciappelletto DecameronDocumento1 paginaSer Ciappelletto DecameronChiaraaa CerioniiiNessuna valutazione finora
- 2012 - Caere e Il Suo Territorio Lavori in Corso - CosentinoDocumento24 pagine2012 - Caere e Il Suo Territorio Lavori in Corso - CosentinopspacimbNessuna valutazione finora
- RICCI Sepulcrum Est Memoria Illius Limpiego Del Termine Memoria Negli Epitaffi Latini Di RomaDocumento45 pagineRICCI Sepulcrum Est Memoria Illius Limpiego Del Termine Memoria Negli Epitaffi Latini Di RomaPablo Varona RubioNessuna valutazione finora