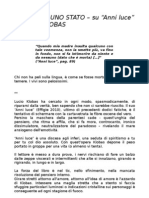Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Su Anni Luce Di Klobas
Caricato da
angelorendo0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
987 visualizzazioni4 pagineIntorno ad "Anni luce" (Effigie 2010) di Lucio Klobas
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
ODT, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoIntorno ad "Anni luce" (Effigie 2010) di Lucio Klobas
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
987 visualizzazioni4 pagineSu Anni Luce Di Klobas
Caricato da
angelorendoIntorno ad "Anni luce" (Effigie 2010) di Lucio Klobas
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 4
APOGEO DI UNO STATO – su “Anni luce”
di LUCIO KLOBAS
“Quando mia madre insulta qualcuno con
tale veemenza, non la smette più, va fino
in fondo, non si fa intimorire da niente e
da nessuno (dato che è morta) […]”
(“Anni luce”, pag. 89)
Chi non ha peli sulla lingua, è come se fosse morto, non ha nulla da
temere. I vivi sono pelosissimi.
**
Lucio Klobas ha cercato in ogni modo, spasmodicamente, di
ripararsi dalla verità, ben sapendo che non ci sarebbe riuscito. Il suo
“Anni luce” (Effigie 2010), ultimo di precedenti dodici fatiche, è il
tentativo di schermare con la cartavetrata le fibre oscene del vero.
Persino la maschera della parentesi cade - quest'unghia del
pensiero, che ritma e affila, che si fa mora, controcanto, ironico
dissimulatore, neutralizzatore del paradosso – rivelando il mare
ansiogeno dell'emotività.
“Anni luce” è una discesa agli inferi, una seduta di spiritismo a tu
per tu col dio assoluto. Con quest'opera Klobas depone il peso
portato in groppa per una vita (o almeno vi tenta).
Il lettore è messo a dura prova, i nervi rischiano di fare un balzo
dalle zeppe viscerali e intermittenti che alte si innalzano, girando e
rigirando, in lungo e in largo.
La forza del libro è nel tic, nello sfinimento, nella mancata
risoluzione del pensiero interno.
Girare stretti attorno all'amore, attorno all'idea di amore è l'azzardo
di Klobas. Intessere una maglia stretta che a stento si faccia
sfuggire particolari luminosi o indicazioni cristalline sui personaggi è
conseguente ad ogni stagione di fuoco.
Dal corpo a corpo con la fotografia – medium e traino dei
personaggi principali (padre e madre, madre e padre, fratello
gemello, cane e gatto) – quasi a volerne cavare oro, è evidente che
Klobas abbia elevato la verità (goffa inesperienza) sulle spalle della
tecnica (tecnicismo).
Il primo capitolo (La fotografia), che la descrizione della foto
contiene, è il negativo ed ha un andamento blando e fisso; (il
secondo, La fuga, assimilate le tensioni, prenderà la via della fuga).
La storia è intimissima, la scrittura una grata, procede per
accumulo, si gonfia e si sgonfia come un fiume che trascina massi e
sporco.
Per gradi infinitesimi si giunge allo svelamento nominale dei
personaggi; dalla foto, dalla carta, mano a mano i personaggi
saltano nella realtà, si fanno di carne, prendono forma.
Col rilievo di un modulo formulare - di una formularità interna al
testo, con nessi e frasi intere di raccordo che si presentano e si
ripresentano: una struttura ossessionata dall'ossessione -
giungiamo
“[...] chi parla da solo non invecchia mai.”
(pag. 66)
“In verità chi possiede un brandello di
memoria (uno qualsiasi) non sarà mai
solo (mi consolo).” (pag. 73)
nei pressi del centro. Verve, ironia e sarcasmo sostituiscono la
macchinazione (macchinosità) iniziale, il libro cerca di embricarsi al
lettore, fa pressione per entrare.
“I due giovani (giovanissimi) innamorati,
sono morti, cioè sono polvere sottile
smossa dall'aria calda, polvere circolare
senza peso, leggera, che a volte si
rovescia nel suo opposto.” (pag. 51)
Fra allusione e nascondimento compaiono i genitori (fantasmi,
zombie); mai hanno finito di volteggiare sopra il campo filiale, non
sono mai morti e zompano nel (sul) testo.
In tutti i modi l'autore-ologramma si sforza di tenerli a distanza e a
bada. Essi, invece, si avvicinano, così, da “i nostri vecchi
vecchissimi genitori” si passa a “i miei vecchi genitori”.
In questo centro, dal ghigno sarcastico, nel quale ci troviamo, il
visionario grande vacilla, e si lascia invadere dal reale smascherato.
“Quando mio padre si arrabbiava per
colpa del cane (ma non solo) gli si
gonfiavano le venuzze del naso e degli
occhi, il volto si contraeva e diventava
più piccolo di un terzo, le labbra
cambiavano posto, sembrava un'anguria
pallida e stenta, le mani parevano palette
di legno (pressappoco), mentre il corpo
dimagriva e si rifugiava in qualche buco
del pavimento.” (pp. 88 – 89)
Klobas intende annullare la propria origine, distruggerla, vanificarla
- tanto ne parla, e si prepara a mo' di cuneo nel massimo spazio
vuoto. Dall'amore all'odio, tanto ne parla e tanto li affossa, e quelli
risorgono - .
Gli stramorti vengono uccisi (riuccisi) nel loro inferno (nell'inferno di
tutti) in una trasfigurazione lisergica e abbandonata dei sentimenti.
Una forza rabbiosa, canina, trionfante nel finale, dilacerante; una
rabbia compressa, esplosa; e corpi dilaniati da una bomba: siamo
nell'oltremondo, fatto di apparizioni ribollenti, demoni al galoppo
senza palafreniere.
Il pre-finale – di questo libro di inquietudini lancinanti, d'orrore
psicologico, di filamenti putridi appiccicati su parole porose – fa
spazio ad “un grugnito malsano di evidente origine straziante” (pag.
127). Pace per i genitori non vi sarà, nemmeno da morti
(soprattutto da morti).
Il processo (capitolo sei) per questi “orribili predatori del nulla” (pag.
143) è il vero capitolo finale: rivelazione, goduria, empatia, forte
abbraccio all'autore e stretta di mano.
L'ultimo capitolo, Paesaggi, sarà innecessario; si corre il rischio che
la tela prima visionariamente tessuta si strappi.
Ma è certa una cosa. Dopo la convulsione (la frenesia) dei primi sei
capitoli, il pianto arriva a scioglimento, a risolvere. L'autore si
scioglie nel pianto, dice perdono per ciò che ha scritto. Questo lo
comprendiamo, tenta il volo, ma è richiamato al dovere dalla
gravità.
A nulla serve la giustificazione, a nulla la bellezza decadente, la
crudeltà mentale ha vigore forma persuasione.
Certo, la tensione accumulata e la fiamma del vero ritornano
indietro, e squagliano la neve, il ghiaccio.
Pare stare a sé, sta a sé, quest'ultimo capitolo: è un bimbo al
freddo, tenero, lirico; la prosa si distende, acquista la sua più intima
marca, la poesia.
“Nei paesaggi vuoti e inesistenti non si
scorge nulla che indichi qualcosa, e ciò
lascia sommamente interdetti, sorpresi e
meravigliati, increduli. Si resta come si è,
né più né meno, più poveri di prima
certamente.” (pag. 153)
**
Lucio Klobas possiede lo scettro della profondità e sua retorica.
La poesia rende più edibile la morte.
L'intensità del falso finale (Paesaggi) smangia la grana cinica e,
abbiamo detto, scartavetrante del romanzo.
A volte la decadenza, l'autocompiacimento e il vittimismo non sono
altro che l'apogeo di uno stato.
Potrebbero piacerti anche
- Rimedi Per La Salvezza-3Documento1 paginaRimedi Per La Salvezza-3angelorendoNessuna valutazione finora
- Orazio, Satira 1, 8Documento2 pagineOrazio, Satira 1, 8angelorendoNessuna valutazione finora
- Inno Omerico Ad Ermes, IV, 1-67Documento4 pagineInno Omerico Ad Ermes, IV, 1-67angelorendoNessuna valutazione finora
- Inno Omerico Ad Ermes, IV, 68-183Documento3 pagineInno Omerico Ad Ermes, IV, 68-183angelorendoNessuna valutazione finora
- Inno Omerico Ad Ermes, IV, 68-183Documento3 pagineInno Omerico Ad Ermes, IV, 68-183angelorendoNessuna valutazione finora
- Inno Ermes IIDocumento3 pagineInno Ermes IIangelorendoNessuna valutazione finora
- Su Anni Luce Di KlobasDocumento4 pagineSu Anni Luce Di KlobasangelorendoNessuna valutazione finora
- La Fabbrica Del VentoDocumento9 pagineLa Fabbrica Del VentoangelorendoNessuna valutazione finora
- Canti Invocando Lo Spirito SantoDocumento4 pagineCanti Invocando Lo Spirito SantotontonscalaNessuna valutazione finora
- Gli Dei RomaniDocumento16 pagineGli Dei RomanideligaNessuna valutazione finora
- Regolazione Impianti Con Turbine A Gas-1Documento47 pagineRegolazione Impianti Con Turbine A Gas-1AlCoganNessuna valutazione finora
- Interruttori Basculanti MinDocumento136 pagineInterruttori Basculanti MinKaran Bir SinghNessuna valutazione finora
- Bacone, FilosofiaDocumento4 pagineBacone, FilosofiaErika Capponi BrunettiNessuna valutazione finora
- Susanna Casciani Meglio Soffrire Che Mettere in Un Ripostiglio Il Cuore PDFDocumento208 pagineSusanna Casciani Meglio Soffrire Che Mettere in Un Ripostiglio Il Cuore PDFSignoraLatoLuminosoNessuna valutazione finora
- Farmaci Prima o Dopo I PastiDocumento6 pagineFarmaci Prima o Dopo I Pastixdagoopass100% (1)
- Ritorno VenosoDocumento31 pagineRitorno VenosoFrancesco LucianiNessuna valutazione finora
- TESI - Analisi Modale Sperimentale Per La Validazione Del Modello FEM Di Una Pompa A PaletteDocumento102 pagineTESI - Analisi Modale Sperimentale Per La Validazione Del Modello FEM Di Una Pompa A Paletteseve75Nessuna valutazione finora
- Autoliberazione in DzogchenDocumento29 pagineAutoliberazione in Dzogchenapi-3834672100% (1)