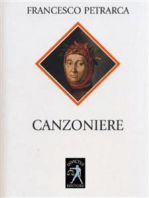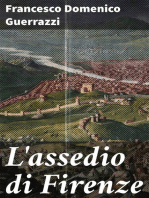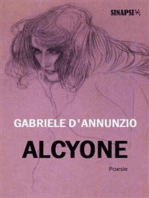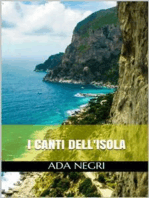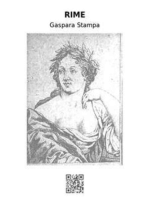Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Poesie Italiano 2020-2021
Caricato da
Maria Salvo0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
158 visualizzazioni11 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
158 visualizzazioni11 paginePoesie Italiano 2020-2021
Caricato da
Maria SalvoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 11
IL MATTINO
Giovin Signore, o a te scenda per lungo
Di magnanimi lombi ordine il sangue
Purissimo celeste, o in te del sangue
Emendino il difetto i compri onori
E le adunate in terra o in mar ricchezze
Dal genitor frugale in pochi lustri,
Me Precettor d’amabil rito ascolta.
Come ingannar questi noiosi e lenti
Giorni di vita, cui sí lungo tedio
E fastidio insoffribile accompagna,
Or io t’insegnerò. Quali al Mattino,
Quai dopo il Mezzodí, quali la Sera
Esser debban tue cure apprenderai,
Se in mezzo a gli ozi tuo ozio ti resta
Pur di tender gli orecchi a’ versi miei.
Già l’are a Vener sacre e al giocatore
Mercurio ne le Gallie e in Albïone
Devotamente hai visitate, e porti
Pur anco i segni del tuo zelo impressi:
Ora è tempo di posa. In vano Marte
A sé t’invita; ché ben folle è quegli
Che a rischio de la vita onor si merca,
E tu naturalmente il sangue aborri.
Né i mesti de la dea Pallade studi
Ti son meno odïosi: avverso ad essi
Ti feron troppo i queruli ricinti
Ove l’arti migliori e le scïenze,
Cangiate in mostri e in vane orride larve,
Fan le capaci volte eccheggiar sempre
Di giovanili strida. Or primamente
Odi quali il Mattino a te soavi
Cure debba guidar con facil mano.
Sorge il Mattino in compagnia dell’Alba
Innanzi al Sol che di poi grande appare
Su l’estremo orizzonte a render lieti
Gli animali e le piante e i campi e l’onde.
Allora il buon villan sorge dal caro
Letto cui la fedel moglie e i minori
Suoi figlioletti intiepidîr la notte;
Poi sul collo recando i sacri arnesi
Che prima ritrovâr Cerere e Pale,
Va col bue lento innanzi al campo, e scuote
Lungo il picciol sentier da’ curvi rami
Il rudagioso umor che, quasi gemma,
I nascenti del Sol raggi rifrange.
Allora sorge il fabbro, e la sonante
Officina riapre, e all’opre torna
L’altro dí non perfette, o se di chiave
Ardua e ferrati ingegni all’inquïeto
Ricco l’arche assecura, o se d’argento
E d’oro incider vuol gioielli e vasi
Per ornamento a nova sposa o a mense.
Ma che? Tu inorridisci, e mostri in capo,
Qual istrice pungente, irti i capegli
Al suon di mie parole? Ah non è questo,
Signore, il tuo mattin. Tu col cadente
Sol non sedesti a parca mensa, e al lume
Dell’incerto crepuscolo non gisti
Ieri a corcarti in male agiate piume,
Come dannato è a far l’umile vulgo.
A voi, celeste prole, a voi, concilio
Di Semidei terreni, altro concesse
Giove benigno: e con altr’arti e leggi
Per novo calle a me convien guidarvi.
Tu tra le veglie e le canore scene
E il patetico gioco oltre piú assai
Producesti la notte; e stanco alfine
In aureo cocchio, col fragor di calde
Precipitose rote e il calpestio
Di volanti corsier, lunge agitasti
Il queto aere notturno; e le tenébre
Con fiaccole superbe intorno apristi,
Siccome allor che il Siculo terreno
Da l’uno a l’altro mar rimbombar fèo
Pluto col carro, a cui splendeano innanzi
Le tede de le Furie anguicrinite.
Così tornasti a la magion; ma quivi
A novi studi ti attendea la mensa
Cui ricopríen pruriginosi cibi
E licor lieti di Francesi colli
O d’Ispani, o di Toschi, o l’Ongarese
Bottiglia a cui di verde edera Bacco
Concedette corona, e disse: Siedi
De le mense reina. Alfine il Sonno
Ti sprimacciò le morbide coltríci
Di propria mano, ove, te accolto, il fido
Servo calò le seriche cortine:
E a te soavemente i lumi chiuse
Il gallo che li suole aprire altrui.
Dritto è perciò, che a te gli stanchi sensi
Non sciolga da’ papaveri tenaci
Morfeo, prima che già grande il giorno
Tenti di penetrar fra gli spiragli
De le dorate imposte, e la parete
Pingano a stento in alcun lato i raggi
Del sol ch’eccelso a te pende sul capo.
Or qui principio le leggiadre cure
Denno aver del tuo giorno; e quinci io debbo
Sciorre il mio legno; e co’ precetti miei
Te ad alte imprese ammaestrar cantando.
SUBLIME SPECCHIO DI VERACI DETTI - CLXXXV. (n.185)
Sublime specchio di veraci detti,
Mostrami in corpo e in anima qual sono:
Capelli, or radi in fronte, e rossi pretti;
Lunga statura, e capo a terra prono;
Sottil persona in su due stinchi schietti;
Bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono;
Giusto naso, bel labro, e denti eletti;
Pallido in volto, più che un re sul trono:
Or duro, acerbo, ora pieghevol, mite;
Irato sempre, e non maligno mai;
La mente e il cor meco in perpetua lite:
Per lo più mesto, e talor lieto assai,
Or stimandomi Achille, ed or Tersìte:
Uom, se’ tu grande, o vil? Muori, e il saprai.
TACITO ORROR DI SOLITARIA SELVA - CXIII. (n.113)
Tacito orror di solitaria selva
Di sì dolce tristezza il cor mi bea,
Che in essa al par di me non si ricrea
Tra’ figli suoi nessuna orrida belva.
E quanto addentro più il mio piè s’inselva,
Tanto più calma e gioja in me si crea;
Onde membrando com’io là godea,
Spesso mia mente poscia si rinselva.
Non ch’io gli uomini abborra, e che in me stesso
Mende non vegga, e più che in altri assai;
Nè ch’io mi creda al buon sentier più appresso:
Ma, non mi piacque il vil mio secol mai:
E dal pesante regal giogo oppresso,
Sol nei deserti tacciono i miei guai.
AUTORITRATTO - VII. (n.7)
Solcata ho fronte, occhi incavati intenti;
Crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto;
Labbro tumido acceso, e tersi denti,
Capo chino, bel collo, e largo petto;
Giuste membra, vestir semplice eletto;
Ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti,
Sobrio, umano, leal, prodigo, schietto;
Avverso al mondo, avversi a me gli eventi.
Talor di lingua, e spesso di man prode;
Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso,
Pronto, iracondo, inquieto, tenace:
Di vizi ricco e di virtù, do lode
Alla ragion, ma corro ove al cor piace:
Morte sol mi darà fama e riposo.
IN MORTE DEL FRATELLO GIOVANNI – X. (n.10)
Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo
Di gente in gente; mi vedrai seduto
Su la tua pietra, o fratel mio, gemendo
Il fior de’ tuoi gentili anni caduto:
La madre or sol, suo dì tardo traendo,
Parla di me col tuo cenere muto:
Ma io deluse a voi le palme tendo;
E se da lunge i miei tetti saluto,
Sento gli avversi Numi, e le secrete
Cure che al viver tuo furon tempesta;
E prego anch’io nel tuo porto quiete:
Questo di tanta speme oggi mi resta!
Straniere genti, l’ossa mie rendete
Allora al petto della madre mesta.
A SILVIA.
Silvia, sovvienti ancora
Quel tempo de la tua vita mortale,
Quando beltà splendea
Ne gli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
E tu, lieta e pensosa, il limitare
Di gioventù salivi?
Sonavan le quiete
Stanze, e le vie dintorno,
Al tuo perpetuo canto,
Allor che a l’opre femminili intenta
Sedevi, assai contenta
Di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
Così menare il giorno.
Io gli studi leggiadri
Talor lasciando e le sudate carte,
Ove il tempo mio primo
E di me si spendea la miglior parte,
D’in su i veroni del paterno ostello
Porgea gli orecchi al suon de la tua voce,
Ed a la man veloce
Che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
Le vie dorate e gli orti,
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
Quel ch’io sentiva in seno.
Che pensieri soavi,
Che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
La vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
Un affetto mi preme
Acerbo e sconsolato,
E tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
Perchè non rendi poi
Quel che prometti allor? perchè di tanto
Inganni i figli tuoi?
Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,
Da chiuso morbo consumata e vinta,
Perivi, o tenerella. E non vedevi
Il fior de gli anni tuoi;
Non ti molceva il core
La dolce lode or de le negre chiome,
Or de gli sguardi innamorati e schivi;
Nè teco le compagne a i dì festivi
Ragionavan d’amore.
Anco peria fra poco
La speranza mia dolce: a gli anni miei
Anco negaro i fati
La giovanezza. Ahi come,
Come passata sei,
Cara compagna de l’età mia nova,
Mia lagrimata speme!
Questo è quel mondo? questi
I diletti, l’amor, l’opre, gli eventi
Onde cotanto ragionammo insieme?
Questa la sorte de l’umane genti?
A l’apparir del vero,
Tu, misera, cadesti: e con la mano
La fredda morte ed una tomba ignuda
Mostravi di lontano.
Potrebbero piacerti anche
- Ugo Foscolo, Odi e SonettiDocumento9 pagineUgo Foscolo, Odi e SonettiAlessandro Di PietriNessuna valutazione finora
- Foscolo SonettiDocumento5 pagineFoscolo SonettiEmanuelaNessuna valutazione finora
- Poesia Femminile Del CinquecentoDocumento27 paginePoesia Femminile Del CinquecentoTiziano LicataNessuna valutazione finora
- Poeti InglesiDocumento7 paginePoeti InglesigorlichNessuna valutazione finora
- Poesie - Fede e Bellezza Dell'Italia - Niccolò Tommaseo, Detto Anche Nicolò (Sebenico, 9 Ottobre 1802 - Firenze, 1º Maggio 1874Documento58 paginePoesie - Fede e Bellezza Dell'Italia - Niccolò Tommaseo, Detto Anche Nicolò (Sebenico, 9 Ottobre 1802 - Firenze, 1º Maggio 1874Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Gabriele D'Annunzio - Alcyone 1903Documento117 pagineGabriele D'Annunzio - Alcyone 1903scribd.jbls6Nessuna valutazione finora
- RimeDocumento102 pagineRimegiangi57Nessuna valutazione finora
- A Silvia, Giacomo Leopardi-ParafrasiDocumento2 pagineA Silvia, Giacomo Leopardi-ParafrasiKavidu WeerasingheNessuna valutazione finora
- Il ProfetaDocumento64 pagineIl ProfetaGigi Franco100% (1)
- Poeti Cinquecento IIDocumento43 paginePoeti Cinquecento IIarkadijNessuna valutazione finora
- Zanella LiricheDocumento112 pagineZanella LirichemarinonigianNessuna valutazione finora
- CANTATE e RIME Di Metastasio. Materiali Di LavoroDocumento80 pagineCANTATE e RIME Di Metastasio. Materiali Di Lavoroanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Dei SepolcriDocumento6 pagineDei Sepolcriteddy pickerNessuna valutazione finora
- Perle Di SaggezzaDocumento66 paginePerle Di Saggezzajoseph5923Nessuna valutazione finora
- A SilviaDocumento3 pagineA SilviaugoNessuna valutazione finora
- AAVV - Lirici GreciDocumento61 pagineAAVV - Lirici GreciLucia NigroNessuna valutazione finora
- Pietro BemboDocumento5 paginePietro Bemboana.djNessuna valutazione finora
- A SilviaDocumento2 pagineA SilviagNessuna valutazione finora
- Cremonino, Cesare - Le Pompe Funebri, Ouero Aminta, e Clori 1591Documento145 pagineCremonino, Cesare - Le Pompe Funebri, Ouero Aminta, e Clori 1591Tarquinia MolzaNessuna valutazione finora
- Poesie Di Venceslao IvanovDocumento19 paginePoesie Di Venceslao IvanovtheourgikonNessuna valutazione finora
- Ariosto, Ludovico - RimeDocumento90 pagineAriosto, Ludovico - RimeRoberto FilippiNessuna valutazione finora
- Trecento (Guido Novello Da P)Documento83 pagineTrecento (Guido Novello Da P)Enzo SalomoneNessuna valutazione finora
- Canto NotturnoDocumento6 pagineCanto NotturnowuweitaoNessuna valutazione finora
- Carme in Morte Di Carlo Imbonati ManzoniDocumento6 pagineCarme in Morte Di Carlo Imbonati ManzoniFlavia PierottiNessuna valutazione finora
- Euridice PeriDocumento19 pagineEuridice PeriNéstor PindadoNessuna valutazione finora
- Parafrasi Parini Il Mattino 1-360 APPUNTIDocumento1 paginaParafrasi Parini Il Mattino 1-360 APPUNTICarmine PastoreNessuna valutazione finora
- Canto NovoDocumento14 pagineCanto NovoGian LuigiNessuna valutazione finora
- 2 Vittorio AlfieriDocumento2 pagine2 Vittorio AlfieriRoberta RosoliaNessuna valutazione finora
- Comunicard Fac CT 3 Edwin RinconDocumento8 pagineComunicard Fac CT 3 Edwin RinconDaron CoronadoNessuna valutazione finora
- Rinascimento MUSICA MAPPADocumento3 pagineRinascimento MUSICA MAPPACristina AlberiniNessuna valutazione finora
- Analisi Musicale Beethoven, Sonata Op 31 N 2 Tempest A)Documento30 pagineAnalisi Musicale Beethoven, Sonata Op 31 N 2 Tempest A)DUGUIT100% (1)
- 8 9 Archi e VolteDocumento71 pagine8 9 Archi e VoltejuanpecopeNessuna valutazione finora
- Fonetica CombinatoriaDocumento14 pagineFonetica CombinatoriaLarry DarrellNessuna valutazione finora
- La Biologia Delle Emozioni 9788896865422 637111Documento225 pagineLa Biologia Delle Emozioni 9788896865422 637111Elisa Osimani100% (4)
- 2022 MSI - Lez 03 - Incertezza CombinataDocumento22 pagine2022 MSI - Lez 03 - Incertezza CombinataLorenzo TripodinaNessuna valutazione finora