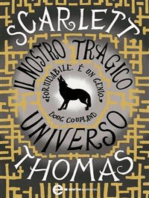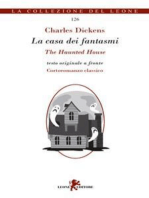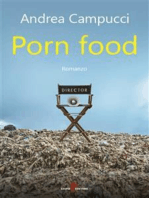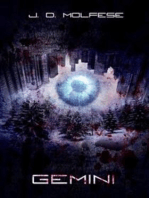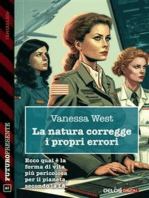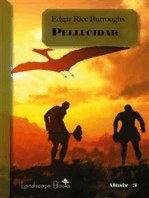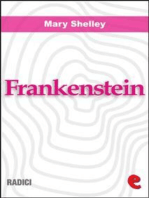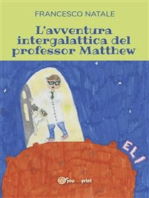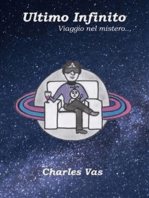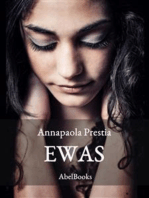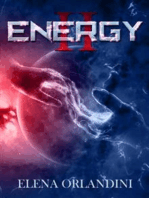Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Armada - Ernest Cline
Caricato da
MarcoBarison0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
83 visualizzazioni16 pagineDa spendere
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoDa spendere
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
83 visualizzazioni16 pagineArmada - Ernest Cline
Caricato da
MarcoBarisonDa spendere
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 16
Ernest Cline
ARMADA
Le prime pagine di Armada,
l'attesissimo nuovo romanzo dell'autore di Ready Player One
DAL 30 OTTOBRE 2018 IN LIBRERIA
1
—
Stavo guardando fuori dalla finestra dell’aula, come al solito immerso in
avventure a occhi aperti, quando vidi un disco volante.
Sbattei le palpebre, ma il disco non mostrò di voler sparire. Un piatto
cromato e lucente che procedeva a zig zag nel cielo. I miei occhi faticavano a
seguire i movimenti repentini e le svolte fulminee che avrebbero stritolato
qualsiasi essere umano fosse stato a bordo. Il disco saettò verso l’orizzonte e
poi si fermò di colpo. Restò sospeso per qualche secondo, immobile sopra la
linea degli alberi, come se stesse scansionando l’area sottostante con un
raggio invisibile, quindi sfrecciò verso l’alto, lanciando nuove sfide alle leggi
della fisica.
Cercai di mantenere la calma. Cercai di conservare un sano scetticismo.
Ricordai a me stesso che ero un uomo di scienza, anche se nelle materie
scientifiche sfioravo appena la sufficienza.
Guardai di nuovo. Non capivo ancora cosa fosse, ma sapevo cosa non era:
non era una stella cadente. E neppure un pallone meteorologico, né un gas di
palude o un fulmine globulare. No, l’oggetto volante non identificato che
avevo di fronte non era di questa Terra.
Il mio primo pensiero fu: Porca puttana.
Seguito immediatamente da: Non ci credo, finalmente sta succedendo!
Voglio dire, era dall’asilo che aspettavo e speravo che un evento inatteso,
eccezionale, sbalorditivo ponesse fine al mondo così come lo conoscevo – e
quindi anche al tedio insostenibile della mia esperienza nell’istruzione
pubblica. Avevo passato centinaia di ore a fissare il placido panorama di
periferia intorno alla mia scuola sperando che scoppiasse un’apocalisse
zombie, o che uno strambo incidente mi conferisse qualche superpotere, o
magari che spuntasse dal nulla una banda di nani cleptomani che viaggiavano
nel tempo.
A spanne, circa un terzo dei sogni a occhi aperti che ho fatto in quei lunghi
anni noiosi riguardava l’improvviso arrivo di visitatori da un altro mondo.
Ovviamente non avevo mai pensato che sarebbe successo davvero. Se
anche degli alieni avessero deciso di fare visita al mio insignificante pianeta
verdeazzurro, nessun extraterrestre che si rispetti avrebbe mai scelto la mia
città – Beaverton, nell’Oregon, ovvero Noiopoli, U.S.A. – come sede del
primo contatto. A meno che il loro piano non prevedesse di annientare per
primi i terrestri meno interessanti. Se l’universo aveva un centro nevralgico,
mi trovavo all’estremità opposta. Per favore, zia Beru, passami il latte blu.
E invece stava davvero succedendo un miracolo, e proprio in quell’istante!
Accidenti, là fuori c’era un disco volante! Ce l’avevo davanti agli occhi!
E mi sembrava proprio che si stesse avvicinando.
Scoccai un’occhiata furtiva ai miei due migliori amici, Cruz e Diehl, che
erano seduti dietro di me. Ma in quel momento erano impegnati in un acceso
dibattito condotto a bassa voce, e nessuno dei due guardava fuori. Potevo
provare ad attirare la loro attenzione, ma temevo che l’oggetto volante
sparisse da un momento all’altro e non volevo perdere l’occasione di
rimirarlo.
Tornai a girarmi verso la finestra, appena in tempo per scorgere un intenso
lampo argentato: la nave scartò di lato e restò sospesa sopra un’area sterrata
per poi ripartire.
Si fermava, ripartiva. Si fermava, ripartiva.
Sì, il disco si stava proprio avvicinando. Ora si distinguevano meglio i
contorni. Quando si piegò di lato per qualche secondo per la prima volta
riuscii a vederlo bene di profilo, e mi accorsi che non era affatto un disco. Da
quell’angolazione il suo scafo simmetrico somigliava più a un’ascia da guerra
a due lame: tra le lunghe ali seghettate, un ottagono nero riluceva nel sole del
mattino come un gioiello scuro.
Fu allora che iniziai a percepire un cortocircuito nel cervello, perché quella
forma era inconfondibile. Dopotutto la guardavo quasi ogni sera da anni,
attraverso il reticolo di un mirino. Avevo di fronte un Falcione Sobrukai: una
delle navi da guerra degli alieni cattivi in Armada, il mio videogioco
preferito.
Il che, ovviamente, era impossibile. Era come vedere in cielo un Caccia
TIE o uno Sparviero Klingon. I Sobrukai e i loro Caccia Falcioni erano
personaggi immaginari di un videogioco. Non esistevano nel mondo reale…
non era possibile! Nella realtà i videogame non prendevano vita e le astronavi
della fantascienza non sorvolavano la tua città. Cose del genere capitavano
solo nei più dozzinali film anni Ottanta, come TRON, Wargames o Giochi
stellari. Il genere di film di cui andava pazzo il mio defunto padre.
La nave scintillante tornò a piegarsi su un fianco. Non c’era più alcun
dubbio. Stavo vedendo un Falcione, come confermavano i tipici solchi ad
artiglio lungo la fusoliera e i due cannoni al plasma che sporgevano dal muso
come due zanne.
C’era una sola spiegazione logica per ciò che stavo vedendo. Dovevo avere
le allucinazioni. E sapevo bene quale tipologia di persone soffre di
allucinazioni in pieno giorno senza l’ausilio di droghe o alcol. Persone a cui
manca qualche venerdì, ecco chi. Gente che ha svariate rotelle fuori posto.
Da tempo mi domandavo se mio padre fosse stato una di quelle persone,
per via di quello che avevo letto in uno dei suoi vecchi diari. Ne avevo tratto
l’impressione che, verso la fine della sua vita, avesse iniziato a delirare. Che
potesse addirittura aver perso la capacità di distinguere tra i videogiochi e la
realtà: esattamente lo stesso problema che in quel momento sembravo avere
io. Forse era come avevo sempre temuto: la mela era caduta poco lontano
dall’Albero della Pazzia.
Mi avevano drogato? No, impossibile. Quella mattina avevo mangiato solo
una merendina alla fragola, in macchina mentre andavo a scuola: e l’unica
cosa più folle che avere allucinazioni sulle astronavi dei videogiochi sarebbe
stata attribuirle a un dolcetto glassato. Specialmente se sapevo che il mio
DNA era un colpevole molto più probabile.
Era colpa mia. Avrei potuto prendere precauzioni. E invece avevo fatto il
contrario. Come mio padre, avevo dedicato la vita a un’overdose di evasione
pura: avevo permesso alla fantasia di diventare la mia realtà. E ora anch’io,
come mio padre, pagavo il prezzo della scarsa lungimiranza. Ero a bordo del
treno della pazzia e stavo deragliando. Mi pareva quasi di sentire le grida di
Ozzy: «All aboard!»
Non farlo, mi dissi. Non crollare proprio adesso che mancano solo due
mesi al diploma! Sei sul rettilineo finale, Lightman! Resisti!
Fuori dalla finestra il Caccia Falcione piegò nuovamente di lato. Sorvolò
un bosco scuotendo i rami alti degli alberi, poi fendette un altro banco di
nubi, così in fretta da praticare un foro perfettamente circolare, e si trascinò
dietro lunghe scie di vapore quando uscì dall’altra parte.
Un attimo dopo, la nave si fermò a mezz’aria per l’ultima volta e poi saettò
dritta verso l’alto in una nube argentata, sparendo alla vista con la stessa
rapidità con cui era apparsa.
Restai immobile per un momento, senza riuscire a far altro che fissare il
cielo vuoto dove un secondo prima si trovava la nave spaziale. Poi mi girai
per guardare gli studenti seduti intorno a me. Nessun altro era rivolto verso le
finestre. Se quel Falcione era davvero passato fuori dalla mia scuola, nessun
altro a parte me l’aveva visto.
Tornai a contemplare il cielo deserto e pregai la strana nave argentata di
riapparire. Ma se n’era andata, e io dovevo affrontare i postumi.
Vedere quel Falcione, o immaginare di averlo visto, aveva innescato nella
mia mente una piccola frana che stava già diventando una valanga di
emozioni in conflitto e ricordi frammentari: tutti legati a mio padre e a quel
vecchio diario che avevo trovato tra le sue cose.
A dire il vero non ero neppure certo che si trattasse di un diario. Non avevo
mai finito di leggerlo. Ero rimasto troppo sconvolto dai suoi contenuti e da
ciò che sembravano implicare circa lo stato mentale dell’autore. Quindi
avevo rimesso il quaderno dove l’avevo trovato, ripromettendomi di
dimenticare che esistesse… e fino a pochi secondi prima ce l’avevo fatta.
Ma ora non riuscivo a pensare ad altro.
Sentii il bisogno improvviso di correre alla macchina, tornare a casa e
trovarlo. Non ci sarebbe voluto molto tempo: abitavo a pochi minuti da lì.
Guardai verso l’uscita e verso l’uomo che mi impediva di imboccarla: il
professor Sayles, il nostro anziano insegnante di Matematica integrata II.
Aveva i capelli bianchi tagliati corti con la macchinetta e spessi occhiali dalla
montatura di corno, e indossava gli stessi abiti monocromatici di sempre:
mocassini neri, pantaloni neri, una camicia bianca a maniche corte e una
cravatta nera con la clip. Insegnava in quel liceo da oltre quarantacinque anni
e le foto dei vecchi annuari in biblioteca testimoniavano che si era sempre
vestito in quel modo. Finalmente quell’anno sarebbe andato in pensione, e
tanto meglio così, perché aveva smesso di interessarsi al suo lavoro più o
meno il secolo precedente. Quel giorno aveva passato i primi cinque minuti a
spiegarci i compiti da fare e ci aveva lasciato il resto dell’ora per farli,
dopodiché aveva spento l’apparecchio acustico e si era messo a fare il suo
cruciverba. Ma se avessi provato a filarmela dall’aula mi avrebbe visto.
Spostai lo sguardo sull’orologio d’epoca incastonato nella parete di
mattoni verde acido sopra l’antiquata lavagna. Con la consueta spietatezza,
mi informò che mancavano ancora trentadue minuti alla campanella.
Era impossibile resistere ad altri trentadue minuti di quella roba. Dopo
quello che avevo appena visto, sarei stato fortunato a mantenere la calma per
altri trentadue secondi.
Alla mia sinistra, Douglas Knotcher era impegnato nella quotidiana
umiliazione di Casey Cox, il ragazzino timido e brufoloso che aveva la
sfortuna di essere seduto davanti a lui. Di solito Knotcher si limitava a
insultare il poveretto, ma quel giorno aveva deciso di fare le cose alla vecchia
maniera e lanciargli palline di carta imbevute di saliva. Aveva accumulato
una scorta di quei proiettili umidi sul suo banco, come palle di cannone, e in
quel momento li stava sparando uno a uno verso la nuca di Casey. Il
poveretto aveva già i capelli bagnati a causa delle aggressioni precedenti. Due
amici di Knotcher guardavano la scena dal fondo dell’aula, sghignazzavano
ogni volta che un proiettile andava a segno e lo incitavano a continuare.
Assistere a quel bullismo mi faceva stare male, e sospettavo che anche per
quello Knotcher ci si divertisse tanto: perché sapeva che non potevo farci
niente.
Il prof Sayles era concentrato sul cruciverba e come al solito non si era
accorto di nulla: una circostanza di cui Knotcher si approfittava ogni giorno.
E ogni giorno io dovevo resistere alla tentazione di fargli saltare tutti i denti.
Io e Doug Knotcher eravamo riusciti a evitarci quasi sempre, dopo la
«Cosa» che era successa alle scuole medie. Fino a quell’anno, quando un
crudele scherzo del destino ci aveva fatti finire nello stesso corso di
matematica. E seduti in due file adiacenti, nientemeno. Sembrava quasi che
l’universo volesse farmi passare le pene dell’inferno nel mio ultimo semestre
di liceo.
Il che in effetti avrebbe spiegato perché ci fosse anche la mia ex ragazza,
Ellen Adams, in quel corso. Tre file alla mia destra e due file indietro, seduta
appena oltre il limite della mia visione periferica.
Ellen era stata il mio primo amore e avevamo perso la verginità insieme.
Erano passati quasi due anni da quando mi aveva lasciato per un lottatore di
wrestling di una scuola vicina, ma ogni volta che mi balenavano davanti
quelle lentiggini sul naso – o la vedevo scostarsi dagli occhi i riccioli rossi –
mi si spezzava il cuore da capo. Di solito passavo l’intera lezione a cercare di
dimenticare che lei fosse nella stanza.
Essere costretto a sedermi ogni pomeriggio tra il mio nemico mortale e la
mia ex rendeva la lezione di matematica della settima ora la mia personale
Kobayashi Maru: uno scenario disperato senza alcuna possibilità di vittoria,
progettato per mettere alla prova la mia forza d’animo.
Per fortuna il destino aveva riequilibrato leggermente le forze in gioco in
quell’incubo, mettendomi accanto anche i miei due migliori amici. Se Cruz e
Diehl non fossero stati assegnati a quel corso, probabilmente mi sarebbero
venute le allucinazioni già alla prima settimana.
Diehl, che era alto e magro, e Cruz, che era basso e tarchiato, avevano lo
stesso nome, Michael. Fin dalle elementari li chiamavo per cognome per
evitare confusione. E in quel momento i due Mike erano ancora impegnati
nella conversazione a bassa voce di prima che mi venissero le traveggole: un
acceso dibattito su quale fosse l’arma migliore per il combattimento
ravvicinato nella storia del cinema. Cercai di concentrarmi nuovamente sulle
loro voci.
«Pungolo non era neppure tecnicamente una spada» stava dicendo Diehl.
«Era una specie di coltello da burro fosforescente hobbit, usato per spalmare
la marmellata sugli scones, sul pane lembas eccetera.»
Cruz alzò gli occhi al cielo. «Il tuo amore per la foglia-pipa dei
Mezzuomini ti ha rallentato il cervello» citò. «Pungolo era una spada elfica,
forgiata a Gondolin durante la Prima Era! Poteva tagliare praticamente
qualsiasi cosa! E la sua lama riluceva solo quando individuava la presenza di
orchi nei paraggi. Cos’è che individua Mjolnir, invece? Sentiamo. Accenti
fasulli e capelli con le punte ossigenate?»
Volevo raccontare loro ciò che avevo appena visto, ma neppure i miei
migliori amici mi avrebbero creduto. L’avrebbero considerato un altro
sintomo dell’instabilità psichica del loro amico Zack.
E forse era davvero così.
«Thor non ha bisogno di individuare i nemici per andare a nascondersi
nella sua tana da hobbit!» bisbigliò Diehl. «Mjolnir è così potente che può
fare a pezzi una montagna, e poi emette raggi energetici, crea campi di forza,
evoca i fulmini. Inoltre torna sempre nella mano di Thor, anche a costo di
fare a pezzi un pianeta intero! E solo Thor può brandirlo!» Si appoggiò allo
schienale.
«Ma piantala! Mjolnir è una fregatura, un coltellino svizzero con un po’ di
magia» ribattè Cruz. «Peggio ancora dell’anello di Lanterna Verde! Una
settimana sì e una no si inventano un nuovo potere per quel martello, solo per
tirar fuori Thor da qualche stupido guaio in cui l’hanno mandato a cacciarsi.»
Sghignazzò. «A proposito, un mucchio di altra gente ha impugnato Mjolnir,
compresa Wonder Woman in un episodio crossover! Cercalo su Google. La
tua teoria non sta in piedi, Diehl!»
Per la cronaca, personalmente avrei forse scelto Excalibur per com’è
rappresentata nel film omonimo. Ma non avevo la forza di partecipare a quel
dibattito. La mia attenzione fu richiamata nuovamente da Knotcher, che
scagliò su Casey un altro gigantesco globo di carta e saliva.
Casey si irrigidì nell’istante dell’impatto, ma non si girò. Sprofondò ancor
di più sulla sedia mentre il suo aguzzino preparava un’altra raffica.
C’era un legame evidente tra il comportamento di Knotcher e l’ubriaco
violento che aveva per padre, ma la causa del suo sadismo non bastava a
giustificarlo, secondo me. Anch’io avevo grossi problemi con la figura
paterna, ma non per questo strappavo le ali alle mosche. D’altro canto però
incontravo qualche lieve difficoltà nella gestione della rabbia, che aveva
condotto a episodi di violenza fisica ben documentati nella burocrazia
dell’istruzione pubblica.
Ah sì, e poi c’era tutta quella faccenda delle allucinazioni sulle astronavi
aliene del mio videogioco preferito.
Quindi forse non ero nella posizione migliore per giudicare la sanità
mentale altrui.
Mi guardai intorno. Tutti i miei compagni stavano fissando Casey,
probabilmente chiedendosi se quel giorno finalmente avrebbe tenuto testa a
Knotcher. Ma Casey fingeva di essere concentrato sul professore, che era
ancora assorto sul cruciverba e ignaro del dramma adolescenziale che si
consumava davanti a lui.
Knotcher lanciò un’altra pallina e io cercai di fare quello che avevo fatto
per tutto il semestre. Cercai di gestire la rabbia. Di spostare l’attenzione
altrove e farmi gli affari miei. Ma non ci riuscii.
Guardare Knotcher che tormentava indisturbato Casey mi riempiva non
solo di odio verso me stesso, ma anche di disgusto per l’intera specie a cui
appartenevo. Se c’erano altre civiltà là fuori, perché mai avrebbero dovuto
mettersi in contatto con l’umanità? Se era così che ci trattavamo l’un l’altro,
con quanta gentilezza avremmo trattato una razza di alieni con gli occhi a
palla?
Mi riaffiorò alla mente un’immagine nitida del Caccia Falcione e sentii
subito tendere i nervi allo spasimo. Per calmarmi provai a pensare
all’equazione di Drake e al paradosso di Fermi. Sapevo che con tutta
probabilità c’era vita là fuori, da qualche parte. Ma sapevo anche che, poiché
l’universo era così sterminato e così antico, era improbabile che riuscissimo a
entrare in contatto con altre forme di vita, tantomeno nel breve lasso di tempo
della mia vita. Probabilmente eravamo tutti prigionieri lì, sulla terza pietra dal
Sole. Ci saremmo estinti senza mai esplorare nuovi mondi.
Un dolore improvviso al mento mi fece notare che stavo digrignando i
denti con tanta forza da incrinarli. Con un certo sforzo rilassai i muscoli. Poi
mi girai a guardare Ellen, per vedere se stava assistendo alla scena. Fissava
Casey con un’espressione impotente e gli occhi pieni di compassione.
Fu la goccia che fece traboccare il vaso.
«Zack, che stai facendo?» mi chiese Diehl in un bisbiglio concitato.
«Siediti!»
Senza rendermene conto mi ero alzato dal banco. Tenevo ancora gli occhi
fissi su Knotcher e Casey.
«Già, stanne fuori!» sussurrò Cruz verso l’altra mia spalla. «Eddai, bello..»
Ma ormai avevo la vista annebbiata dalla rabbia.
Quando raggiunsi Knotcher non feci ciò che avrei voluto fare, ovvero
acciuffarlo per i capelli e sbattergli ripetutamente la faccia sul banco con tutta
la forza che avevo.
Invece andai a raccogliere le palline bagnate di saliva sul pavimento dietro
la sedia di Casey, le appallottolai in un’unica sfera, e la scaraventai
direttamente sulla testa di Knotcher. Emise uno splat molto soddisfacente.
Knotcher scattò in piedi e si girò per affrontare l’aggressore, ma restò
spiazzato quando si trovò davanti la mia faccia. Sbarrò gli occhi e impallidì.
Nell’aula si levò un «Ooooooh!» collettivo. Tutti sapevano cos’era
successo tra me e Knotcher alle medie, e ora tutti erano galvanizzati dalla
possibilità di una rivincita. La lezione di Matematica integrata della settima
ora stava diventando molto più entusiasmante.
Knotcher alzò le mani e si tolse dalla testa la palla di tovaglioli masticati.
Con un gesto stizzito la lanciò all’altro capo della stanza, colpendo
involontariamente una mezza dozzina di persone. Ci guardammo negli occhi.
Notai un rivolo di saliva che gli scorreva lungo la guancia sinistra. Lo
asciugò senza staccare gli occhi da me.
«Finalmente hai deciso di difendere il tuo fidanzato, Lightman?» mormorò,
senza riuscire a evitare che gli tremasse un po’ la voce.
Mostrai i denti e avanzai di un passo, tirando indietro il pugno destro.
Ottenni l’effetto desiderato. Knotcher arretrò precipitosamente, inciampò
sulla sedia e rischiò di cadere a terra. Ma poi ritrovò l’equilibrio e si piazzò di
nuovo davanti a me, con le guance rosse per l’imbarazzo.
Nell’aula non volava una mosca, a parte il ticchettio incessante
dell’orologio alla parete.
Forza, pensai. Dammi una buona scusa. Tirami un pugno.
Ma vedevo crescere la paura negli occhi di Knotcher, e la paura assorbiva
la sua rabbia. Forse capiva dalla mia espressione che stavo impazzendo.
«Psicopatico» sussurrò. Poi si girò, si sedette e mi mostrò il dito medio da
sopra la spalla.
Mi accorsi che avevo ancora il pugno destro alzato. Quando finalmente lo
abbassai, tutta la classe sembrò espirare all’unisono. Mi aspettavo un cenno
di gratitudine da Casey, che però era ancora acquattato sul banco come un
cane bastonato, la testa bassa.
Ellen invece sì che mi fissava, ma quando tentai di incrociare il suo
sguardo distolse subito gli occhi. In tutta l’aula, le uniche due persone
disposte a guardarmi in faccia erano Cruz e Diehl, e sembravano entrambi
piuttosto preoccupati.
Fu allora che il prof Sayles ritenne di potersi distrarre dal suo cruciverba e
mi vide incombere sopra Knotcher come un assassino armato di ascia. Si
rimise l’apparecchio acustico e lo accese: poi tornò a guardare me, poi
Knotcher, poi di nuovo me.
«Che succede, Lightman?» domandò, puntandomi addosso un dito nodoso.
Vedendo che non rispondevo si accigliò. «Torna subito al tuo posto.»
Ma non potevo. Se fossi rimasto lì un solo istante di più mi sarebbe
imploso il cranio. Quindi uscii dall’aula, passando davanti alla cattedra per
raggiungere la porta aperta. Sayles aveva le sopracciglia alzate in
un’espressione incredula.
«Farai meglio a dirigerti verso l’ufficio del preside, ragazzo!» mi gridò
dietro.
Stavo già correndo verso l’uscita più vicina, disturbando una classe dopo
l’altra con i cigolii delle mie scarpe da ginnastica sul pavimento incerato del
corridoio.
Arrivai all’ingresso principale della scuola dopo quella che mi parve
un’eternità. Mentre correvo verso il parcheggio degli studenti scrutai il cielo
da un orizzonte all’altro. Probabilmente sembravo un pazzo furioso, intento a
seguire una partita di tennis tra giganti che solo io potevo vedere… o forse
Don Chisciotte che aggrediva un mulino a vento.
La mia macchina era quasi in fondo al parcheggio. Era una Dodge Omni
bianca del 1989 che un tempo era appartenuta a mio padre, coperta di
ammaccature, crepe, vernice scrostata e grandi chiazze di ruggine. Era
rimasta ferma sotto un telo impermeabile nel nostro garage per tutta la mia
infanzia, finché mia madre mi aveva lanciato le chiavi il giorno del mio
sedicesimo compleanno. Avevo accettato quel dono con sentimenti
contrastanti: e non solo perché era un catorcio che si accendeva per miracolo.
Si dava il caso che fosse anche la macchina in cui ero stato concepito, e per di
più nello stesso parcheggio in cui mi trovavo in quel momento.
Un’informazione superflua che mia madre si era lasciata sfuggire un giorno
di san Valentino dopo troppo vino e troppe visioni di Non per soldi… ma per
amore. D’altronde, in vino veritas: doppiamente vero nel caso di mia madre,
quando c’era di mezzo un film di Cameron Crowe.
Comunque, ora l’Omni apparteneva a me. I corsi e ricorsi della vita,
immagino. E una macchina gratis è pur sempre una macchina gratis,
soprattutto per un ragazzino spiantato come me. Dovevo solo fare del mio
meglio per non pensare ai miei genitori adolescenti che lo facevano sul sedile
posteriore mentre Peter Gabriel cantava nel mangianastri.
Ebbene sì: quell’auto vantava ancora un mangianastri funzionante. Avevo
un cavo adattatore, quindi potevo ascoltare musica dal telefono, ma preferivo
le vecchie cassette di mio padre. Le sue band preferite erano diventate le mie:
ZZ Top, AC/DC, Van Halen, Queen. Accesi il potente motore a quattro
cilindri della Omni e dalle casse mezze sfondate uscirono le note della cover
di Get It On (Bang a Gong) dei Power Station.
Me ne andai a casa a tutta birra, nel labirinto di ombrose strade di periferia,
a una velocità probabilmente pericolosa, soprattutto dal momento che passai
gran parte del viaggio a guardare per aria anziché davanti a me. Era solo metà
pomeriggio ma si intravedeva già una luna quasi piena, che continuava ad
attrarre il mio sguardo mentre scandagliavo la volta celeste. Quindi rischiai di
bruciare due stop durante il breve tragitto verso casa, e per un pelo non venni
travolto da un Suv quando passai con il rosso a un semaforo.
A quel punto accesi le quattro frecce e guidai a passo d’uomo per gli ultimi
chilometri… sempre con la testa fuori dal finestrino, senza riuscire a staccare
gli occhi dal cielo.
... continua a leggere Armada dal 30 ottobre 2018 in
libreria.
© 2018 DeA Planeta Libri S.r.l.
Redazione: Via Inverigo, 2 − 20151 Milano
Prima edizione e-Book: maggio 2018
www.deagostini.it
www.deaplanetalibri.it
@DeAPlanetaLibri
@DeAPlanetaLibri
@DeAPlanetaLibri
@DeAPlanetanarrativa
@DeA_Planeta
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta,
memorizzata o trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo elettronico, meccanico, in
fotocopia, in disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione, senza
autorizzazione scritta dell’Editore.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale
o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di
specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana n. 108, Milano
20122, e-mail info@clearedi.org e sito web www.clearedi.org
Potrebbero piacerti anche
- Tolkien - Lo Hobbit (Italiano) PDFDocumento90 pagineTolkien - Lo Hobbit (Italiano) PDFmateusalmeidacunha50% (2)
- Tolkien - Lo Hobbit (Italiano) PDFDocumento90 pagineTolkien - Lo Hobbit (Italiano) PDFmateusalmeidacunha100% (1)
- Reiki-Symbols-Infographic en ItDocumento1 paginaReiki-Symbols-Infographic en ItMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Genes A CristalDocumento23 pagineGenes A CristalMarcoBarison100% (1)
- Cacciola Orto GiardinoDocumento26 pagineCacciola Orto GiardinoMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Pendolo Ebraico o MetuteletDocumento3 paginePendolo Ebraico o MetuteletMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Materiale UfoDocumento117 pagineMateriale UfoMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Una serie di racconti totalmente inaspettati: Quindici passi furtivi in prospettive inesplorateDa EverandUna serie di racconti totalmente inaspettati: Quindici passi furtivi in prospettive inesplorateNessuna valutazione finora
- Manochete: Perché anche in Africa non sempre le ciambelle riescono col bucoDa EverandManochete: Perché anche in Africa non sempre le ciambelle riescono col bucoNessuna valutazione finora
- Passione senza tempo: “Un viaggio fantastico nel mondo delle scienze ottiche”Da EverandPassione senza tempo: “Un viaggio fantastico nel mondo delle scienze ottiche”Nessuna valutazione finora
- Wilson Tucker - Signori Del Tempo (Ita Libro)Documento131 pagineWilson Tucker - Signori Del Tempo (Ita Libro)Pasquale AsquinoNessuna valutazione finora
- Roger Zelazny - La Variante Dell'UnicornoDocumento25 pagineRoger Zelazny - La Variante Dell'UnicornoLivio Quintilio GlobuloNessuna valutazione finora
- Bufalino Gesualdo Tommaso e Il Fotografo Cieco Ovvero Il PatatracDocumento103 pagineBufalino Gesualdo Tommaso e Il Fotografo Cieco Ovvero Il PatatracViandante852Nessuna valutazione finora
- Ligotti FabbricaDocumento10 pagineLigotti FabbricaMassimilianoRuzzante100% (1)
- Frankenstein ovvero Il Moderno Prometeo (Frankenstein or the Modern Prometheus)Da EverandFrankenstein ovvero Il Moderno Prometeo (Frankenstein or the Modern Prometheus)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (365)
- Il CommedianteDocumento73 pagineIl Commediantesaab9355Nessuna valutazione finora
- L'avventura intergalattica del professor MatthewDa EverandL'avventura intergalattica del professor MatthewNessuna valutazione finora
- Silenziosamente al mattino spicca il tuo voloDa EverandSilenziosamente al mattino spicca il tuo voloNessuna valutazione finora
- Il Gigante ImmortaleDocumento5 pagineIl Gigante ImmortaleEmilio RapisNessuna valutazione finora
- 29 Luglio 2022 - BDocumento1 pagina29 Luglio 2022 - BMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- 31 Luglio 2022 - BDocumento1 pagina31 Luglio 2022 - BMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- 29 Luglio 2022 - DDocumento1 pagina29 Luglio 2022 - DMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- 30 Luglio 2022Documento1 pagina30 Luglio 2022MarcoBarisonNessuna valutazione finora
- 29 Luglio 2022 - ADocumento1 pagina29 Luglio 2022 - AMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Gallimbo 34Documento2 pagineGallimbo 34MarcoBarisonNessuna valutazione finora
- 28 Luglio 2022Documento2 pagine28 Luglio 2022MarcoBarisonNessuna valutazione finora
- FNV Ancora SorpreseDocumento13 pagineFNV Ancora SorpreseMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Forno RosyDocumento28 pagineForno RosyMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Tabella Consociazioni Degli OrtaggiDocumento2 pagineTabella Consociazioni Degli OrtaggiMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Questa Analisi Cambierà Per Sempre Il Tuo Modo Di Investire - Parte 5 - Cerco AlfaDocumento17 pagineQuesta Analisi Cambierà Per Sempre Il Tuo Modo Di Investire - Parte 5 - Cerco AlfaMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Sistema Pratico 1954 - 01Documento52 pagineSistema Pratico 1954 - 01MarcoBarisonNessuna valutazione finora
- Filatelia Numismatica Quattrobaj - Note Al Catalogo Monete - Repubblica ItalianaDocumento2 pagineFilatelia Numismatica Quattrobaj - Note Al Catalogo Monete - Repubblica ItalianaMarcoBarisonNessuna valutazione finora
- La Compagnia Dell'anelloDocumento3 pagineLa Compagnia Dell'anelloKristal FishNessuna valutazione finora
- Lo Hobbit BilboOTWT Palantir ITA PDFDocumento90 pagineLo Hobbit BilboOTWT Palantir ITA PDFTurel626Nessuna valutazione finora
- La Spada Dalle Sette StelleDocumento3 pagineLa Spada Dalle Sette StelleArandilmeaq100% (3)