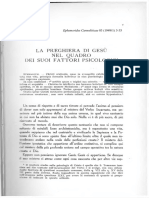Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Les Facultés Que L'homme Naturel Avoit Reçues en Puissance
Caricato da
Francesco TotoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Les Facultés Que L'homme Naturel Avoit Reçues en Puissance
Caricato da
Francesco TotoCopyright:
Formati disponibili
Francesco Toto
«Les facultés que l’homme naturel
avoit reçues en puissance».
In questo saggio cercheremo di dimostrare come già nella
Première partie del Discours sur l’inégalité, quella cioè relativa al
«pur état de Nature»1, siano in realtà positivamente, attivamente
operanti tutte quelle facoltà (riflessione, ragione, perfettibilità…)
che pure l’uomo naturale, ad una prima lettura, sembra possedere
solo «en puissance»2. Con ciò, non intendiamo affatto mettere
Rousseau in contraddizione con sé stesso, ma rendere manifesto un
livello di coerenza del suo discorso che non per il fatto di essere
meno appariscente e spesso trascurato può esser detto
semplicemente implicito. Oggetto dell’indagine non sarà cioè un
ipotetico non-detto, o addirittura, in termini althusseriani, un
impensato: come se, al di là della consapevolezza e delle
intenzioni dell’autore, il testo russoiano lasciasse trasparire un
vuoto, una lacuna, un contenuto rimosso che ne sorreggesse
nascostamente l’intera struttura concettuale, e che l’interprete
sarebbe dunque chiamato a riconoscere e a colmare. 3 Ad esser
messo al centro dell’analisi, esattamente al contrario, sarà qualcosa
che il testo dice, e dice anzi a chiare lettere, e a cui però il lettore
1
Cfr. J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi les
hommes, texte établi, présenté et annoté par J. Starobinski, in Œuvres complètes, édition
publiée sous la direction de B. Gagnebin et M. Raymond, 5 voll., Paris 1959-95, vol. III
(d’ora in poi: Disc.), p. 132
2 Ivi, p. 152
3
L. Althusser, Sur le Contrat Social (Les décalages), in L’impensée de J.-J.
Rousseau, «Cahiers pour l’analyse», 8, 1967, pp. 5-42 (L. Althusser, L’impensato di J.-
J. Rousseau, trad. it. a cura di V. Morfino, Milano 2003).
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
Francesco Toto
difficilmente riesce a prestare ascolto, perché la stessa storia delle
interpretazioni, che ne preorienta la comprensione, è in buona
parte basata precisamente sulla sua rimozione. Si trattasse solo
della difesa di una sedicente interpretazione autentica, della lettura
filologicamente corretta di un testo pur importante della storia del
pensiero occidentale, la questione non meriterebbe forse neppure
di essere presa in considerazione. Sulla presunta assenza delle
facoltà potenziali dallo stato di natura, e nella supposizione di un
loro intrinseco legame con la corruzione, si è spesso fatto leva per
forgiare un’immagine di Rousseau quale critico non più, come
osserva Burgio, di una «vicenda determinata», 1 di forme cioè
«storicamente determinate della società», ma della società e della
storia in quanto tali, in quanto fonti non contingenti di corruzione
o alienazione, e il portavoce, quindi, «di un’ideologia radicalmente
anti-sociale». 2 La posta in gioco, allora, è il modo in cui si pensa,
in generale, il rapporto tra la natura e la storia dell’uomo.
Ora, che sia Rousseau stesso ad attribuire esplicitamente
all’uomo naturale un qualche uso delle cosiddette «facultés
artificielles»3, è chiarissimamente testimoniato da almeno un luogo
del Discours. All’interno di quella Seconde partie che è dedicata
alla ricostruzione del lento passaggio dal pur état de Nature a
quello stato di natura capovolto che sarebbe il dispotismo, e più
precisamente nella cornice della descrizione della cosiddetta
société naissante, Rousseau inserisce un passo che, al fine di
distinguerne l’uomo già coinvolto nel processo di socializzazione,
riassume rapidamente il ritratto dell’homme naturel fornito dalla
Première partie.
Voilà précisément le degré où étoient parvenus la plûpart des Peuples
Sauvages qui nous sont connus ; et c'est faute d'avoir suffisamment distingué les
idées, et remarqué combien ces Peuples étoient déjà loin du premier état de
Nature, que plusieurs se sont hâtés de conclure que l'homme est naturellement
cruel et qu'il a besoin de police pour l'adoucir, tandis que rien n'est si doux que
1
A. Burgio, Eguaglianza interesse unanimità. La politica di Rousseau, Napoli 1989,
p. 40.
2
Ivi, p. 29.
3 Disc., p. 134
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 2
lui dans son état primitif, lorsque placé par la nature à des distances égales de
la stupidité des brutes et des lumières funestes de l'homme civil, et borné
également par l'instinct et par la raison à se garantir du mal qui le menace, il est
retenu par la pitié naturelle de faire lui-même du mal à personne, sans y être
porté par rien, même après en avoir reçû.1
Ad essere retrospettivamente chiarito, qui, è innanzitutto il senso
della “dolcezza” propria dell’uomo primitivo, la sua strutturale
necessità all’interno della generale economia dell’opera. Essa si
dimostra infatti come l’obiezione più forte all’idea di una naturale
necessità tanto della morale quanto della politica, di un
“disciplinamento” in qualsivoglia senso repressivo delle sue
passioni, di una limitazione esterna della libertà da parte vuoi di un
controllo sociale, nella forma dei «costumi», vuoi di una forza
monopolizzata da un’autorità esterna al gioco sociale e fattasi
indipendente da qualunque controllo. 2 La libertà dell’uomo,
nonostante la sua interna illimitatezza, si mostra qui come
tutt’altro che di per sé stessa necessariamente eccessiva, rovinosa.
C’è poi un secondo aspetto del testo russoiano che rischia quasi di
passare inosservato, e che è invece per noi di centrale importanza.
Riprendendo puntualmente e radicalizzando una constatazione già
presente nella Première partie, per la quale l’uomo primitivo
sarebbe «plus attentifs à se garantir du mal qu'ils pouvoient
recevoir que tentés d'en faire à autrui», Rousseau spiega questa
perfetta assenza di ogni inclinazione al male, questa sua
“dolcezza” capace di rendere superfluo qualunque “addolcimento”,
non più soltanto – come il contesto permette qui di lasciare
nell’implicito – attraverso il fatto che il primitivo non conosce «ni
la vanité, ni la considération, ni l'estime, ni le mépris», e neppure
solo mediante quel libero gioco delle passioni nel quale la pietà
riesce a porsi come un «frein si salutaire»3 al naturale «ardeur qu’il
1
Ivi., p. 170. Tutti i corsivi delle citazioni sono nostri.
2
Per una contestualizzazione di questa idea russoiana, di un’assenza di police nelle
società selvagge, e della complessa influenza che le relazioni provenienti dall’America
hanno avuto nel pensiero europeo, vedi l’amplissima documentazione presente
nell’ormai classico S. Landucci, I filosofi e i selvaggi (1580-1780), Bari 1972.
3
Cfr. Ivi., p. 157.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 3
a pour son bien-être»1, ma anche grazie all’intervento, all’interno
di questo gioco, della ragione stessa. Se però lungo il corso
dell’intera Première partie la posizione russoiana era sembrata – e
nel modo più netto possibile – proprio quella dell’esclusione della
ragione dal quadro del «pur état de Nature», come spiegare questa
sua tardiva inclusione?2
Rimaniamo, a questo riguardo, ancora un momento ancorati al
nostro testo. Da una parte, infatti, ci pare di dover consentire con
l’interpretazione di Masters, secondo la quale l’introduzione del
passo citato in uno snodo testuale delicato come quello relativo
alla société naissante sarebbe da ascrivere precisamente
all’intenzione russoiana di «sfumare le differenze tra puro stato di
natura […] e società selvaggia». 3 Se in un primo momento la
discontinuità viene posta nella sua forma più radicale
(«sanguinaires et cruels»/«rien n’est si doux»), la radicalità di
questa disgiunzione viene immediatamente sostituita da un
rapporto di genere diverso. L’attribuzione già all’uomo primitivo,
per un verso, di quella ragione che dovrebbe caratterizzare l’uomo
in qualche misura già socializzato, e ancora al selvaggio della
société commencée, per altro verso, esattamente delle medesime
qualità che nel puro stato di natura caratterizzavano l’uomo
primitivo – «libres, sains, bons et heureux»4 – pone tra primitivo e
selvaggio, tra «primo stato di natura» e società, tra l’al di qua della
storia e la storia stessa, accanto alla cesura e all’opposizione,
un’inconfutabile continuità. In questo modo la linea del conflitto
può essere spinta al di là dell’opposizione tra il fronte della
1 Ivi, p. 154
2
Lasciamo pure da parte il grossolano errore di quanti, come Polin, riferiscono non
all’uomo primitivo ma al selvaggio già socializzato la posizione « à des distances égales
de la stupidité des brutes et des lumières funestes de l'homme civil », e dunque anche la
limitazione da parte della ragione. Si tratta infatti di un caso del tutto esemplare di come
un radicato pregiudizio interpretativo possa rendere sordi alla concretezza e addirittura
all’evidenza del testo (cfr. R. Polin, La politique de la solitude. Essai sur J.-J. Rousseau,
Paris 1971, p. 19).
3
R.D. Masters, The political philosophy of Rousseau, Princeton 1968, p. 171.
4
Cfr. Disc., p. 171, dove appare senz’altro «stridente» (cfr. S. Landucci, I filosofi e i
selvaggi, cit., p. 381) questa attribuzione da una parte di una crudeltà sanguinaria, e
dall’altra di bontà e felicità.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 4
perfetta solitudine, coincidente col puro stato di natura, e quello, di
converso, di qualunque socializzazione, e giungere a riguardare
non più, astrattamente, natura e società, ma più concretamente la
separazione tra una certa forma, ancora naturale, di socializzazione
e un’altra, che dello stato di natura segna la zona del suo «dernier
terme»,1 tracciato dall’istituzione della divisione del lavoro e,
conseguentemente, della proprietà,2 da quel «funeste hazard, qui
pour l’utilité commune eût dû ne jamais arriver»,3 e che renderà
necessario il cosiddetto “patto iniquo”.
D’altra parte c’è un punto, di importanza tutt’altro che
secondaria, sul quale con Masters non si può consentire. Se è vero
che l’immagine dell’uomo naturale era sembrata tutta costruita
proprio nel segno, tra «solitude» e «sociabilité», della più netta
discontinuità, il tardivo riconoscimento di una forte continuità tra
«primitivo» e «selvaggio», contenuto nell’assegnazione al primo,
non meno che al secondo, della raison, non può essere considerato
1
Un’opposizione, questa tra diverse forme di socializzazione, tutta interna allo stato
di natura, perché il criterio che viene assunto qui per distinguere stato di natura e stato
civile è ormai quello dell’istituzione di un’autorità politica, e non più quello della
semplice socializzazione: in questo modo tanto la morale quanto l’economia vengono
incluse però nella sfera di ciò che è naturale. La medesima ambiguità del concetto di
«stato di natura» – che in un’accezione “etnologica” «est opposé à la vie civilisée» e in
una giuridica, invece, «est opposé à l’état civil» – era già registrata, come suo secondo e
terzo significato, nell’articolo di L. de Jaucourt, «Etat de nature», nel vol. VI
dell’Encyclopédie (1756). Per una discussione dei diversi modi di intendere lo stato di
natura, cfr. S. Landucci, I filosofi e i selvaggi, cit., p. 333 sgg. Sul debito contratto da
Rousseau verso Pufendorf in questa disgiunzione, contro Hobbes, di società e Stato, cfr.
anche ivi, p. 146.
2
Il ruolo di un vero e proprio spartiacque è costituito qui dall’evento di una relazione
tra gli uomini fondata non più sulla loro reciproca indipendenza, sulle loro libere
decisioni, ma su una divisione dei compiti e delle risorse tale che ognuno, non più
soltanto nella ricerca della stima, ma per la sua stessa sopravvivenza, viene a dipendere
oltre che da tutti gli altri membri della comunità e dalla fedeltà, all’interno di
quest’ultima, al proprio ruolo, anche da un sistema il quale, nella sua impersonalità ed
oggettività, si è ormai separato dalle volontà di ogni singolo. Tale evento, infatti, separa
la storia umana in due parti che nonostante ogni loro interna articolazione vengono a
opporsi, almeno in apparenza, nel modo più netto, come una storia dell’indipendenza,
della libertà da una parte, e una storia della reciproca dipendenza, della coercizione
dall’altra; in una parola, come storia della natura l’una, e storia della politica l’altra.
3
Disc., p. 171.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 5
come l’inserzione, nel Discours, di un elemento di «confusione»,1
come se Rousseau cadesse vittima del rimprovero che egli stesso
polemicamente muove ai «plusieurs» che non hanno
«suffisamment distingué les idées», confondendo di conseguenza
il «premir état de Nature» con quello dei «Peuples Sauvages» che
ci sono noti. Quel riconoscimento, proprio al contrario, ci pare
debba essere accolto in tutta la sua forza chiarificatrice, rivelativa:
nel suo invito a ripercorrere l’intera prima metà dell’opera alla
ricerca dei luoghi in cui giungano a palesarsi, ad uno sguardo
fattosi retrospettivamente attento, le tracce di quell’incolmabile
«distanza» la quale, per il tramite della ragione, si è già da sempre
frapposta tra l’uomo naturale e la «stupidité des brutes», e che
rende tutt’altro che «ovvia» –nonostante la contraria opinione di
Landucci – la «dissociazione selvaggi-uomini di natura».2
Si tratta, cioè, di mettere a tema la questione delle facultés
virtuelles, attraverso l’esame diretto dei passaggi in cui viene
affrontata. Ognuna delle sezioni in cui questo lavoro si articola
tenterà allora, a partire dai luoghi in cui la posizione russoiana
sembra più dura, di rispondere ad una delle seguenti, semplici
domande. Il nesso che la Première partie pone tra «facultés
artificielles» da una parte, corruzione e miseria dall’altra, è
davvero quello della necessità, in modo tale che non si può in
alcun modo, senza bandirne quelle facoltà, tener ferma
l’identificazione dello stato di natura come luogo di felicità e di
innocenza? L’esclusione di ogni loro attività e sviluppo dal «puro
1
Cfr. R.D. Masters, The political philosophy of Rousseau, cit., p. 171.
2
Cfr. S. Landucci, I filosofi e i selvaggi, cit., p. 368, ma cfr. anche la nota 122 a p.
375, dove si dice che il rigore di questa dissociazione «non può trovare attenuazioni». La
motivazione di Landucci circa l’ovvietà della dissociazione tra uomo primitivo e
selvaggio verte in realtà sull’opposizione, istituita dal nostro testo, tra la dolcezza del
primo e la crudeltà del secondo. Anche su questo piano, però, non si può non ricordare
come già l’uomo naturale fosse a più riprese definito da Rousseau pericoloso e «feroce»
(cfr. Disc., p. 135, dove l’uomo viene implicitamente definito una bestia feroce tra le
altre; cfr. anche ivi, p. 136, dove quelle bestie evitano di attaccare l’uomo, di cui
conoscono la ferocia; cfr., infine, ivi, p. 157, dove gli uomini sono esplicitamente definiri
«plus farouches que méchans»; è dunque in funzione di questa già stabilita ferocia, unita
al già citato ardore per il benessere, che trova una sua plausibilità l’esempio dell’«homme
dépravé, assés paresseux, et assez féroce» fornito in Disc., p. 161).
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 6
stato di natura» può davvero esser mantenuta nella sua integralità?
Ha o non ha senso, nei termini russoiani, parlare di un’origine
dello sviluppo, dello sviluppo come abbandono dell’origine? Il
fatto che Rousseau dia mostra, nella congiunzione dell’esercizio
delle facoltà alla corruzione, e quindi nel rinvio della loro
attivazione e sviluppo ad un momento “secondo”, distante rispetto
alle origini, della più ferma – quasi ostentata – decisione, non
impedirà ad una lettura più disposta a considerare le sfumature del
testo di cogliere, al di sotto di questa fermezza, una più profonda
cautela.
Sulle profonde differenze tra homme naturel e homme civil la
letteratura specialistica si è sempre soffermata con grande
attenzione. Qui di seguito sarà invece proprio la tendenza a porre –
accanto alla più radicale discontinuità – una qualche continuità tra
puro stato di natura e storia, a dover emergere come un’esigenza
strutturale e coerente dell’intero Discours. Se l’evoluzione che ha
condotto l’uomo sino alla società civile e al dispotismo, infatti,
non può esser stata priva di strappi e di cesure, poiché altrimenti
civilizzazione, servitù e dispotismo dovrebbero esser considerati
alla stregua di un inevitabile destino proprio della specie umana in
quanto tale, dall’altra non si può negare né – con Burgelin – che
anche per Rousseau «la storia supponga necessariamente, per
essere intelligibile, una certa continuità», 1 dalla quale discontinuità
e fratture possano essere in qualche modo sorrette, né – contro
Burgelin – che, lungi dal rassegnarsi ad abbandonare l’idea della
storia ad un’impenetrabile opacità, è proprio una qualche
intelligibilità che Rousseau ha di mira nel seguire il suo
procedimento ipotetico.2 È certo possibile, infatti, «che l’uomo sia
cambiato radicalmente, sin nella sua natura»:3 la sua nature
actuelle, infatti, pur non smettendo di esser «nature», è senza
1
P. Burgelin, La philosophie de l’existence de J.-J. Rousseau, Paris 1952, p. 198.
2
Il presupposto di questo metodo, in effetti, è proprio quello che possa essere la
«filosofia» – la speculazione – a supplire alla mancante testimonianza dei fatti, alle
mancanze della storia (cfr. Disc., p. 163).
3
P. Burgelin, La philosophie de l’existence, cit., p. 197.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 7
dubbio diversa dalla quella originaire;1 e ciò nonostante, se uomo
naturale e civile fossero a tal punto divergenti da costituirsi come
due specie differenti, prive di qualunque punto di contatto, non
solo non avrebbe alcun senso il progetto russoiano di uno studio
dell’«homme en général», 2 ma la conoscenza dell’uomo naturale,
lungi dal rappresentare «la plus utile […] de toutes les
connoissances humaines», 3 non sarebbe altro che un
divertissement, un inutile vezzo intellettuale.4
1. La «réflexion», l’«animal dépravé»
1.1. Uno schema interpretativo che si rivelerà infondato
Si elle [la Nature] nous a destiné à être sains, j’ose presque assurer, que l’état de
réflexion est un état contre Nature, et que l’homme qui médite est un animal
dépravé.5
Sembra quasi scontato leggere questo passo come una vera e
propria «professione di fede antirazionalista»,6 il puntuale
capovolgimento polemico della nota tesi diderotiana per cui «celui
qui ne veut pas raisonner, renonçant à sa qualité d’homme, doit
1
Cfr. Disc., p. 123, dove si parla di «ce qu’il y a d’originaire […] dans la Nature
actuelle de l’homme». Distinguere, all’interno di questa «natura attuale dell’uomo», ciò
che è originario da ciò che invece non lo è, significa respingere la riduzione del naturale
all’originario.
2
Cfr. Disc., p. 133, dove si legge: « Mon sujet intéressant l'homme en général, je
tâcherai de prendre un langage qui convienne à toutes les Nations, ou plutôt, oubliant les
temps et les Lieux…».
3
Ivi, p. 122.
4
La descrizione russoiana dell’uomo naturale ha, per così dire, una funzione
“straniante”, che consiste nello spingere il lettore – l’uomo civile – a prendere le distanze
dalla propria identità e condizione, guardandole come “dall’esterno”, nella contingenza
della loro genesi, e non più “dall’interno”, come un semplice dato di fatto che si può
bensì constatare senza poterlo però rimettere in discussione, o come l’esito necessario cui
la storia non poteva non tendere, e al quale, dunque, non ci si può che rassegnare. Questo
effetto “straniante”, però, può essere raggiunto solo a patto che sia comunque consentita
all’uomo civile una qualche “immedesimazione” nell’uomo naturale, la possibilità di
poter riconoscere il selvaggio come un proprio simile, sé stesso come simile al selvaggio.
5
Disc., p. 138.
6
J. Starobinski, note 3, ivi, p. 1311.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 8
être traité comme un animal dénaturé».1 È a partire da simili
affermazioni, apparentemente così perentorie da non lasciar spazio
all’interpretazione, che ha potuto formarsi ed imporsi il diffuso
schema interpretativo per il quale nel puro stato di natura l’uomo
vivrebbe «nell’immediato», in una condizione nella quale cioè «la
sensazione gli rende il mondo accessibile in maniera tanto diretta
che […] sa a malapena distinguersi da quel che lo circonda», 2
consentendogli così di rimanere «uno, semplice, chiuso in sé
stesso, ignorante ogni rapporto con un mondo che non sente che
come prolungamento di sé», in «questo blocco senza fessure [che]
esclude la coscienza», 3 con lo scarto che essa implica. Tenendosi a
questo schema, sarebbe allora proprio «riflettendo, ragionando
[che] l’uomo si strappa alla comunione con la natura». 4 Non
appena smette di «seguire ciecamente il proprio impulso» 5 e
comincia a riflettere, la riflessione al tempo stesso infrange la sua
«originaria unità con sé stesso»6 e gli fa perdere «la presenza
immediata del mondo naturale». 7 L’intervento della riflessione a
«distinguere l’io dal mondo, il sé dall’altro» non può fare a meno
di condurre l’uomo ad «alienarsi», 8 rivelandosi inseparabile dal
prodursi delle dinamiche perverse legate al sorgere dell’amour-
propre. Il fatto che egli nasca «privo di inclinazione al male» non
vuol dire dunque – come invece ritiene Derathé – che «le nostre
facoltà sono sane in sé stesse, e si corrompono solo per colpa
nostra»,9 ma solo che, pur essendo di per sé stesse corrotte ed
inclini al disordine, l’uomo le possiede sì come parte integrante
1
D. Diderot, «Droit naturel», in Encyclopédie, Paris 1986, vol. I, p. 336.
2
J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. La trasparenza e l’ostacolo (1958), trad. it.
di R. Albertini, Bologna 1982, p. 58.
3
P. Burgelin, La philosophie de l’existence, cit., p. 227.
4
B. Carnevali, Romanticismo e riconoscimento. Figure della coscienza in Rousseau,
Bologna 2004, p. 75.
5
R. Derathé, Rousseau e la scienza politica del suo tempo (1950), trad. it. di R.
Ferrara, Bologna 1993, p. 202.
6
J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. La trasparenza e l’ostacolo, cit., p. 338.
7
Ivi, p. 319.
8
Ivi, p. 13.
9
R. Derathé, Le rationalisme de J.-J. Rousseau, Paris 1948, p. 14.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 9
della propria natura, ma all’inizio solo «en puissance», come delle
pure virtualità.
Finché si tiene ferma l’ipotesi di una tale «immediatezza
naturale», si deve senza dubbio concordare con Reale quando
afferma che la ragione – di cui la «riflessione» può essere
considerata uno dei molteplici “doppi” – in quanto «è nell’uomo
uno strumento di mediazione, comporta nell’atto stesso un distacco
dall’immediatezza naturale, è scelta e dunque libertà, differimento
e progetto».1 Posta questa peculiare identità tra ragione e libertà,
però, non è affatto chiaro come sia possibile allo stesso Reale,
commentando il passo sopra citato, affermare che
è il pensiero il grande prevaricatore che rompe l’ordine e non sa ricostituire
alcun ordine. Nel pensiero e attraverso di esso si radicano nell’animale uomo la
malattia e l’angoscia, la consapevolezza e l’istinto di morte, il peccato e
l’alienazione. Le enormi potenzialità che la ragione possiede sono state distorte
sin dal suo primo apparire, incanalate in una direzione in cui ogni diversa
possibilità sembra quasi essersi annullata.2
L’autore, è vero, non manca di prestare attenzione alle sfumature.
Qui, però, ci si trova di fronte a un’alternativa, che non sembra
ammettere sfumature. Si può infatti ritenere o che per Rousseau
l’annichilimento, nella corruzione, di «ogni possibilità diversa» sia
in realtà solo una parvenza; oppure – come Reale sembra propenso
a credere – che quella possibilità sia davvero «annullata», e
interpretare allora quella dispiegata nel Discours, in blocco, come
«storia di una corruzione senza rimedio». 3
Nel primo caso, quando cioè si suppone che «la ricchezza della
potenza sussista integralmente al di sotto della povertà delle sue
attualizzazioni», 4 lungi dall’esser negato qualunque orizzonte di
salvezza, la libertà si pone proprio al contrario come la riduzione
del male ad un’assoluta contingenza, una sempre attuale capacità
di autoredenzione. Il secondo caso, poi, sembra subito complicarsi,
1
M. Reale, Le ragioni della politica. J.-J. Rousseau dal “Discorso
sull’ineguaglianza” al “Contratto”, Roma 1983, p. 123.
2
Ibidem.
3
Ivi, p. 206.
4
P. Burgelin, La philosophie de l’existence, cit., p. 209.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 10
ed imporre con ciò una nuova alternativa. Ferma restando la
presupposizione di una «corruzione senza rimedio», sembra infatti
si possa ritenere o che la libertà sia essa stessa annullata, oppure
che essa si conservi, anche se solo come fattore di corruzione.
Stando alla prima soluzione, che la vuole annullata, la libertà si
farebbe presente solo nell’atto di segnare il passaggio «dalla pura
natura al divenire della storia»: 1 senza essere attiva né nella natura,
necessariamente innocente, né nella storia, necessariamente
corrotta, e senza avere dunque alcun luogo che le appartenga, essa
non potrebbe realizzarsi nel mondo se non nell’atto di sopprimere
sé stessa. Stando alla seconda soluzione, per la quale optano quegli
interpreti che, come Philonenko o Gatti, 2 ritengono di scorgere in
Rousseau un anticipatore del kantiano radikales Böse, la libertà
rimane al contrario bensì presente e operativa anche nella storia,
ma solo come «libertà incomprensibilmente volta al male» ovvero,
più semplicemente, come «libertà per il male»: esisterebbero allora
bensì molteplici forme possibili di corruzione ma, in ogni caso,
«nessuna salvezza». 3
Questo bivio tra un annullamento integrale della libertà e una
sua conservazione in una forma inevitabilmente degenerata, però,
non è che apparente. Innanzitutto perché una e la stessa, in
entrambi i casi, è la relazione tra «essere» e «divenire», ovvero tra
natura e storia: relazione che non riesce a porsi se non nel segno di
un’inconciliabile opposizione, 4 legittimando così la tesi per cui,
secondo Starobinski, l’uomo «è divenuto cattivo perché si è
abbandonato al divenire». 5 Già in quanto alterazione della natura
originaria, in questa prospettiva il divenire non può configurarsi se
1
Ivi, p. 196.
2
Cfr. in particolare R. Gatti, L’enigma del male. Un’interpretazione di Rousseau,
Roma 1996 e, Id., L’ordine naturale e il problema del male. Figure della modernità,
2001, in www.swif.uniba.it/lei/swifdisc/gatti.htm.
3
A. Philonenko, J.-J. Rousseau et la pensée du malheur, vol. I, Le traité du mal,
Paris 1984, p. 213.
4
H. Gouhier, Les méditations métaphysiques de J.-J. Rousseau, Paris 1970, p. 12:
«L’uomo è divenuto altro da quello che è; una volta ancora il divenire si oppone
all’essere; ma il divenire è qui il divenire dell’uomo, e si oppone all’essere dell’uomo: in
altri termini, è la storia che si oppone alla natura».
5
Cfr. J. Starobinski, Introduction a Disc., p. lx.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 11
non come abbandono dell’essere, e dunque come decadenza. In
secondo luogo, in entrambi i casi la storia è una storia della
necessità, e non della libertà, e la libertà, dunque, null’altro che il
nome con cui si tenta di nascondere l’incomprensibilità vuoi
dell’origine, vuoi della persistenza della corruzione. Una volta che
la storia sia intesa come soppressione della natura originaria,
«pensare l’essere che si apre al divenire non è possibile»,1 perché
il prodursi dell’una a partire dall’altra non può in ogni caso essere
pensato se non come qualcosa di impensabile: come l’«irruzione di
un factum puramente esterno, irrazionale, catastrofico», 2 l’operare
di quella stessa «contraddizione», di quel «principio totalmente
illogico»3 che sono l’unica spiegazione dell’insorgere e
dell’approfondirsi della decadenza.
In questo modo, l’alternativa si riduce a quella che già si è vista,
per la quale l’«alienazione» legata all’insorgere del pensiero o
annulla o lascia intatta la libertà di cui essa stessa è il prodotto.
All’interno di questo aut-aut, però, nessuna delle possibili
soluzioni è esente da problemi. In un caso, infatti, a venir meno è
in fondo la possibilità stessa, di fronte al male, di una
responsabilità diversa da quella –assurda però in termini russoiani
– di un peccato originale, compiuto dal primo uomo che si trovò a
strapparsi dalla felice, innocente «stupidità dei bruti» e ricaduto in
seguito sull’interezza del genere umano. La «depravazione»,
interiorizzata alla sua natura, verrebbe ad imporsi come la più
autentica vocazione dell’uomo, e ad orientarne l’azione, dunque,
secondo una ineludibile necessità, dalla quale solo un intervento
del tutto esterno, eccezionale – quello della grazia divina o, come
suo supplente, del «Legislatore»4 –, potrebbe redimerlo. Nell’altro
caso, conformemente alla classica interpretazione di Karl Barth, il
male resterebbe esterno alla natura – o al «cuore» – dell’uomo,
1
M. Reale, Le ragioni della politica, cit., p. 115.
2
J. Derrida, Della grammatologia (1967), trad. it. a cura di G. Dalmasso, Milano
1998, p. 344.
3
A. Philonenko, J.-J. Rousseau et la pensée du malheur, I, cit., p. 146.
4
Cfr. J.-J. Rousseau, Du contract social, in Œuvres complètes, cit., vol. III (d’ora in
poi: Contr.), II, 7, pp. 381 e sgg.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 12
senza riuscire ad intaccarla.1 Con Starobinski, allora, non sarebbe
«l’essenza dell’uomo ad essere compromessa, ma solo la
situazione storica». Poiché la caduta «è un incidente della storia
umana», 2 anche «la lotta contro il male è un fatto storico»: lotta
che però si configura come uno sforzo di recuperare quella «norma
immanente all’Io» che giace, immutata ed immutabile, nel
profondo della sua interiorità,3 ovvero quella stessa originaria,
immediata unità con sé stesso e con la propria essenza o natura che
l’intervento del pensiero era bensì venuto a infrangere, e che però
permane, intatta, al di sotto della scissione. La storia appare così o
come o un destino che l’uomo impone bensì a sé stesso, e che però
finisce per travolgere, con la sua natura, la sua stessa capacità di
risponderne; oppure come un fatto del tutto estrinseco, il mero
occultamento di una natura eterna, inaccessibile al mutamento,
sempre ancora disponibile e fruibile nella sua integrità. È proprio
tra questi due Rousseau inconciliabilmente alternativi – quello il
cui pensiero rappresenterebbe una sorta di «secolarizzazione
integrale» della tradizione cristiana del peccato originale e della
natura lapsa4 da una parte, quello ottimista e pelagiano dall’altra –
, ugualmente falsi, o almeno ugualmente parziali, che qui di
seguito ci si troverà costretti a muoversi, rifiutando implicitamente
ma recisamente entrambi.
1.2. La riflessione e lo spirito
Torniamo allora al nostro passo, per il quale, come sappiamo, se
la natura ci ha davvero destinati alla salute, allora si può quasi
affermare «l’état de réflexion est un état contre Nature, et que
l’homme qui médite est un animal dépravé». Giunti a questo
punto, ciò che occorre chiedersi è se davvero, come pure
sembrerebbe a prima vista innegabile, la riflessione sia identificata
1
Cfr. K. Barth, La teologia protestante del XIX secolo (1946), trad. it., Milano 1975,
pp. 268-69.
2
Cfr. J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. La trasparenza e l’ostacolo, cit., p. 39.
3
Ivi, p. 48.
4
Cfr. M. Reale, Le ragioni della politica, cit., p. 279.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 13
qui come uno «stato contro natura». La questione è più complicata
di quanto non sembri. Concludere a quella identificazione non è
possibile, a ben vedere, se non sulla base di una triplice premessa,
ammettendo cioè in primo luogo che la natura sia realmente
capace di “destinarci” a qualcosa, in secondo luogo che essa ci
abbia di fatto «déstiné à être sains», e che esista infine uno stretto
legame tra la «réflexion» da una parte e l’«histoire des maladies
humaines»1 dall’altra. Anche a voler sospendere il giudizio su
questa presunta destinazione naturale dell’uomo alla sanità, la
quale pure è tutt’altro che scontata, non ci si può esimere
dall’interrogarsi sulla natura del legame che unirebbe la riflessione
a quegli «excès de toute espèce» – come ad esempio « les aliments
trop recherchés des riches » e «la mauvaise nourriture des paure»,
o il «l'excès d'oisiveté» degli uni e l’«l'excès de travail»2 degli altri
– i quali soltanto sono la causa prossima delle malattie, e che a
loro volta devono senz’altro essere imputati piuttosto a una
socializzazione ineguale che alla semplice riflessione.
Per quanto si possa cercare, sulla relazione réflexion-maladies il
testo russoiano manca di qualunque chiarimento. Questa
circostanza ha lasciato supporre che essa si costituisca come un
nesso ben più stretto di quello che unisce la causa e l’effetto: come
un nesso, per così dire, immediato; e che perciò il suo significato
trascenda quello determinato dal proprio contesto, facendone un
simbolo dell’insorgere della corruzione in quanto tale, ovvero non
solo «physique», ma anche «morale». Non appena si assume la
natura come luogo, al tempo stesso, di una salute, di un’innocenza
e di una felicità immediate, sembra allora quasi andare da sé, di
converso, l’identificazione della riflessione, in quanto essa è
mediazione, con malattia, miseria, dolore e morte da una parte,
colpa e depravazione dall’altra. Se infatti si presuppone che
naturale sia solo l’abbandono alle «simples impulsions de la
Nature», l’acquisizione della riflessione viene a imporsi come la
prima presa di distanza, la prima deviazione rispetto a quel
1
Disc., p. 138.
2
Ibidem.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 14
«determinismo biologico» e alla semplicità di quegli «automatismi
elementari» da cui, con la salute, anche l’innocenza è definita e
garantita, e al di fuori dei quali non c’è che eccesso e malattia.
Sarebbe allora “per essenza”, come sembra ritenere Starobinski,
che la salute-innocenza «non ha coscienza di sé»,1 perché questa
«coscienza», che con la riflessione è tutt’uno, rappresenta non la
semplice condizione di possibilità, ma il fatto stesso, in generale,
della «depravazione» fisico-morale: la sua inevitabilità. Qualcosa,
inoltre, che rende ad un tempo possibile e impossibile l’esercizio
della libertà, perché nell’atto stesso di emancipare l’uomo dalla
sfera deterministica della mera impulsività, legata ai sensi, lo
sottomette a un altro impulso, autodistruttivamente rivolto
all’eccesso e alla corruzione.
Per capire se questa interpretazione riesca davvero a reggere
alla prova dell’analisi testuale, si può prendere in considerazione
un passo da cui quello sulla riflessione viene ricordato assai da
vicino, e che può quindi contribuire a chiarirne il significato. Si
tratta della fine del capoverso che, nel segnare l’abbandono del
piano puramente «Physique» della descrizione, introduce alla
trattazione del «côté Métaphysique ou Moral» dell’identità umana.
Affrontando le diversità nel rapporto di uomo e bestia con l’istinto,
Rousseau afferma che l’animale «ne peut s'écarter de la règle qui
lui est préscrite, même quand il lui seroit avantageux de le faire»,
mentre l’uomo, data la sua libertà, la sua capacità di partecipare
attivamente alle «operations» della propria natura, «s'en écarte
souvent à son préjudice», e che
les hommes dissolus se livrent à des excès, qui leur causent la fiévre et la mort;
parce que l’Esprit déprave les sens, et que la volonté parle encore, quand la
Nature se taît.2
Tornano qui con simmetrica puntualità tutti gli elementi già
visti: gli eccessi, le malattie, la depravazione. Se in precedenza era
la riflessione, ora è però lo «spirito», pare, a fungere da soggetto
dell’imputazione. Ad emergere da questa precisa simmetria dei
1
J. Starobinski, nota 3, ivi, p. 1311.
2
Ivi, p. 141.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 15
due passi è allora innanzitutto lo stretto vincolo mediante il quale,
nell’atto stesso di attribuir loro esattamente una medesima
funzione, il testo del Discours unisce réflexion ed esprit. Al fine di
comprendere il nesso réflexion-dépravation, non è dunque inutile
indagare preliminarmente lo specifico legame che tra riflessione e
spirito viene ad istituirsi.
In questa direzione si deve allora innanzitutto tener presente che
nell’uomo la «spiritualité de son âme» si esprime sia (sebbene solo
“in minor grado”)1 attraverso l’esercizio dell’«entendement», sia
nel riconoscimento di sé stesso come libero «d’acquiescer ou de
resister» alle pulsioni che pure lo attraversano e lo scuotono2. La
«spiritualità», vale a dire, consiste senz’altro nel pensiero ma,
prima ancora, da una parte nella «puissance de vouloir, ou plûtôt
de choisir», dall’altra nel «sentiment de cette puissance», nella
«conscience de cette liberté»: quel sentimento e quella
consapevolezza della libertà che soli possono spingere al suo
1
Il testo del Discours non afferma, come talvolta lo si legge, che riguardo
all’intelletto non vi sia alcuna «distinction spécifique» tra uomo e animale, ma solo che
«ce n'est donc pas tant l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique
de l'homme que sa qualité d'agent libre»: la facoltà intellettuale, come qualità distintiva,
non scompare, ma perde solo il suo primato rispetto alla libertà. Ciò nonostante, poiché
gli animali sono dotati anch’essi di intelletto, senza che ciò permetta di riferir loro alcuna
spitualité, l’intelletto umano può essere incluso nella definizione dell’esprit solo a patto
di cancellare la sua separazione dalla libertà, di subordinarsi ad essa. Cfr. ivi, pp. 141,
dove si passa senza soluzione di continuità dalla considerazione della differenza tra
intelletto animale ed umano a quella della differenza tra la mera istintualità della bestia e
l’umana libertà, e proprio l’assenza di ogni chiarimento riguardo a questo passaggio da
una differenza all’altra sembra lasciar intendere che esse non siano, alla radice, che
un’unica differenza, e che cioè la vera differenza dell’intelletto umano con quello
animale sia da individuare, prima ancora che nella sua maggiore capacità di combinare le
idee, proprio in quel suo legame con la libertà che lo priva del saldo fondamento che
l’animale, nel combinare le proprie idee, può trovare nell’istinto. La differenza tra
l’entendement animale e l’umano sembra ridursi, a prima vista, a quella «du plus au
moins». A ben vedere, però, l’intelletto umano, in quanto appartenente a un soggetto
capace di distinguersi dalla natura, è posto dal suo nesso immediato con la libertà in una
differenza non più quantitativa ma qualitativa rispetto all’analoga facoltà animale. Se
«tout animal […] combine même ses idées jusqu’à un certain point», il punto è che
nell’animale questa “combinazione” è solo uno strumento usato dall’istinto per realizzare
sé stesso, mentre nell’uomo l’assenza di un istinto priva l’operare dell’entendement di
qualunque fondamento.
2 Disc., p. 142
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 16
esercizio e renderlo possibile. Come una scelta inconsapevole, cioè
non intenzionale, è una contraddizione in termini, così non può
esser posta alcuna separazione, alla radice, tra l’essere un «agent
libre» e il riconoscersi tale, tra la liberté, o puissance, che
definisce la soggettività umana, e la conscience che la tiene a
oggetto. L’esprit si definisce dunque certo come «intelletto», ma
anche, ed anzi primariamente, come «libertà», la quale è
necessariamente anche sentimento e consapevolezza del fatto di
essere liberi, del proprio interno potere di cedere o resistere alla
forza degli impulsi. In questo modo, per la sua strutturale
congiunzione con la libertà, la riflessione viene implicitamente ad
essere inclusa nella definizione stessa dell’esprit. Contrariamente a
quanto ritiene ad esempio Polin, infatti, il senso in cui Rousseau
parla qui di «conscience» non può essere quello di una «pura
coscienza affettiva», 1 di un apercevoir che si risolve ancora in un
mero percevoir, in una semplice forma del «sentire». 2 Il
“riconoscimento di sé”, in effetti, è l’atto riflessivo per eccellenza,
al quale ogni altro può essere ricondotto. Non può essere il
semplice sentire – oltre che a porsi come il sentimento di
un’indeterminata, indistinta puissance – a distinguere al proprio
interno la possibilità di «acconsentire» e quella, invece, di
«resistere» all’impulso, perché in effetti solo ciò che è dato, ciò
che è presente può essere sentito, mentre entrambe quelle
possibilità riguardano proprio ciò che, in quanto ancora solo
possibile, non può in nessun modo essere “dato”.
Il testo russoiano ha dunque lasciato emergere l’inseparabilità sia
della liberté – intesa almeno nella sua forma di «puissance de
vouloir ou plûtôt de choisir» – dalla «coscience de cette liberté»,
sia di quest’ultima dalla réflexion. La riflessione è un aspetto
ineliminabile dell’esprit, e della libertà che lo definisce.
Ammettere che quello tra riflessione e corruzione si imponga come
un nesso immediato, dunque, significa postulare che liberté e
spiritualité de l’ame appartengano a un ordine non solo diverso,
1
A. Philonenko, J.-J. Rousseau et la pensée du malheur, I, cit., p. 185.
2
Cfr. R. Polin, La politique de la solitude, cit., p. 57.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 17
“ulteriore”, ma anche direttamente contrapposto a quello della
Nature, a quella sua «innocenza» che in fondo è solo un altro
modo di nominare la sua intima conformità a leggi rigidamente
necessarie. Diversi sono allora gli interrogativi che non ci si può
esimere dal porre. È quanto meno dubbia, infatti, la disponibilità di
Rousseau ad ammettere che la libertà – come malattie ed eccessi –
sia non per accidente ma per essenza «contre Nature», che sia essa
stessa una forma di malattia o di eccesso. Se per un verso già nel
Discours si fa strada la consapevolezza che, come la «raison» è di
per sé stessa «sans principe», così l’«entendement» è «sans
règle»,1 per altro verso diventa allora piuttosto complicato
ammettere che sia proprio la libertà, questa privazione di ogni
necessità, a porsi quale necessità della corruzione, e questa
mancanza di princìpi, allora, come l’inevitabile principio della
decadenza. Perché mai l’assenza di una regola rigidamente già
data dovrebbe costituirsi per l’uomo quale fondamento di una
costitutiva sregolatezza, di una fatale tendenza all’eccesso, e non,
al contrario, della sua capacità di dare a sé stesso la regola da
seguire, di una sua imprescindibile autonomia? Sono davvero la
volontà e lo spirito, allora, a produrre l’insorgere della
depravazione, oppure ciò che negli «uomini dissoluti» si esprime e
si approfondisce, attraverso l’esercizio della volontà, sono le
ripercussioni soggettive, individuali di una dissolutezza oggettiva e
generalizzata, la quale è in realtà già presente e dipende non dalla
volontà dei singoli, ma da quella socializzazione diseguale lungo
la quale la «la manière de vivre simple, uniforme, et solitaire qui
nous étoit prescrite par la nature»2 viene a capovolgersi, per un
«concours singuliers […] de circonstances»3 indipendenti dalla
volontà di ognuno, in quella «extrême inégalité dans la maniére de
vivre»4 che fa l’uomo «sociable et Esclave»?5
1
Cfr. J.-J. Rousseau, Emile, ou de l’éducation, in Œuvres complètes, cit., vol. IV
(d’ora in poi: Émile), p. 601.
2
Disc., p. 138.
3
Ivi, p. 140.
4
Ivi, p. 138.
5
Ivi, p. 139.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 18
Per comprendere questi punti è alla lettera del testo russoiano
che occorre innanzitutto prestare attenzione. Concentriamoci allora
sul ruolo svolto dall’esprit e dalla libertà, consapevoli del loro
legame con la riflessione. Se negli «uomini dissoluti […] lo spirito
deprava i sensi», è precisamente perché «la volontà parla ancora
quando la natura tace», perché cioè, attraverso l’esercizio della
propria puissance de choisir, l’esprit giunge a modificare quella
stessa sensibilità che pure era sembrata in precedenza una struttura
meramente fisica e rigidamente predeterminata, partecipe cioè
della stessa necessità delle «loix de la Mécanique», e dai cui
automatismi la condotta dell’uomo naturale sembrava interamente
determinata. La sensibilità stessa, infatti, è non già messa a tacere,
ma depravata, alterata. Lo stesso mécanisme des sens, in questo
modo, si rivela allora come qualcosa non solo di suscettibile di
divenire, di storicità, ma anche di omogeneo allo spirito, perché
solo in quanto tale è capace di essere alterato, di accogliere su di sé
l’influenza di una «puissance» – quella propria della volontà – che
è appunto non fisica ma spirituale. Ad interessarci, però, è un altro
aspetto della questione: il fatto, vale a dire, che tale permeabilità
della sensibilità allo spirito sia non un frutto tardivo e corrotto
dell’evoluzione, ma un dato originario e strutturale, una sua
intrinseca qualità. Affermando che il modo in cui la volontà funge
da tramite all’approfondirsi della corruzione è quello di colmare
con la propria voce il sopravvenuto silenzio della natura,
Rousseau, a ben vedere, sta affermando anche qualcos’altro. Se la
volontà «parla ancora» quando la natura, invece, si tace, vuol dire
che neanche quando la natura non taceva la volontà poteva fare a
meno di parlare. «Vouloir et ne pas vouloir, désirer et craindre»,
infatti, «seront les premières […] operations de son ame». 1 Per
questa sua peculiare “priorità”, che ci costringe a riconoscerla
come qualcosa di assolutamente originario, della volontà non si
può affermare né che comincia a parlare, al fine di compensarlo,
solo in seguito all’intervenuto silenzio della natura, né che sia il
suo stesso parlare a mettere necessariamente a tacere la natura: a
1
Ivi, p. 143.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 19
meno di non ammettere che la natura sia stata già da sempre
imbavagliata, la sua voce soffocata già nell’uomo del puro stato di
natura.
Il fatto che la volontà «parli ancora quando la natura tace»,
come si vede, non è affatto una situazione di per sé deplorevole,
come quella che in Descartes verrebbe a configurarsi qualora la
volontà pretendesse – come del resto è in suo potere – di
continuare ad affermare e negare anche al di là del confine della
certezza intellettuale. Che la volontà si faccia sentire anche nel
silenzio della natura è infatti una semplice necessità, se è vero che
nella storia non possono fare a meno di prodursi situazioni sulle
quali la natura non ha direttamente nulla da dire e ciononostante è
necessario deliberare. In un senso ancora più radicale, il problema
è che non solo la natura, con le sue premières impulsions, non può
imporsi all’uomo naturale come una regola universale, rispetto alla
quale ogni sua azione particolare debba essere giudicata conforme
o contraria, ma che essa non è neppure una regola di fronte alla
quale all’uomo sia possibile limitarsi a rispettarla o a violarla,
perché non solo si è già sempre riconosciuto libero di
sottometterlesi o resisterle, ma è già da sempre anche chiamato a
partecipare egli stesso alla sua determinazione. La natura non solo
non esclude l’attiva partecipazione dell’uomo, ma la esige essa
stessa, richiedendo già da sempre, già nel puro stato di natura,
l’attivo coinvolgimento della «puissance de vouloir», e con essa
della riflessione. «L'homme sauvage», infatti, «livré par la nature
au seul instinct, ou plutôt dédommagé de celui qui lui manque
peut-être, par des facultés capables d'y suppléer d'abord, et de
l'élever ensuite fort au-dessus de celle là, commencera donc par les
fonctions purement animales»1 , legate cioè al soddisfacimento dei
suoi soli besoins physiques. Neanche nell’adempimento di queste
fonctions purement animales, allora, quelle facultés possono
restare inoperative. La stessa mancanza di un istinto fa sì che,
paradossalmente, l’uomo possa sia sottomettersi sia resistere alla
«règle», al «principe» che la natura rappresenta, ovvero alle
1 Ivi, pp. 142-3.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 20
proprie pulsioni, solo dopo averne determinato egli stesso il
contenuto,1 facendo libero uso delle proprie facoltà. Se ogni
animale non è che « une machine ingenieuse, à qui la nature a
donné des sens pour se remonter elle-même, et pour se garantir,
jusqu'à un certain point, de tout ce qui tend à la détruire, ou à la
déranger», è la stessa natura della machine humaine,
l’indeterminatezza cioè del suo istinto, ad esigere che la libertà e le
altre facoltà concorrano con la natura, ovvero con il mechanisme
des sens, alla determinazione di quelle operations che la natura
compie «da sola» nella bestia.2 Per questa sua naturale funzione,
della libertà non si può dire, con Starobinski, che «resti senza
impiego, lasciando che l’uomo di natura sia libero per niente [pour
rien]»;3 ovvero, con Baczko, che essa nell’uomo naturale «non sia
cioè messa a profitto, non stimoli alcuna attività, non serva ad
alcuna scelta»: 4 che «la sua esistenza» – lungi dal condursi
consapevolmente, autonomamente – «sia regolata esclusivamente
dal corso della natura e da leggi puramente fisiche». 5 Con Polin, al
contrario, occorre riconoscere la presenza di una «libertà che è
naturalmente in armonia con l’ordine della natura». 6 Esattamente
lo stesso deve dirsi allora delle altre facoltà, e innanzitutto della
riflessione, che dalla libertà sono inseparabili.
Il precedente rinvenimento di un’analoga posizione di réflexion
ed esprit rispetto alla medesima depravazione, e una prima
constatazione di una loro originaria operatività, non possono non
indirizzarci verso una differente lettura della posizione della prima
1
È proprio per questo, come sappiamo, che l’uomo naturale è essenzialmente,
strutturalmente innocente: perché la «voix de la Nature» – quella stessa «voix» attraverso
la quale deve farsi sentire la «loi naturelle» – non ha altro senso se non quello che la
volontà stessa (nella sua unità con l’entendement-réflexion) «concorre» a determinare, o
a chiarire, ed è allora perfettamente insensato parlare di una violazione da parte
dell’uomo di quella regola che egli stesso ha deliberatamente imposto a sé stesso.
2
Cfr. ivi, p. 141.
3
J. Starobinski, Du Discours de l’inegalité au Contract social, in AA.VV., Études
sur le «Contrat social» de J.-J. Rousseau, Paris 1964, p. 99.
4
B. Baczko, Rousseau. Solitude et communauté, Paris-La Haye 1974, p. 90.
5
L. Pezzillo, Rousseau e Hobbes. Fondamenti razionali per una democrazia politica,
Genève-Paris 1987, p. 37.
6
R. Polin, La politique de la solitude, cit., p. 51.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 21
nella complessiva architettura del Discours. Che sia l’esprit, nella
sua libertà, a “depravare” i sensi, e che cioè questa corruzione non
possa non esprimersi spiritualmente ed essere liberamente accolta,
non significa affatto che l’esprit non possa, quella corruzione, non
porla in atto, ma solo che, dove esso sia presente, debba esserlo
anche una puissance che è costitutivamente esposta alla possibilità
dell’eccesso, della depravazione, e dunque alla possibilità di
esercitarsi, nell’uomo, «spesso [ma allora non sempre,
necessariamente] a suo danno». È proprio in questa possibilità, del
resto, che si giustifica l’inserzione, già nella descrizione del puro
stato di natura, di quell’homme dépravé che è spinto dalla sua
naturale pigrizia al tentativo – destinato al fallimento – di
sottomettere l’altro uomo ai capricci del proprio arbitrio.1 L’esprit,
che con la libertà è tutt’uno, costituisce dunque solo l’originaria
capacità, propria dell’uomo, di modificare sé stesso, sin nella
propria natura sensibile. In quanto tale esso non è che la
necessaria, naturale condizione di possibilità della depravazione, e
il medium attraverso il quale, quando sia giunta a farsi presente,
essa deve pure trovare espressione. Poiché però spiritualité e
liberté, come si è detto, dalla réflexion non possono in alcun modo
essere separate, è impossibile che questa, diversamente da quelle,
si costituisca come fondamento, rispetto ad una medesima
depravazione, di una sua ineluttabile necessità. Il collegamento,
nel segno della necessità, di riflessione e corruzione, operato dalla
maggior parte degli interpreti, non è che un fraintendimento.2
1
Cfr. Disc., p. 161. Per l’importanza generale che ci pare rivestire questa lunga
digressione russoiana, ci riserviamo di parlarne più diffusamente altrove. Per ora,
ricordiamo soltanto che ad essere ammessa nel passo citato è la possibilità di una
depravazione la quale, per quanto incapace di successo, è comunque tutta interna al puro
stato di natura, e determinata da condizioni in ultima istanza assolutamente naturali, e più
precisamente dalla «ferocia», che abbiamo già visto propria dell’uomo naturale, e da
quella pigrizia che con l’«ardore per il benessere» è tutt’uno, e che in Disc, Note x, p.
211 viene detta comune alla «plûpart des animaux, sans en excepter l’homme».
2
Sarebbe ciò nonostante impossibile, oltre che ingeneroso, affermare che esso sia
privo di qualunque fondamento nel testo russoiano stesso. L’intento dichiarato
dell’opera, infatti, è quello di spiegare l’insorgere e il progressivo sviluppo, assieme alla
disuguaglianza, di quell’«excès de corruption» da cui è caratterizzato il dispotismo,
questo stato di natura capovolto (ivi, p. 191). Il metodo costantemente usato da Rousseau
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 22
1.3. L’oggetto della critica
Rileggendo le parole di Rousseau alla luce delle precedenti
considerazioni non è difficile, da una parte, scorgere quella cautela
che la loro forza polemica e retorica, senza potervi riuscire fino in
fondo, è tutta tesa a rimuovere, a dissimulare, e individuare
dall’altra quale sia il bersaglio concreto che si nasconde al di sotto
dell’apparenza di un attacco rivolto alla riflessione in quanto tale.
Non solo non vi si afferma, ma vi si osa solo «quasi» assicurare
che «lo stato di riflessione è uno stato contro natura», ma questa
quasi-affermazione riguarda inoltre, come si vede, non l’atto, o
è però quello di lasciar sempre balenare la corruzione, già quando essa è assente, in
relazione a quegli elementi che, pur ancora incorrotti, si sa già retrospettivamente che
dovranno contribuire alla sua produzione. Il fatto che nella ricostruzione genealogica
della modernità messa a punto attraverso il Discours la meta – la corruzione dell’uomo
civilizzato – sia data per così dire già prima dell’inizio, costringe il racconto a
risussumere ad essa ogni propria movenza, assumendo così il ritmo e l’apparenza di un
progressivo farsi manifesto di un destino che sembra sempre già presente – già compiuto,
già scritto – all’orizzonte. (Sulla fine del racconto come già data, cfr. A. Burgio,
Necessità della storia e storia impossibile. Per un’analisi metodologica del «Discours
sur l’inégalité» di Rousseau¸ «Studi settecenteschi», vol. 11-12, 1988-89, p. 138, dove si
legge che «è il giudizio di condanna dello stato attuale delle cose, che determina la forma
complessiva del racconto e il suo stesso esordio»). Riguardo alla riflessione, ad esempio,
potrebbe quasi sembrare – come spesso si è preteso – che la descrizione del suo
“insorgere” rappresenti una forma secolarizzata di spiegazione dell’originario avvento
della corruzione “morale”, del peccato originale, dell’orgoglio. In realtà essa non
costituisce se non la presa di consapevolezza, da parte dell’uomo, della propria
superiorità in quanto membro della specie umana sugli altri animali. A presentarsi, cioè,
è da una parte una prima forma di coscienza di specie, e dall’altro il riconoscimento di
una superiorità cui l’uomo, se è vero – come Rousseau ripeterà in diversi luoghi della sua
opera – che egli è il «Roy de la terre» (Emile, p. 582), può andare a giusto titolo
orgoglioso. Se infatti ci si sofferma sull’aspetto “morale”, poi, si vede bene che in Disc.,
p. 165-6: a) il presentarsi della riflessione non è, già di per sé, quello del vizio
dell’orgoglio, della pretesa, cioè, di essere superiore al proprio simile, ma solo un fattore
da cui l’orgoglio è “preparato”, che ne costituisce cioè una condizione necessaria sì, ma
insufficiente: la necessaria condizione di possibilità, ma non la necessità del suo attuarsi;
b) il primo esito della riflessione è, nell’atto stesso in cui si produce la consapevolezza
della propria superiorità sugli altri animali, il riconoscimento della propria somiglianza
con l’altro uomo, che è al tempo stesso riconoscimento dell’uguaglianza col proprio
simile. Si vuol forse dire che il riconoscimento della naturale uguaglianza tra gli uomini
sia per Rousseau un peccato?
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 23
l’attività, ma solo lo «stato di riflessione». La riflessione è la
facoltà che sola consente all’uomo naturale di determinare i propri
desideri o i propri timori, come pure, facendo «bientôt la
comparaison» tra le proprie forze e quelle della bestia che ne
minaccia l’incolumità, scegliere liberamente tra «le prendre ou le
laisser»m di compiere «le choix de la fuite ou du combat»1: ed è
proprio per questa sua originaria necessità che ad essere «dépravé»
non può essere, di per sé, l’uomo che riflette. «Contre Nature»,
«dépravé», non è l’uomo che usa la riflessione in vista di una
qualche utilità, di un qualche «intérêt présent et sensible»2 ma,
ripetiamolo, «l’homme qui médite», quello cioè che nella
riflessione si trova a sostare gratuitamente, senza motivo, senza
esservi spinto da quell’«amour du bien-être» che è «le seul mobile
des actions humanines»3 conforme all’ordine della natura.
Nel nostro passaggio, è vero, riflessione e meditazione
sembrano tutt’uno. Non appena si rivolge lo sguardo al più ampio
contesto della Première partie, però, dell’«uomo che medita» non
è impossibile ricostruire un identikit più dettagliato e aderente.
Egli non è l’uomo naturale reale, ma solo l’uomo naturale che
secondo Rousseau i Philosophes si foggiano «à leur exemple»4,
trasportando «à l’état de Nature des idées que’ils avoient prises
dans la société»5. «Très grand raisonneur et […] profond
mataphsicien»,6 proprio come un filosofo quest’uomo, che esiste
solo nei «livres, […] qui sont menteurs», 7 scopre da solo «les plus
sublimes vérités» e costruisce, «par des suites de raisonnemens
très abstraits, des maximes de justice et de raison».8 È il loro
stesso fondamento su questi «ragionamenti molto astratti» e su
«Connoissances que les hommes n’ont point naturellement»,
assieme alla loro conseguente incapacità di parlare con quella
1 Ivi, p. 136
2
Ivi, p. 166.
3
Ibidem.
4
Ivi, p. 145.
5 Ivi, p. 132
6
Ivi, p. 125.
7
Ivi, p. 133.
8
Ivi, pp. 145.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 24
«voix de la Nature» che è la voce non della ragione, ma della
sensibilità, a rendere «presque arbitraires» queste «regole di
giustizia», identificabili con la presunta legge naturale dei
giusnaturalismi. 1 In effetti, come si legge altrove, «il y a longtms
que le Genre-humain ne seroit plus, si sa conservation n’eût
dépendu que des raisonnemens de ceux qui le composent».2
«L’uomo che medita», se pretendesse di orientare il suo
comportamento solo su quelle astrattissime «regole di giustizia»,
negando ogni ascolto alle proprie passioni, altro non sarebbe, in
realtà, se non un «monstre»,3 come ogni uomo il quale fosse per
ipotesi privo di pietà, o ne avesse volontariamente soffocato la
voce, e in cui la vuota universalità della «regola» potesse
affermarsi solo attraverso la rescissione del rapporto, nel loro
legame, col proprio e con l’altrui sentire.
«L’uomo che medita», dunque, e che viene definito un
«animale depravato», non è che il filosofo, o colui che
corrispondesse davvero alle sue fantasie. «C’est la réflexion», è
vero, «qui replie l’homme sur lui-même; c’est elle qui le sépare de
tout ce qui le gêne et l’afflige», facendone appunto un «monstre».
Ma anche questa affermazione, così perentoria da sembrar quasi
confutare l’intera argomentazione svolta sinora, si traduce
immediatamente in un’altra, che ne chiarisce il senso più
determinato.
C'est la Philosophie qui l'isole ; c'est par elle qu'il dit en secret, à l'aspect
d'un homme souffrant : péris si tu veux, je suis en sureté. Il n'y a plus que
les dangers de la société entiére qui troublent le sommeil tranquille du
Philosophe, et qui l'arrachent de son lit. On peut impunément égorger son
semblable sous sa fenêstre ; il n'a qu'à mettre ses mains sur ses oreilles et
s'argumenter un peu pour empêcher la Nature qui se révolte en lui, de
l'identifier avec celui qu'on assassine. L'homme Sauvage n'a point cet
admirable talent […], on le voit toujours se livrer étourdiment au premier
sentiment de l'Humanité.4
1
Ivi, p. 125.
2
Ivi, pp. 156-7.
3
Cfr. ivi, p. 155.
4
Cfr. ivi, p. 156.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 25
Come vedremo nell’ultimo paragrafo, questa stessa humanité,
attraverso la quale il selvaggio si abbandona alla propria
identificazione con l’altro, rimane impensabile per Rousseau senza
quella medesima riflessione che «fa ripiegare l’uomo su sé stesso».
Sin d’ora, comunque, risulta sin troppo chiaro che nella sua
polemica Rousseau non mira affatto, genericamente, alla
riflessione o alla ragione in quanto tali, ma all’uso che,
storicamente, ne hanno fatto giusnaturalismo e philosophes. Da
una parte infatti, come si intuisce dall’esempio appena riportato, ad
essere rifiutata è innanzitutto l’impostazione razionalistica del
problema della legge naturale, per la quale alla moralité, nella sua
prestabilita armonia con l’intérêt, sono proprie delle regole che
non spetterebbe agli uomini, nella contingenza dei loro rapporti
reciproci, produrre e dare spontaneamente a sé stessi, ma che
invece, per il loro stesso bene, essi non potrebbero far altro che
limitarsi a ricevere – nella loro assoluta verità, nella loro identità
con la ragione – direttamente dalla propria natura e dunque, in
ultima istanza, da Dio stesso: verità alla quale, in questa sua
esteriorità rispetto al legame sociale e affettivo, di cui deve fondare
la legittimità, rimarrebbe in fondo indifferente se a farsene custodi
fossero gli uomini stessi che alle regole sono soggetti, o una
qualche autorità esterna e sovrana. Dall’altra parte, a trasparire
attraverso il Discours sur l’origine de l’inégalité, è una sorta di
indiretta intensificazione e radicalizzazione teorica della polemica
già ingaggiata nel Discours sur les sciences et les arts e nelle
discussioni che ne seguirono la pubblicazione. Nella Préface au
Narcisse, ad esempio, dopo aver constatato come tutti i vizi di cui
ha appena parlato «n’appartiennent pas tant à l’homme, qu’a
l’homme mal gouverné»1, e subito dopo aver inserito
un’importante nota sulla differenza tra selvaggio ed uomo civile,
Rousseau si trova ad affermare che
La science n’est point faite pour l’homme en général. […] Il est né
pour agir et penser, et non pour réfléchir. La réflexion ne sert qu’à
1
Cfr. J.-J. Rousseau, Préface au Narcisse, in Œuvres complètes, cit., vol. II, p. 969
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 26
le rendre malheureux sans le rendre meilleur ni plus sage : elle lui
fait regretter les biens passés et l’empêche de jouir du présent : elle
lui présente l’avenir heureux pour le séduire par l’imagination et le
tourmenter par les desirs, et l’avenir malheureux pour le lui faire
sentir d’avance. L’étude corrompt ses moeurs, altére sa santé,
détruit son tempéramment, et gâte souvent sa raison […].1
Il tempérament che qui è corrotto dalla riflessione, spinta a quel
livello in cui essa si emancipa dagli scopi dell’agire, è esattamente
lo stesso che nell’uomo naturale – affinché fosse possibile che egli
sopravvivesse in solitudine e senza l’aiuto di strumenti, e che lo
stato di natura non portasse già in sé il destino di un proprio
immediato annientamento – doveva essere «robuste et presque
inaltérable»,2 e tale da presentare in sé «toute la vigueur dont
l’espèce humaine est capable». 3 Ma che differenza può mai esser
posta, qui, tra quel «pensare» per il quale – assieme all’«agire» –
l’uomo sarebbe pur sempre «nato», e il «riflettere», che invece
«serve solo a renderlo infelice»? A noi pare che essa sia
esattamente la stessa che, come vedremo meglio nel prossimo
paragrafo, distanzia e congiunge i diversi gradi di sviluppo, o
meglio le diverse forme in cui l’energia di una stessa facoltà può
incarnarsi. È la stessa differenza che, come già si è accennato,
distingue le due figure in cui la réflexion può fissarsi, e dunque le
opposte generalità proprie, l’una, dell’humanité, rivolta
indifferentemente ad ogni singolo uomo, e l’altra della
philosophie, rivolta ai soli «dangers de la société entiére»:
riguardanti cioè l’una gli individui ma non la società, e l’altra
questa ma non quelli. È la stessa differenza, per fare un altro
esempio, che distingue altre due forme della stessa riflessione:
«prévoyance» e «prudence machinale». 4 Se la prima è infatti
espressione e strumento di quell’estensione dei bisogni che nel
selvaggio rappresenterebbe una «tentation […] de cesser de
1
Ivi, p. 970.
2
Disc., p. 135.
3
Ibidem.
4
Ivi, p. 165: si noti che la «machinale prudence» rappresenta una «quelque sorte de
réflexion».
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 27
l’être», e deve perciò essere rigorosamente esclusa dal quadro del
puro stato di natura, la seconda è quel «degré de prévoyance»1 che
rende l’uomo naturale «plus attentif à se garantir du mal qu’il peut
recevoir que tenté d’en faire à autrui», 2 e fa sì che « ses projets
bornés comme ses vues, s’étendent à peine jusqu’à la fin de la
journée».3 Se nella fase precedente della produzione russoiana la
critica era rivolta alla riflessione innanzitutto per il suo rapporto
con una cultura malata e corruttrice dei costumi, nel Discours
questo aspetto, pur ancora presente, passa in secondo piano,
venendo risussunto alla polemica antigiusnaturalistica. Rousseau
conosce bene il legame che nel pensiero hobbesiano, ad esempio,
unisce la prudenza determinata dalla paura all’illimitatezza dei
desideri e questa, a sua volta, al pactum subiectionis. Fissandosi
come previdenza, come una «raison sans sagesse» che è legata ad
un «plaisir sans bonheur», 4 è vero, anche per Rousseau la
riflessione spinge necessariamente l’uomo, nel tentativo di
assicurarsi da ogni male, a immaginarsi «follement […] le seul
propriétaire de tout l’Univers».5 È allora alla prévoyance che deve
essere ricondotta quella «concurrence et rivalité» che da una parte
fa nascere un «désir caché de faire son profit aux depends
d’autrui», 6 spingendo dall’altra a quel «travail continu »7 nel quale
l’uomo «suë, s’agite […], travaille jusqu’à la mort »,8 e in forza
del quale gli uomini, una volta insorto il conflitto, si trovano ad
avere «trops d’affaires à démêler entr’eux […] pour pouvoir
longtems se passer de Maîtres»9: troppi impegni privati, insomma,
per poter fare a meno di una politica intesa innanzitutto come
freno, contenimento e limitazione esterna della libertà e del diritto
originari. Possiamo invece pensare che la prudence machinale, che
1
Ivi, p. 144.
2
Ivi, p. 157.
3
Ivi, p. 144.
4
Ivi, p. ultima pagina del discorso.
5
Ivi, p. 153.
6
Ivi, p. 175.
7
Ivi, p. 145.
8
Ivi, p. 192.
9
Ivi, p. 177.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 28
come l’humanité nasce dalla riflessione, corrisponda all’originaria
presenza, individuata da Kramer-Marietti, di un «principio di
realtà» capace di affiancarsi al «principio di piacere»: 1 un principio
principio che, sottraendo l’uomo a quel «godimento immediato»2
nel quale, secondo molti interpreti, il desiderio si troverebbe
«circoscritto nell’angusto limite dell’istante», 3 è indispensabile
all’uomo naturale per riuscire a determinare già «les précautions
les plus nécessaires à sa sûreté», 4 e date le quali il pur naturale
bisogno di sécurité può trovare soddisfazione già nel puro stato di
natura, senza cioè l’intervento della “disciplina statale”, della
police. Attraverso questa distinzione tra due diverse figure in cui si
esprime l’energia della riflessione, l’una originaria e incorrotta e
l’altra al tempo stesso più sviluppata e funzionale alla corruzione,
l’assenza di un legame necessario tra riflessione e corruzione non
solo dimostra di essere chiaramente testimoniata dai testi, ma
rivela inoltre la propria coerenza con la più generale intenzione
russoiana da una parte di delegittimare la pretesa fondazione di
politica e diritto, e di una loro funzione essenzialmente repressiva,
su una natura umana pensata come di per sé stessa incline al
disordine, e di lasciare perciò aperta, d’altra parte, la possibilità di
una politica diversa, che sia espressione positiva di autonomia e
libertà, e non strumento dissimulato dell’asservimento, vettore
dell’ineguaglianza.
Nell’affrontare fin qui la questione del loro nesso con la
dépravation, ci è già capitato di incontrare indizi di una presenza
ed operatività originarie di réflexion ed esprit ovvero, più in
generale, di quelle facultés che pure l’uomo naturale dovrebbe
aver ricevuto solo «en puissance». Qui di seguito non potremo
allora non sottoporre a verifica l’autenticità di queste tracce, e
cercare di comprendere se esse siano da attribuire ad una interna
1
Cfr. A. Kramer-Marietti, Droit naturel et état de nature, in AA.VV., J.-J. Rousseau
et la crise contemporaine de la conscience, Paris 1978, pp. 175-208, e in particolare pp.
186-7.
2
R. Polin, La politique de la solitude, cit., p. 43.
3
J. Starobinski, Introduction a Disc., p. lvi.
4
Ivi, p. 165.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 29
contraddizione del pensiero russoiano, oppure segni di una sua più
nascosta coerenza.
2. Esclusione, inclusione, sviluppo
2.1. La perfettibilità neutralizzata?
Domandando «jusqu’à quel point pourroient se perfectionner, et
s’éclairer mutuellement des hommes qui […] se rencontreroient
peut-être à peine deux fois en leur vie, sans se connoître, et sans se
parler»,1 Rousseau sembra compiere implicitamente, riguardo alla
perfectibilité, una duplice riduzione. Da una parte, nell’identificare
“perfezionamento” e “illuminazione”, quella «faculté […] presque
illimitée»2 sembra esser risolta nell’indeterminata capacità, propria
della specie umana, di estendere sempre ulteriormente,
indefinitamente, il proprio capitale di conoscenze. Dall’altra,
riconoscendola come dipendente dal configurarsi di rapporti
sociali stabili all’interno dei quali un linguaggio comune consenta
ai singoli di scambiare e condividere quelle conoscenze, sembra
che la «faculté de se perfectionner»3 propria dell’uomo tanto come
singolo quanto come specie venga ridotta a quella di «se
perfectionner […] mutuellement», a una facoltà che nel singolo
potrebbe attivarsi soltanto all’interno di un contesto comunicativo,
in una situazione di reciprocità: una facoltà che solo in quanto
essere già socializzato può esser propria del singolo, e in forza
della quale non possono comunque mai essere i singoli stessi a
sviluppare direttamente sé stessi e le proprie possibilità, perché
sarebbe invece unicamente l’incontro, il contatto, la relazione – la
socializzazione – nella diversità delle sue forme concrete, ad
innescare e indirizzare lo sviluppo di chi vi si trovi coinvolto.
All’interno della discussione sull’origine e sul progresso delle
lingue e presente nella Première partie si trova un passo che
sembra offrire una forte conferma a questa duplice riduzione.
1
Ivi, p. 146.
2 Ivi, p. 142.
3
Ibidem.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 30
Rousseau parla delle «idées générales» come, da una parte,
«purement intellectuelles» e tali, dall’altra, da non poter
«s’introduire dans l’Esprit qu’à l’aide des mots», perché
«l’entendement ne le saisit que par des propositions». 1 È proprio in
forza di questo loro intrinseco rapporto col linguaggio che gli
animali, nonostante siano già stati dichiarati anch’essi portatori di
una qualche forma di «entendement»,2 non possono acquisire né
quelle idées né, di conseguenza – ed è proprio questo il punto –,
«la perfectibilité qui en dépende».3 Poiché però gli animali diversi
dall’uomo non possono acquisire nessuna perfettibilità, pare che
sia la perfettibilità in quanto tale, nella sua interezza, a “dipendere”
dalle «idee generali» e «puramente intellettuali»: prodotte da un
intelletto il cui pensare, nel suo carattere invalicabilmente
linguistico, è sempre un operare sociale, un lasciar pensare quel
linguaggio nel quale è la società ad aver accumulato, depositato e
reso disponibile ai suoi singoli membri il proprio patrimonio di
conoscenze ed esperienze, la propria storia.
Come qualità distintiva dell’essere umano, su questi presupposti
la perfectibilité si troverebbe in ultima istanza a dover o cedere il
posto al langage, o identificarsi con esso. Come le «circonstances»
per la perfettibilità, 4 le «parole» sono infatti per l’attività
1
Cfr. ivi, pp. 149-150.
2
Cfr. ivi, p. 141.
3
Ivi, p. 149: « C'est une des raisons pour quoi les animaux ne sauraient se former de telles
idées, ni jamais acquérir la perfectibilité qui en dépend». Si tratta di capire, in realtà, se tale
affermazione vada letta nel senso che sia “tutta” la perfettibilità o piuttosto solo una
qualche “parte” a dipenderne: «la perfectibilité, qui en dépend» o «la perfectibilité qui en
dépend»? La versione russoiana, in realtà, è la seconda. Né il mutamento che la
perfettibilità rende possibile è tale da riguardare, nell’uomo, solo le sue idee o
conoscenze, rimanendo esterno, per tutto il resto, all’identità profonda dell’uomo, né può
essere il sapere o non sapere ad essere assunto come suo fondamento unico, come se il
corso della storia dipendesse solo dalla conoscenza, dalla consapevolezza dell’uomo.
Senza approfondire qui questi problemi, non si può non notare come sia proprio
nell’assenza di una semplice virgola, nel vuoto che questa assenza spalanca tra
perfettibilità e conoscenza, che giunge a farsi presente l’interezza del pensiero russoiano,
della sua antropologia come della sua concezione della storia.
4
Cfr. Disc., p. 142: «faculté qui, à l’aide des circonstances, développe
successivement toutes les autres», dove le «circostanze» – come le parole per il pensiero
– vengono nominate appunto come un «aiuto» alla perfettibilità.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 31
dell’entendement, e per le conoscenze che esso produce, molto più
che un semplice «aiuto» esterno, di un veicolo che si limitasse a
trasportare dei contenuti, immutati, dall’esterno all’interno
dell’esprit, quasi che quest’ultimo non fosse la loro patria
originaria. In questo modo, però, quelle idee «puramente
intellettuali», «astratte», da cui perfettibilità e conoscenza
sembrano interamente dipendere, si trovano in realtà a dover
dipendere a loro volta dalla presenza di un linguaggio capace,
prima ancora che di esprimerle ed articolarle tra loro, di produrle e
costruirle esso stesso. Da una parte, dunque, entendement ed esprit
dimostrano di non possedere alcuna sfera autonoma rispetto al
langage; dall’altra è la perfettibilità stessa, nella misura in cui la
sua attività è immediatamente connessa alla presenza di idee che
sono «puramente intellettuali», a rivelare con il linguaggio una
relazione così stretta da sconfinare quasi – come quella di volontà
e riflessione – in una radicale identità.
Nella misura in cui la perfettibilità, come «qualité très
spécifique» propria dell’uomo, si dimostrasse allora subordinata ad
un linguaggio che non è – contrariamente al “linguaggio” animale1
– un semplice istinto, identico in ogni membro della specie, bensì
un’«arte», una tecnica specifica e acquisita socialmente, in modo
diverso a seconda dei luoghi e dei tempi, sarebbe dunque
innanzitutto la distinzione stessa tra uomo e animale, e in ultima
istanza, con ciò, la stessa natura dell’uomo, a richiedere di essere
pensata non più come un semplice dato naturale, ma sempre anche
come un’acquisizione, una produzione storica e sociale. Finché
«ogni individuo», nel puro stato di natura, «si ritrova chiuso in sé
stesso come in un mondo chiuso, senza aperture sugli altri», 2
rimanendo dunque «una totalità indipendente, sufficiente a sé
stessa, autonoma»,3 «una monade ignorante ogni rapporto, fuori di
cui non c’è nulla», 4 «una totalità chiusa nella sua perfetta
1
Cfr. J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, in Œuvres complètes, cit., vol.
V, p. 7.
2
R. Polin, La politique de la solitude, cit., p. 11.
3
Ivi, p. 4.
4
P. Burgelin, La philosophie de l’existence, cit., p. 251.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 32
compiutezza»,1 l’uomo sarebbe privo sia di linguaggio sia, dunque,
della perfettibilità e di tutte le altre sue facoltà distintive. Neppure
si potrebbe dire, con Polin o Masters, 2 che «per quanto vicino
all’animale, l’uomo di natura è già un essere propriamente
umano», perché «è la libertà che lo distingue dall’animale», 3 a
costituire cioè «la natura dell’uomo». 4 È vero, in effetti, che in
Rousseau «è la libertà che si oppone all’istinto, e non più (come ad
esempio in Condillac) la ragione», e che nella sua versione
russoiana il dualismo non riguarda più la coppia istinto-intelletto,
ma quella istinto-libertà, perché «la libertà è l’unico principio che
si possa sottrarre al meccanicismo universale». 5 Ciò non toglie che
la libertà stessa, come abbiamo già visto, sia inseparabile
dall’esercizio delle altre facoltà potenziali, assenti le quali si
dovrebbe dunque concordare con quanti, come Fetscher,
pretendono che «in sostanza la libertà […] competa solo
potenzialmente all’uomo naturale». 6 Esattamente come nel
Contract, anche qui sarebbe cioè solo la sua progressiva
socializzazione a fare «d’un animal stupide et borné, […] un être
intelligent et un homme». 7 Sarebbe la società a produrre l’uomo, a
costruirne l’umanità nell’atto stesso non di “realizzare”, attuare,
sviluppare, ma di mutare una natura umana8 che occorrerebbe
postulare allora, prima di tale mutazione, originariamente
indistinta da quella animale. Poiché nel Discours il compito di
sviluppare le altre facoltà distintive dell’uomo viene riferito
esattamente all’attivarsi della perfettibilità 9 – «la radice comune»,
1
R. Esposito, Communitas. Origine e destino delle comunità, Torino 1998, p. 40.
2
R.D. Masters, The political philosophy of Rousseau, cit., p. 150: «l’uomo primitivo
è diverso dagli altri animali […] perché egli ha una specie di scelta, che a quelli manca».
3
R. Polin, La politique de la solitude, cit., p. 41.
4
Ivi, p. 35.
5
Cfr. V. Goldschmidt, Anthropologie et politique. Les principes du Système de
Rousseau, Paris 1974, pp. 276-84.
6
I. Fetscher, La filosofia politica di Rousseau. Per la storia del concetto democratico
di libertà (1960), trad. it. di L. Derla, Milano 1972, p. 23.
7
Contr., I, 8, p. 364; dove sembra che umanità e intelligenza vengano a coincidere.
8
Ivi, II, 7, p. 381, dove si parla appunto di «changer […] la nature humaine»
9
Disc., p. 142.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 33
«la condizione preliminare e formale che le rende possibili»1– una
volta che l’operare di questa facoltà si rivelasse subordinato al
linguaggio e alla comunicazione, tutte quelle facoltà, se è vero che
l’uomo «è per natura asociale», 2 si troverebbero per ciò stesso
radicalmente escluse dal puro stato di natura. Fermo a una «pura
animalità», 3 e posta con ciò una perfetta «continuità tra l’animale e
l’uomo», 4 l’uomo naturale non sarebbe allora, con Reale, se non
«un animale meglio sviluppato».5 Si dovrebbe allora ritenere, con
Strauss, che «tutto ciò che è specificamente umano viene acquisito
o dipende in ultima istanza dall’artificio e dalla convenzione», 6 o
più semplicemente, con Illuminati, che «ciò che è umano è tutto
acquisito».7 Assente nell’uomo naturale ciò che lo distingue dagli
altri animali, l’esser-uomo dell’uomo, la sua stessa appartenenza
alla specie umana, si porrebbero non come una semplice necessità
biologica, ma come l’esito di una mutazione: come «una creazione
umana», 8 un prodotto – necessariamente contingente – della
società e della storia.
A noi non sembra che Rousseau sia disposto a compiere questo
passo, abbandonando così, assieme all’idea di una natura umana
originaria e immutabile, anche quella di una universalità
dell’“umano”, ed ammettendo dunque, come succederà in Herder,
che l’esser-uomo possa e debba coniugarsi in tanti modi,
irriducibili gli uni agli altri e ad una misura comune, quante sono
le società storicamente sviluppatesi. Ci pare che sia esattamente in
forza di questa sua indisponibilità che non si può fare a meno di
ammettere la paradossale figura di un uomo la cui «umanità» sia
1
V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 288.
2
L. Strauss, Diritto naturale e storia (1953), trad. it. di N. Pierri, Venezia 1957, p.
262.
3
J. Lovejoy, L’albero della conoscenza. Saggi sulla storia delle idee (1949), trad. it.,
Bologna 1982, p. 54.
4
V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 273.
5
M. Reale, Le ragioni della politica, cit., p 189.
6
L. Strauss, Diritto naturale e storia, cit., p. 263.
7
A. Illuminati, Rousseau, solitudine e comunità, Roma 2002 (che è una ristampa, con
una nuova prefazione, di J.-J. Rousseau e la fondazione dei valori borghesi, Milano
1977), p. 78.
8
R. Derathé, Rousseau e la scienza politica del suo tempo, cit., p. 183.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 34
tale da precedere e prescindere da quel processo di umanizzazione
che pure è necessario per separarlo dal suo «état animal»,
un’«humanité» tale, cioè, da poter essere storicamente non
determinata, ma solo coltivata, sviluppata: è per questo che
Rousseau parla non già – come invece farà esplicitamente il Marx
dei Manoscritti – di una produzione, ma sempre e solo di uno
sviluppo dell’“umano”, dell’insieme di qualità che definiscono
l’«uomo in quanto uomo».1 Se sono allora ben note le presunte
aporie – che spesso la letteratura russoiana si compiace di
riprodurre e ricalcare pedissequamente – attraverso le quali il
Discours sembra bandire dal «premier état de Nature» qualunque
presenza della perfettibilità, e dunque sia delle «facultés
artificielles» sia della conoscenza, qui di seguito – senza negare la
centralità del fatto sociale – si tratterà invece di mostrare, al di
sotto di questa apparente logica dell’esclusione, una logica
profondamente diversa: una logica della limitazione, limitazione
che però presuppone, di per sé stessa, la presenza di ciò che pure
deve limitare.
A uno sguardo attento, infatti, quelle che in un primo momento
possono sembrare delle aporie, mostreranno subito di non essere
che dei “semplici” paradossi, tesi a dimostrare non l’impossibilità,
in generale, di qualunque sviluppo delle umane facoltà nel singolo
uomo, o più in particolare di un loro sviluppo interno al puro stato
di natura, ma per un verso l’inseparabilità della prosecuzione, oltre
una certa soglia, di questo sviluppo individuale dalla
socializzazione, che sola rende possibile lo sviluppo non tanto del
singolo quanto della specie, e per altro verso l’inconsistenza di
ogni impostazione “contrattualistica” del tema dell’origine di
società e linguaggio, dell’idea per la quale il consapevole
patteggiamento delle regole dell’associazione e del linguaggio
costituirebbe una condizione preliminare alla loro istituzione.
1
Cfr. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio,
Torino 1949, p. 113, in cui si afferma che come l’uomo produce la società, così è «la
società a produrre l’uomo in quanto uomo».
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 35
2.2. Il carattere illusorio dell’esclusione
Gli ostacoli che si frappongono al riconoscimento di qualunque
originaria attività delle facultés reçues en puissance già
nell’homme originel sono essenzialmente tre: il rapporto di
entendement e langage; quello tra raison e société; l’antecedenza
ed indipendenza di amore di sé e pietà rispetto ad ogni riflessione
o ragione. Nel tentativo di rimuoverli, ad essere assunti ad oggetto
di analisi, qui di seguito, saranno proprio quei testi in cui la
posizione russoiana si presenta più aspra e indiscutibile, per
mostrare in essi quelle sfumature che il lettore percepisce
normalmente solo in modo oscuro e confuso. Nel presente
paragrafo ci soffermeremo unicamente su intelletto e ragione,
rispetto ai quali cercheremo di rendere visibile il carattere solo
illusorio della loro esclusione.
Il problema dell’apparente coimplicazione di intelletto e
linguaggio può essere inquadrato e riassunto attraverso
l’accostamento di alcuni passi, nei quali sembrerebbe quasi che lo
sforzo del ragionamento sia quello di privarsi di ogni via di
scampo. Da un lato, infatti, l’oggettivo “imbarazzo” legato al
problema dell’«origine des Langues»1 tende a configurarsi
immediatamente come il prodotto di un inevitabile cortocircuito
tra «art de la parole» ed «art de penser»: «si les Hommes ont eu
besoin de la parole pour apprendre à penser, ils ont eu bien plus
besoin encore de savoir penser pour trouver l'art de la parole».2
Dall’altro lato, questa prima difficoltà si salda immediatamente ad
una seconda, delineando un’«impossibilité presque démontrée
ayent pû naître, et s’établir par des moyens purement humains»,3
«vale a dire», come chiosa Goldschmidt, «naturali», 4 e lasciando
balenare in queste rapide parole addirittura l’idea del linguaggio
come di uno di quei «dons surnaturels» cui genericamente si
1
Disc., p. 146.
2
Ivi, p. 147.
3
Cfr. Ivi, p. 151. Su questo passo, cfr. A. Philonenko, J.-J. Rousseau et la pensée du
malheur, I, cit., p. 199.
4
V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 303.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 36
accenna nella prima pagina del Discours.1 Come poi la lingua
richiede il pensiero e il pensiero la lingua, senza che si possa
attribuire all’uno o all’altro una qualche priorità, così è impossibile
decidere «lequel a été le plus nécessaire, de la Société déjà liée, à
l'institution des Langues, ou des Langues déjà inventées, à
l'établissement de la Société».2 Per un verso, infatti, poiché gli
uomini non avevano originariamente «nulle correspondance entre
eux, ni aucun besoin d'en avoir», dell’«invention» del linguaggio
«on ne conçoit ni la nécessité […], ni sa possibilité, si elle ne fut
pas indispensable».3 È infatti solo all’interno di una «société déjà
liée», quando cioè gli uomini non possono più fare a meno gli uni
degli altri, che può prodursi tanto il «bisogno» di una lingua
quanto, perciò, uno sforzo teso alla sua soddisfazione: è solo la sua
necessità, nella logica del ragionamento russoiano, a determinare
la possibilità del linguaggio. Per altro verso, però, non solo non si
vede come l’uomo primitivo possa cominciare ad avere «plûtôt
besoin d'un autre homme qu'un singe ou un Loup de son
semblable», ma rimane inoltre oscuro, «ce besoin supposé», come
gli uomini possano essersi associati in assenza di un linguaggio,
senza cioè poter prima «convenir entr’eux des conditions».4 La
stessa associazione che rende possibile il formarsi del linguaggio,
vale a dire, è resa possibile solo dallo stabilimento di quelle stesse
«conditions» e di quel «commun consentement»5 che non possono
però essere raggiunti, a loro volta, se non linguisticamente. Nella
misura in cui – con Strauss – «la ragione è contemporanea al
linguaggio»,6 è ben vero che «i progressi della ragione e quelli
della socievolezza vanno di pari passo»;7 se però entrambi «non
1
Disc., p. 134.
2
Ivi, p. 151.
3
Ivi, p. 146.
4
Ivi, p. 151.
5
Ivi, p. 148.
6
L. Strauss, Diritto naturale e storia, cit., p. 263: dove peraltro, enunciandolo come
quello della semplice simultaneità, Strauss indica sì l’essenzialità del nesso tra ragione e
linguaggio, ma in modo del tutto generico, indeterminato, senza affrontare cioè il
problema vero e proprio.
7
R. Derathé, Rousseau e la scienza politica del suo tempo, cit., p. 203.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 37
esistono nell’uomo naturale se non “in potenza”», 1 non si riesce a
scorgere come sia mai stato possibile, all’una o l’altra, aver mosso
il primo passo.
Come si vede, anche senza complicarla ulteriormente – come
pure il testo russoiano in realtà non manca di fare – sembra che la
situazione concettuale che si profila sia davvero senza uscita, e che
l’insorgere di intelletto, società e linguaggio, e dunque la stessa
uscita dal puro stato di natura – salvo richiamarsi al deus ex
machina dell’intervento divino – finisca per ridursi allo statuto di
un fatto che la ragione deve bensì riconoscere, riconoscendo però
al tempo stesso la propria incapacità di renderne conto, di
comprenderne la possibilità, di penetrarne il «mistero». “Sembra”,
appunto. Ciò che il testo dice, in realtà, è tutt’altro da ciò che – per
un motivo o per l’altro – è sembrato dire. A prodursi è cioè un
altro caso esemplare di conflitto tra testo e Wirkungsgeschichte, di
sistematica cancellazione delle ragioni del primo ad opera della
seconda. Non potendo soffermarci su langage e sociabilité, la cui
trattazione esula dagli interessi di questo lavoro, è alle tracce di un
carattere “originario” della presenza delle «facoltà potenziali» e di
un qualche loro sviluppo che qui di seguito dovremo prestare
attenzione. 2
1
Ivi, p. 185.
2
Ci limiteremo qui a notare che la Seconde partie svolge in un senso assolutamente
naturalistico il tema della genesi congiunta di linguaggio e società, seguendolo in quelle
sue diverse tappe – libere associazioni, famiglia, società nascente – che si susseguono
senza alcun bisogno di patteggiamenti. L’assimilazione dell’uomo ai lupi e alle scimmie,
ad ogni modo, sta ad indicare anche nel Discours, come nell’Essai, l’originalità di una
qualche pur occasionale dimensione gregaria, di branco, ed è a questa dimensione che
all’inizio della Seconde partie viene collegata una forma embrionale di linguaggio, che è
dunque impossibile escludere dal puro stato di natura. La nostra ipotesi, su cui torneremo
brevemente nel terzo paragrafo, è che come la competizione, anche le prime forme di
cooperazione – occasionali, prive di regole esplicite, legate a un fine determinato,
all’«intérêt présent et sensible» – debbano essere incluse all’interno del puro stato di
natura russoiano. Esse non solo sono strutturalmente descritte esattamente nei medesimi
termini in cui viene descritta quella originaria forma di «association libre» (Disc. p. 166),
di cooperazione che è il rapporto sessuale, ma introdotte inoltre all’inizio della Seconde
partie: in un contesto, come vedremo tra breve, che sembra sì mettere in scena nuovi
elementi, e che in realtà si limita a chiarire il senso di quelli già nascostamente presenti
nella Première partie. Tali forme di associazioni «n'éxigeoit pas un langage beaucoup
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 38
Cosa succede se, nel rileggere i passaggi già citati, prestiamo
attenzione unicamente al loro significato letterale? In forza della
sua stessa definizione come «Art de communiquer ses pensées» il
linguaggio dell’uomo mostra di presupporre, innanzitutto, tanto dei
«pensieri» da poter comunicare quanto un intelletto già operativo
ed effettivamente in grado di pensarli. Coerentemente con questo
presupposto si deve allora riconoscere che, «se gli uomini hanno
avuto bisogno della parola per imparare a parlare, hanno avuto
molto più bisogno di saper pensare per trovare l’arte della parola»:
dove però ciò non sta affatto ad indicare, come ritiene ad esempio
Goldschmidt,1 una totale “reciprocità” di intelletto e linguaggio
ma, proprio al contrario, la priorità e, in una certa misura,
l’autonomia del primo rispetto al secondo («molto più bisogno»).
La circolazione delle idee è bensì necessaria al loro sviluppo – e a
quello, congiunto, dell’intelletto e delle conoscenze – oltre un
certo grado, ma deve comunque essere preceduta da una qualche
loro produzione ed accumulazione: ed infatti Rousseau, nell’atto
stesso di invitare il lettore a considerare «de combien d’idées nous
sommes redevables à l’usage de la parole», e «combien la
Grammaire exerce, et favilite les operations de l’Esprit»,2
presuppone da una parte che il “debito” del pensiero verso il
linguaggio non riguardi il suo stesso essere, né la totalità dei suoi
contenuti, e si dia perciò una produzione intellettuale
prelinguistica, e dall’altra che, se l’intervento esterno del
linguaggio si limita ad “esercitare” e “facilitare” «les operations de
l’Esprit», ovvero l’attività delle «facoltés artificielles», queste
operazioni devono allora prescindere, di per sé stesse, da un tale
plus rafiné que celui des Corneilles ou des Singes, qui s'attroupent à peu près de
même», di modo che «Des cris inarticulés, beaucoup de gestes et quelques bruits
imitatifs durent composer pendant longtemps la langue universelle » (Ivi., p. 167).
Questa langue universelle, però, è esattamente la stessa di cui la Première partie
riconosceva la presenza nel puro stato di natura, nel quale, prima che si stabilisse tra loro
«une communication plus étroite» (ma dunque una qualche communication era già
presente) «le premier langage de l’homme, le langage le plus universel, le plus
énergique, et le seul dont il eut besoin, […], est le cri de la nature» (ivi, p. 148).
1
Cfr. V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 303.
2
Disc., p. 146
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 39
esercizio o facilitazione. Per quanto riguarda il rapporto tra
l’istituzione della società e quelle «conditions» la cui statuizione
esige la comunicazione, e dunque l’’invenzione” del linguaggio,
vedremo alla fine di questo lavoro in che modo una qualche
embrionale, occasionale forma di cooperazione possa prodursi in
modo spontaneo, legato a delle pulsioni naturali: senza bisogno
dunque di essere «stabilita», contrattualisticamente, attraverso
l’esplicito patteggiamento delle sue condizioni. Già qui, però,
l’analisi di uno dei luoghi su cui maggiormente la letteratura
critica ha fatto leva per escludere le facultés virtuelles dal puro
stato di natura, ha permesso di rimuovere uno degli ostacoli più
ingombranti, quello della loro subordinazione ad una forma
necessariamente linguistica, e dunque sociale, che si oppone
all’individuazione di una loro operativa presenza al puro stato di
natura.
Per sgombrare il campo anche dal secondo degli ostacoli sopra
elencati, cominciamo col leggere un passo che sembra riproporre,
rispetto a raison e lumières, quella medesima subordinazione alla
socializzazione che già abbiamo confutato a proposito
dell’entendement. Esso si inserisce alla fine del capoverso nel
quale Rousseau, concludendo la trattazione del côté métaphique
dell’uomo e introducendo a quella del suo versante moral, si
domanda provocatoriamente se il puro stato di natura sia davvero
così miserabile come orgogliosamente «on nous répéte sans
cesse»: se cioè la «véritable misére», intesa come «souffrance du
Corps ou de l’ame», sia davvero dal lato del selvaggio, che vive
«libre, dont le coeur est en paix, et le corps en santé», e non
piuttosto dal lato della «vie Civile», la cui insopportabilità è
testimoniata dal fatto che le leggi umane e divine, assieme,
riescono «à peine» ad arginare un fenomeno, come quello del
suicidio, che senza di esse sarebbe inoltre assai più diffuso.
Sospendendo il giudizio sulla questione, Rousseau afferma, come
indubbio, ciò che segue:
Rien […] n’eût été si misérable que l’homme sauvage, ébloui par des lumieres,
tourmenté par les passions, et raisonnant sur un état différent du sien. Ce fut
pour une providence très sage, que les facultés qu’il avoit en puissance ne
devoient se développer qu’avec les occasions de les exercer, afin qu’elles ne lui
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 40
fussent ni superflues et à charge avant le tems, ni tardives, et inutiles, au besoin.
Il avoit dans le seul instinct tout ce qu’il lui falloit pour vivre dans l’état de
nature, il n’a dans une raison cultivée que ce qu’il lui faut pour vivre en société.1
Teniamo innanzitutto presente il modo in cui la raison –
essendo l’unica ad essere esplicitamente nominata – viene qui
implicitamente assunta quale espressione per così dire
“metonimica”, esemplare, di tutte le «faculté qu’il avoit en
puissance», come se la ragione – con Polin – «non fosse che il
composto di tutte le facoltà […] dell’uomo», 2 ed esse dovessero
essere tutte, alla radice, ragione, o comunque all’esempio della
ragione, in ultima istanza, ugualmente riconducibili. Parlare
dell’una, dunque, significa parlare di tutte le altre. Come poi si
comprende facilmente, lo strano selvaggio di cui qui si affaccia per
un momento l’ipotesi, e del quale niente sarebbe più miserabile,
non è nuovamente se non quello fantasticato a propria immagine e
somiglianza dai teorici del diritto naturale. 3 La sua irrealtà,
segnalata già dall’uso del condizionale («niente sarebbe più
miserabile…»), può essere data per scontata. Questo, però, non ci
esime dal cercare di comprenderne il significato più preciso.
Negare la possibilità stessa di questo selvaggio «stordito dai lumi,
tormentato dalla passione, ragionante su uno stato differente dal
suo» significa davvero, come sembrerebbe evidente, fare della
società l’unica «occasione» dell’esercizio e dello sviluppo delle
«facoltà che egli aveva in potenza», escludere quindi, al di là di
questa loro latente potenza, ogni loro attualità?
Rileggendo il passo, ci sono due aspetti che destano qualche
sospetto. Il primo, come emerge con chiarezza, è che l’unica
possibilità negata da Rousseau è quella di lumières che giungano a
“stordire” l’uomo naturale, di passions o raisonnements tali da
riuscire a “tormentarlo”, riguardando «un état différent du sien».
Come però dalla loro incapacità di “tormentarlo”, di turbare la
1
Disc., p. 152.
2
R. Polin, La politique de la solitude, cit., p. 11.
3
Che infatti «parloient de l’Homme Sauvage et […] peignoient l’homme Civil»
(Disc., p. 132), ed erano anzi «obligés de faire de l'homme un philosophe avant que
d'en faire un homme» (ivi, p. 126).
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 41
pace del suo cuore, di suscitare in lui quella «souffrance […] de
l’âme» che l’uomo civile è invece obbligato a sopportare, non si
può dedurre una radicale estraneità delle passioni all’uomo
naturale; così né si può passare, come fa ad esempio Burgelin,
dall’idea di un’impossibilità di lumières tali da “abbagliarlo”,
accecarlo, stordirlo, a quella di un uomo tutto immerso nelle
«tenebre della natura»;1 né sarebbe corretto, a partire dalla
evidente impossibilità del selvaggio di ragionare «su uno stato
diverso dal proprio», di quel ragionamento che costituirebbe una
tentazione a por fine alla sua condizione, 2 concludere ad una sua
radicale incapacità di ragionare su alcunché. Con Goldschmidt e
Reale, insomma, è senz’altro vero che «l’uomo naturale non
possiede in alcun grado una “ragione coltivata”», 3 in quanto essa è
«intrinsecamente contraddittoria» col puro stato di natura.4 Resa al
tempo stesso necessaria e possibile solo dalla società, essa sarebbe
infatti prematura, ed anzi di peso, nel selvaggio. Uno «Esprit
cultivé» dipende dall’«éducation» e dalla «culture», e quindi anche
dalla socializzazione, che rende possibile entrambe, e non può
essere esente da disuguaglianze: cose che sono tutte impedite, alla
radice, dalla « la simplicité et l'uniformité de la vie […] sauvage»,5
la quale, con la solitudine che la caratterizza, impedisce agli
uomini di «se perfectionner […] mutuellement». Contro
Golschmidt e Reale, ciò nonostante, occorre anche riconoscere che
la contraddizione col premier état de nature non può essere
interpretata come riguardante l’attualità delle facultés reçues en
puissance in quanto tali. Perché la contraddizione si accendesse, in
effetti, occorrerebbe ammettere quella «cultivée» come l’unica
possibile loro forma di esercizio. Nulla, però, esclude in linea di
1
Cfr. P. Burgelin, Hors des ténèbres de la nature, «Annales de philosophie
politique», 5, 1965.
2
Cfr. Disc., p. 144.
3
V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 267, dove va notata la
confusione della ragione «coltivata» con la ragione tout court.
4
Cfr. M. Reale, Le ragioni della politica, cit., p. 111, dove tale intrinseca
contraddittorietà è riferita non alla sola ragione «coltivata», ma anche a una ragione sia
pur solo «embrionale».
5
Disc., p. 160.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 42
principio la possibilità di una raison (o di un esprit) non
«coltivata», capace di prescindere dalle modalità socialmente
determinate e storicamente tramandate dall’éducation e dalla
culture, e compatibile, quindi, col naturale bonheur del selvaggio.
2.3. Limitata inclusione di facoltà e conoscenze
Attraverso l’analisi del rapporto prima tra entendement e
langage, poi tra raison e société, non siamo approdati ancora se
non a un risultato puramente negativo. Fin qui, infatti, abbiamo
riconosciuto unicamente la priorità dell’intelletto sul linguaggio, e
scoperto che il passaggio sul selvaggio stordito dai lumi confuta
l’attualità non già delle facultés reçues en puissance in quanto tali,
ma solo di quel loro grado di sviluppo che nasce da educazione e
cultura. Questo riconoscimento e questa scoperta non ci
consentono ancora, tuttavia, di affermare positivamente una loro
qualunque attiva presenza. Come l’indipendenza e la precedenza
dell’attività intellettuale rispetto a quella linguistica non
presuppone, a rigore, un suo carattere originario, così la
constatazione del carattere meramente potenziale, nel puro stato di
natura, della ragione coltivata e delle conoscenze che stordiscono
gli uomini non esclude certo la presenza di ragione e conoscenza
in generale, ma nemmeno la implica.
Come dicevamo, però, il testo in cui si parla della raison
cultivée presenta un secondo motivo di sospetto, l’osservazione del
quale può aiutarci a chiarire quale sia, qui, la posta in gioco. Il
«seul instinct» nel quale l’uomo sembrerebbe possedere «tout ce
qu’il lui falloit pour vivre dans l’état de nature» è infatti esattamente il
medesimo «seul instinct» cui egli sarebbe «livré par la Nature» o
meglio «dédommagé de celui qui lui manque par des facultés
capables d’y suppléer»:1 un istinto, come riconoscono ad esempio
Starobinski o Masters,2 definito essenzialmente dal fatto di essere
1
Ivi, p. 142.
2
Cfr. J. Starobinski, note 2, ivi, p. 1307, dove perentoriamente si afferma che
«l’uomo è sprovvisto d’istinto», e R.D. Masters, The political philosophy of Rousseau,
cit., p. 149.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 43
assente, “mancante”, e alla “supplenza” del quale sarebbe la natura
stessa ad assegnare, appunto, le «facultés» propriamente umane;
facoltà che qui sembrano però appartenere all’uomo naturale
unicamente «en puissance». Se nel puro stato di natura questa loro
«puissance» dovesse davvero rimanere relegata al rango di una
mera potenza, e costituirsi allora, per non negare la propria pura
virtualità, come una radicale impossibilità di realizzare ciò di cui
pure rappresenta la capacità, una facoltà identica all’incapacità di
esercitarsi, di passare all’atto: come potrebbero allora, quelle
facoltà, assolvere alla loro naturale funzione “suppletiva” o, con
un termine caro a Derrida, “supplementare”? come potrebbe
l’uomo naturale sopravvivere, privato tanto di un istinto suo
proprio quanto di ciò che pure a questa “privazione” è deputato a
fornire un risarcimento, una “compensazione”? La posta in gioco,
come si vede, è quella della coerenza della più generale struttura
argomentativa del Discours. Il problema che il rapporto tra deficit
istintuale e «facultés capables d’y suppléer» ci invita a risolvere,
vale a dire, è quello rappresentato dal presunto carattere pre-
riflessivo, pre-cognitivo, dell’amour de soi-même. Attraverso la
sua analisi sarà possibile fornire una prima prova,
incontrovertibile, dell’effettuale operatività delle facoltà potenziali
nel puro stato di natura.
Oltre a quelli già commentati, l’impedimento più radicale al
riconoscimento di questa operatività è rappresentato proprio dai
testi che riguardano sia l’amour de soi-même, identificato come
interesse ad un tempo per la conservation e per il bien-être, sia la
pitié:1 i due «Principes certains et invariables»,2 cioè, dai quali la
condotta dell’uomo naturale è interamente definita. La discussione
di questi «princìpi» è svolta nella Préface contestualmente a quella
della legge naturale, alla quale in tanto riescono a fornire un solido
fondamento, permettendole di parlare «immediatement par la voix
de la Nature»3, in quanto ne dimostrano il radicamento in una
dimensione puramente istintuale, pulsionale, e si configurano
1
Disc., p. 126.
2
Ivi, p. 122.
3
Ivi, p. 125
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 44
dunque – in un senso che tuttavia occorrerà chiarire – come
«Principes antérieurs à la raison»,1 «simples impulsions» legate al
«pur mouvement de la Nature, antérieur à toute réflexion».2
C'est du concours et de la combinaison
C'est du concours et de la combinaison que nôtre esprit est en état
de faire de ces deux Principes, sans qu'il soit nécessaire d'y faire entrer
celui de la sociabilité, que me paroissent découler toutes les régles du
droit naturel; régles que la raison est ensuite forcée de rétablir sur
d'autres fondemens, quand par ses développements successifs elle est
venue à bout d'étouffer la Nature.3
Contro l’antica tradizione che vuole l’uomo naturalmente
socievole e razionale, e pensa la legge naturale, quindi, come
espressione di questa sua specifica natura, in questo passo raison e
sociabilité sembrano entrambe non poter avere nulla di naturale, o
di originario, perché il loro parallelo sviluppo sembra da una parte
poter intervenire solo in un secondo momento – successivo,
appunto, rispetto a quello in cui a vigere erano solo le due
«simples impulsions» dell’amore di sé e della pietà – e dall’altra
dover necessariamente coincidere non già con lo sviluppo, ma col
soffocamento della natura. Contro questa duplice apparenza
occorre domandarsi se ciò che si pone come «successivo» rispetto
all’amore di sé e alla pietà originari, e che conduce inevitabilmente
al soffocamento della natura, sia davvero qualunque sviluppo della
ragione (e della socializzazione), l’attività cioè della ragione in
quanto tale, o se non sia piuttosto la sola raison cultivée (con la
socializzazione diseguale che essa comporta). Parlare di
«developpements successifs» della ragione, il cui carattere
ipertrofico finisce col soffocare la natura, non significa forse
implicitamente ammetterne anche, come un momento interno alla
vita della natura, uno sviluppo precedente, e salvaguardare così la
possibile “simultaneità” di natura e ragione?
A ben vedere, già nel criticare il modo di procedere dei «
1
Ivi, p. 126.
2
Ivi, p. 155.
3
Ivi., p. 126.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 45
Philosophes, che nella loro trattazione della legge naturale
presuppongano «plusieurs Connoissances que les hommes n’ont
point naturellement», e «Lumiéres qui ne se développent qu’avec
beaucoup de peine […] dans le sein de la société même», e nel
dimostrare che in questo modo essi rendono «impossible
d’entendre la Loy de Nature et par consequent d’y obéir, sans être
un très grand raisonneur et un profond Metaphsicien», 1 Rousseau
sembra dare per inteso che vi sia, accanto a quello delle
conoscenze che gli uomini «n’ont point naturellement», un altro
insieme di conoscenze, distinte dalle prime per il fatto che uomini
le posseggono del tutto «naturalmente». Nella sua definizione,
infatti, non nega affatto che, per essere oltre che naturale anche
legge, la loi naturelle, debba poter riguardare «un être moral, c'est-
à-dire intelligent, libre, et considéré dans ses rapports avec d'autres
êtres»2, cosicché «la volonté de celui qu'elle oblige puisse s'y
soumettre avec connoissance». 3 È inoltre pur sempre «notre esprit»
– con la libertà e le altre facoltà che lo definiscono – ad operare il
concours e la combination tra i due princìpi4. Tutto, qui,
sembrerebbe condurre nella direzione dell’attribuzione all’uomo
naturale, in quanto sottoposto al diritto e alla legge naturali, di una
qualche spiritualità, di un qualche grado di conoscenza e libertà.
Proprio il disconoscimento dell’inerenza delle facoltà potenziali al
puro stato di natura, tuttavia, ha spinto molti interpreti ad escludere
qualunque ruolo della legge e del diritto naturali all’interno del
medesimo stato di natura. Finché si nega all’uomo naturale
qualunque «spiritualité de son âme», e cioè quella libertà e
conoscenza («intelligent, libre») che ne definiscono appunto il côté
métaphysique; finché lo si presuppone schiacciato, insomma, su
quella dimensione meramente pulsionale, ridotto al mécanisme des
sens in cui si risolve il suo côté physique, è impossibile pensare
che la volonté dell’uomo naturale si sottometta avec connoissance
a una qualunque legge, perché si suppone che egli non abbia,
1
Cfr. ivi, p. 125
2
Ivi, p. 124
3
Cfr. ivi, p. 125.
4
Cfr. ivi, p. 126.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 46
appunto, né volontà né conoscenza alcuna. «Nostre esprit», di cui
Rousseau afferma che realizza il «concours et la combinaison» tra
amore di sé e pietà, derivandone «toutes les régles du droit
naturel», non può essere in questa prospettiva quello in generale di
“noi uomini”, e quindi anche dell’uomo naturale, ma solo quello di
“noi uomini colti”, di noi filosofi. Se così fosse, bisognerebbe
davvero concordare con quanti ritengono che la trattazione
russoiana sia volta a «fare tabula rasa dell’idea di legge
naturale»,1 a far cadere «ogni riferimento a un legittimo “dover-
essere”», riducendo «il diritto naturale […] al fatto»,2 situandosi
ormai su un piano di immanenza che non ammette più alcun
orientamento teleologico.3 Ma è davvero questa, ci si può chiedere,
l’intenzione russoiana? Cerchiamo di capire meglio tutti questi
problemi.
In questa direzione occorre innanzitutto notare che l’intero testo
del Discours è disseminato di indizi che suggeriscono, anche se
senza mai metterla esplicitamente a tema, una necessaria
complicità di amore di sé e facoltà artificiali. Già nella sezione
della Première partie dedicata, secondo la ripartizione proposta da
Goldschmidt,4 al suo solo côté physique si può leggere che
Mais l'homme Sauvage vivant dispersé parmi les animaux, et se trouvant
de bonne heure dans le cas de se mesurer avec eux, il en fait bientôt la
1
C.E. Vaughan, Introduction a The political writings of J.-J. Rousseau, trad. ingl.,
Cambridge 1915, p. 449.
2
R. Pezzillo, Rousseau e Hobbes, cit., p. 58.
3
Su questo punto, poco considerato dalla letteratura critica, cfr. P. Vernière, Spinoza
et la pensée française avant la revolution, Paris 1954, p. 482: «Niente più leggi naturali
esprimenti l’origine divina dell’uomo o le sue esigenze religiose: Rousseau si rifiuta
all’atto di fede di Voltaire, di Pufendorf, di Locke». Cfr. anche V. Goldschmidt,
Anthropologie et politique, cit., p. 319.
4
Cfr. V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 270, dove si distingue una
prima sezione dedicata all’uomo “fisico”, il cui l’esempio centrale è quello
dell’esclusione della malattia; da una seconda, il cui oggetto è l’uomo “metafisico”, e ciò
che in particolare viene escluso è la presenza del linguaggio; da una terza, incentrata
sull’aspetto “morale” del selvaggio e, a titolo esemplificativo, sulla sottrazione all’uomo
naturale dell’aspetto “morale”, appunto, dell’amore.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 47
comparaison, et sentant qu'il les surpasse plus en adresse qu'ils ne le
surpassent en force, il apprend à ne les plus craindre.1
Avendo poi mostrato che le stesse bestie feroci, in seguito a
«plusieurs expériences» di come un selvaggio possa essere, non
meno di loro, pericoloso e feroce, imparano ad attaccare «peu
volentiers» l’uomo, Rousseau prosegue:
A l'égard des animaux qui ont réellement plus de force qu'il n'a d'adresse,
[…] il a partout le prendre et le laisser dans la rencontre, et le choix de la
fuite ou du combat. 2
Già poco sopra, del resto, si era asserito essere «circostanze rare»
quelle in cui l’uomo naturale, imbattendosi di fronte all’ignoto,
non sarebbe in grado di « distinguer le bien et le mal Physiques
qu'il en doit attendre, ni comparer ses forces avec les dangers qu'il
a à courir»: laddove il riferimento alla rarità dei pericoli
sconosciuti e all’incapacità (dovuta alla loro novità,
all’inesperienza), in questi casi, di prevedere il pericolo, e di
paragonarlo alle proprie forze, pare necessariamente far
riferimento ad altri possibili pericoli a proposito dei quali,
avendone già fatto esperienza, l’uomo è perfettamente in grado di
operare sia il paragone sia, sulla sua base, una scelta ponderata.
Quando qualche volta è necessario disputare il proprio pasto con
un suo simile, infine, l’uomo non viene mai alle mani «sans avoir
auparavant comparé la difficulté de vaincre avec celle de trouver
ailleurs sa subsistance».3 Come si vede da questo insieme di casi, è
solo attraverso un attivo esercizio tanto delle sue «facoltà
artificiali» quanto della sua libertà, e cioè distinguendo il bene dal
male, paragonando forze, difficoltà e pericoli che l’uomo naturale
può interessarsi della propria conservazione, apprendere cosa
temere e cosa non temere, «accettare o rifiutare lo scontro»,
«scegliere tra la fuga e il combattimento»: trovare insomma,
conformemente alla propria «prudence machinale», le
1
Disc., p. 136.
2
Ibidem.
3
Ivi, Note ix, p. 203
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 48
«précautions les plus nécessaires à sa sûreté». 1 Se in questo senso
lo si può chiamare «vertueux», è certo solo in quel «sens
physique» in cui per virtù si intende ciò che giova alla
conservazione: nello stesso senso, cioè, in cui «il faudroit appeler
les plus vertueux, celui qui résisteroit le moins aux simples
impulsions de la Nature», 2 a quegli impulsi da cui si son viste
derivare «toutes les régles du droit naturel». La pulsione
autoconservativa, è vero, è senz’altro un principio – o una «loi» –
al quale l’uomo naturale non può in nessun modo disobbedire;
altrettanto vero, però, come facevamo notare sopra,3 è che il suo
contenuto non è fissato dalla pulsione stessa. La pulsione, di per
sé, non è cioè se non un principio vuoto, perché ciò a cui essa
determina l’uomo non può essere determinato, a sua volta,
dall’uomo stesso, attraverso una scelta consapevole, basata su una
precedente esperienza. In questo senso, però, essa non può neppure
essere considerata come un istinto, un automatismo legato al
semplice mécanisme des sens, ma solo o come una passione
(l’amour de soi-même come un ardeur il quale non a caso richiede
la moderazione della pietà…) o come un interesse: un amour o
intérêt al quale, se non si può disobbedire, non è per via di un suo
presunto carattere istintuale, ma solo perché esso è appunto «le
seul mobile des actions humaines». 4
Alla stessa prudence in cui abbiamo visto risolversi il presunto
istinto di conservazione, e che, per quanto machinale, si è
riconosciuta comunque inseparabile da un qualche esercizio delle
facoltà propriamente umane, neanche la pietà, per essere
compatibile con l’amore di sé, può rimanere insubordinata.
Nessuno, è vero, «est tenté de désobéir à sa doux voix», che è la
1
Ivi, p. 74.
2
Cfr. ivi, p. 152.
3
Cfr. supra, penultimo capoverso di § 1.2.
4
Disc., p. 166. In questo senso, bisogna ritenere che la pietà, che pure gli si può
opporre, non è un «motivo» radicalmente diverso, irriducibile, duale rispetto all’amore di
sé, ma solo una sua interna determinazione, legata all’identificazione immaginativa tra sé
e l’altro, della sofferenza dell’altro come la propria. Non ci pare dunque che si possa
opporre il Discours all’Émile, come se il primo presentasse una dualità di princìpi
affettivi elementari che il secondo giungerebbe invece a superare.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 49
stessa «voix de la Nature» attraverso la quale la legge naturale
parla all’uomo. «C'est elle qui détournera tout Sauvage robuste
d'enlever à un faible enfant, ou à un vieillard infirme, sa
subsistance acquise avec peine, si lui-même espère pouvoir trouver
la sienne ailleurs»:1 «excepté», cioè, «dans le cas légitime où sa
conservation se trouvant intéressée, il est obligé de se donner la
préférence à lui-même».2 Nel caso in cui l’interesse per
conservation o bien-être venga a confliggere con la pitié, questo
«sentiment qui met à la place de celui qui souffre»3, è solo un
calcolo prudenziale a poter conciliare queste divergenti pulsions,
permettendo all’«ardeur» o alla «férocité» della prima, alla
«préférence» cioè che ognuno deve a sé stesso, di essere bensì
“moderate”, o “temperate”, o “addolcite”, ma non sopraffatte dalla
«doux voix» della seconda, da quella «répugnance innée à voir
souffrir son semblable»»4 di cui non a caso Rousseau dice che,
nello stato di natura, «tient lieu de Loix».5 L’unione o
combinazione dei due principes può dunque senz’altro essere
espressa, conformemente alla cosiddetta «maxime de bonté
naturelle», nel comando «Fais ton bien avec le moindre mal
d’autrui qu’il est possible»6; ciò, però, solo a patto di riconoscere
che a fissare sia quel «bene» sia, dunque, quel «minor male», può
essere solo – come riconosce correttamente Reale – un «complesso
calcolo», un «momento ulteriore»:7 un momento che solo in forza
di questa sua “ulteriorità” rispetto al mécanism des sens, alle
diverse pulsions che qui entrano in conflitto, è in grado di operare
la loro sintesi, e che «non sarebbe possibile senza una blanda
forma di razionalità riflettente», 8 senza cioè l’attivo esercizio di
1
Ivi, p. 156.
2
Ivi, p. 126. Si può notare, qui, che espoir e préférence sono entrambe indissociabili
da un qualche impiego della riflessione.
3
Ivi, .p. 155.
4
Cfr. ivi, p. 154.
5
Ivi, p. 156.
6
Ibidem (corsivo di Rousseau).
7
M. Reale, Le ragioni della politica, cit., p. 213, che però trae motivo, da questa
constatazione, per escludere la pietà dal quadro del puro stato di natura.
8
A. Loche, Immagini dello stato di natura in J.-J. Rousseau, Milano 2003, p. 47.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 50
quelle «facoltà artificiali» che sono parte integrante della
«spiritualité de son Ame». La combinazione dei due differenti
princìpi in un’unica «massima», dalla quale derivano «tutte le
regole del diritto naturale», è qualcosa che si compie non,
arbitrariamente, nella testa di Rousseau ma, per così dire, nella
cosa stessa, in modo che non si può più negare né all’uomo
naturale qualunque attivo esercizio della spiritualité de son âme,
né allo stato di natura la pertinenza delle regole del diritto naturale.
Si è costretti a riconoscere, con ciò, che se i principes o le
impulsions o i sentiments della pietà e dell’amore di sé possono
esser definiti «antérieurs à la raison», o «a toute réflexion», non è
nel senso in cui essi sarebbero in grado di prescindere dal loro
intervento, o da quello di connoissance e volonté, rinviando così
ad un secondo momento ogni sviluppo del «côté Mètaphysique»,
ma solo in quanto non è la ragione a risvegliarli, essendo piuttosto
l’energia potenzialmente conflittuale di quelle pulsioni ad esigere,
già da sempre, l’intervento mediatore e la direzione di raison ed
esprit. Si capisce, allora, come sia solo l’accettazione di un diffuso
pregiudizio interpretativo a costringere ad esempio Reale, pur di
non riconoscere la presenza di quelle facoltà già nel puro stato di
natura, addirittura a bandirne sia la pietà, ritenendola «un principio
che non tanto si integra, moderandola, con la conservazione,
quanto piuttosto la sostituisce», «un principio alternativo e
dissolutore, una sospensione che però sconvolge il sostrato in cui
dovrebbe iscriversi», 1 sia la capacità dell’amore di sé, pur
esplicitamente riconosciuta da Rousseau, di essere «dirigé […] par
la raison et modifié par la pitié».2 È sempre il medesimo
pregiudizio che ha impedito di vedere che ad essere esclusi dallo
stato di natura, e quindi confutati, non sono il diritto e la legge
naturale in quanto tali, in quanto cioè richiedono pur sempre un
1
Cfr. M. Reale, Le ragioni della politica, pp. 213-15. Si noti inoltre che è solo
l’incomprensione del ruolo strutturale della ragione all’interno del rapporto tra amore di
sé e pietà a spingere Reale ad una grave svista testuale, interpretando come un «terzo
sentimento» quello che egli chiama, escludendolo dal puro stato di natura, «l’amore di sé
umano», e che invece non è per Rousseau se non l’amore di sé tout court, già da sempre
«dirigé dans l’homme par la raison et modifié par la pitié».
2
Disc., Note xv, p. 219.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 51
minimo di conoscenze, ma solo quella certa loro concezione che
rende «impossible d’entendre la Loy de Nature, et par consequent
d’y obéir» a chi non sia un «très grand raisonneur et un profond
Metaphisicien», e che presuppone quindi delle «lumieres qui ne se
développent qu’avec beaucoup de peine et pour fort peu de gens
dans le sein de la société même». 1
Questo problema, della russoiana concezione delle pulsioni
elementari, e quindi della legge e del diritto naturali che a tali
pulsioni si connettono, richiederebbe ben altro approfondimento.2
Per ciò che ci interessa in questa sede, sia sufficiente l’aver
rinvenuto una prima, inconfutabile prova dell’inclusione delle
facoltà artificiali nel puro stato di natura, e della sua intima
coerenza con la struttura profonda e meno appariscente del
Discours. Prima di passare a un nuovo aspetto del problema ci sia
però consentito, di quella inclusione, fornire qui un’ulteriore
conferma, seguendo il modo in cui nel corso della Première partie
Rousseau affronta il tema delle lumières, che alle facoltà artificiali
sono intrinsecamente legate.
Come già nel caso della prévoyance, nel quale l’energica
negazione di qualunque sua presenza si capovolgeva subito in una
sua limitata ammissione, anche alla prospettiva nella quale l’uomo
naturale viene riguardato come «privé de toute sorte de lumiéres»3
si sostituisce immediatamente, già nella pagina seguente, una
prospettiva affatto diversa, all’interno della quale l’homme naturel
viene colto non più nella sua incondizionata incapacità di
qualunque conoscenza, ma solo nella sua relativa lontananza da
quel preciso «degré de connoissances»4 che nell’uomo socializzato
consentirà il «progrès» delle passioni al di là dei «besoins
Physiques»,5 verso dei besoins non solo «plus grandes»1, ma
1
Ivi, p. 125
2
Per alcune rapide considerazioni al riguardo, da un diverso punto di vista, ci
permettiamo di rinviare al nostro Il diritto, i costumi. Dal «Discorso sull’origine della
diseguaglianza» al «Contratto sociale», «Il cannocchiale. Rivista di filosofia», 2008, n.
1, pp. 68-90.
3
Disc., p. 143.
4
Ivi., p. 144.
5
Ivi, p. 143.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 52
radicalmente diversi: morali, psichici, sociali. Anche riguardo alle
lumières, quindi, l’oggetto della critica russoiana è solo quella
«naturalizzazione della storia» attraverso la quale la «nature
actuelle» dell’uomo già implicato in una determinata forma di
socializzazione viene spacciata per natura dell’«uomo in
generale»:2 l’idea cioè che gli uomini posseggano naturellement
quelle «numerose conoscenze» – di vanité, considération, estime e
mépris, «du tien et du mien»3, «du Juste et de l’Injuste»,4 di
«servitude et domination»5 – le quali, non potendo essere attinte se
non «dans la societé»,6 possono dunque essere acquisite solo
«après être sortis de l’Etat de Nature».7 Si tratta, è evidente,
esattamente delle stesse conoscenze presupposte dai diversi teorici
del diritto naturale.
Riguardo a conoscenza ed intelligenza c’è poi un altro luogo, non
privo di rilievo, in cui la limitazione convive con l’inclusione.
Proprio nel riassumere gli esiti raggiunti dalla Première partie,
infatti, Rousseau si trova ad affermare che, nel puro stato di natura,
«sujet à peu de passions, et se suffisant à lui même», l’uomo
«n’avoit que les sentimens et les lumiéres propres à cet état» e
un’intelligenza che «ne faisoit pas plus de progès que sa vanité».8
Per un verso è senz’altro riconosciuta, qui, una qualche presenza
sia di sentiments e passions dalle quali l’uomo naturale non è
«tourmenté» (e come si potrebbe negarla se, come abbiamo visto,
lo stesso amore di sé è una di queste passions?), sia di lumières
che non lo stordiscono, sia, infine, di un’«intelligence» che, per
ricordare il passo citato all’inizio di questo saggio, si distingue
tanto dalla «stupidité des brutes», degli animali, quanto da quella
che si realizza nelle «lumières funestes de l'homme civil». Per altro
verso, poiché nel pur état de nature la «vanité» – ovvero
1
Ivi, p. 144.
2
A. Burgio, Necessità della storia e storia impossibile, cit., p. 117.
3
Ivi, p. 157.
4
Disc., p. 132.
5
Ivi, p. 161.
6
Ivi, p. 132.
7
Ivi, p. 125.
8
Ivi, p. 160.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 53
quell’amour-propre, quella fureur de se distinguer cui si deve «ce
qu'il y a de meilleur et de pire parmi les hommes, nos vertus et nos
vices, nos sciences et nos erreurs»1 – non fa alcun progresso,
questa concessione non impedisce né di negare con ogni nettezza
all’uomo naturale ogni lume “improprio”, “inappropriato”, né di
tener ferma l’esclusione dei «lumi», ad esempio, nella misura in
cui essi sono, nella loro piena “luminosità”, «filosofia», nella
misura in cui sono, vale a dire, l’ammirato stupore di una
conoscenza “abbagliata”, “stordita”, nella quale l’uomo non sa più
guardare, come il selvaggio, soltanto a ciò che egli ha «intérêt à
voir»,2 e alla quale, nella sua “gratuità”, «l’intérêt présent et
sensible»3 non è più capace di fornire né un fondamento, né un
indirizzo, né un limite. Poiché «il n’a pas l’esprit de s’étonner des
plus grandes merveilles», infatti, non è nell’uomo primitivo «qu’il
faut chercher la Philosophie dont l’homme a besoin, pour savoir
observer une fois ce qu’il a vû tous les jours»4, per dedicarsi a
quell’osservazione disancorata da ogni utilità, fine a sé stessa, che
non sarebbe possibile se non per una ragione o a uno spirito già
coltivati. Ad esser tenuta ferma nel suo pieno rigore è bensì, come
si vede, la rimozione dallo stato di natura di ogni cognizione
politica o morale, come anche di quelle già citate «sublimes
vérités» alle quali solo la casta dei filosofi, «par des suites de
raisonnements très abstraits»,5 potrebbe riuscire a pervenire.
Riguardo alla conoscenza in generale, invece, la logica
dell’esclusione mostra di non essere altro che una logica della
limitazione.
2.4. L’inclusione di un limitato sviluppo individuale
1
Ivi, p. 189. Si noti come questo passo ricalchi quasi alla lettera quello sulla
perfettibilità (ivi, p. 142), identicamente definita anch’essa come fonte di lumi ed errori,
vizi e virtù. In questo modo l’amour-propre, che inizialmente poteva sembrare ridotto ad
un ruolo puramente negativo, viene a partecipare della stessa strutturale duplicità propria
dalla perfettibilità.
2
Ivi, p. 160.
3
Ivi, p. 166.
4
Ivi, p. 144.
5
Ivi, p. 145.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 54
Attraverso l’analisi prima di amore di sé e pietà, nella loro
apparente antecedenza rispetto a ragione e riflessione, e poi delle
lumières, si è data positivamente una prova della limitata
inclusione nel puro stato di natura di quelle stesse facoltà di cui era
stata dimostrata solo, negativamente, la non esclusione. Con ciò,
però, il senso preciso di tale limitazione non è stato ancora chiarito
fino in fondo. Si spalanca qui, infatti, una nuova alternativa. O,
come sembra suggerire il paragone con la vanità, la limitazione,
pur includendo le conoscenze e le facoltà che esse presuppongono,
si pone come radicale esclusione di ogni progresso; oppure un
qualche sviluppo, per quanto limitato, può essere esso stesso
incluso, senza essere inappropriato. La comprensione di questo
punto costringe a domandarsi fino a che punto il limite che nello
stato di natura circoscrive l’attività delle umane facoltà si imponga
come un confine che la natura ha tracciato una volta per tutte, e
rispetto al quale, dunque, ogni sviluppo non potrebbe essere che
innaturale, esterno cioè al naturale ordine delle cose.
Un primo indizio in direzione dell’interiorità di un qualche
sviluppo al puro stato di natura può essere tratto proprio dal
passaggio in cui la sua negazione sembra più radicale, quello in cui
la medesima circolarità già riscontrata sul piano del rapporto
entendement-langage, apparentemente senza vie d’uscita, si
ripropone ora su quello della reciprocità di entendement e raison
da una parte, passions dall’altra. «Quoiqu’en disent les
Moralistes», infatti, non si può negare né che «l’entendement
humain doit beaucoup aux Passions », e che è allora proprio «par
leur activité, que la raison se perfectionne», né, però, che «les
Passions, à leur tour, tirent […] leur progrès de non
connoissances».1 Come nel caso delle facoltà artificiali, anche alle
passioni si è spesso preteso di negare qualunque carattere
originario, nel presupposto che esse si sviluppino solo «al di fuori
della sfera del bisogno, definita dallo stretto necessario», e
appartengano perciò a quella «sfera indefinita del superfluo», 2 e
1
Ivi, p. 143.
2
A. Philonenko, J.-J. Rousseau et la pensée du malheur, I, cit., p. 137.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 55
che non può certo essere originaria, se non può esserlo
l’attaccamento dell’uomo a «toutes ces inutilités, que nous croyons
si necessaires».1 Abbiamo visto poco sopra come l’uomo della
natura, dotato di qualche lumière, non possa esser ritenuto del tutto
privo neanche delle passions, per quanto poche2 e «peu actives»3
esse siano, non foss’altro di quell’«ardeur qu’il a pour son propre
bien-être», quell’«amour du bien-être », cioè, che s’impone quale
«seul mobile des actions humaines». Se allora «nous ne cherchons
à connoître, que parce que nous desirons jouïr»4, e da quest’ultimo
desiderio neppure l’homme originel può non essere scosso, si deve
concludere che la reciprocità di intelletto e passione debba
risolversi in una circolarità la quale, lungi dal renderlo impossibile,
si rivela al contrario intimamente aperta allo sviluppo, e costituisce
anzi essa stessa un primo stimolo a quel «progresso delle
conoscenze» e delle passioni attraverso il quale «la ragione si
perfeziona».
Questo passaggio da una radicale esclusione «di ogni sorta di
lumi» all’inclusione non solo della loro presenza, ma anche di un
qualche loro sviluppo, trova poi conferma in un altro capoverso,
all’inizio del quale la posizione russoiana sembra così netta da
rimettere in discussione tutti i risultati da noi già raggiunti.
Plus on médite sur ce sujet, plus la distance des pures sensations aux plus
simples connoissances s'aggrandit à nos regards ; et il est impossible de
concevoir comment un homme auroit pû par ses seules forces, sans le
secours de la communication, et sans l'aiguillon de la nécessité, franchir un
si grand intervale.5
Pare davvero impossibile, qui, disconoscere che per Rousseau,
«sprovvisto di lumi», fermo al «puro sentimento»,6 «l’uomo della
natura non possiede che la sensibilità»: 7 quella stessa sensibilità
1
Disc., p. 140.
2
Cfr. Ivi, p. 160, dove si parla di «peu de passions».
3
Cfr. Ivi, p. 157.
4
Ivi, p. 143
5
Ivi, p. 144.
6
P. Burgelin, La philosophie de l’éxistence, cit., p. 226.
7
Ivi, p. 230.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 56
che «è, alla radice, una funzione della passività», 1 e relegato alla
quale, proprio in quanto privo «sul piano gnoseologico, […] di
ogni force active»,2 l’uomo naturale può «conoscere ancora un
limpido contatto con le cose, non ancora turbato dall’errore»,
perché «la sensazione ha sempre ragione, anche se non sa di
averla». 3 Sarebbe allora proprio l’inattività delle facoltà artificiali,
che sole possono mettere in relazione tra loro i dati della
sensibilità, organizzandoli in un’esperienza unitaria e coerente, a
far sì da una parte che «per lui ogni sensazione sia nuova» e
dall’altra che «tale apparente discontinuità non sia altro che un
modo di vivere nella continuità dell’immediato »,4 e a permettergli
allora di «vivere nell’immediato, nella sua esistenza qui ed ora
[…] in una perfetta continuità con tutto ciò che è», «naturalmente
in armonia con l’ordine della natura». 5 Poiché in effetti la
«communication» non può giungere a prestare il proprio «secours»
se non quando l’uomo abbia già abbandonato la propria originaria
solitudine, si potrebbe avere l’impressione che la «necessité»
debba anch’essa giungere a pungolare l’uomo, inizialmente fermo
al livello delle pures sensations, solo in relazione al fatto della
socializzazione, senza che da questo pungolo egli possa esser stato
già da sempre afflitto. Si potrebbe credere allora che l’ostacolo,
l’abisso da cui l’uomo sembra separato, nel puro stato di natura,
fin dalle «plus simples connoissances» debba essere a tal punto
profondo da risultare – almeno all’interno di questo stesso stato –
insormontabile. Se però, a partire da questa opinione, si procede
nella lettura delle righe immediatamente successive a quelle citate,
ci si trova subito davanti a un duplice motivo di perplessità, o di
stupore.
A destare stupore, in primo luogo, è il fatto che vi si passi dalla
constatazione dell’incolmabile distanza, in generale, tra sensazione
e conoscenza, prima ad una serie di esclamazioni riguardanti il
1
J. Derrida, Della grammatologia, cit., p. 250.
2
M. Reale, Le ragioni della politica, cit., p. 189
3
J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. La trasparenza e l’ostacolo, cit., p. 58.
4
Ibidem.
5
R. Polin, La politique de la solitude, cit., 71.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 57
tema dell’acquisizione del dominio sul fuoco, e subito dopo a una
serie di considerazioni sull’impossibile originarietà
dell’agricoltura: e ciò senza alcuna soluzione di continuità, senza
che Rousseau si preoccupi minimamente di mediare questo
passaggio, esplicitando il nesso che stringerebbe questo nuovo
problema con quello – non solo più ampio ma, in fondo, anche
diverso – della possibilità stessa del conoscere in generale. Questa
assenza di ogni indicazione utile alla comprensione del salto da un
momento all’altro dell’argomentazione istituisce tra i due momenti
una relazione immediata, costringendoci ad assumere
l’impossibilità delle plus simples connaissances e quella
dell’appropriazione del fuoco, in realtà, come un’unica
impossibilità, ad assumere la seconda, cioè, come un simbolo della
prima, e l’acquisizione del fuoco, di conseguenza, come simbolo
di ogni acquisizione, in generale, della conoscenza e della tecnica. 1
L’agricoltura è invece il simbolo non delle «più semplici
conoscenze», e quindi della conoscenza in generale, ma di una
conoscenza e di una padronanza tecnica della natura già più
evoluta.
Un analogo stupore, in secondo luogo, non può non cogliere il
lettore che si aspettasse di trovare, nella serie di esclamazioni
riguardanti il fuoco, una conferma all’idea di quell’intervale, di
quella distance capaci da una parte – sbarrandogli l’accesso alle
«idées générales» e «purement intellectuelles»,2 dalle quali
neanche le «plus simples des connoissances» possono essere
separate – di impedire che l’uomo “trasgredisca”, «par ses seules
forces», il confine che lo relega alle «pures sensations»; e
dall’altra, con ciò, di preservare l’uomo naturale da qualunque
possibile evoluzione. L’agricoltura, nel suo legame con la
proprietà, la divisione del lavoro, la disuguaglianza, rimane
senz’altro impossibile «tant que l’état de Nature ne sera point
1
A stagliarsi sullo sfondo, qui, è l’idea di un’essenziale priorità del momento pratico
su quello cognitivo: è innanzitutto l’agire a produrre e determinare le conoscenze che
esso stesso esige, e non una conoscenza, già acquisita a prescindere dall’azione, a
determinarla ed indirizzarla dall’esterno.
2
Cfr. Disc., pp. 149-150.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 58
anéanti». 1 Per quanto riguarda il fuoco, però, si assiste subito a una
sorta di diminuendo nel quale, di esclamazione in esclamazione, si
passa da una prima, in cui pare asserita l’impossibilità, nello stato
di natura, di ogni sua acquisizione; a una seconda, in cui la
possibilità del suo uso, pur sempre ancora solo occasionale e legata
a qualche accidente, pur sempre accompagnata dall’incapacità di
produrlo, viene comunque affermata; a una terza, in cui si dice che
l’uso reiterato, svelando grazie a questa sua reiterazione il segreto
della produzione, finisce per trasformarsi in apprendimento, in
tecnica, in dominio; a una quarta, infine, nella quale
l’affermazione che quest’«art», come un incomunicabile «secret»,
sia dovuta a lungo perire col suo inventore e custode,2 finisce suo
malgrado col rivelare l’acquisizione di quell’«arte» come un
evento da situare proprio all’interno di quel «puro stato di natura»
(senza peraltro che questo evento possa costituire di per sé stesso
un superamento di questo stato),3 perché in esso soltanto, data la
caratteristica solitudine dell’uomo, una scoperta potrebbe essere
incomunicabile. Dovremo tornare nell’ultima parte di questo
lavoro sulla singolare figura di questa conversione, di questo
capovolgimento della ripetizione del medesimo in una produzione
del diverso (la ripetizione dell’uso nella produzione della
conoscenza). Se però il fuoco è davvero il simbolo, o il
rappresentante, della conoscenza, si è costretti a riconoscere che si
passa qui, all’interno dello stesso puro stato di natura, dall’idea di
una radicale impossibilità della conoscenza e di ogni suo sviluppo
a quella di una loro semplice incomunicabilità. «Des hommes qui
1
Ivi, p. 150.
2
Si noti che quest’ultima esclamazione non può in nessun modo essere considerata
una svista, perché viene ripresa quasi alla lettera («l’arte periva con l’inventore», ivi, p.
68) diverse pagine dopo, e proprio al momento di fornire un riassunto degli esiti già
raggiunti.
3
Rousseau si domanda infatti «combien de fois […] chacun de ces secrets n’est-il
pas mort avec celui qui l’avoit découvert?». Il dominio del fuoco, come apprendimento di
un’«arte», di una qualche padronanza tecnica sui fenomeni naturali, non può costituire di
per sé stesso il superamento dello stato di natura, perché questo stato è caratterizzato
innanzitutto dalla solitudine. È questa solitudine, che non ne viene intaccata, che
costringe la scoperta a perire con l’inventore, e per ciò stesso ad una indefinita
reiterazione.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 59
[…] se rencontreroient, peut-être à peine deux fois en leur vie, sans
se connoître et peut-être sans se parler», è vero, non possono certo
«se perfectionner, et s’éclairer mutuellement», e alla domanda
riguardo a «qurl progrès pourroit faire le Genre humain épars dans
les Bois parmi les animaux»1, una sola è la risposta possibile:
nessuno. «La faculté de se perfectionner», però, «reside parmi
nous tant dans l’espéce, que dans l’individu». Per quanto
indissolubilmente questi due livelli possano essere intrecciati, essi
mantengono comunque una certa reciproca autonomia. Constatare
allora, nel puro stato di natura, l’assenza di qualunque progresso
capace di coinvolgere il genre humain, il fatto cioè che la specie
umana, come quelle animali, è «au but de mille ans, ce qu’elle
étoit la premiere année de ces mille ans»2, e che allora «les
générations se multiplioient inutilement»3, non significa ammettere
che anche l’individuo, al pari dell’animale, sia «au bout de
quelques mois, ce qu’il sera toute sa vie». 4 Nell’atto stesso di
affermare che «il n’est pas concevable que ces prèmiers
changemens, par quelque moyen qu’ils soient arrivés, aient altéré
tout à la fois et de la même maniére tous les Individus de
l’espéce»,5 in effetti, Rousseau si trova a riconoscere dei
changemens, ovvero un’evoluzione individuale, che non sono
impediti dall’assenza di una “storia universale del genere umano”.
«Education» e «communication», in breve, sono necessarie a
sbloccare una situazione in cui «les générations se multiplioient
inutilement […], et les Siécles s’écouloient dans toute la
grossiéreté des premiers âges», perché «chacune» partiva «du
même point»6, senza poter far leva sulle pregresse conquiste
dell’altro: non a una qualunque produzione o sviluppo delle
conoscenze (pur «dallo stesso punto», infatti, resta il fatto che
ciascuno partiva), ma unicamente a quella loro circolazione e
1
Ivi, p. 146.
2
Ivi, p. 142.
3
Ivi, p. 160.
4
Ivi, p. 142.
5
Ivi, p. 123.
6
Ivi, p. 160.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 60
trasmissione che sola rende possibile il loro incremento oltre una
certa soglia e un’accumulazione progressiva, capace cioè di
proseguire, di generazione in generazione, lungo una linea più o
meno continua.
Che «une Providence très sage» impedisca alle facoltà che
l’uomo aveva «en puissance» di svilupparsi se non «avec les
occasions de les exercer», come si è visto alla fine del § 2.2,
significa allora da una parte che deve essere quella stessa
«provvidenza» ad autorizzarle a svilupparsi nell’occasione del loro
esercizio, di modo che però, come nota Gouhier, «esercizio» e
«sviluppo» non possono che andare di pari passo;1 e che d’altra
parte le occasions di un qualche esercizio devono essere già da
sempre presenti. Per quanto ancora germinale, embrionale, una
qualche loro operatività, come si è visto, è comunque oltre che
ammessa anche direttamente esigita dalla struttura profonda del
ragionamento, in forza del quale – come si è già notato – la società
e la comunicazione sopraggiungono dall’esterno non a produrre,
ma a coltivare, a sviluppare, a “perfezionare” nell’individuo
qualcosa che, proprio per essere ancora “non coltivato”,
perfettibile, non può fare a meno di essere non solo virtualmente,
ma già anche attualmente, operativamente presente, e per ciò
stesso teso a quello sviluppo nel quale «lumiere et […] erreurs,
[…] vice set […] vertus»2 andranno necessariamente di pari passo.
Si capisce allora come il Rousseau della Lettre à Ch. de Beaumont,
proprio nel riassumere alcuni degli esiti del Discours, possa
sentirsi autorizzato a scrivere che «l’homme qui, privé du secours
de ses semblables et sans cesse occupé de pourvoir à ses besoins,
est reduit en tout chose à la seule marche de ses propres idées, fait
un progrès tres lent de ce côté-là: il vieillit et meurt avant d’être
1
Cfr. H. Gouhier, La perfectibilité selon Rousseau, «Revue de théologie et de
philosophie», CX, 1978, p. 329, dove si afferma che la perfettibilità «designa un fatto
molto semplice: la reazione dell’esercizio sulla facoltà che si esercita», il fatto cioè che le
facoltà siano concepite non come cose, ma come «funzioni» le quali «sono naturalmente
perfezionate dal loro funzionare».
2
Disc., p. 142.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 61
sorti de l’enfance de la raison», 1 affermando così non solo che la
ragione, invece di rimanervi allo stato embrionale, latente, viene
alla luce già nell’uomo naturale e senza il «secours de ses
semblables», perché il travaglio e il parto della ragione non sono
un fatto essenzialmente sociale, ma che inoltre la ragione, per
quanto in modo «très lent», e senza uscire dalla propria «enfance»,
già all’interno del puro stato di natura non manca neanche di
muovere i suoi primi passi, nel proprio sviluppo, senza alcun
bisogno di un’assistenza esterna.
2.5. «Reçues en puissance»
Se allora, per concludere questa sezione, proviamo a chiederci
cosa possa mai significare l’esser state le facoltà distintive
dell’uomo ricevute solo «in potenza» dall’uomo naturale, non è
forse impossibile scorgere, sulla base di quanto siamo venuti
dicendo, il senso preciso di questa loro caratteristica virtualità.
Sappiamo già che Rousseau si riferisce alla facoltà di volere, alla
volontà, nominandola come una «puissance», una potenza. Questa
«potenza», o «facoltà» – i due termini, come si vede, sono infatti
sinonimi – non si configura però come una mera potenzialità
senz’atto, né come una potenza che all’atto possa “passare”,
realizzandosi e risolvendosi in un’attualità senza scarti.
Innanzitutto, la «puissance de vouloir», in cui abbiamo visto
consistere primariamente la «spiritualité de son ame», non è
neanche per l’uomo naturale una astratta virtualità. 2 In secondo
luogo la volontà è una puissance inesauribile, tale che nessun
1
Cfr. J.-J. Rousseau, Œuvres complètes, cit., vol. IV, p. 951. Sull’applicazione di
questa metafora biologica (infanzia, maturità, decrepitezza…) alla storia del genere
umano all’interno della settecentesca filosofia del progresso, cfr. S. Landucci, I filosofi e
i selvaggi, cit., p. 235.
2
Da una parte, come si è già visto, è certamente vero che per l’uomo «apercevoir et
sentir sera son premier état, qu’il lui sera commun avec tous les animaux»; dall’altra,
però, non è meno vero che, se «vouloir et ne pas vouloir […] seront les premiéres […]
operations de son ame» (cfr. Disc., pp.142-3), quell’apercevoir e quel sentir devono
essere in realtà proprio il «sentiment» e la «conscience» – diversamente che in qualunque
altro animale – di quella «puissance», o «liberté».
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 62
progetto, nessun telos può rappresentarne un compimento, che le
impedisca di sempre nuovamente volere: tale, dunque, da dover
restar salda accanto a ogni sua realizzazione come una pura, intatta
possibilità di volizioni sempre ulteriori, potendosi “realizzare” solo
in una serie potenzialmente infinita di atti discreti, in un’attività di
per sé stessa naturalmente inconcludente, inconclusa. La
«puissance de vouloir» non può dunque essere né, da una parte,
una mera potenza senz’atto, una potenza incapace di risolversi essa
stessa da sé stessa, spontaneamente, all’atto, né, d’altra parte, una
potenza che in un qualche atto, in una qualche determinata
attualità, possa essere pienamente risolta, o compiuta, o realizzata
o, in una parola, esaurita, una potenza in grado, cioè, di “passare”
all’atto, in un atto che sia proprio il “passare”, l’“esser-passata”
della potenza. Esattamente allo stesso modo il fatto che l’uomo
naturale possedesse solo «en puissance» quelle facoltà che sono
metonimicamente riassunte dalla «raison», poiché una facoltà altro
non è se non una «puissance», non significa affatto che quelle
potenze dovessero essere incapaci di ogni attualizzazione, ma,
esattamente al contrario, che proprio come “potenze”, come
facoltà, esse devono essere attualmente, attivamente possedute
dall’uomo naturale non meno che dall’uomo civile.
In primo luogo, allora, le facultés que l’homme naturel avoit
reçues en puissance, nonostante le diversità che ne segnano
l’esercizio, rappresentano delle invarianti generiche,
identicamente, attivamente proprie di ogni uomo in quanto tale. In
questo modo, però, la proposta di Derathé di distinguere,
all’interno della produzione russoiana, due significati del concetto
di «natura umana» non può non mostrare la propria fragilità. Nel
Discours, conformemente a questa distinzione, il «naturale»
coinciderebbe con l’«originario, in opposizione a ciò che è
acquisito», all’«artificiel», mentre nell’Émile naturale sarebbe «ciò
che è essenziale», «comune a tutti», «in opposizione a ciò che non
è se non contingente o accidentale». 1 Noi abbiamo visto,
1
R. Derathé, L’homme selon Rousseau, in AA.VV. Études sur le «Contrat social» de
J.-J. Rousseau, cit., pp. 203-17.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 63
esattamente al contrario, come ciò che è comune a tutti, ovvero le
facultés o puissances in quanto tali, sia anche originario, e
contingente solo ciò che è acquisito, ovvero le singole
attualizzazioni o “fissazioni” di quelle facoltà. È solo su questo
presupposto che si riesce a comprendere in che senso Rousseau
possa dichiarare che l’oggetto unitario del Discours, il suo «sujet»,
è l’homme en général – esattamente lo stesso che l’Émile chiamerà
«homme abstrait» – e la sua storia. Da una parte, infatti, la natura
originaria, propria del primo, e la nature actuelle, propria del
secondo, non sono alla radice che una stessa natura, attualizzazioni
diverse di una medesima potenzialità. Dall’altra anche la prima,
non meno della seconda, deve inoltre essere pensata come una
sintesi tanto di elementi originari, identici in entrambe (le facoltà),
quanto di quelle «diverses qualités» che alla loro comune natura
«n’etoient point inhérentes»1 (le attualizzazioni), e che, essendo il
risultato di uno sviluppo, meritano pur sempre di essere definite
artificiali. Il fatto che qualità artificiali e contingenti siano quindi
necessariamente proprie dell’homme en général, e dunque tanto
dell’uomo originario o naturale quanto dell’uomo civilizzato,
impedisce di parlare, come fa ad esempio Landucci, di una
«identità rousseauiana natura-origine»:2 se l’artificiel, pur nella
sua variabilità, deve esser pensato come qualcosa di esso stesso
naturale, e necessario, allora naturale sarà non già l’opposizione tra
originario e artificiale, tra l’essere e il divenire, ma la loro
integrazione. «Tutto è storia», si può dire con Burgio; ciò però solo
se si ammette, contro Burgio, non già che «niente è immutabile»,3
ma che la storia è pur sempre il divenire di una stessa, permanente
natura, di un soggetto – il genere umano – che non può essere
pensato come lo stesso senza pensare al tempo stesso qualcosa, in
esso, che si sottrae al mutamento.
Uomo civile e uomo naturale, insomma, non sono distinti per il
solo fatto che l’uno possiede in atto quelle facoltà che l’altro non
possiede affatto, se non in potenza, ma dalle differenze che
1
Disc., p. 123.
2
S. Landucci, I filosofi e i selvaggi, cit., p. 367.
3
Cfr. A. Burgio, Necessità della storia e storia impossibile, cit., p. 118.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 64
caratterizzano la loro attività ed i loro prodotti. Le «facoltà che
l’uomo naturale aveva ricevuto in potenza», vale a dire, sono
esattamente le stesse che l’uomo civile, in quanto partecipa di una
tradizione, ed è cioè inserito in un dato contesto storico, sociale,
culturale, riceve per così dire già in atto. La differenza tra i due
casi, dunque, sta in ciò, che mentre nel puro stato di natura la
potenza di quelle facoltà si presenta ancora in tutta la sua
indeterminatezza, e la loro attività non è quindi condizionata da
una loro precedente oggettivazione, nell’uomo civile essa subisce
invece, da parte delle sue stesse realizzazioni, dei condizionamenti
che ne preorientano in qualche misura l’attività e lo sviluppo. La
«cultura», che è un prodotto dell’esercizio di quelle facoltà, un
modo in cui la loro energia si è fissata, oggettivata, diventa
qualcosa che i singoli si trovano di fronte come un dato naturale ed
«autonomo», come nota Goldschmidt, rispetto al loro volere, il
presupposto storico di quella stessa naturale attività di cui è il
prodotto.1 Essendo solo due attualizzazioni determinate di una
potenza che però, al di sotto di ogni propria realizzazione, permane
invariata nella propria generica indeterminatezza, si capisce in che
senso l’identità dell’uomo civile e quella del selvaggio debbano
costituire, nonostante ogni loro differenza, come due variazioni su
uno stesso tema, quello dell’identità dell’«uomo in generale».
Fin qui abbiamo dimostrato il carattere originario sia
dell’attività sia di un qualche sviluppo delle facoltà che
distinguono l’uomo dall’animale. L’analisi di una questione più
circoscritta, quella della loro origine, dovrà qui di seguito essere
occasione di un importante chiarimento sul rapporto tra Première e
Seconde partie del Discours, attraverso il quale ad emergere sarà,
riguardo alla costruzione russoiana del puro stato di natura, la
tensione da cui è interiormente attraversata.
1
Cfr. V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 759. Su questa particolare
struttura concettuale, nonché sul rapporto tra indeterminatezza e determinazione di
facoltà e desideri, ci permettiamo di rimandare inoltre al nostro Passione,
riconoscimento, diritto nel «Discorso sulle origini della disuguaglianza», «Post-filosofie.
Rivista di pratica filosofica e di scienze umane», 4, 2007, pp. 129-57.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 65
3. L’origine assente
3.1. L’inizio della «Seconde partie» come riepilogo della
«Première partie»
La Seconde partie comincia, nel suo primo capoverso, con lo
gettare il lettore direttamente nel vivo degli argomenti che
dovranno essere affrontati; nel secondo, invece, si volge a
rievocare gli esiti della prima metà dell’opera; nel terzo e quarto
mostra come l’uomo dovette muovere i primissimi passi al di là
della propria condizione originaria; nel quinto e nel sesto descrive
l’insorgere della riflessione e l’acquisizione, in seguito a questa
comparsa, tanto di una prima forma di dominio dell’uomo sugli
altri animali quanto, conseguentemente, di una qualche
consapevolezza ed orgoglio del genere umano; nel settimo e
nell’ottavo, infine (chiarendo così, implicitamente, il carattere
illusorio della circolarità tra la socializzazione, come condizione di
possibilità del linguaggio, e le precondizioni linguistiche
dell’associazione stessa), coniuga questa stessa consapevolezza
come riconoscimento di sé nell’altro in quanto membri, entrambi,
di una stessa specie, come reciprocamente simili l’uno dell’altro,
ed espone in che modo essa conduca naturalmente –
contrariamente al parere di quanti parlano di pactum associationis1
– a «qualque sorte d’association libre»,2 senza bisogno, per
fondarne la possibilità, di mediazioni o patteggiamenti. 3
Di questo inizio, per il dinamismo che in esso si dispiega, è
stato detto che il contrasto con la Première partie, che sarebbe
caratterizzata invece da un equilibrio statico e senza tempo, «non
potrebbe essere più stridente». 4 Sebbene costretti ormai a
1
V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 414.
2
Disc., p. 166.
3
È per questa assenza di un contratto, e per la sufficienza del solo naturale amore di
sé a produrre le prime forme di socializzazione, che si può concordare con A. Loche
quando afferma che «la vita sociale […] è altrettanto naturale di quella del primitivo» (A.
Loche, Immagini dello stato di natura in J.-J. Rousseau, cit., p. 70).
4
A. Burgio, Eguaglianza interesse unanimità, cit., p. 32; per il vero e proprio topos
interpretativo rappresentato dall’assenza di temporalità, intesa sia come temporalità
vissuta, soggettiva, sia come la temporalità oggettiva del processo storico, vedi anche J.
Starobinski, Introduction a Disc., p. lvi; G. Poulet, Études sur le temps humain, I, Paris
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 66
soffermarci in particolare sul solo passaggio riguardante la genesi
della riflessione, ciò che qui di seguito si dovrà dimostrare, al
contrario, è come la dinamica cui ci pone di fronte l’inizio della
Seconde partie debba essere considerata tutta inerente al «puro
stato di natura» e alla descrizione che ne è stata fatta nella prima
metà dell’opera. Un «vero» stato di natura la cui “purezza” – o
“verità” –, nell’atto stesso in cui si rivela definita non più da
un’incondizionata solitudine, ma solo dal carattere occasionale di
cooperazione e competizione, deve rivelarsi altresì omogenea alla
storia e, proprio per questo, internamente votata al dissolvimento:
dissolvimento che non è mai stato altro, allora, se non questione di
tempo.1
Dopo il breve riassunto degli esiti raggiunti, 2 viene introdotta
tutta una serie di «difficultés» che l’uomo dovette imparare a
vincere, e la cui soluzione richiese, tra l’altro, quella che viene qui
nominata come «une nouvelle industrie»: l’invenzione e
costruzione di strumenti. In questo contesto è innanzitutto degno di
nota il fatto che ad essere presentato come una concatenazione di
novità è in realtà un insieme di elementi i quali in precedenza
erano stati bensì – come nota Goldschmidt – «trascurati», «messi
come tra parentesi», e che però a uno sguardo fattosi
retrospettivamente attento – cosa che Goldschmidt non nota – non
possono sfuggire come tutti ugualmente, proprio in quanto
trascurati, presenti. Non solo tutti gli «obstacles» elencati
1950, p. 158; M. Ansart-Dourlen, Dénaturation et violence dans la pensée de J.-J.
Rousseau, Paris 1975, p. 47; V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 239; J.
Derrida, Della grammatologia, cit., pp. 336-37; R. Esposito, Communitas, cit., p. 36.
1
È proprio in questo senso che occorre allora intendere il fatto che la forza della
perfettibilità sia la stessa «force» del tempo» (Disc., p. 142).
2
Cfr. ivi, p. 164, secondo capoverso. In questo riepilogo ci pare sia presente almeno
un lapsus che, proprio nella misura in cui incorre in un riassunto del già detto, conferma
l’interpretazione che finora abbiamo data dello stato di natura. La conservazione della
propria vita viene definita – analogamente a quanto si legge ivi, p. 140 – l’oggetto, per
l’uomo, non di un istinto, ma di un «soin», e cioè una cura, un compito, una
preoccupazione o una responsabilità, e anzi del suo «premier soin», come a dire che
“cura” e “responsabilità” (anche se ancora solo verso sé stessi) sono un prius
dell’umanità, qualcosa che la costituisce originariamente e come tale.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 67
(l’attacco da parte delle bestie feroci,1 l’altezza degli alberi, 2 la
presenza delle stagioni3 o di differenze climatiche 4…) sono
puntualmente ripresi dalla Première partie, ma neanche della
«nouvelle industrie» acquisita dall’uomo nello sforzo di superarli
vi si dava una vera e propria assenza: si pensi agli scontri in cui
l’uomo combatteva «armé de pierres, et d’un bon bâton», 5 alla
conciatura delle pelli, 6 o al dominio del fuoco.7 Con ciò stesso,
1
Cfr., ad esempio, ivi, p. 136.
2
Cfr. ivi, p. 135: «S’il avoit eu une échelle, grimperoit-il si légérement sur un
arbre?».
3
Cfr. ibidem: «Accoutumé des l’enfance aux intempéries de l’air, et au rigueur des
saisons».
4
Cfr. ivi, p. 140: «Païs chauds… Païs froids».
5
Ivi, p. 136.
6
Ivi, p. 140.
7
Ivi, pp. 144. L’unico tema completamente assente nella prima metà dell’opera – o
meglio nominatovi solo en passant, quale premessa ipotetica di un ragionamento per
assurdo (cfr. ivi, p. 145) –, a ben vedere, è quello dell’incremento demografico. Non è un
caso allora che proprio su di esso molti interpreti (cfr. ad esempio, L. Strauss, Diritto
naturale e storia, cit., p. 265; A. Philonenko, J.-J. Rousseau et la pensée du malheur, I,
cit., p. 195; B. Carnevali, Romanticismo e riconoscimento, cit., p. 72) si siano trovati a
far leva nel tentativo di chiarire dove possa mai essere collocata, all’interno della cornice
del Discours, l’origine della storia, a quale elemento riferita la scintilla che, innescando
l’inarrestabile meccanismo dell’evoluzione, segna il passaggio dell’uomo al di là del
«puro stato di natura». Ad una simile interpretazione del problema dell’origine della
storia – o del passaggio ad essa – intesa come «un processo naturale, dovuto non all’uso
buono o cattivo della libertà, o a una necessità essenziale, ma alla meccanica causalità»
(L. Strauss, Diritto naturale e storia, cit., p. 266), all’«attività incosciente di riproduzione
della specie» e al carattere illimitato «attività sessuale» (A. Philonenko, J.-J. Rousseau et
la pensée du malheur, I, cit., p. 195), che determina assieme sovrappopolazione e
migrazioni, può esser mossa in realtà – ad un livello, per il momento, di semplice critica
testuale – almeno un’obiezione. Leggendo il testo con attenzione si nota subito un primo
indizio. Il prodursi della «différence […] dans leur manières de vivre», legata al differire
«des terrains, des Climats, des saisons», viene infatti connessa al progressivo “estendersi
del genere umano” come a una sua conseguenza (Disc., p. 165). È in forza cioè di un
incremento demografico che l’uomo, costretto a migrare per sopravvivere, si imbattere in
quella «différence» e ne viene costretto egli stesso a mutare. Se però si tiene conto, in
primo luogo, di come la differenza di climi e stagioni fosse già stata introdotta nella
Première partie come un elemento interno del puro stato di natura, e in secondo luogo di
come sia Rousseau stesso a parlare, esattamente nel riassunto degli esiti già raggiunti
proprio nella Première partie, di «diverses maniéres d’exister», non si vede come
potrebbe allora negarsi un’identica “interiorità” a ciò che pure, di questa differenza dei
climi e dei modi di vivere, è la causa: alla migrazione e all’accrescimento numerico che
la occasiona e necessita. Lungo l’intera produzione russoiana, in effetti, è presente un
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 68
quella operata da Rousseau in questo luogo rivela di dover essere
considerata non – come a un primo sguardo potrebbe sembrare
naturale – una descrizione dell’oltrepassamento del «puro stato di
natura» ma, proprio al contrario, come un approfondimento della
descrizione già fornitane, l’unificazione in un unico sguardo di
elementi che, tutti interni, vi si erano trovati però come
sparpagliati, dispersi. Raccolti ed ordinati l’uno rispetto all’altro in
un unico sguardo, essi rivelano ora tutta la «puissance
surprenante» di quelle «causes très-légeres» che nascostamente e
«sans rêlache»1 agiscono già nella Première partie, e proprio nella
constatazione delle quali, nonché del loro ruolo imprescindibile nel
superamento dello stato di natura, quella sezione dell’opera
trovava la propria conclusione. Sono cioè esattamente i medesimi
elementi che in precedenza contribuivano alla definizione di un
equilibrio nel rapporto uomo-natura apparentemente capace di
porsi come statico – e cioè essenzialmente la sua capacità adattiva,
l’abilità di approntare soluzioni non date a problemi dati –, a
rivelare ora di dover minare, di un tale equilibrio, la stessa
possibilità, inserendo in esso un inarrestabile dinamismo. È vero,
con Starobinski, che «dall’istante in cui [gli uomini] si impegnano
a lottare contro gli ostacoli, essi vengono strappati all’eterno
presente che era la loro precedente dimora, devono giudicare,
confrontare, servirsi di strumenti; scoprono la speranza e il
rimpianto, mentre il tempo dispiega le dimensioni dell’assenza,
nesso imprescindibile tra estensione della popolazione e felicità (basti qui ricordare
Contr., III, 9, «Des signes d’un bon gouvernement», p. 420, dove « leur [dei cittadini]
nombre et leur population» sono un segno evidente della conformità dell’associazione
politica al proprio fine, e cioè – almeno in questo passo – «la conservation e la prospérité
de ses membres»). Anche in un frammento politico che originariamente doveva costituire
proprio la risposta a un problema posto e non risolto dal Discours (cfr. Disc., p. 152), si
può leggere che «quicinqye renonçant de bonne foi à tous les préjugés de la vanité
humaine, réfléchira sérieusement à toutes ces choses, […] concluera, malgré tous les
sophismes des raisonneurs, que le pur état de nature est celui de tous où les hommes
seroient le moins méchants, le plus heureux, et en plus grand nombre sur la terre» (cfr.
J.-J. Rousseau, Fragments politiques, In Œuvres complètes, cit., vol. III, p. 475). Questo
per dire non che la diffusione del genere umano nei vari luoghi del globo fosse un dato
originario, ma che essa dovette rappresentare un’altra delle interne evoluzioni dello stato
di natura, insufficiente, di per sé stessa, ad infrangerne i confini.
1
Ivi, p. 162.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 69
mettendo in moto l’evoluzione umana». 1 Dato il carattere
originario degli obstacles, si deve riconoscere o che nel puro stato
di natura l’uomo abbia mai potuto dimorare o, come si è cercato di
dimostrare nel precedente paragrafo, che esso non sia mai stato un
tale «eterno presente», sottratto ad ogni evoluzione.
È esattamente nel contesto intimamente dinamico che siamo
venuti delineando che si produce la riflessione. Ciò che dobbiamo
cercare di scorgere nell’analisi di questa sua “produzione” non è
solo un segno del fatto – già dimostrato – che neppure il «puro
stato di natura» possa essere esentato da un suo interno divenire, e
neppure un semplice indizio della continuità tra questo suo interno
divenire e quello da cui l’uomo sarà storicamente sospinto, al di là
della sua condizione originaria, lungo le diverse tappe della
socializzazione; a doversi palesare sarà, più radicalmente, una
interna “dissoluzione” della logica dell’origine, dell’originario, un
indizio del fatto che nel Discours – per i suoi esiti consapevoli, e
non per le sue interne difficoltà – la logica dell’originario trova
recisa ogni validità, o credibilità, mostrando come la sua unica
verità stia nella sua impossibilità di consistere in sé stessa. Come
poi questo esito finisca per coincidere con una – limitata –
prossimità alla posizione giusnaturalistica, è un aspetto della
questione a proposito del quale ci si dovrà limitare a null’altro che
a un accenno.
3.2. L’atto di nascita della riflessione?
Tenendo ferma la possibilità di verificare, nell’originario stato
di natura, tanto il presentarsi delle «difficultés», quanto il
rinvenimento della loro soluzione attraverso la «nouvelle
industrie», e dunque nell’uso di strumenti, in un rapporto mediato
con il mondo, occorre ora passare direttamente all’esame di quella
che viene proposta da Rousseau come la spiegazione – o piuttosto
il “racconto” – della genesi della riflessione. 2
1
J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. La trasparenza e l’ostacolo, cit., p. 336.
2
Notiamo subito, per non dovervi tornare in seguito, che se l’esito di questa genesi è
proprio quella «sorte de réflexion» che equivale piuttosto «une prudence machinale», e
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 70
Cette application réitérée des êtres diverses à lui-même, et des uns aux autres,
dut naturellement engendrer dans l’esprit de l’homme des perceptions des
certains raports. Ces relations que nous exprimons avec les mots de grand, de
petit, de fort, de foible, de vîte, de lent, de peureux, de hardi, et d’autres idées
pareilles, comparées au besoin, et presque sans y songer, produisirent enfin chez
lui quelque sorte de réflexion, ou plûtôt une prudence machinale qui lui
indiquoit les précautions les plus nécessaires à sa sûreté.1
Nell’analisi di questa tentata esibizione dell’origine non è
inopportuno, per metterne alla prova l’interna consistenza,
procedere a ritroso. Cerchiamo di avanzare con ordine, anche se
invertito. La réflexion, innanzitutto, sembra porsi in ultima istanza
come prodotto («produisirent») di quelle idee «che noi esprimiamo
con le parole grande, piccolo […], e di altri simili idee,
comparate»: non direttamente delle idee, dunque, ma solo della
loro comparazione, dell’attività che, nel paragonarle, le pone in
relazione tra loro. È solo nella posizione, in un medesimo atto,
tanto della loro congiunzione quanto della loro differenza, nell’atto
che istituisce ad un tempo la relazione e la distinzione tra il
concetto di “forte” e quello di “debole”, di “veloce” e di “lento”,
che può insorgere quella «specie di riflessione o, piuttosto,
prudenza macchinale» grazie alla quale l’uomo è in grado, come
abbiamo visto, di «accettare o rifiutare lo scontro» con un animale,
poniamo, più forte e più lento di lui. Ma può davvero essere questa
l’origine della riflessione, essere cioè un certo paragone a
“produrla”, a determinarne il passaggio al di là della pura
virtualità? Quello tra paragonare e riflettere, in realtà, non può
essere in alcun modo lo stesso genere di rapporto che congiunge e
separa l’attività produttiva dal suo prodotto, l’origine da ciò che
essa origina. Come tutti gli interpreti riconoscono, infatti, è solo
«la réflexion, a differenza del sentiment, passivo e immediato, che
può muoversi attivamente da un termine all’altro, confronta,
però, come abbiamo visto in precedenza, le tracce anche di questa «prudence» sono
rinvenibili all’interno del puro stato di natura, allora quella genesi non altrove potrà
essere collocata se non all’interno di questo stato stesso.
1
Ivi, p. 165.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 71
paragona, giudica», 1 «elabora idee di rapporti e di relazioni». 2 «La
relazione di uno stato di coscienza all’altro non è possibile senza
paragone, ossia senza giudizio», 3 o riflessione. Paragone e
riflessione non possono allora fare a meno di prendere l’una il
posto ed il ruolo dell’altra. L’attivarsi della riflessione non può
certo essere il prodotto di un paragone, perché, semplicemente,
ogni paragone non è che un atto di riflessione. A prodursi
attraverso la comparaison tra le idee «di grande e di piccolo, di
forte e di debole», a ben notare, non è affatto la riflessione, la
“riflessione in generale”, ma solo quella particolare «specie di
riflessione» che può anche essere nominata come una «machinale
prudence», di cui abbiamo precedentemente mostrato l’operatività
già nel puro stato di natura. Tale «sorte de réflexion» è dunque
solo un modo determinato in cui la riflessione si pone in atto da sé
stessa, in un circolo all’interno del quale è la riflessione stessa a
determinare spontaneamente, “riflessivamente” sé stessa, ad auto-
modificarsi cioè fissandosi nella “nuova”, particolare figura di
quella «prudenza». Dell’origine della “riflessione in generale”,
dell’innescarsi della sua attività, del processo – o dell’istante, lo
“scarto” – del suo “passare” all’atto, fin qui, non c’è traccia.
Nel presupposto che camminando a ritroso sia possibile
pervenire, infine, all’inizio del cammino, si potrebbe supporre che
muovere un passo indietro, all’interno della successione di
momenti scandita dal nostro testo, possa costituire in realtà, per la
ricerca di questo “scarto” tra origine ed originato, tra potenza ed
atto, un passo in avanti. Non appena questo passo viene mosso,
però, si vede subito che le «idee» alla cui comparazione
spetterebbe di produrre quella «specie di riflessione» che è la
«meccanica prudenza» – le idee di grande e di piccolo, di lento e
di veloce – sono esse stesse, in sé stesse, oltre che idee astratte,
anche idee di una «relazione», di una differenza, prive di
1
B. Carnevali, Romanticismo e riconoscimento, cit., p. 75
2
M. Viroli, J.-J. Rousseau e la teoria della società ben ordinata (1988), trad. it.,
Bologna 1993, p. 28.
3
Y. Belaval, La théorie du jugement dans l’«Emile», in AA.VV., J.-J. Rousseau,
Neuchâtel-Paris 1978, p. 151.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 72
qualunque significato al di fuori del loro reciproco legame: sono
delle «relations» (o delle «idee» di relazione) ad essere espresse da
ognuna delle parole elencate da Rousseau. Da una parte –
banalizzando i termini della questione – l’idea dell’esser-grande di
una cosa è innanzitutto l’idea di una relazione e di una differenza
di questa cosa con un’insieme di altre cose meno grandi, o più
piccole. Dall’altra, «tous les individus se présentérent isolés à leur
esprit, comme il le sont dans le tableau de la Nature»,1 e la
sensazione, nella sua pura passività, altro non può fare se non
rispecchiare in sé stessa questa isolatezza. Le «percezioni di certi
rapporti», in cui quelle idee di relazione trovano la loro origine,
non possono certo essere, dunque, delle semplici sensazioni. Come
infatti Rousseau scriverà annotando la propria copia dell’opera di
Helvétius, «appercevoir les objets c’est sentir», ma «appercevoir
les rapports, c’est juger». 2 Percezione, almeno in questo caso, non
è sensazione, ma relazione tra sensazioni, ed è solo in un giudizio
– all’interno, cioè, di un atto riflessivo – che la relazione e la
differenza tra le cose sentite può esser posta. Quelle «perceptions»
non possono quindi essere se non, esse stesse, riflessione, o
giudizio.
Finora, dunque, non ci si è trovati di fronte se non alla
riflessione stessa. La riflessione è anzi l’origine di quelle stesse
idee paragonando le quali la riflessione rende possibile lo sviluppo
di una propria nuova figura, fissando la propria puissance nella
forma della prudence machinale. Se non può essere neppure nelle
«percezioni di certi rapporti», percezioni che sono, ognuna, solo
un determinato modo di porsi in atto proprio della riflessione, e se
al di fuori di un atto di riflessione non solo non può darsi il
paragone tra le diverse idee, ma neanche le idee stesse, l’origine
dell’attività riflessiva rimane ancora inattinta. Muovendo però un
ulteriore passo indietro, potrebbe sembrare che il testo giunga
infine ad indicare con chiarezza quale debba essere considerato
l’elemento “generativo” di questo processo, lungo il quale non si è
1
Disc., p. 149.
2
J.-J. Rousseau, Œuvres complètes, cit., vol. IV, p. 1122.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 73
finora assistito a null’altro se non al riprodursi e alterarsi di una
riflessione ogni volta già operativamente presente: esattamente
come nel caso del fuoco era la ripetizione di una serie di «différens
hazards» a consentire l’apprendimento del suo uso, sarebbe qui
l’«applicazione reiterata di esseri diversi a sé stesso, e degli uni
agli altri» a «generare naturalmente» la «percezione» di quei «certi
rapporti», e sarebbe questa stessa “reiterazione”, allora, a porsi a
fondamento dell’insorgere, accanto alla mera potenza, di una
prima attività riflessiva: a determinare cioè una prima presa di
distanza, da parte dell’uomo, rispetto all’irrelata passività delle
sensazioni, da quella continuità del sentire nella quale nulla può
essere né connesso né distinto, consentendo così all’attività della
réflexion una prima organizzazione cognitiva del dato sensibile. Se
il suo passaggio dalla pura virtualità all’atto non fosse reso
possibile che da circostanze esterne alla facoltà stessa, la facoltà
riflessiva coinciderebbe con l’incapacità, senza l’aiuto di
«occasions» esterne, di porsi da sé stessa in atto. Non ci si può non
chiedere, però, quale forza abbia questa mera ripetizione, tale da
poter forzare la riflessione a passare all’atto: come possa, in forza
proprio di una serie di ripetizioni, insorgere quella stessa novità
che è l’interruzione della ripetizione, l’atto che ne spezza la
serialità e la apre, con ciò, a una differenza non più quantitativa (il
diverso numero delle applicazioni), ma già “qualitativa” (quella
che corre tra un essere limitato al mero sentire e uno già, sul
proprio sentire, “riflettente”). Come può, in una parola, la
ripetizione dell’identico trovare in sé medesima, nel proprio
semplice esser sé stessa, ripetizione, la forza di negare sé stessa, e,
sospendendo e superando la propria ripetitività, di essere non più
ripetizione dell’identico ma, esattamente al contrario, successione
di differenze, produzione, generazione, origine di novità? La
nostra ipotesi è che tale ripetizione costituisca bensì l’«occasione»
di un atto riflessivo, ma ciò solo a patto di intendere che è la
riflessione stessa a dare a sé stessa, già da sempre, una tale
occasione. È solo riflettendo, in una parola, che una molteplicità di
casi disparati può esser scorta come ripetizione. Solo ponendo la
loro reciproca distinzione e relazione –una relazione che, di per sé
stessa, è loro estranea – si può scorgere in un’applicazione “B” la
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 74
ripetizione di un’altra applicazione “A”, di cui si ha memoria: solo
prestando attenzione alle affinità e alle differenze di eventi di per
sé stessi perfettamente irrelati, attraverso cioè il loro reciproco
paragone, li si può riconoscere nella propria memoria come al
tempo stesso distinti e congiunti, come momenti diversi di
un’unica serie. È unicamente una precedente attività della
riflessione, come si vede, a trasfigurare in una serie, una
ripetizione, quella molteplicità di eventi che, di per sé, è solo un
insieme di elementi eterogenei e disparati, ed è perciò la riflessione
stessa, col combinare e disporre quegli elementi in una serie, a
porre la loro ripetizione come la «circonstance» – o meglio il
pretesto – del proprio esercizio, a dare attivamente a sé stessa
l’«occasion» della propria stessa attività. 1 Se, come senza
eccezioni accade agli interpreti, si pretende di leggere il nostro
passo come quello in cui verrebbe esibita la genesi dell’attività
riflettente, pare che si sia allora costretti a parlare, in senso stretto,
di un’autoproduzione di questa attività, alla quale risulta per ciò
stesso impossibile assegnare un’origine, perché non c’è nessun
passaggio, nel tempo, dalla potenza all’atto, non si dà cioè alcuna
nuova realizzazione della potenza che non sia, al tempo stesso, il
risultato di una sua attività precedente. Se non si vuole parlare
dell’attività delle facoltà come un dato, l’unica alternativa sarebbe
pensarla come causa sui. Anche in questo senso, ad ogni modo,
originaria è non l’assenza dell’attività, una mera rapsodia di
sensazioni, ma il fatto dell’esperienza, come sintesi riflessiva del
molteplice sensibile.
3.3. L’uomo è per natura imbecille?
1
In modo ancora più radicale, si può supporre che «l’applicazione degli esseri diversi
a sé stesso» stia ad indicare non solo l’uso degli strumenti, ma qualunque contatto col
mondo. In questo senso, generalizzando le nostre conclusioni, si può affermare che è solo
la riflessione ad organizzare una serie di dati sensibili nell’oggettività propria del mondo
dell’esperienza, consentendo ad esempio di riferire una serie di sensazioni di per sé stesse
irrelate ad un medesimo oggetto.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 75
Fondata sull’analisi forse troppo minuziosa di un singolo passo,
la conclusione a cui siamo giunti, quella dell’impensabilità di
un’origine temporale dell’attività riflessiva, si è presentata
innegabilmente sotto un aspetto di arbitrarietà. Questo carattere
apparentemente arbitrario può essere mitigato – e la nostra
conclusione dare prova della propria coerenza con la struttura
generale dell’argomentazione russoiana – se si considera
brevemente una nuova questione.
Si è già visto che originarie, necessarie, naturali, presenti cioè
già nel puro stato di natura, sono non solo le facoltà, intese quali
pure potenze, ma anche, in qualche misura, la loro attività e il loro
sviluppo: contingente, artificiale, in senso forte, è dunque non già
un qualunque loro esercizio, ma unicamente i diversi insiemi di
idee e conoscenze in cui la loro attività si fissa (siano essi formati
naturalmente, nella solitudine dello stato di natura, oppure
storicamente, socialmente determinati), e dai quali essa stessa
finisce inevitabilmente per essere in qualche misura preorientata.
Certo, anche l’uso che l’uomo naturale può fare delle proprie
facoltà è già circolarmente predeterminato dal patrimonio di
conoscenze, contingenti, che quelle stesse facoltà gli hanno
consentito di acquisire, ed egli non può ritenere prudente o
imprudente, ad esempio, affrontare una bestia o fuggire se non
riflettendo sulle proprie precedenti esperienze, che ne vincolano
quindi l’opinione e la decisione. Non si tratta cioè di negare che le
conoscenze sviluppate dai singoli uomini nello stato di natura
siano tutte acquisite, e quindi anche diverse a seconda delle diverse
loro vicende individuali, e per ciò stesso contingenti, ma solo di
affermare la necessità, la naturalità, o spontaneità, in generale, di
un qualche loro sviluppo, e l’impossibilità, quindi, di reperire nella
storia del genere umano un momento in cui i singoli ne fossero del
tutto sprovvisti. Sul piano individuale si può senz’altro tener ferma
la possibilità, ed anzi la necessità, di pensare un momento, un
istante, in cui le facoltà non si presentano ancora se non nella
forma di una pura virtualità; ciò, paradossalmente, solo finché non
si pretende che la mente dell’uomo naturale si sia mai ridotta ad
una simile tabula rasa.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 76
Al fine di comprendere il senso concreto dell’originaria
virtualità di quelle facultés, e il modo in cui essa debba esser stata
già da sempre superata, occorre rivolgere brevemente l’attenzione
alla possibilità di un’espropriazione di ciò che era stato acquisito.
Per capire quale sia, in seguito alla privazione di tutte le sue
acquisizioni, e dunque anche prima di ogni acquisizione, l’identità
dell’uomo, è al problema dell’«imbecilité» che occorre rivolgere
l’attenzione.
Pourquoi l’homme seul est il sujet à devenir imbécile? N’est ce point qu’il
retourne ainsi dans son état primitif, et que, tandis que la Bête, qui n’a rien
acquis et qui n’a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct,
l’homme reperdant par sa vieillesse ou pour des autres accidens, tout ce que sa
perfectibilité lui avoit fait acquerir, retombe ainsi plus bas que la Bête même?1
Alla possibilità dell’uomo di essere elevato dalle proprie
facoltà, e dall’apprendimento che rendono possibile, fino
all’altezza delle bestie, o al di sopra di essa, corrisponde la
possibilità della ri-caduta più in basso della bestia stessa. La bestia,
infatti, ha ricevuto dalla natura un istinto, che per il suo carattere
innato essa non ha avuto bisogno di acquisire, e di cui non può
quindi nemmeno essere privata; non avendo ricevuto nulla se non
«in potenza», l’uomo può perdere tutto ciò che possiede, perché
non è suo per natura, e di tutto ciò di cui ci si appropria si può
anche essere spossessati. È cioè la stessa contingenza di ogni
acquisizione a rendere possibile, in forza di un qualche
«accidente», l’esproprio possibilmente totale delle acquisizioni che
egli già aveva accumulato. Finché per natura di un essere si
continua ad intendere quell’insieme di qualità innate che gli
spettano in modo originario e necessario, come all’animale il
proprio istinto, e quindi al di qua di qualunque contingenza e
differenza, l’unica vera natura umana non può essere se non
l’imbecilité. Il ri-cadere «plus bas que la Bête même» non è infatti
nient’altro, nell’uomo, che il ripiegarsi sul luogo della propria
origine, o provenienza. Quando una qualche contingenza, un
qualche accidente sopravviene a togliere ogni accidente, ogni
1
Disc., p. 142.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 77
contingenza, un caso felice a lavar via tutte le successive
sedimentazioni che il tempo e le circostanze avevano accumulato
sulla sua primitiva costituzione, e permette che venga alla luce,
nell’individuo, l’originaria inattualità delle «facoltà ricevute in
potenza», l’unico volto che l’uomo riesce a mostrare non è, come
nel caso della statua di Glauco, quello di un dio, né quello di un
animale come gli altri, ma solo, tra il comico e il grottesco, quello
di un perfetto imbecille, di un povero deficiente. Poiché è in essa
che Rousseau stesso identifica l’«état primitif»1 dell’uomo, quella
sua «constitution originelle»2 che, al di qua delle acquisite
differenze che li distinguono, è la stessa in tutti gli uomini, e si
impone perciò quale identità dell’«uomo in generale», il
chiarimento dell’imbecilité mostra qui tutta la sua necessità. In
questo tentativo di chiarificazione non è superfluo richiamare alla
mente un passo dell’Émile nel quale Rousseau ritorna
esplicitamente sul tema imbecillità, esplicitandone
retrospettivamente il senso.
Nous naissons capables d’apprendre, mais ne sachant rien, ne connoissant rien.
[…] Supposons qu’un enfant eut à sa naissance la stature et la force d’un
homme fait […]; cet homme-enfant seroit un parfait imbecile, un automate, une
statue immobile et presque insensibile. Il ne verroit rien, il n’entendroit rien, il
ne connoitroit personne, il ne sauroit pas tourner les yeux vers ce qu’il auroit
besoin de voir. Non seulement il n’appercevroit aucun objet hors de lui, il n’en
rapporteroit même aucun dans l’organe du sens qui lui le feroit appercevoir; les
couleurs ne seroint pas dans ses yeux, le sons ne seroient pas dans ses oreilles,
les corps qu’il toucheroit ne seroient point sur le sien, il ne sauroit pas même
qu’il en a un […]. Il sentiroit le mal-aise des besoins sans les connoitre et sans
imaginer aucun moyen d’y pourvoir. […]. Pour peu qu’on ait réfléchi sur l’ordre
et le progrès de nos connoissances, on ne peut nier que tel ne fut à peu près
l’état primitif d’ignorance et de stupidité naturel à l’homme, avant qu’il eut rien
appris de l’expérience ou de ses semblables.3 […] Abandonné à lui-même, il
mourroit de misére avant d’avoir connu ses besoins.4
1
Ibidem.
2
Ivi, p. 122.
3
Émile, pp. 279-80.
4
Ivi, p. 246.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 78
La situazione con la quale l’imbecilité mostra di dover
coincidere è allora quella – secondo l’identica espressione del
Discours e dell’Émile – di un «état primitif», stato «d’ignorance et
de stupidité», all’interno del quale l’uomo non è ancora neppure in
grado di distinguere sé stesso dal mondo, o una cosa dall’altra. A
profilarsi, in altre parole, è proprio l’identità tra l’«imbecilité» e la
limitazione all’ambito delle «pures sensations», in una condizione
di pura virtualità di tutte le «facultés artificielles» che tengono
l’uomo distinto dagli animali, e alle quali «connoissance» ed
«expérience» sono indissolubilmente legate. Isolata dall’intervento
dell’entendement, dal giudizio, la sensibilità è addirittura incapace
di distinguere una sensazione dall’altra, e perciò – affacciata
com’è solo su una muta sonorità senza suoni, su un inarticolato
vuoto di forme e di colori – di consentire qualunque accesso al
mondo dell’oggettività: del tutto priva, dunque, di qualunque
valore cognitivo. Come nota Reale, l’imbecilité non è «nient’altro
che la vanificazione, priva di contenuti, dei caratteri che
definiscono l’uomo», 1 di tutte le sue acquisizioni. Privato però sia
di un istinto sia dei frutti di quelle «facultés capables d’y suppléer
d’abord, et de l’élever ensuite fort au-dessus», l’unico destino di
un uomo ricaduto «plus bas que la Bête même», come si vede,
sarebbe quello della morte, e non è allora in alcun modo possibile
identificare il pur état de Nature con l’imbecilité, né ridurre
l’uomo naturale, che pure non è privo di ogni cognizione, ad un
perfetto imbecille, che proprio in quanto relegato alla pura
sensibilità non potrebbe sopravvivere senza il sostegno di qualche
suo simile. Una volta riconosciuta questa impossibilità, rimane
ancora da chiarire come sia stato possibile, per l’uomo naturale,
colmare l’abisso che separa le pures sensations anche dalle plus
simples connoissances.
Le soluzioni implicitamente proposte dal Discours e dall’Émile,
in generale, sono piuttosto simili. Già nel riconoscere «impossible
de concevoir comment un homme auroit pû par ses seules forces,
1
M. Reale, Le ragioni della politica, cit., p. 202 Nonostante la correttezza di questa
osservazione, è evidente che l’identificazione, compiuta da Reale, tra imbecilité e pur
état de nature non può in alcun modo esser tenuta ferma.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 79
sans le secours de la communication, et sans l’aiguillon de la
nécessité, franchir un si grand intervale»1 tra sensazione e
conoscenza, il Discours afferma implicitamente che la possibilità
di questo superamento debba essere legata o a all’«aiguillon de la
nécessité» o al «secours de la communication». La soluzione
offerta dall’Émile, analoga a quella dell’opera precedente, è poi
formulata da Rousseau nell’atto stesso di affermare che tale
sarebbe «à peu près l’état primitif d’ignorance et de stupidité naturel à
l’homme, avant qu’il eut rien appris de l’expérience ou de ses
semblables».2 Sembra quasi che ci si trovi di fronte a un bivio: o lo
stimolo di una necessità e di un’esperienza, grazie alle quali «le
sue sole forze» sono acuite al punto che egli riesce da solo a trarsi
fuori dalla propria originaria imbecillità, oppure il soccorso della
comunicazione, attraverso il quale l’uomo può apprendere
qualcosa dai suoi simili. La radicalizzazione della solitudine
operata nella Première partie del Discours, però, sembra bandire a
priori la possibilità di un aiuto esterno da parte della
«comunicazione» e del rapporto con i «suoi simili». A voler tenere
ferma la solitudine in tutta la sua radicalità, quindi, non si scorge
cosa possa essere stato, a spingere l’uomo verso il superamento
della propria originaria imbecillità, se non – secondo il Discours –
la nécessité o – secondo l’Émile – l’expérience. Ma la solitudine
può davvero essere considerata come un’indiscutibile evidenza
testuale? E anche nel caso in cui lo possa, o meglio lo debba,
riescono realmente, necessità ed esperienza, a costituirsi come la
fonte o l’origine di quel superamento?
Riguardo alla comunicazione e al rapporto coi suoi simili, in
realtà, non si può non notare che il Discours non nega affatto la
presenza di un certo lasso di tempo durante il quale, già nel puro
stato di natura, i bambini, incapaci a provvedere a sé stessi,
rimanevano sotto la «tendresse»3 della tutela materna. La figura
della madre, nella misura in cui «allaitoit d’abord ses Enfants pour
1
Disc., p. 144.
2
Émile, p. 280.
3
Disc, p. 154
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 80
son propre besoin; puis l’habitude les lui ayant rendus chers, elle
les nourrissoit ensuite pour le leur»,1 rappresenta una vera e
propria eccezione all’assenza di vincoli relazionali che caratterizza
l’uomo all’interno della Première partie, non foss’altro per questa
capacità dell’affetto materno di rappresentare una forma di
fissazione della pitié «sur un objet particulier» tale da spingere un
essere umano (la madre) non solo ad evitare, se possibile, il male
dell’altro (il figlio), ma a ricercarne positivamente il bene, a costo
di affrontare addirittura tutta una serie di perils2, e da
corrispondere perfettamente, allora, alla descrizione delle
cosiddette «vertus sociales»,3 come altrettante fissazioni della pietà
su un oggetto privilegiato. Rousseau avrebbe allora potuto trarsi
tranquillamente dall’imbarazzo, riguardo al problema dell’origine
dell’attività delle facultés reçues en puissance, proprio
valorizzando questo ruolo della maternità, facendo della madre
colei che, costituendo sé stessa quale mediatrice, toglie l’uomo
dall’assurda necessità di mediare, prima ancora che un “sé” si sia
costituito, sé stesso con sé stesso e con il mondo. Avrebbe potuto
dire, ad esempio, che è la donna a insegnare al figlio che cos’è un
bisogno e, insieme, di cos’è che ha bisogno, a riferire cioè il suo
malessere o benessere, interiore e soggettivo, al qualcosa di
oggettivo che ne è la fonte, ad usare le proprie facoltà e a
distinguere, con ciò, il mondo da sé stesso e sé stesso dal mondo.
Contrariamente a quanto accade nell’Émile, nel Discours il
ruolo della maternità, pur riconosciuto, lungi dall’essere oggetto di
valorizzazione, è oggetto invece di un radicale tentativo di
neutralizzazione, o rimozione. Non tacere su questo punto, infatti,
non sarebbe stato privo di conseguenze: mostrare come solo in
relazione con l’altro, col proprio simile (la madre) e, anzi, solo
come relazione con l’altro – come inter-soggettività – la
soggettività possa assumere un volto, e l’uomo lasciarsi alla spalle
la propria originaria imbecillité, avrebbe significato non solo
1
Ivi., p. 147.
2
Ivi, p. 154, dove a proposito delle madri si parla «des perils qu’elles
bravent, pour les [i figli] en garantir».
3
Cfr. ivi, p. 155, 162.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 81
riconoscere nell’uomo un essere naturalmente dipendente, per il
suo stesso essere (un) sé stesso, dall’altro (dalla donna!), e
collocarlo così, secondo necessità e altrettanto esplicitamente, in
una tradizione nella quale le esperienze si tramandano e si
accumulano, in senso matrilineare, di generazione in generazione,
ma anche lasciarsi sfuggire di mano, con ciò, e anzi negarla con
forza, la possibilità di un «homme en général», di un uomo
originario capace di porsi come esemplificazione vivente di una
natura umana in nessun modo commista alla storia, capace di
affermare sé stesso senza nessun bisogno di “compromettersi” – di
“patteggiare” sé stesso, la propria identità – col proprio simile.
Attraverso la radicalizzazione della solitudine, e la coerente
neutralizzazione della figura materna, viene dunque effettivamente
bandita dall’ordine del discorso la possibilità che a consentire il
superamento dell’imbecillità originaria sia stata una qualche forma
pregressa di socializzazione, e quindi la sollecita attività di un
altro: per potersi porre come produzione di sé medesima, la
soggettività non può sorgere nel segno dell’eteronomia, né la
socialità può essere un presupposto delle facoltà umane, di cui
deve essere il prodotto. Resta da vedere se quel superamento, quel
passaggio dalla potenza all’atto, possa esser determinato da
necessità ed esperienza.
Anche qui, però, ci si imbatte subito in un problema. Finché
resta privo ad un tempo tanto di un istinto suo proprio quanto di
qualunque esperienza, infatti, l’uomo non è neppure in grado di
sopravvivere. La «nécessité» dal cui «aiguillon» l’uomo dovrebbe
essere spinto al di là del mero sentire, e costretto ad accedere così
al mondo della conoscenza, non è altro, per un verso, se non la
necessità, il bisogno dell’esperienza. Con ciò stesso, per altro
verso, essa si rivela tale da non poter essere sopraggiunta, in un
certo momento del tempo, ad una propria precedente assenza,
essendo invece una «necessité», un’esigenza che appartiene
all’uomo non per accidente, ma strutturalmente, essa stessa
secondo necessità. In questo modo si rimane però all’interno della
paradossale situazione che già si era delineata in precedenza, nella
quale era sempre un’attività riflessiva già presente a riprodurre,
modificare, sviluppare sé stessa. Poiché l’expérience non è essa
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 82
stessa se non una particolare forma di conoscenza, l’elemento che
dovrebbe spingere l’uomo al di là dell’abisso che separa «pures
sensations» e «connoissances» si trova a supporre a sua volta che i
confini tracciati da un tale abisso siano stati già trasgrediti, e che
l’uomo già si trovi, dunque, nel territorio della conoscenza.
L’esperienza, infatti, non può in nessun modo essere ridotta a una
semplice accumulazione, o capitalizzazione, di sensazioni tra loro
irrelate, rimane del tutto oscuro da dove essa possa mai esser sorta,
se non da un atto della riflessione, quella relazione tra le
sensazioni la quale, venendo a formare una prima conoscenza, una
prima esperienza, segnerebbe il passaggio al di là dell’«état primitif
d’ignorance et de stupidité».
3.4. Uno stato di natura spurio
Ogni nostro tentativo di afferrare il passaggio all’attività delle
facoltà potenziali si è rivelato votato allo scacco, perché ogni volta
ci siamo ritrovati a constatare che quel passaggio è reso possibile
solo da una precedente, spontanea attualità di quelle stesse
puissances, di quelle facultés. Ad ogni passo mosso in sua
direzione, così, l’origine si è ritratta di pari passo indietro,
sottraendosi allo sguardo, e dimostrandosi, infine, inafferrabile:
non perché, con Burgelin, «l’origine resta un mistero»,1 ma perché
è il loro stesso potere a fornire alle facoltà potenziali la possibilità
ed il contesto del proprio esercizio, il caso della propria
applicazione e sviluppo. Spontanea e necessaria ad un tempo, la
loro attività non può non condurle allo sviluppo di sé stesse, senza
che né l’una né l’altro abbiano origine nel tempo. Nel tempo,
infatti, non si dà mai una condizione di mera virtualità, né dunque
un suo superamento, ma già da sempre operatività e produttività.
Se l’uomo, si può dire, nasce imbecille, bisogna anche avvertire
che, per via di questa necessaria spontaneità, smette di esserlo
appena nato. L’imbecillità, la pura virtualità delle facoltà
potenziali, è un istante senza durata, che appartiene già sempre al
1
P. Burgelin, La philosophie de l’existence, cit., p. 247.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 83
passato. Nel rivolgerci ormai alla conclusione del presente lavoro,
ci sembra opportuno indicare un paio di elementi capaci di fornire
un’idea concreta di come la posizione di esercizio e sviluppo delle
facoltà come interni al «puro» o «vero» stato di natura rendano
estremamente problematico pensarne assieme la purezza e la
verità. Se cioè né il «pur état de Nature» può essere «vero», né, di
converso, il «veritable état de Nature» può stare chiuso nella sua
presunta purezza, allora lo stato di natura si rivela, se non esso
stesso già sempre trascorso, almeno interiormente votato al
dissolvimento, e la natura, con ciò, qualcosa non già di contrario,
ma di intimamente aperto alla storia.
Per chiarire questa affermazione, dobbiamo innanzitutto tornare
all’inizio della Seconde partie, e ricordare come il primo esito
della riflessione fosse nell’uomo il riconoscimento di sé stesso e
dell’altro come membri a pari titolo di una stessa specie: di sé e
dell’altro, cioè, come il simile l’uno dell’altro. Questo
riconoscimento dell’altro come proprio simile, e di entrambi come
membri di uno stessa specie, va da sé, è un riconoscimento
necessariamente riflessivo, legato a una facoltà in grado di
produrre «idées générales», di porre degli esseri particolari in
relazione tra loro e di sussumerli entrambi, facendo astrazione
delle loro differenze, all’unità di uno stesso concetto. È la prima
apertura di un territorio agibile di reciprocità e di uguaglianza. La
conseguenza immediata di questo primo riconoscimento reciproco
è a sua volta, senza soluzione di continuità, l’occasionale
formazione di una «qualque sorte d’association libre qui
n’obligeoit personne, et qui ne duroit qu’autant que le besoin
passeger qui l’avoit formée».1 È proprio questo, oltre a quelli che
1
Disc., p. 166. Sulla base di una pretesa incompatibilità di storia e natura, però, si
ragiona allora così: se è vero che dove c’è società c’è storia, e dove c’è riflessione non
può non formarsi la società, allora è anche vero che, dove fosse presente la riflessione,
dovrebbe non esserlo più la natura, e anzi non esserlo mai stata, se alla riflessione si
attribuisce un carattere originario; poiché però la negazione dell’identità di natura ed
origine che ne risulterebbe cozza evidentemente con tutta l’argomentazione russoiana, la
riflessione non può essere qualcosa di originario. Non dovrebbe essere difficile, giunti a
questo punto, intuire l’equivoco concettuale che sta a fondamento di un simile
ragionamento.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 84
abbiamo già commentato (il suo legame con la libertà, con la
corruzione fisica e morale, con idee astratte che sarebbero rese
possibili solo dal linguaggio…), uno dei motivi più forti che hanno
spinto ad escludere la riflessione dalla costruzione russoiana del
puro stato di natura.
Come Reale, la maggior parte degli interpreti ritiene che «lo
stato di natura è costruito appunto sull’esclusione di una simile
consapevolezza dell’identità di specie, che è conseguente allo
sviluppo e dunque frutto di un confronto e di una riflessione». 1
Non dovrebbe essere difficile, giunti a questo punto, intuire
l’equivoco concettuale che sta a fondamento di un simile
ragionamento. Prima di mostrarne l’incongruenza teorica, è
opportuno però mostrarne la cecità di fronte non solo, in primo
luogo, ad una puntuale circostanza testuale ma anche, in secondo
luogo, alla trattazione meno evidente di un tema centrale. Per
quanto riguarda il primo aspetto, lo stesso passaggio a cui di solito
i critici si appellano per provare l’assenza del riconoscimento dal
puro stato di natura dice tutt’altro da ciò che si pretende di fargli
dire. Nell’atto stesso di porre l’uomo naturale, in relazione a «ses
semblables», come incapace d’«en reconnoître aucun
individuellement», 2 infatti, la Première partie escludeva bensì il
riconoscimento dell’altro come singolo (come potrebbero
riconoscersi «des hommes qui […] se rencontreroient peut-être à
peine deux fois en leur vie»3?), ma non come esponente della
propria stessa specie. Per quanto riguarda poi il secondo aspetto,
questo carattere originario del riconoscimento tra gli uomini in
quanto ugualmente umani è perfettamente coerente col modo in
cui Rousseau tratta il tema dei due «Principes certains et
invariables», 4 amore di sé e pietà, e della loro relazione, trattazione
che offre quindi, in questo senso, una decisiva conferma.
1
M. Reale, Le ragioni della politica, cit., p. 213; cfr. anche A. Burgio, Eguaglianza
interesse unanimità, cit., p. 31.
2
Disc., p. 160.
3
Ivi, p. 146
4
Cfr. ivi, p. 122.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 85
La pitié – questo principio strutturalmente inerente all’umano
sentire – rappresenta infatti quella generica capacità di
immedesimazione emotiva che «nous inspire une répugnance
naturelle à voir perir1 ou souffrir» bensì «tout être sensible», ma
«principalement nos semblables»:2 un sentimento di «ripugnanza»
abitato dunque da una interna duplicità e definito cioè, al tempo
stesso, tanto da quella «compassione» indiscriminatamente,
astrattamente rivolta «a tutto ciò che vive, e quindi soffre», nella
quale Lévi-Strauss ritiene di scorgere niente di meno che
1
È di particolare interesse questo momento di riconoscimento della morte dell’altro,
del proprio simile. Sappiamo infatti che, da una parte, «la connoissance de la mort, et de
ses terreurs, est une des premieres acquisitions que l’homme ait faites, en s’éloignant de
la condition animale» (ivi, p. 143) e dall’altra, però, che l’allontanamento dalla
«condition animale» va considerato come una strada che l’uomo si trova già da sempre a
percorrere. «En s’éloignant», del resto, non indica la separazione come già avvenuta, e
l’animalità come qualcosa che già ci si sia lasciata alle spalle, ma proprio ciò da cui il
distanziamento, non ancora compiuto, è, per così dire, “in atto”. Come negare all’uomo
naturale la conoscenza della morte, l’appropriazione (acquisition) anche della morte
come un che di proprio? In realtà, a ben vedere, è solo sulla supposizione di questa
appropriazione come già avvenuta che Rousseau ha potuto distinguere, come ugualmente
appartenenti alla definizione dell’amore di sé, un interesse direttamente rivolto alla
conservation da quello avente di mira il solo bien-être. La capacità di riconoscere la
morte dell’altro, allora, è obliquamente un chiaro segno della capacità di scorgere sé
stesso come mortale, la necessaria finitezza della propria esistenza, la necessità, dunque,
di custodirla, di ritardare artificialmente il naturale corso delle cose. In quest’ordine di
questioni, assume un particolare interesse il fatto che sia proprio all’inizio della Seconde
partie, e relativamente proprio a quella «prudence machinale» di cui abbiamo già scorto
le tracce nel puro stato di natura, che il Discours introduce per la prima volta l’esigenza
di «sûreté» (ivi, p. 165; già presente in ivi, p. 156, ma come esigenza del Philosophe),
evidentemente legata al movimento anticipatorio della morte: una volta riconosciuta da
una parte l’interiorità di questa esigenza nel puro stato di natura, dall’altra l’associazione
come la principale tecnica attraverso la quale l’uomo può arginare la potenza mortale
della natura esterna, e superare gli ostacoli che essa pone all’uomo per la sua
sopravvivenza, garantirsi con lo sforzo minore il massimo di benessere, sembra che la
socialità non possa più essere integralmente estromessa dalla “condizione originaria”
dell’uomo.
2
Ivi, p. 126; questa duplicità trova conferma nel passo in cui, per includere l’animale
quale soggetto di diritti, anche se non di doveri, si dice che «si je suis obligé de ne faire
aucun mal à mon semblable, c’est moins parce qu’il est un être raisonnable que parce
qu’il est un être sensible» (ivi, p. 126): dove è evidente che, nonostante la priorità che le
viene riconosciuta, la sensibilità, che accomuna uomo ed animale, non riesce ad
escludere la ragionevolezza: ragionevolezza che si pone quindi anch’essa quale fonte di
obblighi, e però solo in virtù del presupposto riconoscimento dell’altro, appunto in
quanto «être raisonnable», come proprio simile.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 86
l’affrancamento dall’antagonismo dell’io e dell’altro (e
«addirittura del più altro di tutti, l’animale»);1 quanto, d’altra
parte, sempre anche da una vera e propria préférence, possibile,
come sappiamo, solo nella forma di una réflexion. Se per un verso
la pietà è senza dubbio la forma di una partecipazione immediata
al mondo della vita, una pulsione capace di precedere e
prescindere dall’intervento di quelle facoltà mediante le quali
l’uomo distingue e conduce consapevolmente sé stesso, con tutto il
sistema di conoscenze a quelle facultés immediatamente connesso;
dall’altra, nel suo interno legame con una preferenza, con una
valorizzazione del proprio simile rispetto ad ogni altro «être
sensible», si ritrova comunque a presupporre quelle conoscenze,
ed in primo luogo quella dell’identità di natura tra gli uomini, dalle
quali pure era sembrata affrancata. Rivolta ad un tempo tanto a
tutti gli esseri sensibili quanto, in modo più intenso, a tutti gli
uomini, all’interno della medesima pietà convivono
originariamente due livelli distinti di genereralità. Il secondo
livello, più ristretto del primo in quanto legato alla sola identità di
specie, innesta nella sensibilità umana una dinamica valoriale.
Costituendosi come naturale valorizzazione del proprio simile
rispetto agli altri viventi, ci pare che la pietà finisca per risultare
difficilmente distinguibile da quella «solidarietà generale» che «la
Natura ha certamente istituito fra tutti gli uomini» nella quale ad
esempio Pufendorf e l’intera tradizione giusnaturalistica vedevano
il radicamento della moralità nella natura (e cioè nell’utilità) stessa
dell’uomo, da quella «socievolezza» nell’imporsi la quale il fine
della «Natura […] era di consentire a ognuno di provvedere al
meglio ai propri interessi». 2 Per un verso, infatti, la preferenza
1
Cfr. C. Lévi-Strauss, Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme,
in J. Guehenno, C. Lévi-Strauss, J. Starobinski et al., Jean-Jacques Rousseau, Neuchâtel
1962, tradotto in italiano come «Postfazione» a J.-J. Rousseau, Emilio, a cura di P.
Massimi, Milano, 2004, di cui vedi p. 707.
2
S. Pufendorf, De jure naturae et jentium, 1672, lib. II, cap. III, § 18 (citiamo,
traducendo a nostra volta, la traduzione francese di Barbeyrac, Droit de la nature et des
gens, Amsterdam 1706). Anche su questo punto sarebbe forse necessario un
aggiornamento dell’operazione di contestualizzazione già magistralmente compiuta da
Derathé (il quale però, proprio su un problema così importante, non riesce a scorgere il
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 87
verso l’altro uomo, chiunque egli sia, nell’atto stesso di affiancarsi
già da sempre, e all’interno dunque della stessa pietà, alla sua pura
indeterminatezza, fa sì che la pietà sia paradossalmente già da
sempre, al tempo stesso, distinta e indistinguibile da quella che
Rousseau, in due differenti occorrenze, chiama «humanité». Nel
testo della Première partie l’«humanité» viene infatti definita,
appunto, come null’altro «sinon la Pitié appliquée […] à l’espéce
humaine en général»,1 ossia verso qualunque uomo in quanto tale,
in quanto membro a pari titolo della propria stessa specie, ed in
questo senso viene annoverata a pieno titolo tra quelle che sono
chiamate «vertus sociales». Nella Nota xv, in modo leggermente
diverso, l’umanità è detta invece derivare dall’amore di sé, questo
«sentiment naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre
conservation et qui, dirigé dans l’homme par la raison et modifié
par la pitié, produit l’humanité».2 Poiché però, come si è visto,
pitié e raison sono entrambe operativamente presenti all’interno
del puro stato di natura, se ne deduce in ogni caso che l’humanité è
bensì un sentimento derivato, e ciò nonostante del tutto naturale ed
originario, tale anzi da riguardare l’«homme en général». Da una
parte, che sia definita come una derivazione della sola pietà o un
prodotto del concorso di entrambi i «Principes certains et
invariables», l’«humanité» è comunque incapace di essere assunta
al rango di un “principio” originario e a sé stante, come invece
accadeva nel pensiero giusnaturalistico riguardo alla «sociabilité».
Dall’altra parte, però, essa non è affatto in nessun caso un prodotto
contingente della pietà o della sua congiunzione con l’amore di sé,
essendo, proprio al contrario, un sentimento o una «virtù» che
dalla prima, o dalla sua unione col secondo, non potrebbe non
nesso che stringe assieme “Rousseau e la scienza politica del suo tempo”): ferma
restando la radicalità della rottura col pensiero giusnaturalistico, infatti, non per questo è
opportuno misconoscerne, quando siano evidentemente presenti, i debiti e le influenze
(su questo punto, da un altro punto di vista, cfr. A. Burgio, Necessità della storia e storia
impossibile, cit., p. 134, dove si parla di come «si riducano le distanza che Rousseau
pretende enormi dai propri avversari»).
1
Disc., p. 155.
2
Ivi, Note xv, p. 219.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 88
derivare. Definita infatti per un verso come «virtù»1 – una virtù al
tempo stesso «sociale» e «naturale» –, e dunque legata all’aspetto
propriamente «moral» dell’esistenza umana; connessa per altro
verso all’amore di sé, e dunque inseparabile da una qualche utilità,
è difficile non riconoscere il debito dell’humanité russoiana
rispetto all’idea tradizionale di «sociabilité», nella quale pulsioni
ed obbligazioni, morale e natura, trovavano una loro qualche
spontanea concordanza. È allora proprio in questa direzione che si
può scorgere la nascosta coerenza tra la generale impostazione
della Préface e quello che sarà il concreto svolgimento del
Discours, e in particolare della sua Seconde partie. Quando in
particolare vi si legge che «toutes les régles du droit naturel»
derivano «du concours et de la combinaison que nôtre esprit est en
état de faire» dei due «Principes antérieurs à la raison», «sans qu’il
soit nécessaire d’y faire entrer celui de la sociabilité»2, Rousseau
non sta affatto escludendo la «sociabilité» dal campo delle «régles
du droit naturel». Esattamente al contrario, se ne nega la capacità
di porsi quale loro fonte originaria, è solo perché la socievolezza
altro non è se non una di quelle stesse régles, la loro forma più
generale ed astratta, la prima e più universale derivazione
propriamente morale che l’esprit (e dunque anche la ragione) sia
stato in grado di operare dei due princìpi certi ed immutabili
dell’amore di sé e della pietà.3
1
Una virtù, si badi, che non può essere intesa nella sola accezione “fisica” del
termine, nel senso cioè in cui virtù sarebbe una qualità che può contribuire alla
conservazione dell’individuo (cfr. ivi, p. 152): in che senso, infatti, nel puro stato di
natura, in cui non può aspettarsi nulla in cambio, l’aiuto che un uomo presta ad un altro
sarebbe utile alla sua propria conservazione?
2
Ivi, p. 126.
3
Il riconoscimento dell’identità del loro «maniére de penser et de sentir», ovvero
della loro natura, spinge immediatamente gli uomini tanto a comprendere «les meilleures
régles de conduite que pour son avantage et sa sureté ul lui convînt de garder avec eux
[gli altri uomini]», quanto a riunirsi «en tropeau, ou tout au plus par quelque sorte
d’association libre qui[…] ne duroit qu’autant le besoin passeger qui l’avoit formée» (ivi,
p. 166). Si capisce come precisamente il riconoscimento di quell’identità e di questo
«vantaggio» vengano a rappresentare, senza nessun bisogno di patteggiamenti, tutto ciò
«que les hommes ont dû employer pour l’établissement de la société» (ivi, p. 125).
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 89
Da una parte una qualche forma di «humanité», come si è visto,
è già da sempre presente, e il riconoscimento della somiglianza tra
sé e l’altro, dunque, già da sempre avvenuto. D’altra parte le «
associations libres», per quanto legate ancora solo a un «objet
déterminé»,1 sono una conseguenza immediata di quel
riconoscimento e di quella «humanité», la quale può allora a buon
diritto essere annoverata tra quelle «vertus» che occorre definire
«sociales»: non perché sia la società, come invece ritiene Derathé, 2
a renderla possibile o a farla passare dalla potenza all’atto, ma
perché rappresenta essa stessa una facoltà ricevuta in potenza, 3
implicita cioè nella natura umana, una potenza la quale è essa
stessa produttrice di socialità, capace di autoalimentarsi, di fornire
a sé stessa – come già si è visto per la riflessione – l’occasione del
proprio esercizio e del proprio sviluppo.4 A questo punto, però,
1
J.-J. Rousseau, Œuvres complètes, cit., vol. III, p. 476. Si tratta di un frammento
immediatamente legato alla stesura della pagina del Discours che stiamo considerando. È
forse interessante notare che nell’atto stesso di indicare queste «libere associazioni», che
duravano quanto il particolare bisogno che le aveva occasionate, come di volta in volta
formate per il conseguimento di un qualche «fine determinato», Rousseau fa
implicitamente riferimento a un’associazione il cui fine rimane del tutto “indeterminato”:
nulla di particolare, cioè, o tale da poter essere conseguito una volta per tutte. Quale sia
questo fine – la riproduzione della società stessa? lo sviluppo dell’umanità? l’impossibile
soddisfazione dell’amour-propre? – rimane peraltro, come è giusto, indeterminato.
2
Cfr. R. Derathé, Rousseau e la scienza politica del suo tempo, cit., p. 185, dove però
la socievolezza viene considerata come un sentimento bensì innato, e capace però di
attivarsi solo in società: l’uomo, infatti, «diventerà veramente socievole solo dopo aver
vissuto tra gli uomini».
3
Non è un caso allora che proprio la conclusione della Première partie, nell’atto
stesso di parlare della «perfectibilité, les vertus sociales, et les autres facultés que
l’homme Naturel avoit reçues en puissance», si trovi a includere le «vertus sociales» nel
più ampio insieme delle “facoltà potenziali”, di quelle «puissances» cioè che, come
abbiamo visto, trovano in sé stesse – sebbene, è vero, solo col «concours fortuit de
plusieurs causes étrangeres» – la forza di “passare” all’atto (cfr. Disc, p. 162).
4
Non è privo di interesse, a questo punto, notare che l’affermazione contenuta nella
Lettre à Philopolis, per la quale «la société est naturelle à l’espéce humaine comme la
décrepitude à l’individu» (J.-J. Rousseau, Œuvres complètes, cit., vol. III, p. 232), limita
di fatto il ruolo delle «circonstances extérieures» a quello di rallentare o accelerare un
processo che viene pensato come inevitabile. Il fatto che cioè la società «découle de la
nature du genre humain, non pas immédiatement», ma solo in relazione a quelle
circostanze, non significa che possa non scaturirne, ma da una parte che la socievolezza è
solo “implicita” nella natura umana, derivando – ma in modo necessario – solo dalla
mediazione di amore di sé e pietà (cfr. Disc., p. 219); dall’altra, come si capisce bene
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 90
diventa impossibile tener fermo nella sua integralità il bando della
«sociabilité» dal puro stato di natura, relegare la sua presenza a
quella di una mera virtualità, di un’astratta suscettibilità da parte
dell’uomo di esser posto dagli eventi in relazione col proprio
simile, una semplice capacità, qualora una serie di «causes
étrangeres»1 lo rendesse necessario, di associarsi: ci si trova in una
parola a dover passare anche qui, come già nel caso della
prévoyance e delle altre facultés virtuelles, dalla logica
dell’esclusione a quella di una pur limitata inclusione. Del resto,
ad identificare con l’homme naturel l’uomo che si impegna nelle
prime, occasionali associazioni, non è solo la sin troppo evidente
l’analogia tra questa «sorte d’association libre» e quella spontanea
forma di cooperazione, occasionale e necessaria a un tempo, che è
il rapporto sessuale. 2 A confermare quella identificazione, in
effetti, sta tutta una serie di indizi testuali. Innanzitutto, come già
si è accennato nel paragrafo precedente, questa forma di
associazione era ammessa già dalla Première partie nell’atto
stesso di escludere ogni forma più complessa, e di affermare
leggendo ad esempio il frammento L’influence des climats sur la civilisation, che la
società può prodursi storicamente, nelle sue forme particolari, solo in relazione alle
«circonstances» dell’ambiente esterno (Œuvres complètes, cit., vol. III, p. 529).
1
Lettre à Philopolis., cit., p. 232.
2
Anche della relazione sessuale, come delle associations libres, si deve infatti
parlare – almeno fino alla formazione della famiglia – come di una forma di
cooperazione occasionale, «qui n’obligeoit personne, et qui ne duroit qu’autant le besoin
passeger qui l’avoit formée» (Disc, p. 166; cfr. ivi, pp. 157-9). L’una e l’altra non sono
affatto necessarie alla mera sopravvivenza del singolo, ma al solo benessere, ed è per
questo, inoltre, che sono entrambe ugualmente «libere», e cioè esenti tanto da coercizione
quanto da obbligazione, caratterizzate non da un qualche rapporto pattizio (come invece
pretenderebbe V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 438) di
condizionamento reciproco, ma da un’incondizionata spontaneità: più simili a una
reciproca donazione di sé, naturalmente in armonia con i desideri e i bisogni di entrambi,
che ad uno scambio di prestazioni. Non si può escludere che proprio in questa forma di
incontro, nella sua gratuità (ma si tratta di un’idea che richiederebbe ben altro sviluppo),
risieda il valore esemplare conferito da Rousseau all’immagine del puro stato di natura.
Può essere utile notare, qui, un passaggio che sembra suggerire un carattere “originario”
di relazioni di coppia in qualche modo stabili, delle quali lascerebbe dunque intendere
l’interiorità al non più “puro” stato di natura, costituendo così un indizio (coerentemente
con l’accenno fornito in Disc., p. 132) del carattere meramente fittizio del pur état de
Nature. (Cfr il “lapsus” russoiano in ivi, p. 166, dove si parla delle «conformités que le
tems put lui faire appercevoir entr’eux, sa femelle, et lui»).
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 91
dunque che «il est impossibile d’imaginer pourquoi dans cet état
primitif un homme auroit plûtôt besoin d’un autre homme qu’un
singe ou un Loup de son semblable».1 In secondo luogo, nel
passare alla descrizione della successiva tappa della
socializzazione, la famiglia, Rousseau dichiara di dover percorrere
«comme un trait des multitudes de Siécles», costretto «par le tems
qui s’écoule, […] et par le progrès presque insensibile des
commencemens».2 Non solo, qui, i secoli che sono sorvolati sono
esattamente gli stessi siècles di cui nella Première partie si diceva
che «s’écouloient dans toute la grossiéreté des premiers âges»,3 ma
già nel parlare del progresso «des commencements» ci si trova ad
inserire le libere associazioni, a differenza delle famiglie,
all’interno dello stato primitivo. In terzo luogo, il sorgere di
cooperazione e competizione sono dette andare di pari passo, ma
già la Première partie faceva riferimento a forme di competizione
(per il cibo). In quarto luogo, infine, il grado di sviluppo di
previdenza e di linguaggio che si ritrovano nell’uomo impegnato
nelle prime forme di cooperazione sono esattamente gli stessi che,
quasi con le stesse parole, venivano attribuiti all’uomo naturale. 4
Lo stesso motivo che faceva sì che il rapporto tra madre e figlio
dovesse essere neutralizzato, rimosso, perché avrebbe costituito
una forma di socializzazione presupposta all’attività dell’uomo,
consente ora di includere già nel «puro stato di natura», in quanto
prodotte dalla sua stessa autonomia, queste prime forme di
«association libre».
È facile a questo punto capire anche l’equivoco teorico che
stava a fondamento del ragionamento col quale si pretendeva di
1
Disc., p. 151. Dove è da notare che se è vero, da una parte, che in ivi, p. 166
l’«association libre» viene definita appunto come quella in cui gli uomini si uniscono in
«troupeau», altrettanto vero, d’altra parte, è che anche delle scimmie, in ivi, p. 167, si
dice que «s’attroupent». Se l’uomo naturale e una scimmia hanno il medesimo bisogno
del proprio simile, e se però le scimmie si uniscono in troupeau, allora la libre
association non può essere se non una possibilità tutta interna al pur état de Nature.
2
Ivi, p. 167.
3
Ivi, p. 160.
4
Per il linguaggio cfr. ivi, p. 167 e p. 148, e cfr., supra, la nota relativa in § 2.2.; per
la previdenza, poi, p. 167 e p. 144.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 92
escludere il riconoscimento, e quindi la riflessione, dallo stato di
natura. La situazione che viene profilandosi, infatti, è quella in cui
storia e socializzazione, come l’attività delle facoltà potenziali,
sono mancanti di origine, ovvero qualcosa in cui l’uomo, volente o
nolente, si trova già sempre coinvolto; qualcosa che, lungi
dall’opporsi alla natura dell’uomo, si ritrova anzi ad esserne
inseparabile. Una volta riconosciuta l’attiva presenza, all’interno di
esso, non solo delle facultés artificiels e di quelle passions che,
come nota Burgio, svolgono «una funzione determinante nello
sviluppo della socializzazione»,1 ma anche di una qualche generica
forma di vertu sociale, non si può non concordare con Masters,
quando afferma che «l’esistenza di gruppi umani nello stato di
natura è ammessa da Rousseau» e che, anche quando aveva a mala
pena più rapporti» con i suoi simili «che con gli altri animali», «un
comportamento cooperativo sia presente anche nei primissimi
periodi della specie umana».2 Posta questa inclusione, però, non si
può più concordare con lo stesso Burgio, quando parla del
«processo […] di socializzazione» come alcunché di addirittura
«accidentale», perché quella prima embrionale forma di
cooperazione, retroagendo sulle stesse passioni e facoltà di cui è il
prodotto, le avvia sulla strada di uno sviluppo necessario, e che
ormai non può incontrare più alcun limite esterno. Ci si ritrova,
con ciò, di fronte ad un’alternativa. O si ammette che quello di cui
ha parlato Rousseau nella Première partie sia davvero il «pur état
de Nature», e allora bisogna affermare che esso, secondo lo stesso
Rousseau, non può mai essere stato «vero»,3 perché l’uomo non è
1
A. Burgio, Eguaglianza interesse unanimità, cit., p. 41.
2
R.D. Masters, The political philosophy of Rousseau, cit., p. 169.
3
Cfr. Disc., p. 136: «Il n’est pas venu dans l’esprit de la plupart des nôtres [i filosofi]
de douter que l’Etat de Nature eût existé». Questa negazione dell’esistenza dello stato di
natura (ma subito dopo si precisa: del «puro stato di natura») deve essere presa alla
lettera, e non come una forma di autocensura. Punto, questo, che è indubitabilmente
confermato dalla precisa dichiarazione successiva, nella quale si afferma che, scartando i
fatti, si procederà nel Discours tramite «des raisonnemens hypothétiques et
conditionnels; plus propres à éclaircir la Nature des Choses qu’à montrer la véritable
origine» (ivi, p. 153). Il riferimento immediatamente successivo ai Livres Sacrés e agli
Ecrits de Moïse non serve a stemperare l’originalità del proprio discorso, ma semmai ad
evidenziarla: la maggior parte dei filosofi non solo, come si è detto poco sopra (cfr. ivi, p.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 93
mai stato un perfetto imbecille, relegato alla propria mera natura, e
privo di tutto ciò che è acquisito. Oppure si ritiene che esso sia
davvero il «veritable état de Nature», nel qual caso si deve
ammettere non solo, in primo luogo, che non può essere se non
uno stato per così dire “spurio”, in cui cioè gli elementi originari
sono frammisti ad altri acquisiti, ma anche, in secondo luogo, che
non può essere affatto pensato come un semplice «stato», una
condizione il cui inerte equilibrio fosse capace di permanere
chiuso in sé stesso, e non potesse essere infranto se non
dall’esterno. Nonostante il contrario parere di Goldschmidt e di
buona parte degli interpreti, in questo modo la conclusione che si
impone è una sola: lungi dal costituirsi come il luogo
dell’anteriorità o dell’estraneità dell’essere al divenire, della natura
alla storia, il puro stato di natura si impone come il luogo in cui, a
rivelarsi, è la loro necessaria omogeneità, o complicità: non già
l’esteriorità reciproca di natura e socializzazione, ma
l’inseparabilità del loro intreccio, o sviluppo. Un semplice «luogo
di passaggio in seno al divenire universale»,1 quindi, nel quale
«l’origine non si distingue qualitativamente dal processo».2
132), non riesce a pensare il «puro stato di natura», ma neppure a metterlo in dubbio,
nonostante i contrari indizi di quella tradizione biblica, e l’ossequi che ogni Philosophe
Chrétien è tenuto a prestarle.
1
V. Goldschmidt, Anthropologie et politique, cit., p. 241.
2
M. Reale, Le ragioni della politica, cit., p. 116.
STUDI SETTECENTESCHI, ed. by Gianni Francioni, vol. 27-28, 2007-08
pagina 94
Potrebbero piacerti anche
- Antonio RosminiDocumento6 pagineAntonio RosminiAndrea FerraressoNessuna valutazione finora
- Primato Ontologico Della Percezione in Merleau-PontyDocumento41 paginePrimato Ontologico Della Percezione in Merleau-PontyDavo Lo SchiavoNessuna valutazione finora
- Ephemerides Carmeliticae. T. 3 (1949)Documento582 pagineEphemerides Carmeliticae. T. 3 (1949)LucianaNessuna valutazione finora
- Gritti Proclo 385 PDFDocumento46 pagineGritti Proclo 385 PDFUmberto AttianeseNessuna valutazione finora
- Tucci Teoria e Pratica Del MandalaDocumento134 pagineTucci Teoria e Pratica Del MandalaGiadaNessuna valutazione finora
- Capisaldi Del Sistema HegelianoDocumento5 pagineCapisaldi Del Sistema HegelianoTomas TurbatoNessuna valutazione finora
- Logica Come Scienza Del Concetto Puro (IV Ed 1920) by Croce PDFDocumento427 pagineLogica Come Scienza Del Concetto Puro (IV Ed 1920) by Croce PDFandreNessuna valutazione finora
- Appunti Critica Ragion PraticaDocumento6 pagineAppunti Critica Ragion PraticaAnonymous XW6aq99INessuna valutazione finora
- Herder + SchillerDocumento1 paginaHerder + SchillerMaia Queirolo PalmasNessuna valutazione finora
- Cartesio, Punti PrincipaliDocumento26 pagineCartesio, Punti PrincipaliAlessandra EllyNessuna valutazione finora
- Dionigi Areopagita - Gerarchia CelesteDocumento24 pagineDionigi Areopagita - Gerarchia CelestePapeSatanAleppeNessuna valutazione finora
- Schopenhauer, Riassunto, 1 Parte: Caratteri Generali e PessimismoDocumento2 pagineSchopenhauer, Riassunto, 1 Parte: Caratteri Generali e PessimismoGianfranco Marini100% (3)
- Albino - Didaskàlikos.Documento65 pagineAlbino - Didaskàlikos.TalibNessuna valutazione finora
- Aristotele. RiassuntoDocumento6 pagineAristotele. RiassuntoalfredopietrelliNessuna valutazione finora
- San Tommaso Visto Nelle Sue Opere PrincipaliDocumento12 pagineSan Tommaso Visto Nelle Sue Opere PrincipaliLuca Refatti100% (1)
- Dante e La FilosofiaDocumento11 pagineDante e La FilosofiaNewGFNessuna valutazione finora
- CacciniDocumento12 pagineCacciniAnnieSoprano100% (1)
- ARISTOTELEDocumento8 pagineARISTOTELEalice mareggiateNessuna valutazione finora
- Tucci Teoria e Pratica Del Mandala PDFDocumento145 pagineTucci Teoria e Pratica Del Mandala PDFAnonymous HyP72JvNessuna valutazione finora
- Riassunto Illuminismo Per KantDocumento1 paginaRiassunto Illuminismo Per KantDeniseSironiNessuna valutazione finora
- Fitch FilosofiaDocumento4 pagineFitch FilosofiaGiuseppe TomarchioNessuna valutazione finora
- San Tommaso, Maestro Di Educazione Umana II IzquierdoDocumento35 pagineSan Tommaso, Maestro Di Educazione Umana II IzquierdoFederico VirgilioNessuna valutazione finora
- Edward Feser - Scritti FilosoficiDocumento129 pagineEdward Feser - Scritti FilosoficiIlGhila100% (1)
- Giuseppe Barzaghi - La Somma Teologica Di San Tommaso D'aquino in Un Soffio (0, Edizioni Studio Domenicano) PDFDocumento36 pagineGiuseppe Barzaghi - La Somma Teologica Di San Tommaso D'aquino in Un Soffio (0, Edizioni Studio Domenicano) PDFCarlos AlbertoNessuna valutazione finora
- San Tommaso D'aquino - La Summa TheologicaDocumento45 pagineSan Tommaso D'aquino - La Summa Theologicagiordana214100% (1)
- Riassunto HegelDocumento5 pagineRiassunto HegelDe Sire DarioNessuna valutazione finora
- GRAFOLOGIADocumento4 pagineGRAFOLOGIAJoePansaNessuna valutazione finora
- KantDocumento4 pagineKantCarloCarminati50% (2)
- Essenza Ed Energie Di Dio Secondo San Gregorio Di NissaDocumento6 pagineEssenza Ed Energie Di Dio Secondo San Gregorio Di Nissablueyes247Nessuna valutazione finora
- Millenaria Sapienza DellOccidente-La Gnosi CristianaDocumento8 pagineMillenaria Sapienza DellOccidente-La Gnosi CristianaAlfio Renato VinciguerraNessuna valutazione finora