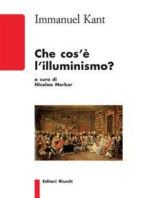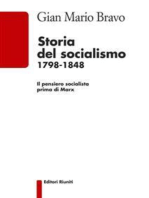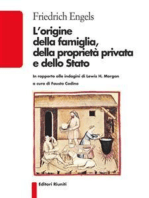Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
L'alienazione
Caricato da
Il Consiglier FuggiascoCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
L'alienazione
Caricato da
Il Consiglier FuggiascoCopyright:
Formati disponibili
Alienazione 2.
dalla Rivoluzione Industriale
all’Era Informatica
5ALS
Indice
Premessa……………………………………………………………………………………………………….3
Etimologia del termine……………………………………………………………………………………3
Il concetto filosofico di alienazione: Hegel, Feuerbach e Marx…………………………...4
The mechanization of human nature in Dickens’ fiction……………………………………5
2 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
Frederick Taylor e l’Organizzazione Scientifica del Lavoro……………………………….6
Henry Ford e la catena di montaggio……………………………………………………………….6
L’alienato moderno nella pittura contemporanea di Apa…………………………………..7
Il linguaggio dell’alienato nella narrativa del ‘900…………………………………..………..7
L’informatizzazione del lavoro: l’alienazione “da ufficio” in Karlsson………………10
Bibliografia…………………………………………………………………………………………………..12
Sitografia……………………………………………………………………………………………………...12
Premessa
Con il presente percorso si intende definire le tappe significative dei mutamenti che hanno
interessato il concetto di alienazione, a partire dall’etimologia del termine e dalle influenze
dei relativi periodi storico-culturali.
Verranno inoltre rintracciate le manifestazioni e le rappresentazioni dell’alienazione in
letteratura italiana, in quella oltremanica e nell’arte figurativa, con particolare riferimento alle
sue forme di espressione nella narrativa del Novecento.
Infine lo scopo prefissato sarà quello di comprendere come l’informatizzazione del lavoro
impiegatizio abbia peculiarità affini all’alienazione degli operai in fabbrica, tanto da andare a
costituire una nuova forma di “alienazione da ufficio”.
Etimologia del termine
Simone Puppo – 5ALS
3 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
Il termine alienazione (in latino alienatio, -onis) ha origine dal verbo latino alienare e
dall’aggettivo alienus, che letteralmente significa appartenente ad altri, che non è dei nostri.
Mentre nel linguaggio giuridico corrente per alienazione si intende vendita, trasferimento o
privazione di un immobile, in ambito filosofico il lemma ha progressivamente acquisito
spessore concettuale tale da diventare una delle nozioni pregnanti della riflessione filosofica
post-hegeliana.
In particolare ciò avviene nella contemporaneità , che sempre più sembra caratterizzarsi
come società del disagio, lacerata drammaticamente dalla contraddizione tra l’enorme
produzione seriale di ricchezza materiale e il sentimento di una profonda povertà , di un senso
d’impotenza, di estraneità ad una realtà potente, indifferente e ricca, che l’alienato è
inadeguato a controllare e inetto a fronteggiare.
Appunto “alienato”, perché alienata è questa realtà da lui prodotta, estranea e ostile, che si
allontana portando con sé la nostra stessa essenza, impoverendoci, privandoci di noi stessi.
Il concetto filosofico di alienazione: Hegel, Feuerbach e Marx
Nei Manoscritti economico-filosofici, redatti da Marx durante il suo soggiorno parigino nel
1844, il filosofo studia e discute le teorie dei più noti economisti (Smith, Malthus, Ricardo
ecc.), ma soprattutto analizza la struttura dell’economia capitalistica.
Ecco allora che il concetto di “alienazione”, precedentemente mutuato da Hegel e
Feuerbach, assume una valenza nuova: se nel sistema hegeliano essa consisteva
dell’estraniarsi dell’Idea nella natura e se in quello feuerbachiano essa descriveva il modo in
cui l’uomo proiettava la sua essenza in Dio, in Marx, nel giovane Marx, l’alienazione è un
concetto che dal “cielo” della religione e della speculazione scende sulla “Terra”.
Secondo il filosofo di Treviri, infatti, alienazione primaria non è quella spirituale, bensì
quella socio-economica generata dalla proprietà privata che sta alla base del sistema
capitalistico, come da lui stesso affermato nel seguente passo:
Simone Puppo – 5ALS
4 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
“Noi partiamo da un fatto dell'economia politica, da un fatto attuale. L'operaio diventa tanto
più povero quanto più produce ricchezza, quanto più la sua produzione cresce in potenza ed
estensione. L'operaio diventa una merce tanto più a buon mercato quanto più crea delle merci.
Con la messa in valore del mondo delle cose cresce in rapporto diretto la svalutazione del
mondo degli uomini. Il lavoro non produce soltanto merci; esso produce se stesso e il lavoratore
come una merce, precisamente nella proporzione in cui esso produce merci in genere. […]
Questa realizzazione del lavoro appare, nella condizione descritta dall'economia politica, come
annullamento dell'operaio, e l'oggettivazione appare come perdita e schiavitù dell'oggetto, e
l'appropriazione come alienazione, come espropriazione. [...] Certamente il lavoro produce
meraviglie per i ricchi, ma produce lo spogliamento dell'operaio. Produce palazzi, ma caverne
per l'operaio. Produce bellezza, ma deformità per l'operaio. Esso sostituisce il lavoro con le
macchine, ma respinge una parte dei lavoratori ad un lavoro barbarico, e riduce a macchine
l'altra parte. Produce spiritualità, e produce la imbecillità, il cretinismo dell'operaio. [...] Ma
l'alienazione non si mostra solo nel risultato, bensì nell'atto della produzione, dentro la stessa
attività producente.”
Marx esordisce sottolineando immediatamente la concretezza della propria analisi rispetto
all’astrattezza degli economisti borghesi. Che nell’economia capitalistica l’impoverimento
dell’operaio sia direttamente proporzionale all’arricchimento del capitalista costituisce per
Marx un dato innegabile: paradossalmente la valorizzazione dell’oggetto (merce) provoca,
attraverso il lavoro, la svalutazione del soggetto (operaio), che si ritrova tanto più reificato e
mercificato, quanto più esso produce i beni in favore del capitalista.
Il lavoratore risulta alienato proprio in quanto espropriato del frutto del proprio lavoro,
che viene estorto a suo danno dal datore di lavoro. Mentre gli economisti borghesi si guardano
bene dal denunciare la spersonalizzazione operaia, Marx invece mette in luce le
contraddizioni della società industriale mediante un suggestivo confronto tra splendori e
miserie del capitalismo: è si vero che l’economia produce ingenti quantità di beni, ma ciò
avviene solo a favore dell’imprenditore facoltoso e a discapito del misero proletario.
L’operaio non trae più soddisfazione dal proprio lavoro, che anzi gli procura fatica ed
infelicità : esso consiste di un malpagato e penoso mezzo per poter giungere indirettamente al
soddisfacimento di altri bisogni come il sostentamento. Perciò quando ad un individuo viene
sottratto il prodotto del proprio operato (derivato da un lavoro forzato, costrittivo e
unilaterale) egli viene altresì privato della propria essenza, che gli sfugge e gli si
contrappone, proiettata al di fuori di sé.
The mechanization of human nature in Dickens’ fiction
Hard Times is the tenth novel by Charles Dickens, first published in 1854. The book appraises
English society and highlights social and economic pressures of the time.
The extract Coketwon is taken from the fifth chapter of the Victorian novel. It consists of a
careful attention to the background where the chapter and the entire novel are set.
Right from the start the setting refers to Coketown, an industrial town whose name
clearly recalls the presence of factories, mines and “tall chimneys” producing “interminable
serpents of smoke”; in a puritan society serpents symbolize the devil. So the word “coke”
Simone Puppo – 5ALS
5 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
immediately strikes the reader’s attention and conveys the overall effect of a polluted
atmosphere, allowing him to create a black-and-white mental picture of the city.
Indeed, the following sequence gives space to a large range of dark colours, which
contribute to emphasize the space’s negative connotation. Its ashes covered everything they
bumped into. The image provided by the narrator also seems to demolish any time reference:
the expression “for ever and ever” conveys the impression of an eternal city disregarding time
and where ordinary life only consists of work.
All in all the first paragraphs provide a photograph of the consequences of the Industrial
Revolution, as the narrator will show in the following sequence.
The reader’s expectations come true when the verbs "rattling" and "trembling", appealing
to hearing and the onomatopoeia of pistons that go up and down all day long give a clear
image of the monotony of worker's lives. The image is reinforced by the anaphoric use of
the adjective same ("same hours", "same sounds", "same pavements", "same work”). With the
description, Dickens creates an unbearable and suffocating atmosphere that perfectly
conveys the reality of that time.
Again in the following passage the reader comes across a new obsessive anaphoric
repetition of the word “fact”, juxtaposed to two contrasting words: “material” and
“immaterial”. The period is full of figures of speech and contributes to create confusion in the
reader’s mind. He has to slow down his reading pace to better understand the contradictions
of an industrialized town where everything seemed the same.
The detailed description of the city on a Sunday morning is nothing more than sad. Again it
suggests the monotony of people's life. Indeed, the narrator uses the repetition of the
possessive adjective "own" (own quarter, own close rooms, own streets) and builds a
sequence of events connected with the temporal adverb "then". Nothing changes, even on
Sundays despite some more drunken people (either religious or not): the portrait of common
people lifestyle.
The overall effect of the contrast between drama and satire contributes to convey a
distorted image which swings from coarse reality to parodic fiction, witnessing the adoption
of a typical Victorian narrative strategy: the grotesque. The narrative device allows the
narrator to alternate dramatic moments (which let the reader identify with the victims) with
exaggerated and ironic ones, something very frequent in Dickens’ narrative.
Frederick Taylor e l’Organizzazione Scientifica del lavoro
In uno dei suoi film più celebri Charlie Chaplin (1889-1977) impersona un operaio che,
costretto a un lavoro ripetitivo e dai ritmi ossessivi, impazzisce e perde il controllo dei propri
movimenti. Il film, intitolato Tempi moderni (1936), dietro l’apparente comicità è in realtà una
dura e chiara denuncia dell’alienazione e della spersonalizzazione del lavoro conformato alle
regole della cosiddetta Organizzazione Scientifica del Lavoro (OSL).
Con questa espressione si è soliti indicare un metodo di razionalizzazione e
riorganizzazione del processo produttivo basato sull’analisi scientifica dei tempi e delle
modalità lavorative, sperimentato all’inizio del Novecento dall’ingegnere statunitense
Frederick W. Taylor (1856-1915).
Simone Puppo – 5ALS
6 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
Questi, osservando in modo sistematico i movimenti degli operai e cronometrandone i
tempi, elaborò un metodo, concepito nella sua monografia The Principles of Scientific
Management (1911), per ridurre all’essenziale i gesti da compiere ed evitare i tempi morti,
che, facendo perdere ritmo al lavoro, ne riducevano la produttività .
L’operaio veniva così considerato come una parte del processo produttivo, una macchina
da programmare e da controllare, un mero esecutore di gesti sui quali non doveva esercitare
alcuna padronanza.
Era infatti l’imprenditore, dietro i suggerimenti dei tecnici responsabili della produzione, a
stabilire i tempi e le modalità del lavoro dell’operaio, senza che questi potesse in alcun modo
intervenire. La netta separazione tra lavoro manuale e attività di ideazione e di direzione
venne così fissata rigidamente e l’operaio fu espropriato delle proprie capacità di iniziativa e
ridotto a un semplice ingranaggio strettamente funzionale a una struttura, la fabbrica,
complessa e articolata.
Henry Ford e la catena di montaggio
Questo processo di alienazione, questa standardizzazione che rendeva spersonalizzato e
intercambiabile il lavoro dell’operaio in fabbrica, si radicalizzò con l’applicazione, a partire dal
1913, del sistema della catena di montaggio (assembly line) ai processi produttivi.
Osservando i carrelli scorrevoli su binari utilizzati nel macello di Chicago per sezionare i
quarti di bue, Henry Ford (1863-1947), il magnate americano dell’auto, ebbe l’idea di far
scorrere i pezzi da montare su un binario, assegnando a ciascun operaio l’esecuzione di una
sola operazione, sempre la stessa.
Così facendo si accelerava il ciclo lavorativo e si evitavano i gesti inutili, portando il lavoro
all’operaio e non l’operaio al lavoro. Quest’ultimo era costretto a sottostare al ritmo imposto
dalla macchina e doveva eseguire il lavoro nei tempi prestabiliti per non interrompere la
catena.
Si trattava di un’occupazione estenuante e alienante, la cui retribuzione, per quanto più alta
rispetto ai salari delle industrie meccaniche, non bastava a ricompensare né la fatica né la
perdita di ruolo e di competenze.
Ormai si era imboccata una strada estranea alle specifiche abilità artigianali che ancora si
potevano riconoscere negli operai della prima rivoluzione industriale. In effetti l’introduzione
della catena di montaggio è l’evento che segna il definitivo passaggio al sistema industriale
moderno.
L’alienato moderno nella pittura contemporanea di Apa
Antonio Apa nasce a Salerno nel 1956. Sin dall’infanzia la sua predisposizione all’arte era
conosciuta a tutti, tanto che, mentre tutti gli altri scolari frequentavano regolarmente le
lezioni, il giovane Antonio si immergeva nella dimensione artistica: disegnava, colorava, ed
una volta completati i disegni il maestro li prendeva e li conservava. Nella sua esperienza ha
visitato molte mostre, ha attinto il classico dalle tele e dagli affreschi rinascimentali del suo
paese, pur rimanendo sempre attento alle problematiche del tempo.
Simone Puppo – 5ALS
7 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
Da qui una serie di dipinti, che culminano con l’opera L’alienato - Seattle, concepita alla fine
del 1999 durante la terza conferenza dell’Organizzazione mondiale per il commercio
(WTO) tenutasi proprio nell’Emerald City.
In esso è percepibile una figura seduta su una poltrona, rannicchiata su sé stessa con le
braccia avvolte attorno alle sue ginocchia. Davanti ad essa è situata una scrivania su cui sono
adagiati un monitor, una tastiera e degli amplificatori, come in un qualsivoglia ufficio
moderno. Inoltre numerosi libri aperti sono scaraventati pietosamente a terra: la cultura e
l’informazione sono stati ormai sostituiti dall’enciclopedia online, dalle risorse web e dagli e-
book.
Da una finestra invece si intravedono delle industrie con ciminiere in rappresentazione
della rivoluzione industriale quale causa, negli anni, dell'inquinamento del pianeta. Appesi alla
parete figurano l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, nonché la sequenza di DNA, nonché
un famoso manifesto propagandistico di Che Guevara; essi rappresentano il genio umano e le
relative scoperte evolutive che, gestite dalle mani dei "Padroni della Terra", finiscono col
produrre ostilità sia all'uomo che all'ecosistema, portando la società ad uno stato di
estraniazione: le nuove tecnologie e la vita frenetica alienano l'uomo.
Il linguaggio dell’alienato nella narrativa italiana del ‘900
Un’ombra sinistra ed affilata si allunga sulla scena letteraria europea a partire dalla metà del
XIX secolo, divenendo poi centrale nel Novecento. L’ombra di un personaggio in perenne
conflitto con la sua epoca e con sè stesso: l’inetto, figura chiave nella produzione narrativa di
autori come Franz Kafka (1883-1924), Luigi Pirandello (1867-1936) ed Italo Svevo (1861-
1928).
In effetti è proprio lo scrittore boemo il primo ad avventurarsi prepotentemente
nell’affrontare il tema dell’inettitudine. Ad esempio nel romanzo Le metamorfosi (1915) il
protagonista Gregor Samsa si ritrova casualmente ed improvvisamente intrappolato nel corpo
di un mostruoso insetto; tuttavia il cambiamento del personaggio interessa solo la forma,
consistendo di una metamorfosi esclusivamente sul piano fisico e non su quello spirituale.
L’inettitudine della sua figura traspare sulla mancanza di consapevolezza della propria
condizione, che si trasfigura per mezzo dell’utilizzo di un soliloquio, che ne connota
l’isolamento all’interno della propria stanza, immagine della prigionia e dell’oppressione
familiare, come visibile dal seguente estratto:
“Ci provò un centinaio di volte, chiuse gli occhi per non vedere le zampe annaspanti, e rinunciò solo
quando cominciò a sentire sul fianco un dolorino sordo, mai provato prima d'allora. "Oh Dio", pensò,
"che mestiere faticoso mi sono scelto!: sempre in giro, un giorno dopo l'altro. L'affanno per gli affari è
molto maggiore che nell'azienda, inoltre devo sopportare anche questa piaga del viaggiatore, i crucci
per le coincidenze, i pasti irregolari e cattivi, rapporti umani sempre mutevoli, mai costanti, mai
cordiali. Che vada tutto al diavolo!".
Ulteriore motivo di solitudine è la permanenza di un narratore esterno spettatore dal punto di
vista di Gregor, che permette l’esplicitazione dei pensieri più remoti del protagonista; inoltre
fabula e intreccio coincidono ancora, contrariamente a quanto accade ne La coscienza di Zeno.
Simone Puppo – 5ALS
8 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
Infatti nel romanzo di Svevo la narrazione è a-logica e richiama la fluidità e la confusione
dell’affiorare dei pensieri all’interno di una coscienza individuale. Una fluidità che, tuttavia,
risulta sporadica sul piano morfosintattico, complici anche le origini triestine dell’autore
nell’ancora esistente impero austro-ungarico. In effetti una tenue disorganizzazione sintattica,
come pure la presenza di cacofonie, rispecchiano sia la frammentazione interiore del
protagonista, che la pesantezza della vita per un inetto come Zeno.
L’alienazione dell’io narrante traspare inoltre dalle scissioni comportamentali di cui Zeno si
rende protagonista: l’alternanza di piani temporali – il cosiddetto tempo misto – contribuisce
a far emergere la frammentazione identitaria dell’individuo, oltre a connotarne la debolezza
caratteriale e la mancanza di autostima.
Il disordine mentale, la mancanza d’azione ed il perenne dubbio vengono trasmessi grazie
al monologo interiore, che rende al meglio l’eccesso di speculazione del protagonista: egli
continua a porsi domande a cui non è capace di rispondere, rimanendo perpetuato
nell’incertezza. Tutte le suddette peculiarità sono condensate nel seguente estratto:
“Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. M’ero
arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la
vita stessa benché ridotta in un matraccio. Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di
attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo. […] Adesso che son qui, ad analizzarmi,
sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa
la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e forte
che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere
quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia
debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione.”
L’io narrante fa anche riferimento ad “un’ultima sigaretta”: l’utilizzo dell’articolo
indeterminativo connota la vanità del proposito dell’alienato Zeno. Egli afferma
inconsapevolmente che dietro la volontà di smettere di fumare si nasconde una latente,
impellente ed invincibile dipendenza dal fumo; una dipendenza da cui vorrebbe liberarsi, ma
su cui è anche comodo rifugiarsi, riversando ogni senso di colpa.
In sintesi è quindi la narrazione autodiegetica, tramite il monologo interiore, la più adatta a
restituire l’immagine alienata del protagonista.
Una tecnica privilegiata anche da Pirandello ne La carriola, dove un io narrante alla prima
persona dà voce a tutti i problemi esistenziali che lo affliggono: dai rapporti con la famiglia
alla consapevolezza di una vita “mancata”.
Analizziamo per esempio il seguente paragrafo tratto dalla novella:
“Chi lo aveva fatto così, quell’uomo che figurava me? chi lo aveva voluto così? chi così lo vestiva e lo
calzava? chi lo faceva muovere e parlare così? chi gli aveva imposto tutti quei doveri uno piú
gravoso e odioso dell’altro? Commendatore, professore, avvocato, quell’uomo che tutti cercavano,
che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevan l’opera, il consiglio, l’assistenza, che tutti
si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro – ero io? io?
propriamente? ma quando mai?”
Simone Puppo – 5ALS
9 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
Resta chiaro fin dall’inizio come il protagonista sia un “ego” problematico, contraddittorio e
scisso, che parla di sé in terza persona. Anche qui sono frequenti le autointerrogative
esistenziali a connotare l’insicurezza e la confusione che regnano nella mente della figura
scissa.
La coordinazione per asindeto crea una climax accumulativa di caratteristiche, che lascia
trasparire al contempo le scissioni di identità e l’ansia esistenziale che angoscia la figura
dell’inetto. Appunto “inetto” in quanto eccessivamente passivo e insufficientemente attivo
nell’affrontare le problematiche della vita.
I dialoghi non sono presenti, testimoniando l’isolamento e la modesta propensione sociale
del personaggio alienato, ma sono spesso sostituiti dall’uso del discorso indiretto libero, che
consiste quasi di un dialogo tra due parti “sdoppiate” dell’omonima solitaria persona.
In narrativa contemporanea è Jonas Karlsson ad offrire l’immagine dell’alienazione moderna
nel suo romanzo La stanza.
L’autore scandinavo è sapiente nel rendere le atmosfere kafkiane della vicenda, puntando
su uno stile minimale, secco nella punteggiatura e scarno nelle descrizioni, utilizzando una
suddivisione in capitoli brevissimi ed una narrazione in prima persona che, con una sarcastica
brutalità , argomenta fatalmente il conflitto io/altri vissuto dal protagonista Bjö rn con i suoi
colleghi.
Le attività di pensiero interne alla mente sono rese tramite una grafetica corsivata, che
denota un dialogo interno ad un personaggio che parla tra sé e sé. L’impiegato, che coincide
con l’io narrante, è anch’esso autore di autointerrogative esistenziali, che hanno più che altro
la funzione di auto convincimento e di ulteriore conferma del proprio punto di vista. Esse
costellano una narrazione perlopiù riflessiva – testimonianza di una tendenza all’autoanalisi -
che lascia meno spazio allo sviluppo narrativo, coerentemente con la mancanza d’azione
tipica della figura dell’inetto.
Il lessico è spesso logico e specialistico, caratterizzato dalla cinicità e dalla rigidità di una
mente poco incline alle relazioni sociali e all’apertura mentale ad eventuali alternative.
Il protagonista sente spesso il bisogno di possedere la situazione sotto controllo: il
narratore lascia molto spazio all’analisi sociologica dei colleghi, all’attenzione per le attitudini
altrui e per i particolari. L’esigenza di “recludere” il lavoro e le sue attività entro categorie
certe (tanto che ad un certo punto Bjö rn afferma di aver suddiviso la giornata in periodi orari
formati da 55 minuti di attività e 5 minuti di pausa) ottiene l’effetto contrario, in quanto egli
entra in crisi non appena si sente impotente nell’impossibilità di pianificare razionalmente la
sua vita.
L’informatizzazione del lavoro: l’alienazione “da ufficio”
Con tutto il rispetto di chi considera l’alienazione da lavoro una prerogativa degli operai in
fabbrica, nel Novecento la produzione seriale, la diffusione degli incarichi impiegatizi e
l’informatizzazione dei compiti da svolgere hanno introdotto tematiche interessanti relative al
microcosmo lavorativo.
L’alienazione da ufficio è in larga parte differente da quella di fabbrica, dove la fatica fisica e
la ripetizione ossessiva delle mansioni incidono come un martello su quella incudine
Simone Puppo – 5ALS
10 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
arroventata che è la psiche ferita dell’operaio. I drammi quotidiani dei “colletti bianchi” sono
invece da cercarsi in due aspetti:
L’aspetto relazionale: un impiegato è “costretto”, più di un operaio, a condividere
giornata e mansioni con diversi colleghi. La relazione è costituita anche da eventi come
la pausa caffè, il pranzo, le chiacchiere e il gossip. Non integrarsi, non far parte “della
massa” è un’opzione che non può essere scelta, pena l’esclusione sociale. D’altronde,
viviamo in un sistema sociale che ci fa frequentare più i nostri colleghi che i nostri cari.
L’aspetto motivazionale: siamo nel secolo del “lavoro stupido”? Lo
asserisce l’antropologo americano David Graeber, secondo cui molte persone
considerano inutile il lavoro che svolgono. Non comprendere l’utilità del proprio
lavoro e tenerlo segreto è un vincolo psicologico insormontabile che porta ad un crollo
interno, perché l’alternativa (la disoccupazione) non è ammessa dal sistema sociale
vigente. Ciò rientrerebbe in un quadro generale per cui il progresso tecnologico non
solo ha semplificato lo svolgimento di molti compiti, ma ne ha addirittura introdotti di
nuovi per aumentare ulteriormente la mole di lavoro dell’impiegato medio. Siamo
ormai lontani dal movimento di protesta luddista (XIX sec.), secondo cui i macchinari
costituivano una minaccia per i lavoratori salariati, in quanto causa di bassi stipendi e
di mancato impiego. Ora le nuove tecnologie non solo creano nuovi mestieri, ma
perfino riducono l’impiegato ad un mero esecutore di gesti programmati.
L’ufficio come luogo di alienazione per eccellenza: ambiente malsano e competitivo,
coacervo di paranoie e paure, motore di dinamiche che possono portare alla follia.
Nel romanzo di Jonas Karlsson, il protagonista, Bjö rn, ci racconta nel dettaglio i suoi primi
giorni in un nuovo posto di lavoro, e la scoperta fortuita, tra i bagni e l’ascensore, di una
“stanza” misteriosa, stranamente inutilizzata e in perfetto ordine.
Bjö rn è incapace di integrarsi a causa di una congenita refrattarietà ai rapporti personali,
unita alla consapevolezza di essere migliore degli altri e al desiderio di fare carriera. Trova
allora utile e rilassante rifugiarsi sempre più spesso nella stanza, al riparo dagli opprimenti
meccanismi d’azienda. Una stanza che, chissà come mai, nessuno dei suoi colleghi ha mai visto
o sentito nominare. Con una scrittura asciutta e incisiva, cambi di prospettiva e colpi di scena
destabilizzanti, Jonas Karlsson ha scritto un romanzo perfetto sulla percezione distorta della
realtà e sull’ansia legata al lavoro moderno.
Sete di carriera, adempienza al dovere e ossessiva razionalità nella divisione del lavoro
sono inversamente proporzionali alla tessitura di rapporti con i colleghi. Le convenzioni
sociali del saluto, della chiacchierata e della pausa caffè non coinvolgono l’ultimo arrivato, che
inizialmente si concentra esclusivamente sulle proprie mansioni, ma poi, quando decide di
dedicare qualche attimo di tempo alle relazioni sociali, viene respinto dalla freddezza e dalla
diffidenza che gli strutturati nutrono verso di lui, complici le sue attitudini ai limiti della
patologia mentale.
L’indole del protagonista è di per sé molto baldanzosa, cinica e consapevolmente
autorevole, ma la necessità di rinchiudersi in una fittizia zona di comfort (la stanza, appunto)
testimonia un’evidente fragilità nell’instaurazione di legami di carattere sociale - se non
Simone Puppo – 5ALS
11 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
addirittura disinteresse a farlo - che lo porta a ritrovarsi a suo agio solo richiudendosi in sé
stesso, lontano dal conformismo e dalle ipocrisie che regnano nel suo ufficio.
La figura di Bjö rn pare scissa in due: la compostezza di impiegato e l’apparente sicurezza
di sé stonano con l’implicito disagio di una personalità attorcigliata su sé stessa e proiettata al
di fuori di sé, che talvolta si ritrova ad ammirare la propria immagine riflessa sullo specchio
antistante la scrivania della stanza.
Egli si “vede vivere” pirandellianamente fino a quando, al capitolo 37, a circa metà della
narrazione, giunge ad un momento di crollo ed al contempo di rinascita: un pianto liberatorio,
che a suo dire è “un segno di debolezza, di mancato contegno e decoro”, sembrerebbe segnare
uno spartiacque tra un’ormai superata follia allucinogena incontrollata ed un’assunzione di
consapevolezza della propria condizione.
In effetti con il progredire nel “ranking” dell’ufficio, dopo la fatalità di aver brillantemente
portato a termine delle delibere a quattro cifre di notevole priorità (sempre rinchiuso
nell’immaginaria stanza), iniziano le prime simpatie con i colleghi ed il capo, che ora lo
guardano da una prospettiva diversa, seppur inconsapevoli della sua latente ed impellente
necessità di ricamarsi di nascosto il proprio spazio all’interno di quelle quattro pareti.
Necessità e bramosia che riaffiorano nel momento in cui Bjö rn sente di aver acquisito un
certo status, una certa posizione e nondimeno una certa confidenza all’interno dell’ambiente
lavorativo. In ufficio in quel momento il caos riemerge dal suo stato di quiescenza, facendo
crollare le aspettative di un impiegato modello che aveva troppo confidato nell’accoglienza e
nella comprensività dei suoi nuovi compagni di reparto.
Il risultato di ciò è un perenne senso di oppressione e inettitudine derivato dal
complottismo di cui il mondo viene accusato, che lo porta a “fondersi” tutt’uno con le pareti
protettive della stanza, lontano da un ambiente di lavoro malsano infestato da colleghi cinici e
indifferenti.
Bibliografia
Narrativa
Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici (1844)
Charles Dickens, Hard Times (1854)
Franz Kafka, Le Metamorfosi (1915)
Luigi Pirandello, Novelle per un anno (1922)
Italo Svevo, La Coscienza di Zeno (1923)
Jonas Karlsson, La stanza (2014)
Simone Puppo – 5ALS
12 Alienazione 2.0 – dalla Rivoluzione Industriale all’Era Informatica
Manualistica
Ruffaldi, Terravecchia, Nicola, Sani, Filosofia: dialogo e cittadinanza, Loescher, 2012
Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Culture & Literature, Zanichelli, 2013
Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, Storia e Identità, Einaudi Scuola, 2012
Panebianco, Pisoni, Reggiani, Malpensa, Testi e scenari, Zanichelli, 2009
Sitografia
www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaM/Marx_12.htm
www.sparknotes.com/lit/hardtimes/themes.html
www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=21&id=855
www.youtube.com/watch?v=YiHbKZcLqy8
www.ioarte.org/artisti/Antonio-Apa/opere/L-Alienato-Seattle/
www.filosofale.altervista.org/alienazione.htm
www.enricogiammarco.com/2014/07/17/la-stanza-karlsson-recensione/
Simone Puppo – 5ALS
Potrebbero piacerti anche
- Cap02 VerificaDocumento2 pagineCap02 VerificaGian Luca PicconiNessuna valutazione finora
- Carme in Morte Di Carlo Imbonati ManzoniDocumento6 pagineCarme in Morte Di Carlo Imbonati ManzoniFlavia PierottiNessuna valutazione finora
- Rcs S.000.BMP - SUM.0015V1T1 PreviewDocumento55 pagineRcs S.000.BMP - SUM.0015V1T1 PreviewjdohernandezNessuna valutazione finora
- Performer Heritage 1 - Soluzioni PDFDocumento251 paginePerformer Heritage 1 - Soluzioni PDFCigognetti NicolaNessuna valutazione finora
- Francesco PetrarcaDocumento16 pagineFrancesco PetrarcaRossella La MuraNessuna valutazione finora
- Il CanzoniereDocumento3 pagineIl CanzoniereasiaNessuna valutazione finora
- 0 Lettura Opere D'arte PulvirentiDocumento33 pagine0 Lettura Opere D'arte PulvirentiSarosh MuhammadNessuna valutazione finora
- Temi Decadenti Pascolo-D'AnnunzioDocumento1 paginaTemi Decadenti Pascolo-D'AnnunzioAntonio MarianoNessuna valutazione finora
- Analisi Testo NarrativoDocumento5 pagineAnalisi Testo NarrativoDebora PanzarellaNessuna valutazione finora
- FavolaDocumento6 pagineFavolayuri bilancioniNessuna valutazione finora
- Dolce Stil NovoDocumento17 pagineDolce Stil NovoGuillermoNessuna valutazione finora
- VERDI Laudi Alla Vergine Maria-Sibelius 4 VociDocumento6 pagineVERDI Laudi Alla Vergine Maria-Sibelius 4 VociIlaria BrunoNessuna valutazione finora
- PETRARCA Sonetto 366Documento1 paginaPETRARCA Sonetto 366irene mutinatiNessuna valutazione finora
- Il Capitale di Marx Brevemente compendiato (Con una lettera di Marx all'autore)Da EverandIl Capitale di Marx Brevemente compendiato (Con una lettera di Marx all'autore)Nessuna valutazione finora
- Storia del socialismo 1798-1848: Il pensiero socialista prima di MarxDa EverandStoria del socialismo 1798-1848: Il pensiero socialista prima di MarxNessuna valutazione finora
- L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello StatoDa EverandL'origine della famiglia, della proprietà privata e dello StatoNessuna valutazione finora
- La società malata. L'umanesimo di Erich Fromm tra Marx e FreudDa EverandLa società malata. L'umanesimo di Erich Fromm tra Marx e FreudNessuna valutazione finora