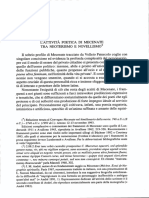Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
19 visualizzazioniHysteron Proteron PDF
Hysteron Proteron PDF
Caricato da
EduardoHenrikAubertCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Potrebbero piacerti anche
- CONTE - Uno Stile Per L'eneideDocumento12 pagineCONTE - Uno Stile Per L'eneideEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- PIAZZI - Un Marchio Di Stile Virgiliano - Il Dicolon AbundansDocumento54 paginePIAZZI - Un Marchio Di Stile Virgiliano - Il Dicolon AbundansEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- BRUGNOLO - Le Terzine Della MaestàDocumento20 pagineBRUGNOLO - Le Terzine Della MaestàEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- SEGRE - Per Una Definizione Del Commento Ai TestiDocumento12 pagineSEGRE - Per Una Definizione Del Commento Ai TestiEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Fenzi - AnticavalcantianaDocumento46 pagineFenzi - AnticavalcantianaEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Fenzi Io SentoDocumento46 pagineFenzi Io SentoEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- PARATORE - CaratteriDocumento48 paginePARATORE - CaratteriEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- MATTIACCI - L'attività Poetica Di Mecenate Tra Neoterismo e Novellismo PDFDocumento20 pagineMATTIACCI - L'attività Poetica Di Mecenate Tra Neoterismo e Novellismo PDFEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Decretum GratianiDocumento1 paginaDecretum GratianiEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- CUGUSI - Note Sullo Stile Dell'oratoria CatonianaDocumento16 pagineCUGUSI - Note Sullo Stile Dell'oratoria CatonianaEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Taruffo La Prova Del Nesso CausaleDocumento9 pagineTaruffo La Prova Del Nesso CausaleEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
Hysteron Proteron PDF
Hysteron Proteron PDF
Caricato da
EduardoHenrikAubert0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
19 visualizzazioni2 pagineTitolo originale
Hysteron proteron.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
19 visualizzazioni2 pagineHysteron Proteron PDF
Hysteron Proteron PDF
Caricato da
EduardoHenrikAubertCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 2
JOHANN BAPTIST HOFMANN - ANTON SZANTYR
STILISTICA LATINA
Acura di ALFONSO TRAINA
Traduzione di CAMILLO NERI
Aggiomamenti i RENATO ONIGA
Revisione e indici di BRUNA PIERL
PATRON EDITORE
BOLOGNA 2002
609
26 1. Collocazione e connessione delle parole
T.Hysteron proteron.
La figura (insterologia’ in Serv. Aen. 9,816) ® di origine
popolare; cid che é pid! importante dal punto di vista psicologico balza
al principio, mentre cid che precede dal punto di vista cronologico,
segue a completamento, li dove l'unitarieta della rappresentazione
consente e al tempo stesso giustifica I'inversione dei membriy ma
entrano in gioco anche ragioni ritmiche: vd. Hofmann 1936": § 112
IRicottilli 1985": 275 s.J: Jacobsohn 1928: 1 ss.; Wackernagel 1938:
161 ss. (che chiama in causa, con riferimento alla teoria “alfa-beta’ di
Winkler, anche il formulare egui viri [ctt. V'avestico aspa-vira e l'o-
merico irra te zai dvBgSv)). I membri sono perlopiti connessi da
particelle copulative, ma possono stare anche in rapporto asindetico
(su cid in particolare Hauler 1888: 578 s.). Nella costituzione della
figura occorre fare attenzione al costrutto copulativo, perché et, atque,
que rappresentano spesso pit che un semplice collegamento (vd.
Nutting 1916: 298 ss. con esempi come Cic. Caril. 4.21, nonché Verg.
den, 2,353 [vd. infra). Nel latino arcaico ne offrono attestazioni
Plauto (per esempio Men. 509 s. neque ego Erotio dedi nee pallam
surrupui), Lucilio, Afranio; off. anche Inscr. col. rostr. (CL 1° 25) 7
ornavet pa(raverque). In epoca classica se ne trovano sporadicamente
‘poco appariscenti esempi in Cicerone (Verr. Il 1,1 statuerat ac delibe-
raverat, 114,40 castra commoverat et vasa collegerat, ad Q. fr. 1.1.21,
ecc., vd, Straub 1893: 128), Cesare (Gall. 5,38,1; vd. Klotz. 1927a: 97
st Bell. Hisp. 3,31; Wolfflin 1889: 104 sul Bellum Africum). Pitt fre-
quente é la figura nella prosa poetizzante della latinita argentea, come
in Quintiliano (per esempio inst. 2,16,16 educare fetus et excludere
[Gabler 1910: 102], e pure le Declamationes [Wahién 1930: 167 s.));
Tacito impiega come particella copulativa quasi esclusivamente -que
(Hauler 1888), Nella poesia esametrica I'attestazione pid antica &
Lucil, 55 M. fandam atque auditam iterabimus ; alquanto
‘moderato & Lucrezio (solo 5 occorrenze, per esempio 3,787 ubi quic-
quid crescat et insit, vd. Heinze 1897: ad locum; Kraetsch 1881: 7),
‘mentre al contrario la figura compare spesso e perlopiti senza partico-
lari ragioni® in Virgilio (per esempio georg. 3,60 s. [vd. Serv. ad
[Sara difficile negare «particolatiragioni» al pid celebre hysteron prote-
‘rom viegiliano, den. 2.353 moriamur etn media arma ruanus, se si considera il verso
successive, uma salus vietis, mullam sperare salem: it fine precede il modo di
i collocacione
j), Aen, 2,353 moriamur et in media arma ruamus (diversamente
1916, vd. supra)), in chiave apertamente omerizzante, non
te (vd. Norden 1916%: 379 s,), ¢ in modo altrettanto ricereato
dio (per esempio met. 8.537 corpus refoventque foventque),
spesso in Orazio (vd. Kiessling-Heinze 1961": ad sat. 2,3,239
figura é arcaizzante anche in Manitio, per esempio 1,18 quaeque
generetque suis animalia signis
Bibliografia: Gerber 1871: 594s: Havers 1931; 92. Bell 1923: 2715
(McDevitt 1967: 319 5: Zaffagno 1985: 872). Alsi motivat esempi in Traina
12119)
Potrebbero piacerti anche
- CONTE - Uno Stile Per L'eneideDocumento12 pagineCONTE - Uno Stile Per L'eneideEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- PIAZZI - Un Marchio Di Stile Virgiliano - Il Dicolon AbundansDocumento54 paginePIAZZI - Un Marchio Di Stile Virgiliano - Il Dicolon AbundansEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- BRUGNOLO - Le Terzine Della MaestàDocumento20 pagineBRUGNOLO - Le Terzine Della MaestàEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- SEGRE - Per Una Definizione Del Commento Ai TestiDocumento12 pagineSEGRE - Per Una Definizione Del Commento Ai TestiEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Fenzi - AnticavalcantianaDocumento46 pagineFenzi - AnticavalcantianaEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Fenzi Io SentoDocumento46 pagineFenzi Io SentoEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- PARATORE - CaratteriDocumento48 paginePARATORE - CaratteriEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- MATTIACCI - L'attività Poetica Di Mecenate Tra Neoterismo e Novellismo PDFDocumento20 pagineMATTIACCI - L'attività Poetica Di Mecenate Tra Neoterismo e Novellismo PDFEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Decretum GratianiDocumento1 paginaDecretum GratianiEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- CUGUSI - Note Sullo Stile Dell'oratoria CatonianaDocumento16 pagineCUGUSI - Note Sullo Stile Dell'oratoria CatonianaEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Taruffo La Prova Del Nesso CausaleDocumento9 pagineTaruffo La Prova Del Nesso CausaleEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora