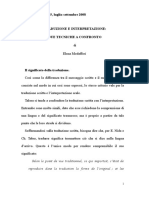Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Dante Canto 16
Caricato da
Matteo BrenciTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Dante Canto 16
Caricato da
Matteo BrenciCopyright:
Formati disponibili
CANTO 16: LA CORRUZIONE DEL MONDO (Scheda) – Argomento politico/morale del canto
Nel canto 16 Dante domanda al Duca delle anime che stanno cantando l’Agnus Dei e apprende che sono le anime degli
iracondi. Una di queste parla (Marco Lombardo) con Dante, si scambiano notizie, nome, informazioni sulla strada, la
preghiera da parte di Marco Lombardo di essere ricordato a Dio. A un certo punto l’anima allude alla corruzione del mondo ed
inizia una delle trattazioni più importanti e più centrali della Commedia (non a caso è posta al 50° canto di tutta la commedia –
in tutto 100 canti: Purgatorio e Paradiso 33 – Inferno 34 perché ha un canto proemiale).
DANTE domanda:
- se il male sulla terra è dovuto agli influssi malefici degli dei, o all’azione umana
MARCO LOMBARDO afferma che:
- il male sulla terra non è dovuto agli dei, perché i cieli muovono nell’uomo gli istinti, ma è poi l’uomo a decidere, grazie
alla ragione e alla libera volontà se lasciarsi trasportare o no dall’istinto (affermata la libertà dell’ uomo – libero arbitrio)
- la causa del male risiede negli uomini stessi
- nei secoli passati si osservavano esempi di virtù innumerevoli, che sono quasi scomparsi (anche Guido del Duca
aveva affermato ciò – Canto 14)
IN SINTESI: la colpa della corruzione è dell’uomo, perché per quanto le stelle dispongano degli impulsi umani, vi sono due
forze nell’uomo che non provengono “dall’alto”, ma provengono bensì dall’intima dignità dello spirito creato “dall’alto” la
capacità di vedere il bene e la libertà di volerlo. (“Lume v’è dato a bene ed a malizia e libero voler” agli uomini è stato dato
il lume della ragione per distinguere il bene dal male, e il libero arbitrio)
Nel Medioevo l’idea di LIBERO ARBITRIO dell’uomo era condizionata dal fatto che si credeva che:
- gli astri potessero influenzare la vita terrena
- la volontà dell’uomo fosse subordinata alla grazia di Dio, che salvava l’uomo predestinandolo (fine del Medioevo
Lutero e Riforma Protestante diretta dell’opposizione a queste credenze)
METAFORA: L’anima viene paragonata ad una fanciulla che ha la tendenza a ciò che le procura piacere e si lascia attrarre
dai beni materiali se non è frenata da leggi e regole.
Ipotesi sulla SCELTA DEL NOME “LOMBARDO”:
- forse apparteneva alla nobile casa dei Lombardi di Venezia
- forse era soprannominato Lombardo, perché si usava molto nelle corti dei signori di Lombardia
- forse perché nel Medioevo si usava la parola Lombardo per indicare tutti gli italiani del nord
- forse perché apparteneva ai “Lombardi”, un gruppo di eretici che sosteneva con energia e spesso ira la povertà e la
corruzione della Chiesa
MARCO LOMBARDO è descritto da Dante come:
- il prototipo dell’uomo cortese del buon tempo antico, che ha ampia conoscenza del bene e del male degli uomini e
che nutre amore nei confronti della virtù
Dante vide DUE ONDATE DI CORRUZIONE distendersi nella storia del mondo:
1) La prima, la più grande, partiva dalla donazione di Costantino, che aveva “guastato” l’ordine stabilito da Dio riguardo
ai doveri che spettano alla Croce e all’Aquila, ovvero riguardo ai doveri che spettano alla Chiesa e all’Impero nei
confronti del governo della vita religiosa e civile.
2) La seconda era la corruzione che si era aggravata nel 13° secolo con Federico II di Hohenstaufen in Toscana,
Lombardia e Romagna. Da quando il potere politico e quello ecclesiastico erano entrati in conflitto, il disordine e la
decadenza si erano diffuse anche nelle regioni settentrionali, proprio dove un tempo regnavano ordine, virtù e
cortesia
DONAZIONE DI COSTANTINO
Era un documento risalente al 324, attribuito all’imperatore romano Costantino I, dimostrato poi falso dall’umanista Lorenzo
Valla, fatto ad hoc dalla Chiesa per legittimare i propri possedimenti e inserirsi nella vita politica dell'impero.
E' stata utilizzata la denominazione "Donazione di Costantino" perché è stato il primo imperatore a riconoscere, con l’Editto di
Milano (che poneva ufficialmente termine a tutte le persecuzioni religiose e proclamava la neutralità dell'Impero nei confronti
di ogni fede), il cristianesimo dopo un periodo in cui i cristiani si nascondevano nelle catacombe per professare il proprio
credo.
Con la donazione l’imperatore si trasferì a Bisanzio lasciando Roma al papa. Da questo momento iniziò il cosiddetto potere
temporale della Chiesa, che iniziò a trascurare sempre più la sua funzione puramente apostolica, cercando di ottenere
sempre più interessi materiali.
Il falso della donazione di Costantino è stata prodotta durante l'impero Carolingio quando la chiesa subì una forte crisi e si era
rotta l'idea universalistica del Cristianesimo. E si aveva la consapevolezza che la chiesa e la religione dividesse i popoli e non
rappresentasse un fattore di aggregazione.
Potrebbero piacerti anche
- Sia Laudato Nostro SignoreDocumento2 pagineSia Laudato Nostro SignoreMatteo BrenciNessuna valutazione finora
- Definizione Violazioni Formali Legge Di Bilancio 2023Documento1 paginaDefinizione Violazioni Formali Legge Di Bilancio 2023Matteo BrenciNessuna valutazione finora
- Luoghi UNESCODocumento1 paginaLuoghi UNESCOMatteo BrenciNessuna valutazione finora
- Appunti Di Soc Com 2012-2013Documento22 pagineAppunti Di Soc Com 2012-2013Matteo BrenciNessuna valutazione finora
- Le Suddivisioni Nel PurgatorioDocumento1 paginaLe Suddivisioni Nel PurgatorioMatteo BrenciNessuna valutazione finora
- Cost Comp de VergottiniDocumento36 pagineCost Comp de VergottiniAna Suelen Tossige GomesNessuna valutazione finora
- L'Opera Al NeroDocumento1 paginaL'Opera Al NeroMatteo BrenciNessuna valutazione finora
- Articoli Della Costituzione CommentatiDocumento22 pagineArticoli Della Costituzione CommentatiMatteo BrenciNessuna valutazione finora
- Articoli Della Costituzione CommentatiDocumento22 pagineArticoli Della Costituzione CommentatiMatteo BrenciNessuna valutazione finora
- Come Funziona La Mente e L'ansiaDocumento9 pagineCome Funziona La Mente e L'ansiaMatteo BrenciNessuna valutazione finora
- L'Opera Al Nero 2Documento1 paginaL'Opera Al Nero 2Matteo BrenciNessuna valutazione finora
- Teorie Sui Movimenti SocialiDocumento17 pagineTeorie Sui Movimenti SocialiMattia LucchesiNessuna valutazione finora
- Interpretazione e Traduzione A ConfrontoDocumento18 pagineInterpretazione e Traduzione A ConfrontogorovskaNessuna valutazione finora
- 2653 9220 1 PBDocumento10 pagine2653 9220 1 PBNadia GirelliNessuna valutazione finora
- Confronto Fra Connetivi Italiani e SpagnoliDocumento10 pagineConfronto Fra Connetivi Italiani e SpagnoliCecilia Sierra CastañoNessuna valutazione finora
- Dialettologia Oc1Documento5 pagineDialettologia Oc1ivo beoleNessuna valutazione finora