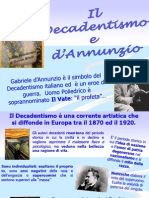Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Le Successioni Dinamiche Di Giacomo Balla
Le Successioni Dinamiche Di Giacomo Balla
Caricato da
Solda Andy AndreaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Le Successioni Dinamiche Di Giacomo Balla
Le Successioni Dinamiche Di Giacomo Balla
Caricato da
Solda Andy AndreaCopyright:
Formati disponibili
Le successioni dinamiche di Giacomo Balla
Un altro artista futurista legato alla raffigurazione del dinamismo e della simultaneit Giacomo Balla (1871-1958). Sin dagli esordi egli mostra un grande amore per la natura, che lo porter ad approfondire lo studio delle apparenze esteriori con un'analiticit tale che gli verr criticata anche da uno dei suoi allievi, Umberto Boccioni ( comunque attraverso quest'ultimo che firmer il Manifesto dei pittori nel 1910). Inoltre ha mostrato un grande interesse per il linguaggio fotografico ( forse l'artista italiano d'inizio Novecento pi avvertito riguardo a questo campo): egli mostra una propensione per i tagli "fotografici" dell'immagine poich, secondo lui, questi liberano la composizione dagli schemi tradizionali proponendo cos un approccio molto ardito al soggetto. Ma, soprattutto al momento della sua adesione al Futurismo, la riflessione sul tema del movimento, come era stato interpretato da Muybridge e Marey, a fornire i primi spunti della svolta stilistica del pittore oramai quarantenne. Balla per svolge questa tematica ancora ancorato al mito positivista della scienza, quindi fiducioso negli sviluppi della tecnica. quindi contrario alla posizione "umanistica" di Boccioni: per lui il dinamismo plastico la conseguenza di un "moto universale" che coinvolge anche oggetti apparentemente immobili.
Fig. 5. Giacomo Balla, Buffalo, Galleria Albright-Knox
Volo
di
rondini,
1913.
Balla sembra invece pi interessato al moto lineare dei corpi; le sue creazioni e il suo nuovo stile futurista derivano da serissimi studi analitici del movimento e da profonde ricerche leonardesche delle successioni dinamiche culminanti nella linea andamentale. A testimonianza di tutto possiamo osservare l'opera intitolata Volo di rondini (fig. 5): uno stormo di rondini passa turbinando fuori dalla finestra e Balla ne ha colto la velocit e il movimento collocandole in una sequenza precisa una dietro l'altra. Sembra che abbia incluso la rigidit dell'imposta per contrastare con l'immobilit il continuo movimento degli uccelli; tuttavia non viene solo introdotta l'idea del movimento ma contraddetta anche la fissit e l'unicit di un unico punto di vista, propri della pittura tradizionale. L'osservatore si muove assieme a ci che sta osservando spaziando coi propri movimenti e la propria fantasia, il pittore si identifica con la libert della rondine: questo il pensiero poetico di Balla.
Fig. 6. Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912. New York, The Museum of Modern Art
Egli poi porta in primo piano le traiettorie degli uccelli con strisce luminose (le linee andamentali), le quali corrispondono al moto che il pittore compie nel suo studio, passeggiando avanti e indietro davanti alla finestra (sul cui fondo si staglia una grondaia e un pezzo di cielo): le linee dei suoi passi si confondono con le rondini che il pittore vede passare. Il tutto - effetti di luce e movimento - ridotto alla purezza di forme geometriche (i triangoli), che si incastrano le une nelle altre e si compenetrano. Anche quest'opera un ottimo esempio del futurismo italiano poich, come questo, esalta il movimento e il dinamismo come massima espressione del mondo moderno. Una cosa importante da considerare che Balla parte dalla realizzazione del movimento come sequenza e ripetizione dell'immagine, e per questo si rivela pi vicino al lavoro di Anton Giulio Bragaglia (1890-1960) nel campo della fotodinamica che non a quello degli altri futuristi. Ed, infatti, l'interesse per la fotografia lo porter a sviluppare tagli prospettici in scorcio. In un quadro come Dinamismo di un cane al guinzaglio (fig. 6) lo sdoppiamento delle immagini dipende dall'immagine fotografica sia per l'inquadratura, che taglia la scena all'altezza delle caviglie della padrona del cane, sia per l'effetto "dinamico", il quale altro non che lo studio analitico dei movimenti delle gambe della signora, delle zampe e della coda del cane.
Lo stesso vale per Le mani del violinista (fig. 7): l'inquadratura si ferma alla spalla del violinista mentre l'effetto dinamico consiste nella rappresentazione dei movimenti delle mani del violinista. La conclusione di tutto ci che l'immagine appare come una sequenza di fotogrammi sovrapposti e leggermente sfalsati.
Fig. 7. Giacomo Balla, Le mani del violinista, 1912
Il movimento, si capisce, analizzato soltanto in rapporto all'oggetto -i particolari veristici rimangono sempre riconoscibili- e non coinvolgono l'ambiente circostante nella boccioniana "continuit dello spazio". Ma l'analisi del movimento resa nel cagnolino e nella mano del violinista con una delicatezza di tocco e con un lirismo tale che va al di l del carattere sperimentale dei dipinti e che rivela l'intenzione di Balla di spiritualizzare il corpo liberandolo dal peso della materia (dopotutto per lui sia il moto sia la luce distruggono la materialit dei corpi). Col passare del tempo per anche Balla, come gi Boccioni, nel 1931 abbandona le iniziali prove futuriste improntate al principio "cronofotografico" della riproduzione del moto per avvicinarsi ad una nuova espressivit molto pi figurativa e gioiosa.
Potrebbero piacerti anche
- Proprietà Delle OperazioniDocumento1 paginaProprietà Delle OperazioniSolda Andy AndreaNessuna valutazione finora
- Il Razzismo Nello SportDocumento11 pagineIl Razzismo Nello SportSolda Andy AndreaNessuna valutazione finora
- OceaniDocumento3 pagineOceaniSolda Andy AndreaNessuna valutazione finora
- Tesi Musica Il JazzDocumento12 pagineTesi Musica Il JazzSolda Andy Andrea100% (3)
- Tesi Musica Il JazzDocumento12 pagineTesi Musica Il JazzSolda Andy Andrea100% (3)
- Tesi Musica Il JazzDocumento12 pagineTesi Musica Il JazzSolda Andy Andrea100% (3)
- Tesi Scienze I VulcaniDocumento9 pagineTesi Scienze I VulcaniSolda Andy AndreaNessuna valutazione finora
- Tesi Tecnologia EnergieRinnovabiliDocumento21 pagineTesi Tecnologia EnergieRinnovabiliSolda Andy AndreaNessuna valutazione finora
- Tesi Storia NazismoDocumento10 pagineTesi Storia NazismoSolda Andy AndreaNessuna valutazione finora
- Tesi-EducazioneFisica-Il Razzismo Nello SportDocumento10 pagineTesi-EducazioneFisica-Il Razzismo Nello SportSolda Andy Andrea100% (1)
- Tesi Italiano Decadentismo e D'annunzioDocumento18 pagineTesi Italiano Decadentismo e D'annunzioSolda Andy Andrea100% (1)
- Il JazzDocumento9 pagineIl JazzSolda Andy AndreaNessuna valutazione finora