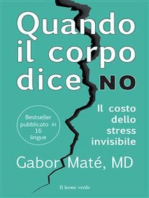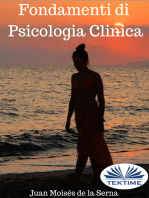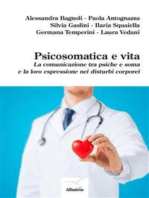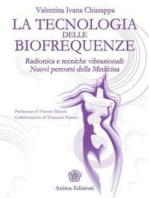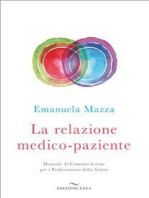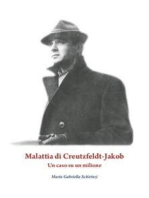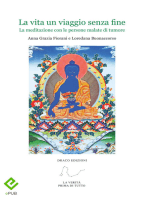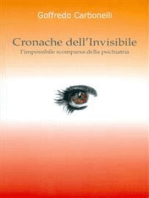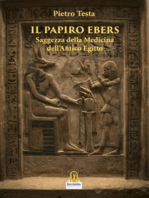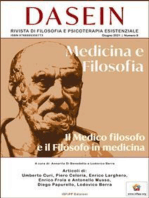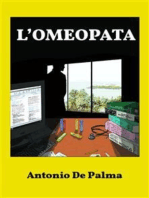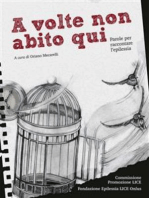Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Diagnosi e Destino Riassunto Mio
Caricato da
marikaritondale60 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
55 visualizzazioni16 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
55 visualizzazioni16 pagineDiagnosi e Destino Riassunto Mio
Caricato da
marikaritondale6Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 16
DIAGNOSI E DESTINO
Riassunto anno 2023/2024
Il termine diagnosi deriva dal greco e vuol dire “conoscere attraverso”,
sottolineando che sia un processo conoscitivo compiuto da chi lo formula ed è così,
ma è anche un momento decisivo della conoscenza del sé. Un famoso medico
canadese William Osler, sulle orme di Ippocrate, sosteneva che era più importante
capire quale paziente avesse la malattia piuttosto che quale malattia avesse il
paziente; inoltre ai suoi studenti ripeteva che se avessero ascoltato il paziente,
sarebbe stato lui stesso a dare la diagnosi. Claudio Rugarli chiama i medici che non
considerano la persona in quanto tale, dei “medici a metà”, in quanto il rapporto
medico-paziente è un problema fondamentale della medicina e chi lo trascura è un
medico dimezzato; il medico “intero” non è un medico perfetto, ma è quello che
comprende, cioè conosce e possiede le caratteristiche non comuni richieste a chi
esercita la professione di clinico; medico e paziente devono essere alleati e la loro
alleanza si chiama “alleanza terapeutica” e, per costruirla, è necessario partire da
un’alleanza diagnostica. Il medico non deve mai dimenticare che il paziente ha perso
qualcosa, ovvero la propria rappresentazione di sé a cui è abituata, il senso di
sicurezza e, a volte, l’autostima. Il medico e psicanalista Michael Balint si dedica allo
studio del rapporto medico-paziente. Egli sosteneva che il medico stesso è un
farmaco e che la relazione con il paziente è in sé un atto terapeutico. Per prima cosa,
secondo lui, il medico deve imparare ad ascoltare, nuova abilità che richiede un
cambiamento, sebbene limitato, nella personalità del dottore, il quale, imparando
ad ascoltare il paziente, inizierà ad ascoltare lo stesso tipo di linguaggio dentro di sé,
che si potrebbe chiamare “controtransfert diagnostico”. Le diagnosi sono raccolte in
massicci volumi tra cui troviamo, per esempio, l’ICD (international classification of
diseases) o il DSM (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). La prima
classificazione internazionale delle malattie risale al 1893 e consiste in una lista delle
cause di morte. Il clinico si muove nel tempo: il presente della diagnosi, il passato
dell’anamnesi e il futuro e ultrafuturo della prognosi; l’avanzare delle conoscenze
scientifiche, infatti, ci permette di mappare il codice genetico e di costruire test
predittivi teoricamente in grado di individuare una malattia a livello molecolare, di
cogliere genotipi di suscettibilità alla trasmissione o allo sviluppo di certe patologie.
Questa possibilità di scoprire il proprio futuro genera speranze, ansie e timori e,
silenziosamente, permette di cambiare il nostro rapporto con la diagnosi. Non più “il
nome di qualcosa che ho”, ma “il nome di qualcosa che avrò”. Ci sono diagnosi per
qualsiasi cosa e in qualsiasi ambito, non c’è storia di vita che non sia attraversata da
una diagnosi.
CAPITOLO 1: diagnosi e tormento
-Malati secondo Sontag.
Alla fine degli anni settanta, Susan Sontag afferma che “non c’è niente di più
primitivo che attribuire a una malattia un significato, poiché tale significato è
inevitabilmente moralistico”. Nel riconoscere l’impatto sociale delle
rappresentazioni psicologiche della malattia, la Sontag combatte perché siano
tenute ben separate e non contagino la realtà scientifica della medicina.
Tubercolosi, cancro e AIDS sono state, e sono ancora, metafore colpevolizzanti di
stili di vita sbagliati. Metafore che lei conosce bene per vissuto proprio con ognuna
di queste, interfacciandosi con la morte per tubercolosi del padre, i suoi due tumori
e la sua omosessualità che, al tempo, si credesse essere connessa all’AIDS,
considerata “peste gay”. Ogni malattia rompe un equilibrio, che sia familiare o
individuale, ma l’AIDS ha rotto l’equilibrio del mondo. Erano anni in cui lottare con
l’AIDS significava prendere coscienza del confine tra un corpo sano e uno malato,
mappare i sintomi e le terapie. Diventare soggetti della cura, non solo oggetti.
Affianco all’AIDS si diffondeva uno stigma storicamente associato al cancro, ma ora
aggravato dal fatto che a ciascun sostantivo si associava l’aggettivo sessuale. L’AIDS
diventava una categoria sociale-morale abitata da metafore punitive. Le parole sono
abitate da fantasmi e sono accompagnate da una sorta di “potere magico”, per
esempio, l’origine della parola “cancro” spiega come mai le persone al tempo, ma
ancora oggi, hanno timore nel nominarlo. Questa parola rinvia all’aspetto del
cancro, circondato di vene turgide e varicose, che sembrano le gambe e le branchie
del granchio, facendoci soffermare sul fatto che questo animale è tenace
nell’afferrare la prenda senza lasciarla andare mai, creando una sorta di parallelismo
con il cancro e la tenacia che ha nell’affermarsi e la difficoltà che si fa per
distruggerlo; questo perché le parole evocano immagini e costituiscono le nostre
rappresentazioni. Per questo motivo, secondo Umberto Veronesi la parola cancro
andrebbe eliminata in quanto paralizzante e andrebbe usata la parola “tumore” o,
meglio, il termine “neoplasia”, che sta indicare la descrizione medica. La Sontag,
infatti, sosteneva che era il nome “cancro” a generare dei problemi in quanto
identificava la malattia come un predatore diabolico e invincibile e non come
malattia.
-Verità e discrezione
Il “rovinoso cartellino” sarebbe la diagnosi. Compito del medico è rivelarla, non
nasconderla. Se la vita psichica non ha alcun ruolo nella formazione e nello sviluppo
della malattia neoplastica, l’atteggiamento psicologico del malato e di chi gli sta
intorno può influire sulla sua reazione alla cura. Karl Jaspers ci insegna che per il
clinico la diagnosi deve rappresentare “un tormento”, che coincide con la capacità
del clinico di sostenere la posizione scomoda, a volte la torsione, tra l’impatto di una
diagnosi e la capacità psicologica del paziente di conoscerla. È grazie alla Sontag se il
potere ingannatore delle metafore applicato alle malattie è diminuito, ma
comunque esse, anche quando non ci piacciono fanno parte di noi. Quindi, pur
prendendo le distanze dalle dimensioni collettive delle metafore, non possiamo
ignorare che le malattie sono anche metafore e rappresentazioni personali. Eppure
la Sontag è irremovibile: nessuna metafora; ella dice che l’immaginario della
malattia non fa che peggiorare la vita del malato e spesso è più difficile da debellare
della malattia stessa. La Sontag invoca l’approccio scientifico, sostenendo che il
ricorso alla psicologia o alla cultura sociale è punitivo e ci porta a sovradeterminare
il significato della malattia, perché essa altro non è che, appunto una malattia, farne
una malattia equivale a usarla in modo per colpevolizzare il malato. Anche
l’elemento di identificazione con la morte viene da ella attaccato in quanto
espulsione del concetto di guarigione da quello di malattia.
-Sontag ha il cancro
È umanamente possibile espellere dalla malattia il concetto di morte? Certo, non
tutte le malattie sono mortali, ma ogni malattia non contiene forse un elemento
depressivo inevitabilmente legato alla morte o alla caducità? Cosa dobbiamo farne,
dichiarare guerra come Oriana Fallaci? Sontag non riusciva a scendere a patti con il
suo essere mortale; da malata passava buona parte del suo tempo a stilare elenchi
di ogni genere, era il suo modo di lottare fino all’ultimo. Come molte persone malate
di tumore, anche lei, la luminosa teorica della malattia razionale, alla fine si è trovata
a fluttuare tra consapevolezza e illusione, pensiero magico e razionalità. Sontag
osserva che le metafore chiave della descrizione del cancro provengono dal
linguaggio militaresco (per esempio, le cellule cancerogene “invadono”,
“colonizzano”); anche le cure hanno qualcosa di militare: metafore della guerra
aerea per la radioterapia (pazienti “bombardati” con raggi tossici) e giunge ad una
conclusione: quando il linguaggio terapeutico si allontanerà da quello militare allora,
in parte, il cancro verrà “smitizzato” e sarà possibile considerarlo non per forza con
una diagnosi fatalistica; e solo allora, aggiunge, sarà possibile “usare il cancro come
metafora”. Ma a quel punto nessuno paragonerà più il cancro a qualcosa di orribile.
-Nella malattia rivelo tutto il mio essere
Non penso che l’insorgenza di una malattia neoplastica possa essere riconducibile a
fattori psicologici, ma temo che alcuni degli argomenti usati dalla Sontag per de-
psicologizzare la malattia possano rivelarsi dei boomerang. All’appuntamento con la
malattia non tutti arrivano tenuti per mano dalla razionalità dell’evidenza scientifica
e dalla laicità del pensiero non metaforico. Non si tratta, come direbbe Sontag, di
separare materia e spirito, ma di capire che oltre la malattia c’è il malato con la sua
storia personale e sociale, le sue metafore e rappresentazioni. Non è dal malato che
dipende l’esito della malattia, ma da lui possono dipendere il percorso, la narrazione
e l’esperienza; infatti ammalarsi è un avvenimento che mette in azione il nostro
sistema di difese psichiche e non solo immunitarie. Minimizzare il lavoro psichico e
l’elaborazione fantasiosa che la malattia sempre richiede mi sembra un modo di
proteggersi, una difesa che punta solo sul lume della ragione. Nell’affermazione di
Sontag per cui la “comprensione psicologica” di una malattia ne erode la “realtà”,
sembra di cogliere l’ombra del diniego. Se per “comprensione psicologica” intende
la ricerca dell’origine o dello sviluppo della malattia nella propria biografia psichica e
relazionale, non posso che essere d’accordo con lei; ma se intende l’ascolto di un
immaginario, personale e collettivo, lo sviluppo di una relazione psichica con la
propria salute e la propria malattia, allora siamo difronte a qualcosa che non può
essere liquidato equiparando la psicologia a una forma di “spiritualismo sublimato”.
-Vite non vissute
C’è un romanzo dedicato “ai malati”. Si intitola “la vita vissuta” e lo ha scritto Nicola
Gardini. La storia è quella di Valerio, un giovane uomo che scopre di essere
sieropositivo all’HIV. Gardini vuole attenuare la contrapposizione malattia/salute e
considera la malattia una condizione della vita. L’intero libro è una riflessione
sull’intrinseca ambivalenza della malattia, la sua indefinibilità. Mi colpisce la
coincidenza tra il titolo di Gardini e quello dello psicoanalista americano Thomas
Ogden. Il libro di Ogden parte dall’idea che ogni paziente porti in analisi la
sensazione di “essere morto” nell’infanzia o in fasi successive della vita, sperando
che il lavoro con l’analista lo aiuterà a ritrovare la sua “vita non vissuta”. Il fulcro di
analisi sarebbe dunque, per Ogden, un evento terrorizzante del passato che ha
costretto il paziente ad assentarsi dalla propria vita per proteggersi dal crollo
psicologico; nella storia di Gardini, invece, funzionerebbe al contrario, cioè è un
evento terrorizzante del presente che costringe il paziente a “presentarsi alla
propria vita”.
-Devozioni per occasioni di emergenza
John Donne scrisse un libro poco conosciuto, pubblicato nel 1624, dal titolo
“devozioni nelle occasioni di emergenza e nei diversi gradi della mia malattia” che
risulta essere un diario, un libro di meditazioni, preghiere e introspezione religiosa,
un documento sulla medicina del tempo; sono anche una raffinatissima descrizione
psicologica del dialogo silenzioso tra il paziente e il medico al suo capezzale:
“osservo il medico, vedo che ha paura e ho paura con lui. Egli sa che la sua paura
non turberà la pratica e l’esercizio della sua arte, ma sa che la mia paura può turbare
l’effetto e l’operazione della sua pratica”. Donne scrive le devozioni a 52 anni, sul
finire dell’accesso di una delle grandi febbri tifoidi che lo avrebbero accompagnato
fino alla morte, avvenuta nel 1631 probabilmente per un tumore allo stomaco. La
condizione dell’uomo, dice Donne, è “mutevole e miserevole”; noi ci sforziamo a
porre attenzione a tutto quello che facciamo, ma in un attimo arriva una malattia
che ci stravolge e ci atterra e ci distrugge in un attimo. Le devozioni sono scritte da
una postazione di combattimento e al tempo stesso di resa: il letto dell’infermo.
L’intera opera è un intreccio tra i pensieri e gli stati mentali del malato e un
sentimento terreno e al tempo stesso spirituale di immersione nella condizione
umana. Ai 23 giorni di infermità corrispondono le 23 sezioni del libro; stazioni della
malattia che Donne divide in ulteriori tre parti: meditation, expostulation, prayers,
cioè meditazioni, suppliche e preghiere. In epigrafe presenta il tema della malattia e
della cura; nella meditazione lo sviluppa filosoficamente e psicologicamente; la
supplica apre un confronto con il soprannaturale e le sacre scritture; infine la
preghiera riprende il dialogo con Dio verso la pace interiore. Del resto sono tre
anche le nascite che lo scrittore si riconosce: una naturale, quando viene al mondo;
una soprannaturale, quando entra nel monastero; una preternaturale che è quella
che dalla malattia lo ha portato alla vita; nascita, quest’ultima, che lo trasforma in
padre del libro. Le 23 stazioni rappresentano un racconto nel quale chiunque potrà
riconoscersi. Tutto parte dalla prima alterazione, il primo risentimento, della
malattia; poi il mutare e il venir meno della forza e della funzione dei sensi e delle
altre facoltà. Ora il malato si mette a letto e manda a chiamare il medico; tutti i
medici consultati fanno le prescrizioni. Scoprono che il morbo avanza, chiuso e
strisciante, e si adoperano per affrontarlo. Inizia la terapia, ma il morbo dichiara la
propria infettività e malignità attraverso macchie. Dalle campane della chiesi vicina,
nei funerali altrui, gli viene ricordata quotidianamente la propria sepoltura. Tu
morirai ì, gli dice questa campana che dolcemente suona per un altro. Ma ora, dopo
un lungo e tempestoso viaggio, i medici vedono terra, ricevono segnali favorevoli di
maturazione della malattia e decidono di procedere a una purga. Dio guarda con
favore alla loro cura e, attraverso di loro, chiama Lazzaro fuori dalla tomba e il
malato Donne fuori dal letto. Prima di andarsene, lo avvertono del terribile pericolo
di ricaduta.
-Narrare la medicina
Le diagnosi sono storie che raccontano la nostra storia. La malattia come storia è il
fulcro psicoanalitico della cosiddetta “medicina narrativa”, un approccio che
rappresenta il tentativo di colmare lo spazio tra armamento tecnico-diagnostico
della medicina moderna e l’esperienza umana della malattia. La medicina narrativa è
un atteggiamento mentale che richiede al medico competenze relazionali e
dimestichezza con il racconto del paziente, i significati, le credenze e le mitologie
che sanciscono l’unicità del malato e della relazione con la malattia. La voce del
paziente è il cuore della relazione clinica e la chiave del processo diagnostico. La
pratica clinica è fatta di racconti; la diagnosi stessa può essere vista come un
tentativo di dare una trama a eventi apparentemente non collegati. Rinunciare alle
metafore è quasi impossibile. Le narrazioni uniscono gli umani, li dispongono alla
condivisione. Quando l’antropologo Byron Good dice che le narrazioni sulla malattia
sono fondamentali per “mettere al congiuntivo la realtà”, intende stimolare la
nostra relazione con le “possibilità umane” e proporre letture aperte della malattia,
capaci di riunire il linguaggio medico della diagnosi e quello dell’esperienza che ne fa
il paziente. L’anamnesi è una narrazione a due voci, un dialogo-intervista tra medico
e paziente fatto di domande e risposte, postille, ricordi, divagazioni e commenti.
Non è per questo che la clinica medica può essere pensata anche come una talking
cure? Il sintomo che il paziente comunica al medico non è solo informazione, è
narrazione e, spesso, è metafora. Anche le narrazioni dei medici sono ricche di
metafore e immagini (es: attacco di panico è come un infarto). Insieme ai sintomi il
paziente porta al medico una storia che rende inseparabili malato e malattia e che ci
identifica e differenzia, perché la malattia può essere comune a più persone, ma è la
storia che differenzia i pazienti. È la differenza tra illness, la malattia inserita nel suo
contesto di esperienza e cultura, e disease, la malattia biologica. La differenza tra
care, prendersi cura della relazione e cure, curare il corpo. Il medico deve saperle
tenere separate, ma deve anche saperle riunire.
-Malati secondo Woolf
Nel 1930, Virginia Woolf dedica un brevissimo saggio all’essere malati, On Being Ill;
posizione diversa da quella della Sontag. Se Sontag critica le fantasie che sorgono
attorno alle grandi malattie, per Woolf, la malattia è “il grande confessionale”. In un
certo senso “rivendica” la condizione di malattia perché le permette l’accesso a
verità che rimarrebbero altrimenti escluse alla conoscenza, individuale e collettiva.
Woolf si rammarica che in letteratura “salvo uno o due passioni, come il desiderio
sessuale e l’ingordigia, il corpo non c’è, non esiste”. Che cosa succede in noi quando
diventiamo malati? Per Woolf avviene un “tremendo cambiamento spirituale”. Per il
linguaggio della malattia, dice, non c’è niente di pronto, anzi, il malato deve coniare
le parole da solo; Patrizia Cavalli, infatti, coglie un elemento importante e lo fa
notare di ritorno da una visita medica e sostiene che ai medici manca il vocabolario
per descrivere i sintomi e, dunque, quando glieli racconti, fanno fatica a capirli. Nella
malattia, scrive febbrile la Woolf, “le parole sembrano possedere una qualità
mistica”. Quando siamo in salute “l’intelligenza domina sui sensi” e “il senso usurpa
il ruolo del suono”. Ma anche se è a letto con l’influenza, il malato “si lamenta di non
avere simpatia”.
-Il guaritore ferito
Sontag e Woolf incarnano due qualità opposte della malattia e della diagnosi. Nella
malattia e nella sua diagnosi la Sontag rintraccia lo stigma e l’accidente. Gli altri non
vedono altro, si concentra sul peso sociale che si aggiunge al fardello sciagurato
della malattia. L’etichetta è lì anche a definire il ruolo del malato. Woolf vive la
malattia come distorsione e torsione, una condizione capace di rivolgere verso il
mondo interno tutte le preoccupazioni e i pensieri. In questo senso, la fragilità a cui
la malattia ci condanna può diventare un’indesiderata opportunità. Ho scelto due
donne perché la storia del cancro spesso è la storia del cancro è spesso una storia di
donne. La prima malata di cancro di cui conosciamo il nome è Atossa, figlia di Ciro e
moglie di Davide il Grande. Erodoto racconta che quando scoprì di avere un tumore
al seno, Atossa abbandonò la corte e si isolò. Un oncologo racconta questo episodio
per sottolineare come la vergogna sia stato uno dei sintomi più dolorosi di questa
malattia; e ricorda come, negli Stati Uniti dei primi anni cinquanta, il “New York
Times” rifiutò di pubblicare l’annuncio a pagamento di un gruppo di sostegno per
malate di cancro al seno. Quando la psicoanalista Francoise Dolto scrisse inconscio e
destini, il destino viene visto come qualcosa di indeterminato e ignoto, insaturo. La
diagnosi può produrre un destino, ma non il destino. Gardini scrive “la malattia non
sta in una definizione, ma in una storia”, in una storia che diventa una trama. Il mito
ci insegna che ogni medico, ogni terapeuta, è un guaritore ferito. L’arte di chi
guarisce, scrive T.S. Eliot, è tagliente e pietosa. Per Michael Balint il medico stesso è
un farmaco; quindi un rimedio ma anche un veleno. Difronte alla malattia, sulla
soglia della diagnosi, il medico, dice Jung, “è chiamato in causa con il suo essere”;
deve conoscere e riconoscere, perché “il medico ferito guarisce”. Io penso che
accanto all’aspetto demiurgico del sapere e della tecnica, c’è sempre un dolore
“contenuto nella comune matrice umana”; quindi, per poter curare, un medico non
deve separarsi troppo dal suo aspetto di paziente. Per curarsi e farsi curare, un
paziente non deve separarsi troppo dal suo aspetto di medico.
CAPITOLO 2: diagnosi e difese
“Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita”.
Arriva un’età in cui, tra amici, si parla sempre più spesso di medici. La frase sopra
citata è stata scritta da Joan Didion, 84 anni, una delle più grandi giornaliste
americane. Nel documentario-intervista che il nipote Griffin Dunne le ha dedicato,
l’ascolto parlare mentre addomestica le discinesie del Parkinson e ne fa una danza.
Ogni parola racconta la sua terapia. Per introdurre una raccolta di saggi sceglie il
verso del poeta irlandese William Butler Yeats: “le cose vanno in pezzi, il centro non
reggerà”. Quante volte ce lo chiediamo, se il centro reggerà. Didion ci ha insegnato
l’elaborazione del lutto. Il suo centro si è solo spostato. In un punto indefinito della
sopravvivenza. Anche per questo ci scambiamo indirizzi di “bravi” medici, è una
forma preziosa dell’amicizia. Inconcepibile quando si è ragazzi, praticata con metodo
una volta entrati in quella che Jung chiamava la seconda metà della vita. E con
struggimento quando le diagnosi non compaiono, come è giusto, in vecchiaia, ma
arrivano, come è ingiusto, in gioventù.
-Diagnosi rimosse, diagnosi negate
In Patrimonio, Philip Roth racconta gli umori e le miserie, la tenacia e la stanchezza,
le rese e le difese di un malato di tumore al cervello: suo padre. Come una frustata,
come un pianto, quella diagnosi, quel referto dal linguaggio incomprensibile, lo
mettono di fronte a ciò che suo padre era stato e a ciò che rimaneva di lui. Al
patrimonio. Qualche mese dopo appare un’altra diagnosi. Un’autodiagnosi: ansia.
Anch’essa sbagliata. Le malattie dei nostri genitori abitano in noi per tutta la vita,
facendoci paragonare con la loro vita, con quanto hanno vissuto, con quanto sono
stati male, a che età e come è iniziata la loro malattia. La malattia attacca e
trasforma il nostro organismo, ma attacca e trasforma anche la nostra identità; ogni
malattia rompe un equilibrio. Una diagnosi minacciosa modifica la nostra vita
psichica e le nostre relazioni private e pubbliche. L’attesa di una diagnosi ci tiene in
ansia e quando arriva porta con sé una gamma infinita di stati d’animo. Con la
malattia, dice Sontag, entriamo nel “lato notturno della vita” e acquisiamo “una
cittadinanza più onerosa”. L’incontro con la malattia implica una ridefinizione della
propria soggettività e la ricerca di forme nuove di adattamento. Una diagnosi
“importante” modifica il nostro equilibrio psichico e relazionale. Tale cambiamento
avviene grazie ai nostri meccanismi di difesa, che sono il principale strumento con
cui gestiamo i conflitti e gli affetti. I meccanismi di difesa sono una delle funzioni
psichiche fondamentali di adattamento alle richieste e alle restrizioni della realtà
esterna, ma anche della realtà interna, ammesso che le due siano separabili.
Quando si tratta di “gestire” una diagnosi di malattia, i meccanismi di difesa sono in
prima linea.
Regredire al servizio dell’Io
Molte persone, anche se malate, non tollerano di dover cambiare, anche per pochi
giorni, le loro abitudini. Tanto grandi sono la paura delle regressioni e l’angoscia di
non tornare a “funzionare” come prima. Un individuo con una personalità ben
funzionante e di conseguenza portato a impiegare difese mature, di solito riesce ad
adattarsi al cambiamento. Diversa è la situazione di chi, per fare i conti con
l’infermità, per difendersi dalla malattia, ricorre a rimozioni, negazioni, scissioni o
proiezioni. Ciò che permette ad una persona malata di convivere con la sua diagnosi
sarà la capacità di sintonizzarsi con il proprio mondo emotivo tenendolo in equilibrio
con il mondo esterno. Nel 1952, per definire la capacità dell’Io di passare da un
livello di funzionamento più elevato a modalità più primitive, formula il concetto di
“regressione al servizio dell’Io”. Un processo che può essere applicato ai processi
creativi, all’amore e alla sessualità, al gioco e persino al lavoro analitico. Una
regressione reversibile rappresenta uno strumento di grande efficacia nell’incontro
con la malattia e gli inevitabili mutamenti dell’immagine di sé e delle proprie
relazioni. Queste dinamiche, sane o patologiche, non dipendono solo dalla
personalità del malato, ma anche da chi gli sta intorno e dal tipo di malattia.
Gerarchie di maturità
Possiamo disporre i meccanismi di difesa lungo una scala di maturità,
consapevolezza ed elasticità (più o meno o per nulla adattive). Quelle che
consentono di gestire al meglio gli eventi stressanti sono chiamate di “alto livello” e
comprendono affiliazione, altruismo, anticipazione, autoaffermazione,
autosservazione, umorismo, repressione e sublimazione. Accentuano la
gratificazione, permettono la consapevolezza dei sentimenti e delle loro
conseguenze, promuovono un equilibrio tra i motivi di conflitto e così via.
Scendendo lungo la scala di maturità, incontriamo un livello chiamato di “inibizione
mentale” o delle “formazioni del compromesso”. È caratterizzato da un
funzionamento più nevrotico, che tende ad escludere qualcosa dalla
consapevolezza, quando questo qualcosa costituisce una minaccia per l’equilibrio
psichico. In questo caso parliamo di difese ossessive come l’annullamento
retroattivo, l’intellettualizzazione o l’isolamento affettivo: il loro scopo è mantenere
intatti gli aspetti cognitivi mentre quelli affettivi vengono inibiti. Difese come la
rimozione e la dissociazione minore lasciano intatti gli aspetti affettivi, mentre
inibiscono quelli cognitivi. Altre difese nevrotiche sono lo spostamento e la
formazione reattiva. Quest’ultima consiste nel provare un sentimento inaccettabile
e sostituirlo con un sentimento opposto. Vi è poi un livello di “distorsione minore
dell’immagine”, che si chiama così perché l’individuo manipola o distorce
l’immagine di sé o di altre persone al fine di regolare l’autostima (chiamate anche
narcisistiche): alcune caratteristiche positive vengono amplificate (idealizzazione),
altre ridimensionate (svalutazione), altre ancora esaltate in modo esagerato
(onnipotenza). Procedendo verso altri livelli sempre meno adattivi, incontriamo le
difese del “disconoscimento”, tra cui la proiezione, la razionalizzazione, la
negazione; le quali hanno il compito di negare la presenza di un evento spiacevole o
di un contenuto minaccioso. Quando vengono diagnosticate delle malattie, che
siano esse mentali o fisiche, l’individuo anziché adattare sé stesso alla realtà, adatta
patologicamente la realtà a sé stesso, attraverso, appunto, i meccanismi di difesa.
Esiste anche un livello di “distorsione maggiore dell’immagine” detto anche delle
difese “borderline”. Le più frequenti sono la scissione e l’identificazione proiettiva. La
scissione indica l’incapacità di tenere insieme gli aspetti negativi e positivi
dell’esperienza. L’inevitabile miscela di buono e cattivo viene polarizzata nei suoi
estremi. L’identificazione proiettiva è la difesa più complessa e difficile da spiegare.
Compare nelle relazioni conflittuali: tra partner, genitori e figli e, medico e paziente.
Si tratta di una dinamica relazionale che spinge ad attribuire a un’altra persona un
proprio sentimento o impulso inaccettabile. Il contesto affettivo non viene
disconosciuto, ma interpretato come una propria reazione giustificata all’ostilità
dell’altro. Il quale si identifica davvero nelle caratteristiche negative che gli sono
state “messe dentro” e si comporta di conseguenza. Un altro meccanismo che
implica dinamiche di aggressività passiva è chiamato dagli inglesi help-reject
complaining: si chiede aiuto, ma quando viene offerto si rifiuta. Il livello più maturo
è quello dell’acting (agire), perché queste difese sostituiscono il pensiero e
l’elaborazione simbolica con azioni distruttive intraprese senza considerare le
conseguenze personali e sociali. Nel cosiddetto acting-out, i sentimenti dolorosi
vengono espressi in modo impulsivo e incontrollato. Tutti i comportamenti
autodistruttivi possono essere considerati degli acting.
Personalità e difese
Francesca ha 38 anni, è sposata da sette e da tempo cerca di avere un figlio. Ha
avuto due aborti spontanei e ora, in seguito a una biopsia che ha mostrato
l’esistenza di un tumore in fase iniziale, deve sottoporsi ad un’isterectomia. La
sorella più giovane ha quattro figli ed è considerata da tutti i parenti una mamma
modello. Francesca non lo ammette, ma nei confronti della sorella prova dei
sentimenti di invidia e inferiorità. Provo a riassumere, per mezzo di vignette cliniche
la gamma di possibili risposte difensive che potrebbero caratterizzare risposte di
Francesca alla sua situazione.
a) Un mese dopo l’operazione, organizza un gruppo di autoaiuto per donne che
hanno subito interventi per tumori al seno o all’utero (altruismo).
b) Dopo una lieve infezione postoperatoria, scrive una lunga, rabbiosa lettera ai
giornali attaccando l’ospedale. Accusa il medico di base di non averle
proposto un secondo test in tempi utili e pensa di procedere contro di lui
legalmente per incapacità professionale (proiezione).
c) “Riscopre” un antico interesse per lo studio della pianificazione familiare. Dice
di essere sempre stata terrorizzata dai dolori del parto e confida al marito che
tutto sommato è contenta di non aver avuto figli (formazione reattiva).
d) Legge varie pubblicazioni scientifiche sui tumori all’utero e pone al medico
domande tecniche sulla natura dell’intervento e sulle procedure dell’esame
istologico. Elabora un file con tutti i nuovi termini medici che apprende
(isolamento affettivo).
e) Al risveglio dall’anestesia non prova dispiacere, ma si dichiara felice per quella
che considera una nuova esperienza religiosa. Il giorno dopo, camminando
per l’ospedale, si ritrova nel reparto maternità senza sapere perché e come ci
è arrivata (dissociazione).
f) Cerca di non lamentarsi troppo quando le rimuovono i punti dalla ferita.
Sapendo di essere turbata dalle immagini dei neonati e notando che sulla
copertina del suo settimanale preferito c’è un servizio sulle giovani mamme,
decide di leggere un altro giornale (repressione).
g) Si scopre incapace di ricordare il nome dell’operazione subita. “Dimentica” di
presentarsi al primo controllo medico. A casa scoppia a piangere quando
rompe una fotografia incorniciata dei nipoti, ma dice di non avere idea del
perché piange (rimozione).
h) Dice insistentemente alle infermiere che dovrebbe essere trasferita al reparto
maternità e vaga per l’ospedale cercando “il suo bambino”. Fa un’ordinazione
telefonica di una culla. Non prova alcun dolore post-operatorio (diniego
psicotico).
i) Chiacchiera affettuosamente al telefono con i nipoti e scrive per loro una
poesia sulle gioie agrodolci dell’essere la classica “zia senza figli”
(sublimazione).
j) È molto interessata alla crescita di tulipani sul balconcino della sua camera
d’ospedale, ma non chiede mai informazioni sul decorso ospedaliero
(spostamento).
k) Il giorno dopo l’operazione, dice ai medici di appartenere a una setta religiosa
e chiede di essere dimessa subito. Aggiunge che hanno bisogno di una
vacanza per fare una piccola “semina primaverile” (distorsione psicotica).
l) Il chirurgo è colpito dalla calma e dal senso pratico con cui Francesca affronta
il decorso post-operatorio. La sorpresa del medico è dovuta al fatto che
Francesca aveva trascorso il periodo delle visite operatorie preoccupandosi di
possibili complicazioni e spesso piangendo perché non avrebbe più potuto
avere bambini (anticipazione).
m) È convinta che l’ospedale sia in mano a nazisti che la vogliono sterilizzare
sterilizzare. Cerca di telefonare alla polizia; rifiuta di prendere gli antidolorifici,
dicendo che sono farmaci sperimentali per controllare il pensiero (proiezione
delirante).
n) Dice all’infermiera che non vuole ricevere visite perché la rendono “triste”.
Getta via tutti i fiori ricevuti in regalo. Va al reparto neonatale e fantastica sul
nome che darebbe a ciascun bambino se fosse suo. Canta spesso a voce alta
una ninna-nanna (ritiro nella fantasia).
o) È preoccupata della possibilità che il tumore possa essersi diffuso anche ai
linfonodi. Si lamenta di essere lasciata in balia della sua preoccupazione, ma
ogni volta che la sorella va a trovarla, la accusa di occuparsi solo dei suoi figli e
non di lei che sta morendo di cancro (lamentarsi ma rifiutare l’aiuto offerto,
ipocondriasi).
p) Un tirocinante, mettendo la flebo, fatica a prenderle la vena: lei gli sorride, gli
dice di non preoccuparsi e aggiunge: “quando si è solo studenti di medicina,
deve essere difficile fare le cose per bene”. Il tubicino della flebo a poco a
poco si ostruisce. Alle 4 di mattina, l’ausiliaria deve chiamare il medico per
rimettere la flebo. Con aria spensierata dice al medico che non ha segnalato
prima il problema per non disturbare, perché sa che in ospedale sono tutti
sempre molto indaffarati (aggressione passiva).
q) Poco tempo dopo aver lasciato l’ospedale, tenta il suicidio (acting out).
La persona malata impiega le funzioni affettive e cognitive nel tentativo di fare i
conti con la malattia. L’intervento dei meccanismi di difesa da un lato rappresenta la
lotta contro l’angoscia; dall’altro permette l’instaurarsi di nuove modalità di
relazione con se stessi e con gli altri. Il ricorso ad uno stile difensivo più o meno
maturo dipende dalle caratteristiche della nostra personalità, dalla sua
organizzazione generale (che può essere sana, nevrotica, borderline o psicotica). La
psicologia medica dedica particolare attenzione agli stili di personalità e al
funzionamento difensivo sia del medico sia del paziente. Conoscere lo stile di
personalità e la struttura difensiva di un paziente è importante anche per prevedere
la sua compliance al trattamento, cioè l’aderenza alle prescrizioni e ai cambiamenti
di vita richiesti.
Anche il medico si difende
Oltre alle difese del paziente ci sono anche quelle del medico. Fare diagnosi, curare
malattie, assistere i malati sono compiti psichicamente impegnativi. Chiunque abbia
a che fare con persone da assistere, prima o poi sente il bisogno di “difendersi”. Se
quelle più caratteristiche della persona malata sono la rimozione, l’isolamento
affettivo, la regressione, la negazione e la proiezione; il medico si appoggerà ad altri
meccanismi, oppure agli stessi, ma usandoli in maniera diversa. La scelta di una vita
professionale fondata sull’aiutare gli altri potrebbe essere influenzata dalla tendenza
a minimizzare, ma anche dalla necessità di elaborare, un proprio bisogno, magari
trascurato, di essere accuditi e aiutati. Oppure potrebbe rappresentare la ricerca di
un antidoto per immunizzarsi da rappresentazioni del sé come deboli, vulnerabili o
in costante pericolo. Soluzioni che traggono nutrimento da un immaginario
individuale e collettivo. Idealizzazioni necessarie ma anche accecanti, le qual ci
impediscono di vedere, per esempio, gli aspetti d’ombra delle helping professions.
Alle dimensioni accennate, riconducibili ai temi della bontà e della forza se ne
aggiunge una terza, più oscura: il potere; il paziente ha bisogno di una persona che si
prenda cura di lui e, per farlo, questa persona (medico) deve avere conoscenza,
strumenti e ruolo, quindi, implicitamente, potere. È importante che i medici siano
consapevoli non solo delle basi psicologiche della loro scelta professionale, ma
anche delle dinamiche di potere consustanziali alle relazioni asimmetriche.
Torniamo ai meccanismi di difesa che il clinico mette in campo per difendersi dai
tanti stati d’animo negativi che caratterizzano la sua professione. Un ricorso
equilibrato all’intellettualizzazione e all’isolamento aiuta a tenere sotto controllo
l’esposizione emotiva alle difficoltà del paziente, ma un loro uso massiccio può
portare il clinico a rifugiarsi in una visione fredda e tecnicista della malattia, spesso
letale per la sensibilità del paziente. Il funzionamento difensivo si appoggia anche a
risposte “mature”, adattive e spesso risolutive. Ma questo se l’organizzazione della
personalità e l’entità della minaccia lo consentono.
Non ci sono più i medici di una volta
La nostalgia facilita l’idealizzazione e spesso si sente dire che i medici di una volta
non ci sono più. È vero che il “medico di famiglia” ci manca. Pare che, entro pochi
anni, 14 milioni di italiani rimarranno senza medico di base. Un dato preoccupante,
soprattutto se pensiamo che con una popolazione che invecchia velocemente, il
tema dell’assistenza sul territorio sarà una priorità. Il “medico condotto” di una volta
visitava i malati a casa. Oggi è impensabile. Ad oggi possiamo notare come la
medicina generale scompare e quella specialistica avanza. Nella sua complessità
integrata, il corpo lascia posto alle sue parti. E quando le parti sono curate come
separate, ci troviamo difronte a un male (la dissociazione) nato da un bene (la
medicina specializzata). Mi sono imbattuto in una serie di riproduzione dei “ritratti
medici” di Norman Rockwell; i medici alla Rockwell facevano visite a domicilio e si
fermavano a parlare con i pazienti, ma avevano poco da offrire in termini di terapie.
Eppure questi medici con poche frecce al loro arco erano più amati e rispettati di
quelli d’oggi. Potremmo elencare una serie infinita di ragioni. Una potrebbe essere
che una volta la maggior parte dei medici era “generalista” e quindi buona parte
delle cure era fornita dalla stessa persona. Un’altra ragione potrebbe essere che la
conoscenza era nelle mani di pochi e chi aveva studiato deteneva un sapere pregiato
che dava autorevolezza. Viviamo in tempi in cui il medico ha perso l’altro suo
compito principale, quello di instaurare una relazione con il paziente. Prendere in
cura le persone e non solo le malattie.
Malato e malattia, inseparabili
Ciò che il sentire comune chiede alla medicina è proprio ciò che la medicina non è in
grado di dare: una capacità di vittoria contro la sofferenza e la morte. Non sarà,
però, la medicina a curare quello che Freud chiamava la nostra “esigenza di
eternità”. L’onnipotenza è il primo meccanismo di difesa a cui un bravo medico e un
bravo paziente devono imparare a rinunciare. Che non significa rinunciare alla
speranza, ma solo che guarire una malattia o ritardare la morte non rappresentano
un passo verso l’immortalità. C’è chi si rivolge alle medicine alternative
reattivamente e chi si rivolge alla medicina scientifica in modo fideistico. Entrambe
le posizioni sono pericolose perché propongono un approccio ideologico alla
medicina, mentre ciò di cui il paziente ha bisogno è una buona comunicazione tra
chi cura e chi è curato. Quanto alla relazione con il paziente, non si tratta di esortare
i medici a essere gentili e comprensivi, ma di insegnar loro a comunicare con i
pazienti. Ogni paziente è intero e unico, ma è anche parziale e simile agli altri. Il
paziente è contemporaneamente malato e malattia. Il medico che non comprende
questo paradosso rischia di essere un “medico a metà”. La psicoanalisi, con Melanie
Klein, inventò il concetto di “oggetto parziale”. Negli anni trenta, la Klein ipotizza
che, per il bambino, una parte del mondo con cui è in contatto e da cui dipende, in
primis il seno materno, è al tempo stesso oggetto “reale”, ma anche un oggetto della
fantasia, un oggetto “interno” capace di rispondere ai suoi bisogni. Secondo la Klein,
il neonato farebbe fatica a distinguere il suo corpo da quello della madre. In questo
senso l’oggetto con cui il neonato stabilisce una relazione è sì una parte, ma anche
tutto ciò che l’oggetto ha da offrire. Il passaggio da una relazione con l’oggetto
parziale a una relazione con l’oggetto intero è riconducibile al transito evolutivo tra
una posizione onnipotente (schizoparanoide) e una posizione realistica (depressiva).
Per riconoscere la totalità dell’oggetto il bambino deve inevitabilmente riconoscere
anche la sua alterità, e quindi la frustrazione legata a una maggior separatezza e una
minor possibilità di controllo. Il medico deve saper passare dall’oggetto parziale
(l’organo malato) all’oggetto intero (il paziente), dalla malattia (simile per tutti) al
malato (diverso da tutti).
L’ipocondria come rifugio psichico
Una diagnosi può spingerci a sublimare, intellettualizzare, rimuovere, negare,
proiettare, agire impulsivamente, e così via. Sono difese immerse nella nostra
personalità, ci appartengono in modo strutturale nella nostra personalità, ci
appartengono in modo strutturale e si manifestano in occasioni specifiche. Vi sono
invece culti diagnostici che possono accompagnarci per la vita intera, infatti,
secondo l’American Psychiatric Association, tra i pazienti che si rivolgono al medico
di base, la percentuale di persone ipocondriache è compresa tra il 2 e il 7%. Per
parlare di loro, ipocondriaci è il termine colloquialmente più in uso. Se internet può
essere utile a chi non è ipocondriaco, per chi lo è può diventare un labirinto di
conferme micidiali. Consultare internet può essere utile; ma per gli ipocondriaci è un
boomerang. Sembrano esserci due tipi di ipocondriaci; quelli che vanno dal medico
continuamente, portando ogni preoccupazione e ogni sintomo; e quelli che dal
medico non ci vanno mai, troppa paura, ma quando sono in autobus, in ufficio,
oppure prima di addormentarsi, non fanno che pensare vi sia qualcosa che non va
nel loro corpo e nella loro salute. Ma cosa significa esattamente “ipocondria”? il
nome si deve agli antichi Greci che, attribuivano la malattia a disturbi dei visceri
posti sotto la cartilagine. Sette secoli dopo, Galeno è il primo a descrivere la
melanconia come una “malattia ipocondriaca” con sede nei visceri addominali. Alla
fine del Seicento, con il medico inglese Thomas Sydenham, l’ipocondria viene a
connotare un vero e proprio stile esistenziale. Nel 1845, Wilhelm Griesinger include
la patologia ipocondriaca tra gli stati depressivi minori. Emil Kraepelin, nel 1896,
suggerisce un’interessante distinzione tra hypochondria cum materia, quando i
disturbi sono “reali” ma “sopravvalutati”, e hypochondria sine materia, quando
manca ogni base “oggettiva”. Nell’ipocondria, il corpo e la sua vulnerabilità sono
l’oggetto di un’attenzione continua. Per lo psichiatra Henry Ey, il complesso
ipocondriaco è universale. Lo stesso Freud pare ne soffrisse, soprattutto in
giovinezza. Sull’oscurità che circonda la questione “ipocondria” di gettare un raggio
di luce. Secondo Fenichel, il paziente ipocondriaco sottrae libido all’oggetto e la
rivolge narcisisticamente su un organo del corpo. Negli anni sessanta, Rosenfeld
considererà l’ipocondria alla stregua di una difesa complessa, costruita su dinamiche
scissionali, proiettive e introiettive. A partire dal 1952, le varie edizioni del Manuale
diagnostico e statico dei disturbi mentali, il famoso DSM, trattano l’ipocondria in
modi assai diversi. Il DSM-5 raccoglie i pazienti ipocondriaci sotto la macrodiagnosi
del disturbo da sintomi somatici, che prevede la presenza impegnativa e continuava
di pensieri, sentimenti e comportamenti sproporzionati e persistenti. Ma il DSM-5
prevede anche la diagnosi di Disturbo da ansia e malattia, che consiste nella
preoccupazione di avere o contrarre una grave malattia, con sintomi somatici, se
presenti, di lieve intensità. Vale ricordare che un altro incallito frequentatore dei
medici è il dismorfofobico, che oggi viene definito affetto da Disturbo di dimorfismo
corporeo. È una persona preoccupata per difetti o imperfezioni fisiche “inesistenti”
che la portano a ritenersi brutta, non attraente o, addirittura, deforme. Secondo
alcune ricerche, associate al manifestarsi dell’ipocondria vi sono malattie gravi,
soprattutto nell’infanzia, ed esperienze precoci di malattie o morte di un familiare.
Con il paziente ipocondriaco è importante che il clinico capisca che tipo di “cultura
della malattia” la famiglia gli ha trasmesso. Un collega mi dice che vede l’ipocondria
di un suo paziente come un eccesso di difesa dalla paura delle relazioni. L’illusione di
un corpo come luogo nel quale l’imprevisto non possa giungere, rafforzerebbe il
controllo di quella pericolosa condizione che è l’essere in relazione con gli altri,
ovvero la dipendenza; un dispositivo diabolico: l’ipersensibilità del corpo che
anestetizza la mente relazionale. Potremmo considerare l’ipocondria una sorta di
rifugio psichico. L’ipocondria è un’idea di perdita dell’integrità, della salute e forse
della “perfezione originaria” del proprio corpo. Figlia di un’ideale dell’Io esigente e
inflessibile, l’ipocondria porta con sé un intreccio di aspetti narcisistici, ossessivi,
melanconici e depressivi. Anche per quanto riguarda il trattamento si naviga
nell’incertezza. Non sempre i pazienti ipocondriaci sono disposti ad accettare che
qualcuno dica loro che il problema è di natura più psicologica che organica e
continuano a peregrinare tra medici di base e specialisti. È raro riuscire a rassicurarli.
È benigno
Potrebbero piacerti anche
- Parole che curano: L'empatia come buona medicina. Storie di malati, familiari e curanti.Da EverandParole che curano: L'empatia come buona medicina. Storie di malati, familiari e curanti.Nessuna valutazione finora
- Quando il corpo dice no: Il costo dello stress invisibileDa EverandQuando il corpo dice no: Il costo dello stress invisibileValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Mutazione genetica ed evoluzione spirituale - Storia di un salto quantico: Malattia neurologica o psichiatrica? Faccia a faccia con la Corea di HuntingtonDa EverandMutazione genetica ed evoluzione spirituale - Storia di un salto quantico: Malattia neurologica o psichiatrica? Faccia a faccia con la Corea di HuntingtonNessuna valutazione finora
- Conoscere la medicina antroposofica: Comprendere le malattie per ritrovare l'equilibrio e le modalità di guarigione. Le basi scientifiche, le applicazioni terapeutiche e le prospettive della medicina antroposoficaDa EverandConoscere la medicina antroposofica: Comprendere le malattie per ritrovare l'equilibrio e le modalità di guarigione. Le basi scientifiche, le applicazioni terapeutiche e le prospettive della medicina antroposoficaNessuna valutazione finora
- Omeopatia scienza dell'individuo: manuale pratico per il medico e per il pazienteDa EverandOmeopatia scienza dell'individuo: manuale pratico per il medico e per il pazienteNessuna valutazione finora
- Il Cancro come espressione dell'Ombra: Dialogare con la propria parte oscura in un percorso di individuazione e integrazioneDa EverandIl Cancro come espressione dell'Ombra: Dialogare con la propria parte oscura in un percorso di individuazione e integrazioneNessuna valutazione finora
- Antropologia 1-2Documento7 pagineAntropologia 1-2pfq2c4k4k6Nessuna valutazione finora
- Nozione Di MalattiaDocumento8 pagineNozione Di MalattiaAgostino BurlaNessuna valutazione finora
- La Scienzah: L’attuale dittatura sanitaria si sostiene grazie alla costituzione di una nuova religione: la ScientocraziaDa EverandLa Scienzah: L’attuale dittatura sanitaria si sostiene grazie alla costituzione di una nuova religione: la ScientocraziaNessuna valutazione finora
- Tecnologia delle biofrequenze (La): radionica e tecniche vibrazionali: nuovi percorsi della medicinaDa EverandTecnologia delle biofrequenze (La): radionica e tecniche vibrazionali: nuovi percorsi della medicinaValutazione: 3.5 su 5 stelle3.5/5 (2)
- Diagnosi e DestinoDocumento5 pagineDiagnosi e DestinoAllegra BruschiNessuna valutazione finora
- La relazione medico-paziente: Manuale di ComunicAzione per i Professionisti della SaluteDa EverandLa relazione medico-paziente: Manuale di ComunicAzione per i Professionisti della SaluteNessuna valutazione finora
- Malattia di Creutzfeldt-Jakob. Un caso su un milioneDa EverandMalattia di Creutzfeldt-Jakob. Un caso su un milioneNessuna valutazione finora
- La vita un viaggio senza fine: La meditazione con le persone malate di tumoreDa EverandLa vita un viaggio senza fine: La meditazione con le persone malate di tumoreNessuna valutazione finora
- Una finestra nella tua casa. Cure palliative e conforto nella malattiaDa EverandUna finestra nella tua casa. Cure palliative e conforto nella malattiaNessuna valutazione finora
- Le parole del benEssere: Percorsi di cura e autocura tra emozioni, voci e relazioni umaneDa EverandLe parole del benEssere: Percorsi di cura e autocura tra emozioni, voci e relazioni umaneNessuna valutazione finora
- Riflessologia plantare: approccio alla sindrome fibromialgicaDa EverandRiflessologia plantare: approccio alla sindrome fibromialgicaNessuna valutazione finora
- Anatomia della Coscienza Quantica: La fisica dell'auto-guarigioneDa EverandAnatomia della Coscienza Quantica: La fisica dell'auto-guarigioneValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3)
- Malattia, Linguaggio Dell'animaDocumento7 pagineMalattia, Linguaggio Dell'animalollololloNessuna valutazione finora
- Malattia Linguaggio Dell'animaDocumento6 pagineMalattia Linguaggio Dell'animaDaniela Magnocavallo100% (1)
- La Psico-Oncologia - Dott - Ssa Francesca LupoDocumento6 pagineLa Psico-Oncologia - Dott - Ssa Francesca Lupodott.ssa Francesca Lupo100% (1)
- Il Papiro Ebers: Saggezza delle Medicina dell'Antico EgittoDa EverandIl Papiro Ebers: Saggezza delle Medicina dell'Antico EgittoNessuna valutazione finora
- La guarigione è dei pazienti: Con la mappa del dr. Hamer e l’ascolto profondo dei sintomi grazie al metodo ENIA®Da EverandLa guarigione è dei pazienti: Con la mappa del dr. Hamer e l’ascolto profondo dei sintomi grazie al metodo ENIA®Nessuna valutazione finora
- Guarire è facile, basta volerlo?: Amarsi nel fisico, nello spirito e nell'inconscio.Da EverandGuarire è facile, basta volerlo?: Amarsi nel fisico, nello spirito e nell'inconscio.Nessuna valutazione finora
- DASEIN. Rivista di Filosofia e Psicoterapia Esistenziale: Il Medico Filosofo e il Filosofo in MedicinaDa EverandDASEIN. Rivista di Filosofia e Psicoterapia Esistenziale: Il Medico Filosofo e il Filosofo in MedicinaNessuna valutazione finora
- Diario di un'ostetrica al contrario: Biografia di un’accompagnatrice nella morte e nel morireDa EverandDiario di un'ostetrica al contrario: Biografia di un’accompagnatrice nella morte e nel morireNessuna valutazione finora
- Come ho sconfitto l'ansia con l'aiuto della visualizzazione creativaDa EverandCome ho sconfitto l'ansia con l'aiuto della visualizzazione creativaNessuna valutazione finora
- Il medico dell'anima: Critica ragionata alla psichiatria contemporanea - Nuovi approcci ad ansia, depressione, panico, psicosi, fobie, stress da covid e disturbi di personalità per clinici e familiariDa EverandIl medico dell'anima: Critica ragionata alla psichiatria contemporanea - Nuovi approcci ad ansia, depressione, panico, psicosi, fobie, stress da covid e disturbi di personalità per clinici e familiariNessuna valutazione finora
- LaMandorla Settembre 2008Documento153 pagineLaMandorla Settembre 2008mikyrobyNessuna valutazione finora
- LA TOSSIEMIA - La causa primaria delle malattie - Riconquista la salute senza medicineDa EverandLA TOSSIEMIA - La causa primaria delle malattie - Riconquista la salute senza medicineNessuna valutazione finora
- Psicosofia: Un ponte tra psicologia e spiritualitàDa EverandPsicosofia: Un ponte tra psicologia e spiritualitàNessuna valutazione finora
- Philippe Pignarre - L'industria Della Depressione-Bollati Boringhieri (2010)Documento159 paginePhilippe Pignarre - L'industria Della Depressione-Bollati Boringhieri (2010)Werner HerzogNessuna valutazione finora
- Gabriella Mereu - La Terapia VerbaleDocumento68 pagineGabriella Mereu - La Terapia VerbaleSabrina GarreffaNessuna valutazione finora
- Pericolo di Morte! Block Notes di SopravvivenzaDa EverandPericolo di Morte! Block Notes di SopravvivenzaNessuna valutazione finora
- I QuadernsaascdDocumento617 pagineI Quadernsaascdiperico68Nessuna valutazione finora
- Lascia stare Dio e muori!: Il lamento di Giobbe al tempo della biotecnomedicinaDa EverandLascia stare Dio e muori!: Il lamento di Giobbe al tempo della biotecnomedicinaNessuna valutazione finora
- Szasz, Thomas - Schizofrenia Simbolo Sacro Della Psi Chi Atria (1976)Documento194 pagineSzasz, Thomas - Schizofrenia Simbolo Sacro Della Psi Chi Atria (1976)Pablo VelosoNessuna valutazione finora
- Numerologia medicale: Le origini delle malattie e la loro possibile risoluzioneDa EverandNumerologia medicale: Le origini delle malattie e la loro possibile risoluzioneNessuna valutazione finora