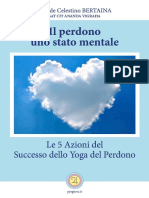Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Guarire Le Malattie Dell Anima
Caricato da
rosalbaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Guarire Le Malattie Dell Anima
Caricato da
rosalbaCopyright:
Formati disponibili
N U O V I E Q U I L I B R I
Thomas Schäfer
Guarire le malattie
dell’anima
con il metodo terapeutico delle Costellazioni Familiari
eBook acquistato da rosalba faraci
Thomas Schäfer
Guarire le malattie dell’anima
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Thomas Schäfer
Guarire
le malattie dell’anima
con il metodo terapeutico
delle Costellazioni Familiari
eBook acquistato da rosalba faraci
EDIZIONE ORIGINALE
Thomas Schäfer, Was die Seele krank macht und was sie heilt
© 1998, Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
EDIZIONE ITALIANA
Traduzione di Maria Teresa Pozzi
Supervisione della traduzione: Attilio Piazza
© 2006 Tecniche Nuove, via Eritrea, 21 - 20157 Milano
Redazione: tel. 0239090273, fax 0239090255
e-mail: libri@tecnichenuove.com
Vendite: tel. 0239090319-251-252, fax 0239090373
e-mail: vendite-libri@tecnichenuove.com
http: //www.tecnichenuove.com
ISBN 88-481 6856 4
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del libro può essere riprodotta o diffusa
con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il permesso dell’editore.
All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted, by any means, electronic, mechanical photocopying, re-
cording or otherwise without written permission from the publisher.
Copertina di JDT-Milano
Foto di copertina di Laila Pozzo
Stampa: Press Grafica, Gravellona Toce (VB)
Finito di stampare nel mese di aprile 2006
Printed in Italy
eBook acquistato da rosalba faraci
In dice
Abbreviazioni utilizzate per le opere di Bert Hellinger .................. pag. VIII
Lettera di Bert Hellinger ................................................................. pag. IX
Ringraziamenti ................................................................................ pag. XI
Prefazione all’edizione italiana ....................................................... pag. XIII
Prefazione ........................................................................................ pag. XV
Introduzione .................................................................................... pag. 1
Differenze rispetto ad altri approcci psicoterapeutici ...................... pag. 2
Cosa significa buona psicoterapia? .................................................. pag. 6
La durata ..................................................................................... pag. 6
Le rappresentazioni delle costellazioni familiari ............................ pag. 6
Soffrire è più facile che agire ........................................................... pag. 9
L’effetto dell’immagine risolutiva .................................................... pag. 10
Da cosa deriva l’effetto della rappresentazione? .............................. pag. 12
Il terapeuta può influenzare ciò che avviene
durante la rappresentazione? ...................................................... pag. 12
Come avere successo nelle relazioni di coppia .............................. pag. 15
Legame, ordine e compensazione .................................................... pag. 15
Il legame ...................................................................................... pag. 15
Gli ordini dell’amore ................................................................... pag. 19
La compensazione fra dare e prendere ....................................... pag. 20
Colpa e innocenza ............................................................................ pag. 22
La scappatoia ............................................................................... pag. 23
La compensazione nell’educazione ............................................ pag. 23
L’assunzione della colpa altrui .................................................... pag. 24
Il vendicatore .............................................................................. pag. 24
Spesso il bambino si assume la colpa in caso
di un matrimonio riparatore ...................................................... pag. 25
Il perdono è un modo sbagliato di gestire la colpa ..................... pag. 25
Destino e colpa ............................................................................ pag. 27
La coscienza ..................................................................................... pag. 28
eBook acquistato da rosalba faraci
La coscienza è al servizio di un ordine superiore ...................... pag. 30
I limiti della coscienza ................................................................ pag. 30
La coscienza collettiva ................................................................ pag. 30
Chi appartiene al gruppo? ........................................................... pag. 31
La compensazione negativa ........................................................ pag. 32
Come risolvere gli irretimenti del destino ................................. pag. 33
.
Genitori e figli .................................................................................. pag. 35
Aspetti fondamentali ........................................................................ pag. 35
Accettare i genitori .......................................................................... pag. 37
Quando i figli diventano genitori o partner dei genitori ................. pag. 43
Gestire la sfera privata dei genitori .................................................. pag. 45
Assistere i genitori anziani ............................................................... pag. 46
Aspetti particolari del rapporto fra genitori e figli .......................... pag. 48
Figli illegittimi - la precedenza della nuova famiglia ................. pag. 48
Figli di genitori divorziati ........................................................... pag. 48
Adozione ..................................................................................... pag. 50
Abuso sessuale ............................................................................ pag. 51
Principi educativi ........................................................................ pag. 55
Il movimento interrotto .............................................................. pag. 59
Uomini e donne ............................................................................... pag. 61
L’“uomo giusto” e la “donna giusta” ................................................ pag. 61
Cosa rende un uomo uomo e una donna donna? ............................ pag. 63
Anima e animus ............................................................................... pag. 65
L’uomo è al servizio del femminile
e la donna segue l’uomo .............................................................. pag. 67
La donna rispetta meno l’uomo di quanto
quest’ultimo rispetti la donna? ................................................... pag. 69
Parità ................................................................................................ pag. 71
Sessualità ......................................................................................... pag. 72
L’importanza del partner precedente ............................................... pag. 72
L’arte di separarsi bene ..................................................................... pag. 76
Rabbia nei confronti del partner ...................................................... pag. 77
Come influiscono i figli o l’assenza di figli
sul rapporto di coppia? ................................................................ pag. 78
Fecondazione assistita e sterilizzazione .......................................... pag. 80
Aborto ............................................................................................... pag. 81
Fedeltà e infedeltà ............................................................................ pag. 84
Dinamiche che fanno ammalare ..................................................... pag. 87
Meglio io di te .................................................................................. pag. 88
Ti seguo ............................................................................................ pag. 89
VI GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
La fede cristiana può essere talvolta nemica della vita? .................. pag. 89
La camicia del morto .................................................................. pag. 91
Espiazione della colpa personale ..................................................... pag. 92
Espiare una colpa altrui ................................................................... pag. 92
Infelicità come prezzo per la salvezza da un pericolo ..................... pag. 93
Vengo con te ..................................................................................... pag. 93
Morire al posto di qualcuno nel rapporto di coppia ........................ pag. 94
Come riconoscere gli irretimenti sistemici .................................... pag. 96
Malattie psicosomatiche e sintomi fisici ........................................ pag. 97
Introduzione .................................................................................... pag. 97
Tumore ............................................................................................. pag. 100
Dipendenza ...................................................................................... pag. 101
Dipendenza da alcol e stupefacenti ............................................. pag. 101
Bulimia ....................................................................................... pag. 102
Anoressia ..................................................................................... pag. 102
Obesità ........................................................................................ pag. 103
Depressione ...................................................................................... pag. 104
Psicosi .............................................................................................. pag. 105
Disturbi cardiaci .............................................................................. pag. 106
Nausea .............................................................................................. pag. 107
Mal di schiena .................................................................................. pag. 107
Mal di testa ed emicrania ................................................................. pag. 108
Neurodermite .................................................................................. pag. 108
Spiritualità e religione .................................................................... pag. 111
Il rapporto con la morte .................................................................. pag. 119
Appendice I - Il percorso di Bert Hellinger verso
le costellazioni familiari ............................................................ pag. 125
Appendice II - Le rappresentazioni
delle costellazioni familiari ........................................................ pag. 131
Bibliografia ...................................................................................... pag. 147
Pubblicazioni di e su Bert Hellinger ............................................... pag. 151
INDICE VII
eBook acquistato da rosalba faraci
Abbreviazioni utilizzate per le opere di Bert Hellinger
AWI: Anerkennen, was ist - Gespräche über Verstrickungen und Lö-
sung. Mit Gabriele ten Hövel, München, 1996 (Riconoscere ciò che
è: la forza rivelatrice delle costellazioni familiari, Milano, 2001).
FS: Familienstellen mit Kranken - Dokumentation eines Kurses für
Kranke, begleitende Psychotherapeuten und Ärzte, Heidelberg,
1995.
FWW: Finden was wirkt - Therapeutische Briefe, München, 1993.
MFL: Die Mitte fühlt sich leicht an - Vorträge und Geschichten, Mün-
chen, 1996 (Costellazioni familiari: aneddoti e brevi racconti, Mi-
lano, 2005).
OL: Ordnungen der Liebe - Ein Kursbuch, Heidelberg, 1994 (Ordini
dell’amore: manuale per la riuscita delle relazioni, Milano, 2003).
SBK: Schicksalsbindungen bei Krebs - Ein Buch für Betroffene, An-
gehörige und Therapeuten, Heidelberg, 1997.
VS: Verdichtetes - Sinnsprüche, kleine Geschichten, Sätze der Kraft,
Heidelberg, 1996.
ZG: Zweierlei Glück - Die Systemische Therapie Bert Hellinger. A cu-
ra di Gunthard Weber, Heidelberg, 1993 (I due volti dell’amore: co-
me far funzionare l’amore nei rapporti affettivi, Spigno Saturnia,
2002).
Una bibliografia più aggiornata è riportata nell’appendice.
eBook acquistato da rosalba faraci
Caro Thomas Schäfer,
ho letto con interesse e ammirazione il manoscritto del Suo
nuovo libro. Si è occupato approfonditamente degli ordini dell’amo-
re nelle relazioni umane e ha la dote non comune di presentare in
modo semplice relazioni estremamente complesse. La Sua esperien-
za personale Le ha permesso di sviluppare alcuni aspetti.
Il Suo è un libro bello e ricco e sono convinto che rappresente-
rà un prezioso aiuto per molti lettori e lettrici nella ricerca di solu-
zioni che consentono la riconciliazione.
Complimenti!
Suo
Bert Hellinger
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Ringraziamenti
U
n ringraziamento particolare a Bert Hellinger. Senza il suo in-
coraggiamento non avrei mai scritto questo libro. Mi ha mes-
so a disposizione materiale e ha sempre ascoltato con pazien-
za le mie domande.
Desidero inoltre ringraziare mia moglie Elisabeth, Werner
Baumgartl e Wolfgang Kasper per i suggerimenti e le critiche.
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Prefazione
all’edizione italiana
L’ autore ci introduce al mondo delle costellazioni familiari attra-
verso le sue esperienze dirette alla scuola di Bert Hellinger e
nella pratica professionale di tutti i giorni. Molti esempi, molti
casi, alcuni concetti fondamentali sull’amore, sugli ordini da rispettare
nelle famiglie o nelle relazioni, sull’essere psicoterapeuta oggi.
Si dispiega un mondo nuovo, quello dell’approccio sistemico
delle costellazioni, che incuriosisce, affascina, fa scattare meccanismi
di identificazione con l’una o con l’altra persona raccontata con vita-
lità e passione.
La realtà dei fatti assume il ruolo centrale nell’esperienza del-
l’autore e non vi è interpretazione psicologica delle cause di un ma-
lessere, vi è la mera profonda osservazione dei fatti della vita.
Che non è interessata ai nostri giudizi, alle nostre opinioni, alle
nostre ideologie. Che non si fa carico dei nostri sensi di colpa, di inade-
guatezza o delle nostre emozioni distruttive, dei rancori, della rabbia.
La vita si palesa con la sua ineluttabile semplicità scorrendo se-
condo dopo secondo, cambiandoci continuamente, portandoci in un
flusso che a volte seguiamo, a volte cerchiamo, invano, di contrastare.
Così è Bert Hellinger, il suo lavoro, i suoi allievi: un flusso di
grande energia che ha cambiato le prospettive del lavoro psicoterapeu-
tico, che ha fatto riflettere su un nuovo rapporto cliente-terapeuta.
Possiamo concordare per tutto o per nulla con ciò che leggiamo,
ma non possiamo sottrarci all’osservazione dei risultati immediati sul
cliente, su ciò che, magari dietro al paradosso, lo rende più forte e
grande dentro la vita.
Anna Zanardi
Centro Studi Hellinger
www.attiliopiazza.org
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Prefazione
B
ert Hellinger ha pubblicato numerosi libri, video e Cd sul me-
todo psicoterapeutico da lui sviluppato. Senz’ombra di dubbio
nessuno è più competente di Bert Hellinger per parlare di se
stesso. Per quale motivo viene dunque pubblicata un’altra opera sul
suo lavoro?
In qualità di terapeuta, mi sono reso conto che molti clienti e
semplici interessati hanno qualche difficoltà ad affrontare le opere di
Hellinger. Sono convinto che i suoi libri siano destinati principalmen-
te a medici, psicoterapeuti e addetti ai lavori in ambito psicosociale.
Molte pubblicazioni di Hellinger sono costituite da registrazioni di se-
minari non sempre di facile comprensione.
Nelle pagine che seguono ho inteso riassumere i pensieri di Bert
Hellinger riguardo a determinati argomenti, per renderli accessibili a
una cerchia più ampia di lettori. Può essere un bene che a scrivere sia
qualcuno che appartiene a un’altra generazione: potrei infatti essere
figlio di Bert Hellinger.
Questo libro non chiarisce solo il pensiero di Hellinger, ma ri-
porta anche esperienze personali con i miei clienti. Certamente sareb-
be auspicabile che i lettori si cimentassero successivamente con le
opere originali di Hellinger. L’incontro con i pensieri di Hellinger in
materia di famiglia, rapporto di coppia, matrimonio, malattia e mor-
te può colpirci profondamente e aiutarci nell’affrontare la vita. Io stes-
so ho fatto questa esperienza e conosco molte persone a cui è accadu-
to lo stesso.
Weinheim-Steinklingen, marzo 1997
eBook acquistato da rosalba faraci
Dalla stesura di questa prefazione sono passati alcuni anni. Con
mia grande sorpresa questo libro è diventato un bestseller. Da allora
sono stati pubblicati numerosi libri sulle costellazioni familiari. Io
stesso ho scritto altre quattro pubblicazioni sull’argomento. Cionono-
stante Guarire le malattie dell’anima resta il libro destinato a chi si
avvicina per la prima volta al lavoro di Bert Hellinger.
XVI GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Introduzione
C
olpa e innocenza, coscienza, ordine, irretimento, umiltà e ri-
spetto dei genitori - sono questi alcuni dei termini centrali
della psicoterapia sistemica di Bert Hellinger. Nella psicotera-
pia contemporanea sono concetti considerati ormai obsoleti e ad alcu-
ni appaiono addirittura equivoci e antiquati. Nessuna meraviglia dun-
que che vi siano posizioni così diverse riguardo a Bert Hellinger.
Per alcuni è colui che favorisce la rinascita di determinati valo-
ri. Viviamo in un mondo in cui tutto si relativizza molto rapidamen-
te. Nulla pare durare a lungo, anche se abbiamo bisogno di sicurezza
e affidabilità. E, d’un tratto, arriva qualcuno che fornisce un orienta-
mento e che riconosce il senso di tante tragedie e destini personali.
Capire i rapporti che consideriamo oltre la nostra comprensione: ciò
risveglia un grande desiderio di armonia con il proprio destino.
Per altri Hellinger è un ciarlatano conservatore e patriarcale, la
cui “dottrina” trova terreno fertile nelle menti disorientate. A tutto ciò
contribuisce anche il fatto che Hellinger è stato per molti anni missio-
nario in Africa. Dopo avere lasciato l’ordine, si è dedicato alla psicote-
rapia. Si tratta di “psicoterapia biblica” afferma il titolo dell’editoriale
della Rivista Psychologie heute [Psicologia oggi] (6/95). L’articolo par-
la inoltre di un “guru” che esercita la “magia bianca” quando, in un
gruppo numeroso, rappresenta la costellazione familiare di un cliente1.
1. La tecnica della rappresentazione delle costellazioni familiari viene spiega-
ta più avanti. La rappresentazione consente di individuare i legami esistenti
fra il cliente e i destini degli altri membri della sua famiglia e i comportamen-
ti che possono aiutare la sua anima.
eBook acquistato da rosalba faraci
Molti terapeuti, che adottano il metodo delle costellazioni fami-
liari o che tengono conto delle sue idee nella pratica quotidiana, e
molti di coloro che oggi parlano e scrivono di lui con simpatia, rico-
noscono di essere rimasti scioccati dal primo approccio con questo
particolare metodo. È accaduta la stessa cosa anche a me. Sono rima-
sto molto colpito da ciò che ho letto (“I due volti dell’amore”) e speri-
mentato poco tempo dopo in un seminario a Heidelberg. Dopo avere
rappresentato la mia costellazione familiare, non solo ho osservato
con maggiore chiarezza la storia della mia famiglia, ma ho anche
guardato i problemi dei miei clienti in una luce completamente nuo-
va e particolare. Un’unica cosa mi ha colpito e reso insicuro: il modo
in cui Hellinger affronta il tema dell’incesto. Col tempo, però, ho avu-
to modo di cambiare idea. Il punto di vista di Hellinger su questo ar-
gomento estremamente spinoso contraddice in effetti lo spirito del
tempo, ma, come dimostrato dalla mia esperienza, aiuta veramente le
vittime (vedi capitolo “Genitori e figli”).
Differenze rispetto ad altri approcci psicoterapeutici
Nella terapia familiare sistemica, come anche nella maggior parte dei
metodi adottati dalla psicoterapia umanistica (terapia gestaltica, psi-
coterapia del colloquio secondo Rogers, terapia primaria, bioenerge-
tica ecc.), la teoria del costruttivismo gioca un ruolo importante2. Non
esistono verità assolute, non vi è nulla che può essere riconosciuto
oggettivamente; i nostri sentimenti dipendono in larga misura dalle
nostre concezioni interiori. Molti approcci terapeutici partono dal
presupposto che il cliente possa raggiungere la maggior parte dei pro-
pri obiettivi grazie all’utilizzo di immagini e concezioni sensate. In
particolare la PNL (Programmazione neurolinguistica), dalla quale
ho tratto grandi benefici come terapeuta, si basa su concetti alquanto
semplicistici che considerano tutto “programmabile”: ricchezza, gua-
rigione da patologie, trovare il partner giusto ecc. L’idea che un’ade-
guata “mobilitazione delle risorse” (nel gergo della PNL) permetta di
realizzare la maggior parte dei propri desideri non si limita natural-
mente alla PNL. Il credo di tanti terapeuti, di cui facevo parte anch’io,
è il seguente: “Ogni uomo è completamente libero e ha la possibilità
di realizzarsi come meglio crede. A tale scopo basta sostituire le con-
2. Teorici come Heinz von Foerster, Bateson, Glaserfeld e successivamente il
biologo Maturana hanno spianato la strada al pensiero costruttivistico.
2 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
cezioni interiorizzate e limitanti con concezioni nuove”.
Più radicale è l’atteggiamento costruttivistico, più pressante di-
venta la questione etica: se ognuno è libero di fare o non fare ciò che
vuole, quali conseguenze si avranno nel tempo?
Hellinger sostiene invece che non siamo liberi come ci piacereb-
be credere. Se agiamo senza tenere conto degli irretimenti, non si
tratta di un’azione libera, ma di un’azione cieca. Agire liberamente è
possibile solo se apparteniamo a un sistema (famiglia). Esso è defini-
to da innumerevoli elementi ognuno dei quali si relaziona agli altri in
un modo ben preciso. Qualsiasi cambiamento di un elemento influi-
sce automaticamente anche sugli altri. Ogni uomo fa parte di un si-
stema familiare e quindi di un insieme di relazioni. In questo modo è
partecipe dei problemi degli altri membri della famiglia, consciamen-
te o inconsciamente.
Un esempio: Quando un marito abbandona la moglie e i figli con
la motivazione “Siete troppo noiosi! Me ne vado per potermi realizza-
re”, può essere convinto che il suo punto di vista sia giusto. Può ban-
dire dalla propria mente l’idea della moglie e dei figli che lo vincolano
giudicandola antiquata e limitante e sostituirla con un’idea di libertà
assoluta. Il legame dell’uomo con la famiglia continua però a esistere,
fatto che può essere constatato da un osservatore neutrale. Quando
qualcuno abbandona a cuor leggero la famiglia smettendo completa-
mente di occuparsene, non di rado accade che un bambino muoia di
una grave malattia, si suicidi o sviluppi patologie croniche. Inoltre
l’uomo avrà difficoltà a instaurare altri rapporti di coppia soddisfacen-
ti. Una separazione così sconsiderata viene vissuta dal sistema come
un crimine con le conseguenze che ne derivano.
Il credo dell’autorealizzazione sostenuto da molti terapeuti è sta-
to aspramente criticato da Hellinger per le conseguenze che produce
sugli altri. Cita come esempio le allocuzioni utilizzate nella terapia ge-
staltica di Fritz Perl, un rappresentante della psicologia umanistica. La
teoria è la seguente: “Io ho una cosa mia, tu hai una cosa tua. Ciò che
ti accade non è più affar mio. Io vado per la mia strada”. Hellinger ha
commentato così: “I legami vengono negati a spese degli altri. A mio
avviso i sostenitori dell’autorealizzazione sono psicocapitalisti della
peggior specie” (AWI: 129). Alla “costruzione della realtà”, sostenuta
da questa teoria, Hellinger contrappone la “percezione dell’ordine”.
Nel libro ci occuperemo spesso del significato del termine “or-
dine”. Diciamo fin da subito che non deve essere confuso con il co-
INTRODUZIONE 3
eBook acquistato da rosalba faraci
mune significato del termine.
A differenza degli altri orientamenti psicoterapeutici, Hellinger
non si occupa della motivazione teorica del proprio lavoro. Sottolinea
continuamente di non avere creato alcuna “dottrina” o teoria, ma di
operare con un approccio fenomenologico. Invece di occuparsi delle
idee e delle interpretazioni del cliente o di creare teorie, osserva ciò
che è. Hellinger sostiene che ciò che è non costituisce una verità og-
gettiva o una legge irrefutabile, ma una realtà viva; si tratta di qualco-
sa di creativo.
Hellinger differenzia anche l’osservare dal percepire. Le osserva-
zioni producono conoscenze parziali a scapito della visione globale.
Osservando il comportamento di una persona si notano solo alcuni
particolari. Se invece ci si apre alla percezione, i dettagli sfuggono, ma
si comprende l’essenziale, il nocciolo, al servizio dell’altro. Forse que-
sto concetto può essere chiarito con un esempio. Da bambino ero af-
fascinato dal capire cosa accade quando ci si concentra su un’unica lu-
ce. Cosa succede? Non la si vede! Solo quando ci si rilassa e si amplia
il proprio campo visivo, gli occhi la vedono chiaramente.
Il tipo di percezione descritta da Hellinger è possibile solo rivol-
gendosi al cliente senza uno scopo preciso, disponibili a instaurare un
rapporto. Solo così nasce un legame interiore caratterizzato dal mas-
simo rispetto, ma anche da una certa distanza. Osservando Bert Hel-
linger durante la rappresentazione di famiglie attuali e famiglie d’ori-
gine bisogna riconoscere che amore, rispetto, ma anche distanza so-
no costantemente presenti.
Quando Hellinger spiega determinate relazioni viene spesso
accusato di essere dogmatico. Se però lo si ascolta con attenzione, ci
si rende conto che il suo obiettivo non è stabilire regole ferree. Se
durante un seminario viene posta la domanda: “La dinamica di que-
sta malattia è sempre come l’ha descritta ora?”, risponde spesso:
“Non so se è sempre così, ma finora ho sempre riscontrato questa re-
lazione. Se Lei o io avremo nuove percezioni, bisognerà rifletterci
nuovamente”.
In passato Hellinger non è certamente stato estraneo alle teo-
rie, in quanto è diventato psicanalista dopo la sua attività di prete. Ciò
che gli è rimasto di quel periodo è l’attenzione per la famiglia. Tutta-
via ciò che guarda, cioè gli ordini in cui siamo inseriti, e come lo
guarda, differisce completamente dalla psicanalisi classica, che lavo-
4 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
ra molto con l’interpretazione dei sogni e le associazioni.
Quando Hellinger osserva la famiglia, si basa su una concezione
di base molto diversa da quella di tanti psicanalisti. L’uomo viene dal-
la famiglia. A lei deve la vita con tutte le possibilità e i limiti e da lei
viene irretito in determinati destini. Per questo Hellinger pensa che
non vi sia nulla di più forte della famiglia e il terapeuta non deve dun-
que diventare più importante di un membro della famiglia trasfor-
mandosi, ad esempio, in una madre o in un padre sostitutivi per il
cliente.
Hellinger si occupa della famiglia con profondo rispetto. In par-
ticolare rispetta i genitori. Essi hanno un ruolo talmente essenziale
che non si permetterebbe mai di mettersi contro di loro. Questo atteg-
giamento ci meraviglia, dal momento che siamo abituati a incolpare i
genitori per tutto ciò che di male ci accade. Durante la terapia il tera-
peuta si allea spesso con il cliente contro uno o entrambi i genitori.
Hellinger rifiuta l’idea diffusa “Devi liberarti dei tuoi genitori”. La giu-
dica assurda perché “Com’è possibile liberarsi dei propri genitori? Noi
siamo i nostri genitori” (AWI: 98). Io sono i miei genitori? Per alcuni
tutto ciò è Medioevo. Ciò che Hellinger intende veramente viene spie-
gato dettagliatamente nel capitolo “Genitori e figli”.
Hellinger non nega che per alcuni il legame con la famiglia pos-
sa causare grande sofferenza. Solo la conclusione differisce da quella
della maggior parte dei terapeuti. Invece di motivare il cliente a urla-
re la propria rabbia contro i genitori, cosa di cui si pentirebbe, lo ri-
mette in contatto con il rapporto originario genitori-figlio-amore, che
esisteva prima della rabbia3. Se il legame con la famiglia crea profon-
do dolore e fa ammalare qualcuno, ciò non avviene perché qualcuno è
arrabbiato, ma perché nella famiglia agiscono dei destini che ne in-
fluenzano tutti i membri.
Il lavoro di Hellinger vede la famiglia come un sistema da cui
non è possibile uscire. I nostri genitori hanno a loro volta dei genito-
ri e provengono da famiglie con determinati destini. Tutto ciò agisce
nella famiglia attuale. Se in passato è accaduto qualcosa di grave, le
conseguenze si ripercuotono sulle generazioni successive. Renderci
consapevoli di questi irretimenti inconsci e far tornare a scorrere
l’amore originario è l’obiettivo delle rappresentazioni delle costella-
zioni familiari di Bert Hellinger.
3. Vedi “Movimento di avvicinamento interrotto” al capitolo “Genitori e figli”.
INTRODUZIONE 5
eBook acquistato da rosalba faraci
Cosa significa buona psicoterapia?
Anche il contesto in cui opera Hellinger si differenzia dalla maggior
parte delle terapie classiche: le costellazioni familiari sono una tera-
pia di gruppo di breve durata. Generalmente Hellinger vede il cliente
una sola volta4. La psicanalisi al contrario è una terapia individuale
che si protrae spesso per anni. Hellinger attribuisce grande importan-
za al fattore durata della terapia. Il suo libro Verdichtetes [Ciò che si
concentra] riporta la seguente storia (VS: 73).
La durata
Un’impiegata dice al capo: “Mi sento male. Ho iniziato una psicotera-
pia e il terapeuta mi ha detto che durerà cinque anni”.
Il capo risponde: “Le ha detto che potrà sentirsi meglio fra cin-
que anni. Nessuna meraviglia se si sente male”.
Per Hellinger la psicoterapia è efficace quando lo psicoterapeu-
ta diventa presto superfluo.
Le rappresentazioni delle costellazioni familiari
Proprio come i sogni rispecchiano l’inconscio personale di chi sogna,
la rappresentazione della costellazione familiare rispecchia l’incon-
scio di un sistema familiare. Durante i seminari di gruppo di Bert
Hellinger i clienti, e spesso anche i terapeuti che li accompagnano,
siedono in cerchio. Bert Hellinger chiede a chi vuole rappresentare la
propria famiglia, quali sono i suoi obiettivi. Poi si decide se rappre-
sentare la famiglia di origine o la famiglia attuale. Il cliente si posizio-
na all’interno del cerchio e chiede a un partecipante di rappresentare
uno dei membri della sua famiglia. In questo modo vengono scelti dei
rappresentanti per il padre, la madre, fratelli e sorelle e per la perso-
na che vuole rappresentare la propria costellazione familiare. Il tera-
peuta deve prestare attenzione a non escludere membri della famiglia
malvisti o esclusi dopo la morte, come figli illegittimi, bambini nati
morti, malati mentali ricoverati o precedenti fidanzati/e. A tale scopo
il terapeuta necessita solo di poche informazioni. Le caratterizzazio-
ni come “mio padre è sempre stato dominante” sono inutili. È impor-
tante conoscere solo gli eventi importanti avvenuti all’interno del si-
stema, come ad esempio la morte di parto di una madre o un suicidio.
4. Alcuni clienti sono già in terapia e possono discutere la rappresentazione
della costellazione familiare con il proprio terapeuta.
6 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Dopo avere nominato e scelto tutti i membri della famiglia, il
cliente prende per un braccio i rappresentanti in un’atmosfera di rac-
coglimento e li dispone nello spazio secondo la sua immagine interio-
re. In questo modo i rappresentanti entrano in relazione. A questo
punto il cliente può tornare al proprio posto. Talvolta la disposizione
dei rappresentanti della costellazione familiare è già sufficiente a
comprenderne le dinamiche. Se ad esempio il padre e la madre vengo-
no disposti uno di fronte all’altro, spesso il cliente proviene da una fa-
miglia in cui i genitori hanno divorziato. A volte un matrimonio può
essere finito solo interiormente, senza arrivare a una separazione vi-
sibile all’esterno.
Dopo che tutti sono in relazione l’uno con l’altro, il terapeuta
chiede come si sentono fisicamente ed emotivamente e cosa provano
nei confronti degli altri membri della famiglia. Anche se i rappresen-
tanti non si conoscono è sempre sorprendente osservare quanto det-
tagliatamente siano in grado di rappresentare la storia della famiglia.
I rappresentanti si sentono proprio come i veri membri della famiglia.
Mi ricordo ad esempio di una rappresentazione a cui ho partecipato
come rappresentante in cui mi sono sentito come se mi avessero ta-
gliato entrambe le gambe. In effetti il paziente aveva subìto questa
mutilazione. Il rappresentante è in grado di percepire i disturbi fisici
attuali o passati dell’interessato, come ad esempio la gastrite cronica
o l’accelerazione del battito cardiaco. Si percepisce inoltre immedia-
tamente chi prova simpatia o antipatia per qualcun altro.
Durante un seminario, una cliente ha rappresentato il padre che
non vedeva da oltre due decenni. Il carattere messo in luce dalla rap-
presentazione era completamente diverso da quanto riportato dalla
madre. Poco dopo il seminario, la cliente si è decisa a fare visita al pa-
dre. Mi ha raccontato di essere rimasta molto sorpresa dal fatto che il
comportamento del padre corrispondesse a quanto emerso durante la
rappresentazione. Non solo espresse gli stessi concetti del suo rappre-
sentante, ma usò pressappoco le medesime parole!
Se durante una rappresentazione qualcuno viene dimenticato,
accade spesso che i rappresentanti fissino come ipnotizzati un posto
vuoto. Manca qualcuno! Non appena il posto della persona in questio-
ne, ad esempio un suicida dimenticato, viene occupato da un rappre-
sentante, tutti tirano un sospiro di sollievo.
Dopo che tutti i membri della famiglia o i loro rappresentanti
hanno detto come si sentono, il terapeuta cambia di posto alle perso-
INTRODUZIONE 7
eBook acquistato da rosalba faraci
ne fino a ottenere un ordine in cui tutti si sentono a proprio agio. La
ricerca della soluzione non aiuta solo il cliente, ma tutta la sua fami-
glia. Il terapeuta si orienta in base alla risonanza verbale e non verba-
le delle persone rappresentate: come reagisce il corpo? Cosa comuni-
cano la gestualità e la mimica? È sempre sorprendente osservare co-
me Hellinger riesca a interpretare velocemente i segnali del corpo.
Quando viene trovata la soluzione giusta, i volti si illuminano e tutti
assumono un atteggiamento rilassato.
Così, ad esempio, lo zio omosessuale disprezzato non continua a
dare le spalle alla famiglia, ma si posiziona in modo che tutti possano
vederlo. In questo modo non è più necessario che un nipote nato do-
po debba imitare il destino dello zio. Hellinger definisce “irretimento”
quest’accettazione inconscia del destino di chi è nato prima. Se le per-
sone escluse vengono rispettate, non è più necessario che altri si iden-
tifichino in loro, ma anzi diventano una benedizione. Se il cliente si è
già identificato con qualcuno, al termine della rappresentazione assu-
me il posto del suo precedente rappresentante e percepisce come si
sente nella famiglia. A seconda della situazione può dire allo zio mor-
to: “Ti onoro. Ti riservo un posto nel mio cuore. Ti prego benedicimi
anche se decido di restare”.
Alcuni hanno difficoltà a pronunciare queste frasi non solo con
le parole, ma anche con il cuore. Rendersene conto e salvaguardare la
serietà della situazione è compito del terapeuta. Se una frase del gene-
re non raggiunge correttamente il destinatario, accade spesso che il
rappresentante lo dica. E se il terapeuta si accorge che il cliente pren-
de tutto per gioco, interrompe immediatamente la rappresentazione.
Senza la serietà di tutti i partecipanti la rappresentazione deve essere
interrotta, perché in questo lavoro non è solo questione di salute e
malattia, ma spesso ne va letteralmente della vita o della morte delle
persone, come ad esempio nel caso di malati di tumore. Ciononostan-
te - o proprio per questo! - durante i seminari di Hellinger si ride mol-
to. La profonda serietà e la tensione spesso insostenibile vengono di
tanto in tanto scaricate. Bert Hellinger sa perfettamente come sdram-
matizzare l’atmosfera con una barzelletta fra una rappresentazione e
l’altra. È quasi come nei drammi di Shakespeare che alternano mo-
menti di serietà a momenti di ilarità.
Se durante una rappresentazione si riesce a trovare una soluzio-
ne, questa viene vissuta come un dono al di là di qualsiasi influsso te-
rapeutico - Hellinger parla in questo caso di “grazia”. Il terapeuta aiu-
8 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
ta semplicemente l’amore nascosto a manifestarsi. Ciò che il cliente
decide di fare a questo bivio non lo riguarda. La responsabilità ricade
totalmente sul cliente. In realtà il terapeuta non sa cos’è meglio per il
cliente.
Bert Hellinger si pone l’obiettivo di mettere in contatto il clien-
te con le forze risanatrici della sua famiglia. Non si tratta solo di tera-
pia, ma di mettersi al servizio della riconciliazione. In questo senso si
considera anche un padre spirituale. Terapeuta è chi pensa di avere in
pugno la situazione. La comprensione di Hellinger per il destino lo fa
sentire molto piccolo di fronte alle forze che agiscono all’interno del-
le famiglie. Considera un atto di arroganza “fare” e decidere.
Soffrire è più facile che agire
Per molti pazienti affetti da patologie mortali è difficile assumere l’at-
teggiamento interiore necessario e pronunciare le frasi risolutive sug-
gerite dal terapeuta. Hellinger sostiene che soffrire è più facile che
agire. Nella nostra anima vi è un pensiero magico che ha un’immagi-
ne ben precisa dell’amore: “Amore significa diventare” o “agire come
i nostri genitori”. Seguire il loro destino, ecco cos’è l’amore da bam-
bini. “Segretamente coltiviamo l’idea di poter salvare l’altro soffrendo
e morendo, di farlo sentire meglio anche se è morto”. È questo il pen-
siero magico, ma anche ingenuo, in quanto non impone di agire. Ci si
abbandona al destino e la salvezza viene dall’infelicità. La soluzione al
contrario richiede forza e azione: “Resto e sono certo che mi benedi-
rete anche se resto”. Rispetto al pensiero magico qui si tratta di
un’azione di fede nel senso più profondo: si rinuncia all’idea che il
proprio dolore abbia un potere liberatorio e ci si offre al mondo per ciò
che è, con i suoi limiti (FS: 81).
Se penso alla gioia che crea dolore, mi viene in mente una gio-
vane donna che si è rivolta a me per un colloquio. “Sono senza soldi
e non potrò tornare da lei un’altra volta”, mi salutò. Aveva tentato più
volte il suicidio e mentre ne parlava il volto le si illuminò. Guardan-
dola si poteva pensare che parlasse di una vincita al lotto o di un prin-
cipe azzurro entrato a far parte della sua vita. In realtà raccontava di
essere depressa e senza voglia di vivere, di essere reduce da dieci an-
ni di psicoterapia e ricoveri in cliniche a indirizzo psicosomatico e
che tutto la faceva “vomitare” - tuttavia era impossibile non notare
quanto fosse radiosa!
Le chiesi cosa sarebbe accaduto se l’indomani si fosse verificato
INTRODUZIONE 9
eBook acquistato da rosalba faraci
un miracolo e tutti i suoi problemi fossero svaniti. All’inizio i suoi oc-
chi divennero tristi. Ammutolì. Dopo un attimo di esitazione disse con
voce debole: “Dovrei rinunciare al prepensionamento e ritornare a la-
vorare. Probabilmente dovrei riflettere anche sull’argomento rappor-
ti di coppia”. Poi si arrabbiò terribilmente con me: “Sono tutte scioc-
chezze! Un tale miracolo è impossibile! Nemmeno lei riuscirà a fare
ciò che nessun medico e terapeuta è riuscito a ottenere in dieci anni!
Sarebbe proprio bella! Nessuno può aiutarmi, nessuno!” gridò. Appar-
ve chiaro che era venuta da me solo per vedere confermata la sua si-
tuazione disperata. Le persone che reagiscono come questa donna so-
no, come dice Hellinger, “irretite sistemicamente”. L’anima del bam-
bino che c’era in questa donna era felice di poter essere solidale con
un destino familiare infelice. Non so quali circostanze hanno determi-
nato tale situazione, dato che la donna non era pronta a parlare della
propria famiglia e non è più ritornata. Nonostante avessi ridotto sen-
sibilmente il mio onorario, le parve comunque troppo. Le sarebbe co-
stato certamente più del denaro… L’esperienza dimostra che le perso-
ne che appaiono orgogliose e raggianti mentre raccontano la propria
infelicità e il proprio dolore, sono inconsciamente solidali con un do-
lore all’interno della famiglia. Chi decide di essere felice deve dire ad-
dio all’anima del bambino che c’è in loro.
L’effetto dell’immagine risolutiva
L’immagine risolutiva individuata durante la rappresentazione della
costellazione familiare è efficace sulla famiglia anche se quest’ultima
né è all’oscuro. Un esempio a tale proposito:
“Una giovane donna è sopravvissuta a un tentativo di suicidio. La
rappresentazione della costellazione familiare ha dimostrato che, in re-
altà, era la madre a volersene andare e la figlia lo voleva fare al suo po-
sto. A sua volta la madre provava nostalgia per il padre suicida. Alla rap-
presentazione è stato aggiunto il padre morto, che è stato posizionato
di fianco alla madre. La soluzione è stata che la madre si appoggiasse
al proprio padre dicendo alla figlia con convinzione: “Io resto”. In que-
sto modo la figlia non era obbligata ad andarsene al posto della madre.
Il padre della cliente aveva accompagnato la figlia al seminario
ed era presente in sala. La madre era a casa in Germania mentre la rap-
presentazione si svolgeva in Svizzera, una domenica mattina. Quella
mattina mentre si svolgeva la rappresentazione la madre stava passeg-
giando su un ponte. Il ponte passava sopra il fiume in cui il padre si
10 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
era suicidato. Ogni volta che passava sul ponte si appoggiava al secon-
do pilastro nel punto in cui il fatto era accaduto e pregava per il padre.
Anche quella mattina voleva recitare la preghiera sul ponte. In quel
momento si sentì afferrare per le spalle e condurre dall’altra parte del
ponte. Qui provò una gioia intensa e inspiegabile. Rivolse lo sguardo
verso il fiume e improvvisamente pensò: ora posso seguire il flusso
della vita. In passato aveva spesso minacciato il suicidio. Improvvisa-
mente questo desiderio scomparve. Qualcosa era accaduto oltre la di-
stanza spaziale, senza che la madre sapesse nulla della rappresentazio-
ne” (AWI: 83/84).
Un altro esempio: durante una rappresentazione con i simboli è
venuto alla luce che un bambino di nove anni si identificava con il fra-
tello del padre. Lo zio si era suicidato assumendo del veleno e il bam-
bino ne voleva condividere il destino. Il padre mi raccontò che il bam-
bino era nervoso e iperattivo. Al tempo stesso stava sempre ai margi-
ni. Aveva molti problemi anche a scuola.
Il bambino non sapeva che lo zio si era suicidato. Il padre gliene
parlò brevemente dopo la rappresentazione. Il bambino si dimostrò
molto interessato e pose numerose domande. Soprattutto voleva ve-
dere una fotografia dello zio. Il padre ne trovò una e gliela mostrò. Il
bambino insistette per tenere la foto, che mise ben in mostra nella sua
camera. In seguito il padre mi raccontò che il figlio era diventato mol-
to più tranquillo ed equilibrato. Il terapeuta Albrecht Mahr ha eviden-
ziato l’importanza di non affidarsi all’unica immagine emersa duran-
te la rappresentazione, ma di farsi accompagnare da lei nella vita di
tutti i giorni. La rappresentazione della costellazione familiare non
cancella certo magicamente tutti i problemi. Si chiede al cliente di
adottare a ogni incontro con i membri della famiglia la prospettiva
che ha percepito come risanatrice. Anche le domande che sorgono al-
l’interno della famiglia possono essere chiarite al meglio se interior-
mente ci si posiziona al proprio posto.
Il termine “contatto” con la famiglia significa anche contatto in-
teriore, quando ad esempio si sta pensando a un membro della fami-
glia. Non bisogna dimenticare che generalmente il cliente ha portato
con sé per decenni un’immagine sbagliata della propria famiglia. L’in-
teriorizzazione dell’immagine risanatrice può richiedere anni. Da
questo punto di vista la psicoterapia sistemica non può certo essere
definita breve. Si tratta al contrario di una terapia a lungo termine di
cui il cliente è responsabile.
INTRODUZIONE 11
eBook acquistato da rosalba faraci
Da cosa deriva l’effetto della rappresentazione?
Spesso ci si chiede come nascano gli effetti delle rappresentazioni e
com’è possibile che persone estranee provino gli stessi sentimenti dei
membri della famiglia che rappresentano. La risposta di Hellinger è
pragmatica. Non gli interessano le teorie, lavora con ciò che funziona.
La famiglia è un sistema talmente potente che la sua rappresentazio-
ne nello spazio consente anche a altre persone di immedesimarsi nel-
la sua dinamica. Resta comunque la domanda: “Com’è possibile?”.
Durante il suo colloquio con il giornalista Gabriele ten Hövel, Hellin-
ger spiega:
“Esiste una profondità in cui tutto confluisce. Si trova al di là del
tempo. Immagino la vita come una piramide. Sulla cima si svolge ciò
che definiamo progresso. In basso, futuro e passato sono identici. Qui
esiste solo lo spazio, senza tempo. A volte vi sono situazioni in cui si
entra in contatto con questa profondità. Si riconoscono ad esempio gli
ordini, gli ordini nascosti e si può toccare qualcosa di più grande nel-
l’anima” (AWI: 82).
Il terapeuta può influenzare ciò che avviene
durante la rappresentazione?
Vi sono due domande che spesso ci tormentano: l’esperienza della rap-
presentazione dipende dalla personalità del terapeuta e quanto è “vera”?
In generale possiamo partire dal presupposto che una rappre-
sentazione non mostra la realtà, ma solo un frammento di realtà. Vie-
ne alla luce ciò di cui il cliente ha bisogno per poter agire. A Bert Hel-
linger non interessa tanto la verità superiore, di cui non sappiamo
nulla, ma la realtà, quindi ciò che agisce. Durante le rappresentazioni
le cose vengono prese come si presentano - con la massima serietà, co-
me se non esistesse nient’altro. Durante la rappresentazione successi-
va, la realtà può apparire leggermente diversa e anche in questo caso
viene presa seriamente, come se non esistesse nient’altro. Infatti la re-
altà non è statica, ma fluisce costantemente e può dunque essere per-
cepita solo momentaneamente. Chi crede di poter afferrare la realtà,
si deve rendere conto immediatamente che con il passare del tempo
essa è già cambiata.
La personalità del terapeuta influisce indubbiamente sull’espe-
rienza della rappresentazione. Durante un colloquio Bert Hellinger ha
detto che la cosa più importante che il terapeuta deve portare con sé
per svolgere il proprio lavoro è l’assenza di paura. Ci vuole coraggio
12 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
per guardare in faccia la realtà, anche quando ci mostra le cose più
spaventose. Se manca il coraggio, i rappresentanti si rendono conto
inconsciamente che il terapeuta non è abituato ad affrontare la realtà
e sono dunque limitati nella percezione. Sia in veste di rappresentan-
te che di osservatore, ho sperimentato che il gruppo solidarizza con il
punto nero del terapeuta, impedendo la percezione di determinate co-
se durante la rappresentazione. Me ne sono potuto rendere conto so-
lo mantenendo una certa distanza.
Per questo tipo di lavoro il terapeuta deve avere un altro requi-
sito: deve amare e rispettare i propri genitori. Altrimenti come può
aiutare i clienti a incontrare i genitori con amore e rispetto?
Nonostante i limiti del terapeuta, il risultato di una rappresenta-
zione non è mai arbitrario. Se il terapeuta ha paura, la realtà non si
mostra completamente, ma anche frammenti di essa stimolano il
cliente ad agire. A questo proposito desidero citare un esempio tratto
dalla mia esperienza come terapeuta individuale con i simboli5.
Un uomo è marito e padre. Prima aveva convissuto con la fidan-
zata, che aveva dato alla luce un bambino mentalmente disabile nato
da una relazione con un altro uomo. Il cliente continuava a fare brut-
ti sogni sul bambino, così ho deciso di rappresentarlo. Sui simboli
l’uomo disse di non provare nulla, ma non era aperto mentalmente.
Ciononostante venne alla luce un forte legame fra l’uomo e il bambi-
no. Quando rappresentavo il bambino sentivo dentro di me una voce
che gridava forte: “Ciao papà!”. L’uomo escluse completamente la pos-
sibilità che il figlio fosse suo. Non era nemmeno disposto a fornire
maggiori dettagli sulla paternità.
Un anno dopo, l’uomo prese parte a un gruppo organizzato da
una collega. Anche in questo caso il risultato fu lo stesso: il rappresen-
tante del figlio disse spontaneamente al rappresentante dell’uomo:
5. Dal momento che non posso sempre organizzare un gruppo, durante il mio
lavoro di terapeuta utilizzo anche i simboli. Per la rappresentazione della co-
stellazione familiare utilizzo fogli di carta colorati, che riportano delle frecce
che indicano la direzione dello sguardo e su cui il cliente si può posizionare.
Sia il cliente che il terapeuta si alternano sui fogli per percepire fisicamente
come si sente il componente della famiglia. Certamente questo tipo di rappre-
sentazione non ha la stessa intensità di quelle che utilizzano rappresentanti
scelti nel gruppo, ma consentono comunque di mettere ordine nel sistema fa-
miliare. L’unica condizione è abbandonare qualsiasi riserva. Con la dovuta se-
rietà è possibile raggiungere molto rapidamente una percezione fisica fedele
alla realtà.
INTRODUZIONE 13
eBook acquistato da rosalba faraci
“Ciao papà!”. La terapeuta non era a conoscenza che la precedente
rappresentazione aveva avuto lo stesso risultato. Ebbe un’intuizione e
ha scelse un rappresentante per il bambino. In questo caso sarebbe
stato utile un test di paternità, ma l’uomo rifiutò.
Durante una rappresentazione di una collega venne alla luce
che un uomo poteva avere un altro fratello. Nella realtà nulla dimo-
strava questa tesi. I genitori erano morti e non potevano dunque for-
nire alcun chiarimento. Alcuni mesi dopo la rappresentazione, la mo-
glie del cliente trovò il certificato di morte di un fratello in una sca-
tola in cantina.
Lo svolgimento concreto delle rappresentazioni delle costella-
zioni familiari viene documentato nell’appendice del libro.
14 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Come ave re
succ esso n elle
relaz ion i di co pp ia
Legame, ordine e compensazione
rapporti con le altre persone possono essere pieni di dolore o di
I gioia. Da una parte le relazioni favoriscono lo sviluppo perso-
nale, dall’altra mirano al raggiungimento di obiettivi che non
tengono conto dei nostri desideri. Spesso siamo coinvolti in legami
che non comprendiamo. La famiglia, dapprima la famiglia di origine
e poi la famiglia propria, è l’elemento che maggiormente influisce sul-
le relazioni. Hellinger sostiene che le condizioni che garantiscono il
successo delle relazioni sono già prestabilite: il legame, l’ordine e la
compensazione fra dare e prendere.
Il legame
La coscienza ci lega al gruppo di persone in cui siamo nati. Quest’af-
fermazione può di primo acchito, apparire sconcertante. Anche se non
percepiamo il legame che ci unisce agli altri membri della famiglia,
ciò non significa che non esista. Può sussistere un forte legame addi-
rittura con persone di cui non conosciamo l’esistenza.
Un esempio: durante una rappresentazione è stato affrontato il
caso di due sorelle morte in un campo di concentramento. Anche se i
successivi membri della famiglia non hanno mai saputo nulla della lo-
ro esistenza, sussisteva un intenso legame. Tutti guardavano i morti
come ipnotizzati, tutto il resto era irrilevante.
Il legame con gli altri membri della famiglia non deve dunque
essere necessariamente consapevole. Possiamo dire: “Non mi interes-
sa nulla di mia madre, non ho alcun rapporto affettivo con lei! L’uni-
eBook acquistato da rosalba faraci
co che ho sempre sentito vicino è mio padre”. La realtà durante la rap-
presentazione mostra però qualcos’altro. Il legame di un figlio con i
genitori è evidente anche se non li ha quasi conosciuti ed è cresciuto
altrove. La genitorialità biologica è sufficiente a creare un legame. Si
può obiettare chiedendosi: esiste qualcosa di più grande che donare la
vita a un altro essere?
I genitori sono uniti ai loro figli e viceversa. Soprattutto per il
bambino è importante rispettare il legame con i genitori, ma anche
questi ultimi ne devono essere consapevoli. Riporto un esempio estre-
mo: il rapporto con i clienti ha dimostrato che il problema non è sem-
pre quello che l’anima vorrebbe mettere all’ordine del giorno. Un uo-
mo venne nel mio studio per risolvere i propri problemi lavorativi.
Utilizzo spesso la rappresentazione con i simboli, già descritta in pre-
cedenza, anche per altri problemi. Gli chiesi di posizionare nel campo
se stesso e le sue possibilità lavorative. Risultò il seguente quadro:
M: Uomo
1: Possibilità lavorativa 1
2: Possibilità lavorativa 2
3: Possibilità lavorativa 3
L’intaglio nei simboli mostra la direzione dello sguardo
Inizialmente l’uomo si posizionò sul simbolo di se stesso. In que-
sta posizione si percepiva una grande tristezza e un colpo al cuore. Il
cuore si stringeva letteralmente. Lo comunicai all’uomo e dissi: “Stra-
no! Tutto questo non ha senso in una costellazione organizzativa. Qui
si tratta di qualcos’altro”. Tale supposizione era supportata da una par-
te dalla profonda tristezza e dal dolore al cuore e dall’altra dall’identi-
ca direzione dello sguardo di tutti i simboli! Mancava qualcosa!
Dopo che gli descrissi la sensazione di un colpo alla parte sini-
16 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
stra del petto, il cliente mi disse che si trattava effettivamente del cuo-
re, non sapeva però cosa fosse. Appariva visibilmente perplesso. Suc-
cessivamente posizionai un foglio con un punto di domanda rivolto
verso il gruppo.
Guardando il punto di domanda percepii di nuovo una grande
tristezza e per un secondo mi parve di vedere un bambino che voleva
andare verso di lui. Tuttavia non mi fidai della mia percezione e tac-
qui. Dopo un po’ l’uomo disse improvvisamente: “Il punto di doman-
da potrebbe essere mio figlio illegittimo”. Mi raccontò di avere gene-
rato un figlio 30 anni prima, ma di non averlo mai visto. Anche se la
sua coscienza aveva quasi dimenticato questo figlio, l’anima se ne ri-
cordava. Consigliai al cliente di rivolgersi a qualcuno che potesse aiu-
tarlo a rintracciare suo figlio. Dal punto di vista interiore era infatti
molto importante per entrambi mettersi in contatto. Soprattutto il
ragazzo aveva bisogno di conoscere suo padre per trovare la propria
identità.
Solo dopo avere affrontato questi argomenti fu possibile occu-
parsi della questione lavorativa. Questo esempio dimostra che, pur
non trattando problemi familiari, essi vengono ugualmente messi in
evidenza. Sono molto più importanti di qualsiasi altro problema che
ci assilla.
Comunque sia il gruppo (famiglia) in cui siamo nati, il legame
che ci unisce è forte. Il bambino percepisce questo legame come amo-
re e felicità, indipendentemente da come riesce a svilupparsi all’inter-
no del gruppo. Questo amore può essere definito amore primordiale o
amore primario.
COME AVERE SUCCESSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA 17
eBook acquistato da rosalba faraci
La nostra coscienza reagisce a tutto ciò che favorisce o minaccia
il legame. Abbiamo una buona coscienza quando il nostro comporta-
mento conferma l’appartenenza al gruppo. Al contrario la coscienza
diventa cattiva, quando il nostro comportamento ci allontana dal
gruppo.
In una famiglia mafiosa la coscienza reagisce in modo comple-
tamente diverso nei confronti di determinati avvenimenti e considera
giuste cose differenti rispetto a una famiglia di impiegati. Il bambino
non distingue fra bene e male. Per lui è buono tutto ciò che viene giu-
dicato tale dal gruppo di riferimento. Qualunque sia l’inclinazione del
pendolo della coscienza, lo scopo resta invariato, cioè garantire il le-
game con il gruppo di origine.
La coscienza non ha lo scopo di salvaguardare il legame con il
gruppo solo all’interno della famiglia. La coscienza che ci consente di
appartenere al gruppo cambia a seconda se parliamo di lavoro, della
squadra di calcio o della cerchia di amici. Tuttavia il legame più im-
portante per gli uomini è il legame con la famiglia. I legami con grup-
pi più allargati vengono dopo.
Il seguente esempio può dimostrare l’intensità del rapporto ge-
nitori-figli: spesso i bambini cercano di ostacolare i genitori che non
hanno più voglia di vivere e che tendono a uscire dalla famiglia. Que-
sto atteggiamento può essere espresso anche verbalmente. Durante
una rappresentazione con i simboli una cliente si posizionò esatta-
mente di fronte al padre. Quando si sistemò sul simbolo che la rappre-
sentava, disse: “Devo stabilizzare mio padre perché resti”. Il padre era
stanco di vivere. Durante la rappresentazione divenne evidente che
era attratto fortemente verso la madre (la nonna della cliente), morta
improvvisamente quando l’uomo aveva solo sei anni.
Quanto intensamente i bambini partecipino alla situazione dei
genitori è dimostrato anche da un altro esempio: un uomo sposato,
padre di due bambini, fu sorpreso di mostrare tendenze suicide a se-
guito di una rappresentazione con i simboli. Egli non si sentiva né
malato né stanco di vivere. Tuttavia durante la rappresentazione si ri-
volse verso numerosi membri della famiglia che si erano suicidati o
erano morti prematuramente. I figli erano dietro di lui e cercavano di
impedirgli di andarsene.
L’uomo mi raccontò che una mattina, dopo la rappresentazione,
volle andare a svegliare il figlio minore. Il bambino si svegliò mentre
lui stava entrando e disse: “Papà, non devi ancora morire. Papà, non
18 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
andartene”. Il cliente si rese conto di avere intenzioni suicide già da
molti anni, ma di non essersene mai voluto rendere conto.
L’amore che lega i figli ai genitori si spinge spesso all’estremo: un
padre punì il figlio per la sua presunzione. La notte successiva il ragaz-
zo s’impiccò. Il senso di colpa accompagnò l’uomo fin nella vecchiaia.
Parlando con un amico si ricordò che pochi giorni prima del suicidio
il bambino aveva assistito a una scena importante e aveva reagito. A ta-
vola la madre aveva raccontato di essere nuovamente incinta. Il bam-
bino aveva gridato fuori di sé: “Santo Cielo, ma non abbiamo spazio!”
Così il padre anziano comprese: il bambino si era sacrificato per evita-
re preoccupazioni ai genitori. Aveva lasciato il posto al nuovo fratello
(MFL: 82).
Gli ordini dell’amore
Solo nominare la parola “ordine” può suscitare brutti ricordi. Ci ri-
corda la sistemazione della nostra stanza, la disciplina a scuola o sul
luogo di lavoro, sottomissione, regole rigide. Nel campo dei numeri
l’ordine naturale garantisce che l’uno venga prima e non dopo il due
e così via. Se si infrange l’ordine, regna il caos. Anche all’interno dei
sistemi familiari vige un ordine dell’amore. Esso esiste e agisce anche
se non lo conosciamo. Di tale ordine fa parte la gerarchia - un’altra pa-
rola apparentemente “brutta”. Nella famiglia l’ordine si basa sul tem-
po, quindi sul fatto che qualcuno arrivi prima o dopo. In questo mo-
do i genitori hanno la precedenza sui figli. Se quest’ordine naturale
viene sovvertito, si crea, proprio come per i numeri e l’alfabeto, un
terribile disordine.
Nella vita quotidiana ci rendiamo continuamente conto dell’im-
portanza del prima e del dopo. Gli ultimi arrivati sono sempre riser-
vati. Coloro che fanno parte del gruppo da più tempo si infastidiscono
se essi pretendono subito gli stessi diritti.
L’ordine dell’amore richiede inoltre che un fratello illegittimo
morto tenuto nascosto o un fratello nato morto possano far parte
apertamente del gruppo. Un esempio: un giovane uomo di origine
araba era sempre malato e si sentiva male, ma nessun medico era in
grado di aiutarlo. Venne alla luce che un fratello era stato escluso dal
sistema familiare. Era nato con gravi disturbi psichici ed era morto al-
l’età di tre anni. Poi nacque il cliente a cui venne dato il suo nome e i
documenti del fratello morto. Si era sempre sentito più vecchio e in
effetti il suo aspetto lo confermava. Andò a scuola troppo presto e ot-
COME AVERE SUCCESSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA 19
eBook acquistato da rosalba faraci
tenne anche la patente prima dell’età prevista. La soluzione previde
che il fratello morto venisse accettato apertamente nel sistema e con-
siderato come un essere a sé stante, ben distinto dal cliente. Durante
la rappresentazione, quest’ultimo disse al fratello escluso: “Caro Mu-
stafa, tu sei mio fratello più grande. Hai un posto nel mio cuore. Ti
prego non arrabbiarti se sono vivo”. L’appartenenza al sistema fami-
liare spetta persino a un assassino; tuttavia vi sono delle eccezioni.
Un’altra violazione dell’ordine naturale sussiste, ad esempio,
quando la seconda moglie è gelosa dei figli nati da un legame prece-
dente. Per l’uomo questi bambini verranno sempre prima della nuova
moglie. Solo se la donna accetta il proprio posto, il matrimonio può
funzionare, non ha alcun diritto di essere gelosa.
Glli ordini dell’amore non possono essere modificati a piacere,
ma costituiscono un dato di fatto che viene alla luce durante le rap-
presentazioni delle costellazioni familiari. Anche i rappresentanti che
prendono parte per la prima volta a una rappresentazione e non han-
no mai letto una riga di ciò che scrive Hellinger, riescono a riprodur-
re chiaramente questi ordini dell’amore. Quando ci si inserisce nel-
l’ordine della propria famiglia, si prova una sensazione di sollievo. È
questo il significato profondo dell’espressione “E’ tutto in ordine”.
A differenza di genitori e figli, nel rapporto di coppia l’uomo e la
donna godono di pari diritti. L’ordine dell’amore prevede che il par-
tner precedente abbia la precedenza sul successivo. Se al partner pre-
cedente non viene attribuito il rispetto che merita, vi saranno riper-
cussioni sul successivo rapporto di coppia e sugli eventuali figli. Al
contrario per quanto riguarda i sistemi vale la seguente regola: il si-
stema successivo ha la precedenza sul precedente.
La compensazione fra dare e prendere
“Dare e prendere” - non ricorda il Monopoli o il capitalismo? Cos’ha a
che fare con i rapporti umani? Sappiamo che in alcune relazioni uno
dei partner “investe” più dell’altro e che ciò crea tensioni.
Alcune persone concentrate sull’autorealizzazione sono convin-
te che si debba “amare disinteressatamente e incondizionatamente”,
e che bisogna dare senza aspettarsi nulla in cambio. Partono inoltre
dal presupposto di poter amare chiunque come il partner o i genitori.
Queste concezioni non sono solo lontane dalla realtà, ma distruggo-
no qualsiasi forma di rapporto.
È proprio l’esigenza di compensazione fra dare e prendere che
20 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
permette lo scambio fra le persone. Se ad esempio una persona conti-
nua a dare, chi prende si sente in dovere di dare a sua volta qualcosa.
Se chi dà non accetta nulla in cambio, il rapporto è minacciato. Chi
impedisce all’altro di dare vuole essere più potente e alla lunga nessun
rapporto è in grado di sopportarlo. Il rapporto è diverso solo fra geni-
tori e figli, i genitori danno e i figli prendono. I figli possono compen-
sare il bilancio fra dare e prendere trasmettendo a loro volta quanto
hanno ricevuto.
In un buon rapporto di coppia non avviene solo una compensa-
zione fra dare e prendere, ma colui che prende restituisce spesso
qualcosa in più. Il primo a sua volta rilancia e permette così al rap-
porto o al matrimonio di crescere e prosperare. Più favorevole è il bi-
lancio fra dare e prendere, maggiore è la felicità. Tutto ciò ha però un
effetto temuto da alcuni: rende il rapporto più profondo.
Chi invece vuole essere “libero”, deve partecipare in modo limi-
tato allo scambio fra dare a prendere. Chi crede di non avere bisogno
di prendere, ma solo di dare, si ritiene migliore e si sente presto solo.
Un rapporto di coppia o un matrimonio non sono in grado di soppor-
tare a lungo un tale squilibrio. Si giunge a una rottura. L’esperienza
di una cliente lo dimostra.
Una donna era andata a convivere con il fidanzato che stava an-
cora completando gli studi. Lei aveva un buon lavoro e si assunse
quindi l’onere dell’affitto e dell’istruzione del ragazzo. Al termine de-
gli studi, mi raccontò arrabbiata, l’uomo aveva preso tutta la sua roba
quando lei era al lavoro e se n’era andato. Il rapporto era finito.
“Quell’ingrato!”, penseranno alcuni. In realtà l’uomo non aveva
potuto fare altro in quanto l’equilibrio fra dare e prendere era irrime-
diabilmente compromesso. Non vi era alcuna parità fra i partner. Una
soluzione avrebbe potuto essere che l’uomo avesse guadagnato i soldi
per l’affitto e i propri studi o avesse chiesto un prestito in banca.
Avrebbe anche potuto restituire alla compagna i soldi a studi conclu-
si o impegnarsi a farlo entro una certa data. In questo modo avrebbe
potuto riacquistare una posizione di parità. D’altro canto la donna
non avrebbe mai dovuto regalare i soldi all’uomo, per evitare di esse-
re superiore a lui.
Anche scambiando i sessi vale lo stesso principio, ciascun par-
tner deve guadagnarsi le proprie opportunità, come ad esempio
l’istruzione.
Se una donna abbiente sposa un uomo povero, il matrimonio
COME AVERE SUCCESSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA 21
eBook acquistato da rosalba faraci
poggerà generalmente su fondamenta instabili. La donna continuerà
a dare e l’uomo a prendere. Il coniuge che non riesce a compensare
ciò che ha ricevuto finisce per reagire con rabbia. Sorgono spesso
complicazioni anche quando un uomo anziano sposa una ragazza gio-
vane. Certamente non è possibile stabilire una regola per la differen-
za d’età, ma Hellinger ha formulato una teoria appropriata. Verifica se
un partner “ha già il futuro dietro di sé” mentre l’altro ce l’ha “anco-
ra davanti”. La giovane donna si vendicherà, ad esempio, contro l’uo-
mo anziano per essere costretta a rinunciare a qualcosa che avrebbe
potuto avere con un uomo più giovane, come ad esempio dei figli. Ta-
li processi sono spesso inconsci.
Nei rapporti di coppia, ma anche in altri ambiti, s’incontrano
sempre persone che danno con generosità. Questo atteggiamento vie-
ne spesso giudicato positivamente. Colui che aiuta spesso intende, ma
non dice: “Meglio se ti impegni tu al mio posto”. Questa mentalità è
diffusa soprattutto negli operatori in ambito psicosociale. Chi si rifiu-
ta di prendere vuole spesso mantenere la propria superiorità ed evita-
re qualsiasi obbligo. Interiormente si sente però vuoto e sbilanciato.
Nella vita vi sono sempre situazioni in cui chi prende non è in
grado di restituire, ad esempio quando è gravemente malato o disabi-
le. Ringraziare è l’unico modo per compensare. Se avviene con rispet-
to e amore, colui che dà si sente abbondantemente ricompensato.
Colpa e innocenza
Con il dare e il prendere iniziano le prime esperienze di colpa e inno-
cenza. Il sentimento di “ora sono in obbligo verso chi dà”, che nasce
in colui che prende, viene vissuto come una specie di colpa, che si ma-
nifesta sotto forma di malessere e stress. Tutti conosciamo questa sen-
sazione. Quando diamo, proviamo invece un senso di innocenza: ci
sentiamo leggeri e liberi da qualsiasi obbligo. La combinazione fra in-
nocenza come esigenza e colpa come obbligo favorisce lo scambio fra
le persone.
Nel dare e nel prendere esistono però anche una colpa cattiva e
un’innocenza cattiva, se ad esempio chi riceve diventa un carnefice e
chi prende una vittima. Entrambi devono soddisfare l’esigenza di
compensazione. La vittima ne sente l’esigenza e il carnefice si sente
obbligato. La vittima vuole danneggiare il carnefice e arrecargli un
danno. Solo dopo che entrambi, la vittima e il carnefice, hanno arre-
cato all’altro lo stesso danno e hanno sofferto e perso come l’altro, so-
22 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
no di nuovo alla pari. Pareggiare il danno non è sufficiente. Questo
concetto non corrisponde alla concezione cristiana del mondo. Il mis-
sionario Hellinger non predicava certo di “porgere l’altra guancia”.
Sono convinto che la riconciliazione sia possibile solo se l’inno-
cente si arrabbia e pretende la punizione del colpevole. Per consenti-
re alle relazioni di proseguire è però necessario che la vittima infligga
al carnefice un po’ meno di quanto lui ha sofferto, altrimenti il rap-
porto finisce. Il prossimo esempio dimostra quanto sia importante per
il matrimonio la compensazione nel male.
La scappatoia
Una donna rinfaccia da vent’anni al marito di essere andato in vacan-
za sei settimane con i genitori subito dopo le nozze lasciandola a ca-
sa, con la scusa che avevano bisogno di un autista. Tutti i tentativi del
marito di scusarsi non hanno sortito alcun effetto.
L’uomo ne ha parlato con un amico che gli ha suggerito: “La co-
sa migliore è dire a tua moglie di fare qualcosa che desidera e che co-
sti a te esattamente quanto è costato a lei allora”.
L’uomo si è illuminato in volto e ha capito di avere trovato la so-
luzione (ZG: 24/MFL: 26).
La compensazione nell’educazione
La compensazione nel bene e nel male non è importante solo nel ma-
trimonio e nel rapporto di coppia, ma anche in altri ambiti, come di-
mostra l’esempio seguente. Bert Hellinger visse in Sudafrica dove fu
parroco e rettore in una scuola. Il giovedì santo i ragazzi dissero che
avrebbero desiderato recarsi in città visto che era un giorno di vacan-
za. Hellinger diede loro il permesso, ma li pregò di essere di ritorno per
la messa per cantare nel coro. Gli alunni fecero ritorno solo a sera inol-
trata. Si rese dunque necessario riparare al torto inflitto al rettore.
La scuola si gestiva autonomamente e la sera i ragazzi furono
convocati. Innanzi tutto il rettore li lasciò seduti un quarto d’ora sen-
za dire nulla. Poi disse: “La disciplina è crollata. Sono certo che voglia-
te qualcosa da me e dalla scuola. Se decido di non darvelo più, cosa ac-
cade? Dovete riconquistarmi. Vi faccio dunque una proposta. Domani
mattina presto radunate tutti gli studenti e discutete su come ripristi-
nare la disciplina”.
Il mattino dopo gli alunni discussero per quattro ore e sottopo-
sero una proposta, che però non era sufficiente per la compensazione.
COME AVERE SUCCESSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA 23
eBook acquistato da rosalba faraci
Hellinger disse: “No, è ridicolo, cercate un’altra soluzione!”. Dopo al-
tre quattro ore di consultazione proposero: “Durante le vacanze dedi-
cheremo un giorno intero alla sistemazione del campo di calcio”. Fu
sufficiente, si trattava di una compensazione adeguata. Quando arrivò
il giorno previsto e i ragazzi ebbero lavorato mezza giornata sul cam-
po da calcio, ottennero la restante mezza giornata libera. Non vi furo-
no mai più problemi di disciplina a scuola (AWI: 55).
Incontrarsi a metà strada è importante dal punto di vista peda-
gogico. Se la madre è troppo coerente, perde l’amore. Deve cedere per
conservare intatto l’amore al di là dei principi. Tuttavia anche l’assen-
za di principi nuoce al bambino.
L’assunzione della colpa altrui
Accade abbastanza spesso che un membro della famiglia si assuma per
amore la colpa di un altro.
Il vendicatore
Un uomo di circa quarant’anni temeva di essere strangolato o di stran-
golare qualcuno anche se non vi era alcun segnale nel suo carattere o
nel suo comportamento che facesse pensare a un gesto del genere. In
famiglia si erano però verificati episodi di violenza. Uno zio, il fratello
della madre, era un assassino. Nella sua ditta lavorava un’impiegata,
che era anche la sua amante. Un giorno le mostrò la foto di un’altra
donna e le chiese di pettinarsi come lei. Dopo che la donna fu vista per
diverso tempo con quella pettinatura, i due andarono all’estero e lui
la uccise. Poi tornò in patria con la donna ritratta nella fotografia, che
divenne sua dipendente e amante. L’omicidio venne però scoperto e
l’uomo fu condannato all’ergastolo.
Lo psicoterapeuta del cliente voleva saperne di più sulla fami-
glia. Alcune ricerche svelarono che la nonna, la madre dell’assassino,
era stata una donna rispettata e pia. Durante il periodo nazista aveva
però accusato il marito di omosessualità facendolo richiudere in un
campo di concentramento dove fu ucciso.
Il vero assassino all’interno del sistema familiare era dunque la
nonna. Il figlio aveva assunto il ruolo di vendicatore del padre. Questo
esempio mostra qualcosa che Hellinger definisce “doppio spostamen-
to”. Il figlio aveva portato a termine la vendetta al posto del padre - si
tratta di uno spostamento sul soggetto. Invece di uccidere la madre,
aveva assassinato la donna amata - spostamento sull’oggetto. In que-
24 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
sto modo subì le conseguenze non solo del proprio gesto, ma anche di
quello della madre. I bambini nel loro amore primordiale vogliono as-
somigliare a entrambi i genitori: il gesto compiuto lo aveva reso simi-
le alla madre e la reclusione al padre (ZG: 149 e segg.).
Segue un altro esempio di quanto sia importante che il colpevo-
le affronti la propria colpa. Un uomo aveva strangolato la madre an-
ziana. La moglie dell’assassino chiese a Hellinger se poteva aiutare il
marito. Egli rispose affermativamente, ma aggiunse: “Solo rendendo
omaggio alla vittima”.
L’uomo scrisse una lettera chiedendo a Hellinger di eseguire una
perizia psichiatrica, al fine di dimostrare che al momento dell’omici-
dio era incapace di intendere e di volere. L’uomo guidava un’azienda
ed era psichicamente normale. Hellinger rifiutò di eseguire la perizia.
Ciononostante l’assassino venne giudicato incapace di intendere e di
volere dal tribunale e quindi prosciolto. In seguito uno dei due figli
adottivi dell’assassino ebbe un incidente mortale. Il bambino si era as-
sunto la colpa del padre.
Un giorno l’imprenditore si rivolse a Bert Hellinger. Quest’ulti-
mo gli disse: “Saresti dovuto andare in prigione”. L’uomo accusò Hel-
linger di essere troppo aggressivo. Hellinger non commentò e disse:
“Anche se ora sei libero, devi vivere come se fossi in prigione”. Suc-
cessivamente l’uomo ha creato una fondazione in memoria del figlio
morto. Si è però completamente dimenticato della madre. (Da un
confronto fra Bert Hellinger e Tilman Moser 1996.)
Spesso il bambino si assume la colpa in caso
di un matrimonio riparatore
Un esempio: un uomo e una donna generano un figlio e si arriva a un
matrimonio riparatore. Se l’unione è infelice, il bambino si assume la
colpa. Soffre per compensare l’infelicità dei genitori. A questi bambini
Hellinger dice: “Non sei una delle parti contraenti, i tuoi genitori lo
sono. Hanno compiuto l’atto sessuale con tutte le conseguenze che ne
derivano e tu accetti i genitori al prezzo che è loro costato”. Assume-
re un tale atteggiamento è molto più difficile che sentirsi colpevoli.
Il perdono è un modo sbagliato di gestire la colpa
Non solo il perdono ha spesso conseguenze nefaste, chiedere perdono
è anche peggio. Un uomo non ha il diritto di perdonare. Chiedendo
COME AVERE SUCCESSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA 25
eBook acquistato da rosalba faraci
perdono si trasferisce la responsabilità della colpa sull’altro.
Quando in passato mi è capitato di perdonare qualcuno mi sen-
tivo peggio. Ora capisco perché: con il mio “generoso perdono” ho tol-
to all’altro la possibilità di rapportarsi a me su un piano paritario. Lo
stesso accade nel caso di una confessione. Si spostano sull’altro le
conseguenze del proprio comportamento. Il perdono impedisce inol-
tre la parità nel rapporto, crea un dislivello dall’alto verso il basso. Di-
cendo “mi dispiace” invece di chiedere perdono, facilitiamo all’altro il
compito di avvicinarsi a noi.
Il perdono serve spesso a evitare un conflitto invece di risolver-
lo. Quando la vittima perdona il proprio carnefice si hanno sempre
conseguenze negative. La riconciliazione è possibile solo se la perso-
na innocente pretende risoluzione e pentimento, si tratta anzi di un
dovere imposto dall’ordine naturale. Al contrario il colpevole non ha
solo l’obbligo, ma anche il diritto, di subire le conseguenze del suo ge-
sto. Ha anche il diritto di confrontarsi con il rancore dell’altro. Si trat-
ta di pensieri alquanto inusuali. In molti libri che trattano l’argomen-
to “aiuti di vita pratici” leggiamo consigli che non hanno l’effetto de-
siderato. Riporto un esempio in proposito.
Un maestro spirituale consiglia in uno dei suoi libri: “Nella vita
dobbiamo imparare ad amare gli altri incondizionatamente. (…) non
dobbiamo sentirci feriti o provare rancore, dobbiamo solo amare. È
questo il potere dell’amore, come lo intendo io”.
Se qualcuno ci ha feriti profondamente, è assurdo fare finta di
niente. L’altro ha il diritto di confrontarsi con il proprio gesto e noi ab-
biamo altrettanto diritto di esprimere il nostro stato d’animo.
Recentemente è venuto da me un uomo che si sentiva molto ad-
dolorato per ciò che aveva fatto alla moglie. Durante il matrimonio
aveva avuto un’amante e lo aveva tenuto nascosto per molti anni. Du-
rante questo periodo l’amante faceva telefonate anonime alla moglie
per spaventarla. L’uomo non ne era al corrente. I due si separarono e
lui andò a vivere con l’amante. L’intimità che c’era prima svanì rapi-
damente. Hellinger sostiene che la felicità a spese di altri è destinata
a durare poco. L’uomo voleva tornare dalla moglie. Si incontravano
spesso e, con sua grande sorpresa, lei non era arrabbiata con lui: “Mi
disse: ‘Ti ho già perdonato tutto’” raccontò l’uomo. Con tutto ciò che
era successo, apparve una soluzione troppo frettolosa. Lo consigliai di
non accontentarsi. Se i due fossero tornati a vivere insieme e tutto fos-
se restato così com’era, lui si sarebbe sentito sempre piccolo nei con-
26 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
fronti della moglie. Non era uno scambio fra pari. Se invece, come già
spiegato nella storia “La scappatoia”, lui l’avesse pregata di chiedergli
qualcosa che gli fosse costato quasi quanto era costato a lei, la bilan-
cia sarebbe potuta tornare in equilibrio.
Tuttavia per salvaguardare il rapporto è bene che la persona in-
nocente non raggiunga il limite con la sua richiesta di compensazione
e che accetti veramente la risoluzione e il pentimento. Senza questo
impegno non vi è riconciliazione. Le crisi coniugali e di coppia dimo-
strano spesso che la riconciliazione non fallisce per colpa del colpevo-
le, ma dell’innocente. È arrabbiato e si sente superiore al colpevole.
Chi è innocente rifiuta spesso il colpevole, come se non ne avesse biso-
gno. Contro quest’innocenza il colpevole non ha alcuna possibilità!
Destino e colpa
Può accadere che determinate situazioni ci facciano sentire in colpa.
Un giovane tossicodipendente aveva perso la madre alla nascita. Ov-
viamente non aveva alcuna responsabilità nella sua morte ma si sen-
tiva in colpa ugualmente. La dinamica inconscia è la seguente: “Visto
che è stato così terribile per te, cara mamma, lo sarà anche per me.
Non posso stare bene”. Credere di poter pagare un dolore passato con
la propria sofferenza è una forma magica di amore.
Durante la rappresentazione la terapeuta propose al giovane di
dire alla madre: “Accetto la vita al prezzo che ti è costato e ne faccio
qualcosa di buono in tua memoria. Ti prego benedicimi, se resto”. Il
ragazzo ha smesso di drogarsi, ha terminato gli studi ed è riuscito a
instaurare un rapporto di coppia.
Un altro esempio fittizio. Nel motore di un elicottero si verifica
un’esplosione nonostante la regolare manutenzione. Quattro passeg-
geri muoiono, solo il pilota si salva. Nonostante non abbia alcuna col-
pa, egli metterà in relazione la propria sopravvivenza con la morte de-
gli altri. Si sentirebbe colpevole se riuscisse a continuare a vivere feli-
cemente: anche in questo caso vi è un’esigenza di compensazione. Chi
“riceve” dal destino, in questo caso chi sopravvive, è convinto di dover
“dare” la propria felicità. Al destino non importa assolutamente nulla
se crediamo di essere colpevoli.
Nei confronti della colpa o dell’innocenza fatale siamo impoten-
ti. Per questo ci risulta difficile affrontarle. In questo caso la soluzio-
ne sarebbe accettare un rapporto dettato da ciò che c’è di più grande
e quindi restare all’oscuro del senso. Tutto ciò ha a che fare con
COME AVERE SUCCESSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA 27
eBook acquistato da rosalba faraci
l’umiltà. Un concetto che è tutt’altro che popolare, che però viene uti-
lizzato spesso da Hellinger. L’umiltà consente di accettare la vita e la
felicità così come sono, indipendentemente dal prezzo che altri han-
no dovuto pagare. Se il mio destino è più difficile di quello degli altri,
l’umiltà mi permette di accettarlo. Non siamo noi a determinare il de-
stino, ma è il destino a influenzarci.
Un esempio riportato da Bert Hellinger può chiarire questo con-
cetto: un uomo ha preso parte a un seminario ed è rimasto immobile
per quasi tutto il tempo. La rappresentazione degli avi ha rivelato che
all’età di cinque anni ha sofferto di un tumore alla spalla e i medici si
aggiravano preoccupati intorno al suo letto. È come se fosse morto in
quel momento. In realtà è stato operato e fortunatamente il tumore si
è rivelato benigno. Ciononostante ha continuato a vivere con la sen-
sazione di essere morto. In questi casi è importante ringraziare per la
salvezza. Permette di accettare il dono della vita e di farne qualcosa di
buono. La dinamica è simile a quella che si innesca quando perdiamo
conoscenza mentre nuotiamo e stiamo per annegare.
La coscienza
Tutto ciò che facciamo nei confronti di altre persone è accompagnato
dal senso di colpa o di innocenza. La sensazione di giovare o nuocere
al rapporto proviene dalla coscienza. Assomiglia al senso dell’equili-
brio, che ci consente costantemente di non sbilanciarci. La coscienza
è superiore alla nostra volontà e reagisce istintivamente se ci allonta-
niamo troppo dal sentiero tracciato, mettendo in pericolo l’apparte-
nenza a un gruppo o il legame con una persona.
I presupposti per i rapporti umani sono il legame, la compensa-
zione e l’ordine. L’interazione di questi tre elementi costituisce la co-
scienza. Tali presupposti vengono rispettati al di là della nostra volon-
tà consapevole sotto forma di impulsi, bisogni e riflessi che coinvol-
gono anche la famiglia.
Sigmund Freud aveva una concezione completamente diversa
della coscienza. Pensava che fosse l’effetto del super-io sull’io; si trat-
ta di un’istanza nella personalità che crea una forte pressione a causa
delle aspettative talvolta eccessive. Al contrario per Hellinger la co-
scienza è un senso simile a quello dell’equilibrio, superiore al libero
arbitrio e al servizio della relazione.
Anche se le esigenze di unione, compensazione e ordine intera-
giscono al servizio del rapporto, ciascun livello viene vissuto con un
28 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
proprio senso di colpa o innocenza.
u Nel rapporto, l’innocenza determina una sensazione di appar-
tenenza al gruppo e la colpa un senso di esclusione. Il legame
di colpa viene vissuto come colpa grave.
u Nella compensazione fra dare e prendere, l’innocenza viene
vissuta come libertà dagli obblighi e leggerezza, la colpa co-
me obbligo.
u Nelle questioni di ordine, la colpa e l’innocenza vengono vis-
sute diversamente a seconda di ciò a cui si riferiscono (vedi
pag. 49). Se per ordine si intendono le regole vigenti, l’inno-
cenza viene percepita come fedeltà e coscienziosità, la colpa
come violazione e paura della punizione.
La coscienza è al servizio di ciascuno di questi obiettivi anche
quando sono in contraddizione. È così che nascono i conflitti di co-
scienza. Osserviamo un esempio in cui il bisogno di ordine si scontra
con il bisogno di legame e amore. Se un padre punisce il figlio ribelle
lasciandolo due ore in cantina a riordinare, soddisfa il bisogno di or-
dine, ma non quello di amore (legame). È quindi bene che raggiunga
il figlio prima e gli risparmi il resto del lavoro. Nell’esempio citato, le-
game e opposizione fra dare e prendere sono contrapposti. Se uno dei
partner fa qualcosa all’altro e riceve in cambio in uguale misura, il le-
game ne soffre. Colui che è stato danneggiato deve restituire un po’
meno rispetto a ciò che ha ricevuto. La compensazione non è totale,
ma l’amore viene salvaguardato.
Non si contraddicono solo il bisogno dei tre requisiti fondamen-
tali verso gli altri, ma anche i nostri rapporti con le altre persone pos-
sono soddisfare interessi diversi ed entrare in conflitto. Facendo qual-
cosa di buono per un rapporto possiamo danneggiarne un altro. Pos-
siamo sentirci allo stesso tempo colpevoli o innocenti.
Colpa e innocenza si presentano sempre insieme. Indipendente-
mente da ciò che facciamo per seguire la nostra coscienza, ci sentia-
mo colpevoli o innocenti. Chi costruisce la propria vita sull’innocen-
za non può crescere, in quanto colpa e innocenza perseguono lo stes-
so obiettivo ed è grazie alla loro interazione che le relazioni possono
crescere. Bert Hellinger paragona la colpa e l’innocenza ai cavalli at-
taccati a un unico carro. Colui che tiene le redini non è però il nostro
io con i suoi desideri, ma la coscienza.
COME AVERE SUCCESSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA 29
eBook acquistato da rosalba faraci
La coscienza è al servizio di un ordine superiore
A volte la coscienza viene vissuta come isolata. Generalmente assomi-
glia invece a un gruppo in cui obiettivi diversi vogliono essere realiz-
zati da persone diverse con sentimenti diversi di colpa e innocenza.
Può apparire conflittuale, ma questi processi di chiarimento sono al
servizio di un ordine superiore. Non possiamo uscire innocenti da tut-
to ciò. Colpa e innocenza possono anche essere scambiate facilmente
a seconda della prospettiva adottata in quel momento. Solo in un se-
condo tempo l’effetto dimostra chi era colpevole e chi innocente.
I limiti della coscienza
La coscienza non solo ci lega, ma ci limita. Per conservare il senso di
appartenenza lo neghiamo ad altri, solo perché sono diversi. Questo
comportamento, imposto dalla coscienza per conservare il legame
con il gruppo, può avere conseguenze nefaste. Le crociate del Medioe-
vo sono un esempio calzante, proprio come ai giorni nostri la guerra
nell’ex Jugoslavia. La storia dimostra come poniamo dei limiti al be-
ne, ma li aboliamo per il male in nome della coscienza.
Colpa e innocenza non devono dunque essere confuse con bene
e male. Le azioni più atroci vengono spesso compiute con la migliore
coscienza e le azioni migliori con una cattiva coscienza. Il bene, che
crea la pace e riconcilia, deve superare i limiti imposti dalla coscienza
per garantire il legame al gruppo. Ne deriva una legge nascosta e l’esi-
stenza del bene è riconoscibile solo dall’effetto.
La coscienza collettiva
Il gruppo da cui siamo nati è fatalmente e indissolubilmente legato a
noi. Ciò che altri membri del gruppo hanno subito o inflitto viene per-
cepito, generalmente inconsciamente, grazie a una particolare co-
scienza, la coscienza collettiva, come diritto o dovere. In questo mo-
do è possibile distinguere la coscienza personale, percepibile, dalla co-
scienza collettiva, generalmente inconscia. La coscienza personale
viene percepita direttamente come gioia e malessere, ad esempio
quando una moglie infedele guarda negli occhi il marito e mente. Al
contrario la coscienza collettiva non viene percepita.
La coscienza individuale si riferisce alle persone a noi diretta-
mente collegate, come il partner, i figli, i genitori, i fratelli e le sorel-
le, gli amici e può essere definita anche coscienza evidente. Viene per-
cepita immediatamente, ma deve sottostare alla coscienza collettiva.
30 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Spesso violiamo le regole della coscienza collettiva per seguire la co-
scienza personale.
La coscienza collettiva è una coscienza nascosta. Costituisce il
senso dell’ordine e dell’equilibrio per tutti i membri di un gruppo, pu-
nisce e compensa qualsiasi ingiustizia subita da un qualsiasi membro
anche se questi non sanno nulla l’uno dell’altro e sono innocenti.
Questa coscienza si prende cura degli esclusi finché anche loro non
trovano un posto nel nostro cuore. Se chi viene prima commette
un’ingiustizia, coloro che vengono dopo se ne fanno carico. In questo
modo vengono irretiti dalla coscienza collettiva in colpe o innocenze
altrui, in pensieri e sentimenti estranei. Tutti gli esclusi, i discono-
sciuti, i dimenticati e i morti in situazioni particolarmente gravi, so-
no legati a noi in questo modo.
Una donna, già ricoverata in un ospedale psichiatrico, mi rac-
contò di sentirsi di tanto in tanto “trascinata nell’abisso”. Nella sua fa-
miglia vi erano stati diversi suicidi. È evidente che i suicidi - anche se
sono accaduti molto tempo prima - influivano sulla famiglia. Tuttavia
nella psicoterapia sistemica di Bert Hellinger la rilevanza di tali avve-
nimenti supera le normali valutazioni psicologiche. Ricordare e ono-
rare i morti con amore può cambiare la vita dei malati psichici.
Chi appartiene al gruppo?
La coscienza collettiva concede a tutti il medesimo diritto di apparte-
nenza e percepisce quando un membro è stato escluso. Come la co-
scienza personale, ma in senso molto più ampio, vigila sul legame. Le
seguenti persone fanno parte del sistema familiare:
u il bambino con i suoi fratelli e le sue sorelle, anche quelli
morti o nati morti
u i genitori
u i fratelli e le sorelle dei genitori, anche quelli morti, nati mor-
ti o illegittimi, le sorellastre e i fratellastri
u i nonni
u a volte anche i bisnonni in caso di destino particolarmente
grave, come l’omicidio
u tutte le persone che hanno ceduto il posto alle persone cita-
te, come precedenti coniugi e compagni del cliente, dei suoi
genitori o nonni
u tutti coloro il cui allontanamento o infelicità ha permesso
COME AVERE SUCCESSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA 31
eBook acquistato da rosalba faraci
l’accesso di altre persone all’interno del gruppo o ha comun-
que rappresentato un beneficio.
Una donna sposata conosce un uomo e dice al marito: “Non vo-
glio più saperne di te. Ti lascio”. Poi la donna ha un figlio con il nuo-
vo compagno. Il bambino rappresenta il primo marito abbandonato.
Svilupperà nei confronti della madre gli stessi sentimenti negativi
provati dal marito abbandonato oppure si sottrarrà a lei così come la
madre ha lasciato il marito. Ciò accade anche se il bambino non sa
nulla del primo marito. Anche i genitori non si rendono generalmen-
te conto di tale correlazione.
La compensazione negativa
Chi nasce prima ha la precedenza su chi nasce dopo. Non è dunque
compito di chi nasce dopo espiare la colpa del suo predecessore o im-
porne il diritto a posteriori. Tuttavia ciò accade comunque. Se un
membro del gruppo si autodistrugge, vi sarà un membro successivo a
imitarlo quasi con sollievo. Hellinger direbbe che “onora” colui che è
nato prima e fornirebbe un esempio:
“Qualche tempo fa si è rivolto a me un avvocato. Era molto tur-
bato. A seguito di ricerche sulla propria famiglia aveva scoperto che
la bisnonna aveva conosciuto un altro uomo ed era rimase incinta.
Quest’uomo morì e nacque il sospetto che fosse stato ucciso. Aveva 27
anni e morì il 31 dicembre. Successivamente la donna non lasciò la
fattoria ereditata dall’uomo ai figli che questi aveva avuto dal primo
matrimonio, ma al figlio del secondo matrimonio. Fu una grande in-
giustizia.
Nel frattempo tre uomini della famiglia si sono suicidati a 27 an-
ni il 31 dicembre o il 27 gennaio, anniversario di matrimonio della bi-
snonna. Uno di loro impazzì il 31 dicembre e si impiccò il 27 genna-
io. Sua moglie era incinta, come allora la bisnonna. Quando il cliente
ci fece caso, si ricordò di avere un cugino di 27 anni e che il 31 dicem-
bre si stava avvicinando. Andò da lui. Il cugino aveva già comperato
una pistola per spararsi. È questo l’effetto degli irretimenti.
Poi il cliente ritornò da me. Vi era la concreta possibilità che si
suicidasse. Così iniziai a lavorare con lui e lo pregai di appoggiarsi con
la schiena contro il muro. Lo pregai di presentarsi all’uomo morto e
di dirgli: ‘Ti onoro. Hai un posto nel mio cuore. Chiamerò per nome
il torto che hai subito in modo che tutto possa andare al proprio po-
32 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
sto’. Così si sentì liberato” (da una trasmissione radiofonica con Bert
Hellinger nel S-2-Forum).
L’omicidio è sempre un’esperienza radicale all’interno del grup-
po. Nell’esempio precedente i suoi effetti sono ancora visibili a 130 an-
ni di distanza. Occorre aggiungere che Hellinger chiese al cliente di
dire alla bisnonna e al suo secondo marito (il bisnonno del cliente):
”Qualunque sia stata la vostra colpa, la lascio a voi. Io sono solo un
bambino”. Disse inoltre al cliente di immaginare di estrarre la testa da
un cappio, di arretrare lentamente e di lasciarlo penzolare. L’uomo si
sentì liberato dai propositi suicidi. Da quel momento il primo marito
della bisnonna è diventato un amico che lo protegge.
Come risolvere gli irretimenti del destino
L’esempio citato dimostra che le esigenze della coscienza collettiva
possono essere soddisfatte anche senza seguire ciecamente il destino
altrui ed espiare le colpe degli altri. Gli esclusi ricevono un posto e vie-
ne riconosciuta la loro importanza offrendo il nostro amore e onoran-
doli. La colpa resta a colui che l’ha causata. L’irretimento può essere
risolto solo con amore e umiltà.
COME AVERE SUCCESSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA 33
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Genito ri e figli
Aspetti fondamentali
I
l quarto comandamento ci esorta a onorare il padre e la madre.
Nella psicoterapia sistemica onorare e rispettare i genitori co-
stituisce un aspetto fondamentale. Ciò non è tuttavia sufficien-
te per definire l’approccio di Hellinger “psicoterapia biblica”. Talvolta
Hellinger assume posizioni estremamente critiche riguardo alla reli-
gione.
Il fatto che una persona rispetti o meno i propri genitori ha sem-
pre delle ripercussioni. Un esempio: un uomo gridava parolacce con-
tro la madre. Faceva male sentirlo. Era inoltre orgoglioso di non ave-
re alcun rapporto con la madre, che chiamava con un termine offen-
sivo, da più di vent’anni. Chi disprezza i propri genitori rifiuta anche
se stesso. Ognuno di noi infatti è il proprio padre e la propria madre
oltre a portare con sé qualcosa di personale, che ha però la possibilità
di fiorire solo se si accettano i genitori così come sono.
A chi disprezza pesantemente i propri genitori, manca qualcosa
di determinante. Si sente vuoto e non realizzato. Più rifiuta i genitori
e più si punisce inconsapevolmente. L’uomo in questione si sentiva
molto depresso ed è stato quasi ricoverato in un ospedale psichiatrico.
Secondo Bert Hellinger i depressi disprezzano spesso uno dei genito-
ri. Ho potuto verificare questa relazione di persona con molti clienti
depressi, anche se naturalmente la dinamica alla base del disturbo può
anche essere diversa. Hellinger ha formulato alcuni concetti fonda-
mentali relativi agli ordini naturali fra genitori e figli.
eBook acquistato da rosalba faraci
1. I genitori danno e i figli prendono. Questa frase appare semplice
ma nasconde moltissimo. Non si tratta infatti di un semplice dare e
prendere, ma di dare e prendere la vita. La vita che i genitori donano
ai figli è un bene che non appartiene a nessuno. I genitori danno al fi-
glio ciò che a loro volta hanno ricevuto dai loro genitori e ciò che co-
me coppia hanno preso e continuano a prendere dall’altro.
I figli prendono innanzitutto i genitori come tali, solo in un secondo
tempo ricevono cose materiali, come ad esempio l’eredità. Il movi-
mento nel rapporto genitori-figli non potrà mai essere compensato. I
figli possono a loro volta trasmettere ciò che hanno ricevuto ai propri
figli e ad altre persone.
I genitori si offrono ai figli così come sono e i figli possono accettarli
solo così. Un figlio non può né aggiungere né rifiutare nulla. In que-
sto modo i figli non solo hanno dei genitori, ma sono i propri genito-
ri. Che ci piaccia o no, i genitori sono l’origine della vita.
Un movimento minore si crea fra fratelli. Il primogenito dà al secon-
dogenito e quest’ultimo prende dal primo. Ciò è evidente, ad esempio,
quando i fratelli maggiori devono andare a prendere all’asilo i più pic-
coli o si assumono altre responsabilità che limitano il loro tempo libe-
ro. Così come i figli sono subordinati ai genitori, così i fratelli maggio-
ri hanno più diritti rispetto ai più piccoli. Se un fratello minore sovver-
te quest’ordine anteponendosi al maggiore, i litigi sono inevitabili.
2. Gli ordini dell’amore fra genitori e figli e fra fratelli prevedono an-
che che chi riceve apprezzi il dono ricevuto e sappia onorare chi lo ha
offerto. È possibile onorare chi ha donato solo senza condizioni e pre-
giudizi. Il bambino è in armonia con l’ordine naturale se accetta la vita
così come i genitori gliel’hanno donata, come un tutt’uno, e se accetta-
no i genitori così come sono. Bert Hellinger definisce questo modo di
accettare un dono “prendere con umiltà”. Queste semplici saggezze so-
no spesso sottintese nelle cosiddette “culture primitive”. Anche per noi
hanno rappresentato un patrimonio comune fino a poco tempo fa.
3. All’interno della famiglia esiste una gerarchia, definita dal prima
e dal dopo che, come il dare e il prendere, fluisce dall’alto verso il bas-
so. I genitori vengono dunque prima dei figli, e il primogenito ha la
precedenza sugli altri fratelli. Tutto ciò può apparire “poco democra-
tico”, ma se tale ordine all’interno della famiglia non viene rispettato,
si assiste a continue liti e incomprensioni.
36 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
Accettare i genitori
Accettare i genitori richiede innanzi tutto umiltà, umiltà di fronte al-
la grandezza del dono della vita. Onorare i genitori con umiltà signi-
fica anche accettare la vita e il destino così come ci vengono dati, non-
ché i limiti e le possibilità imposti dalla vita e gli irretimenti della fa-
miglia in cui siamo nati. In questo modo riconosco che la vita con i
suoi ordini dell’amore è più grande della mia persona.
Ci si può rendere conto dell’effetto di quanto descritto immagi-
nando di inginocchiarsi davanti ai genitori, di inchinarsi profonda-
mente allungando le braccia in avanti con le palme delle mani rivolte
verso l’alto e di dire: “Ti onoro”. Poi ci alziamo, guardiamo negli oc-
chi i genitori e li ringraziamo per il dono della vita. Il ringraziamento
riportato di seguito è stato scritto da Bert Hellinger. Scegliete la for-
ma che utilizzavate da bambini.
Ringraziamento per il giorno della nascita
Cara mamma,
prendo da te,
tutto,
così com’è,
con tutto ciò che è costato a te
e che costa a me.
Lo trasformo in qualcosa, per te
(e in tuo ricordo).
Non deve essere stato inutile.
Lo tengo stretto e lo rispetto,
e, se posso, lo passerò ad altri, come hai fatto tu.
Ti prendo come mia madre,
e tu poi avermi come figlio.
Sei la madre giusta per me,
e io sono il figlio giusto per te.
Tu sei grande, io sono piccolo/a.
Tu dai, io prendo - cara mamma.
GENITORI E FIGLI 37
eBook acquistato da rosalba faraci
Sono contento che tu abbia scelto il papà.
Siete i genitori giusti per me.
Solo voi!
Caro papà,
prendo anche da te,
tutto,
così com’è,
con tutto ciò che è costato a te
e che costa a me.
Lo trasformo in qualcosa, per te
(e in tuo ricordo).
Non deve essere stato inutile.
Lo tengo stretto e lo rispetto,
e, se posso, lo passerò ad altri, come hai fatto tu.
Ti prendo come mio padre,
e tu poi avermi come figlio.
Sei il padre giusto per me,
ed io sono il figlio giusto per te.
Tu sei grande, io sono piccolo/a.
Tu dai, io prendo - caro papà.
Sono contento che tu abbia scelto la mamma.
Siete i genitori giusti per me.
Solo voi!
Se detta con il cuore questa manifestazione di rispetto può ave-
re un effetto molto profondo. Durante un seminario di psicoterapia,
la terapeuta ha fatto leggere entrambi i testi a gruppi di due persone.
In presenza di un testimone l’esercizio viene preso più seriamente
che non da soli. È stato commovente osservare i processi profondi
che la lettura dei brani ha determinato. Pronunciando queste frasi in
modo consapevole è possibile intuire con quale genitore “c’è ancora
da lavorare”.
38 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
Ci si rende conto da soli se si è in armonia con quanto si sta leg-
gendo e se ne ha anche la conferma da parte del “testimone”. Se in de-
terminati punti del testo si hanno delle esitazioni, è opportuno appro-
fondire l’argomento.
Alcuni sono convinti che accettare incondizionatamente i pro-
pri genitori possa costituire una minaccia a causa di un aspetto pro-
blematico del carattere, di una colpa o di un ostacolo. Chi solleva obie-
zioni, perde l’occasione di accettare completamente i genitori.
Una presa di distanza del tipo “Non voglio diventare come mio
padre” ci porta irrimediabilmente a diventare come lui. Anche il ten-
tativo di diventare il contrario della persona rifiutata può essere in un
certo senso considerato come diventare come lei. Non è nostro com-
pito giudicare i genitori. Il risultato dell’incontro dei genitori, quindi
il bambino, non dipende dalla loro bontà o cattiveria e crea un legame
al di là della morale. Chi tratta i propri genitori come una drogheria
in cui si può scegliere cosa comprare, non ha la possibilità di svilup-
pare completamente ciò che gli appartiene per natura. Accettare con
obiezioni e riserve significa arrogarsi il diritto di giudicare e di porsi
sopra i genitori, e quindi non significa accettare. I genitori possono
essere accettati solo con umiltà.
Segue un esempio di ciò che definisco “mentalità da drogheria”
nel rapporto con i genitori. Un cliente, un accademico di successo, mi
disse: “Mio padre purtroppo è solo un contadino. È una persona piut-
tosto semplice. Mi sono sempre vergognato di lui. Mi sarebbe piaciu-
to che da bambino mi avesse stimolato di più mentalmente”.
Ecco un esempio di cosa può causare la differenziazione forzata
dai genitori. Una donna sulla quarantina raccontò di avere tentato per
molti anni di tenere le distanze dalla madre e di non diventare assolu-
tamente come lei. Ora si è resa conto con orrore di essere diventata
esattamente come lei. Quando finalmente ne ha preso coscienza ha
potuto riavvicinarsi alla madre. Chi accetta i genitori così come sono,
non prende i tratti problematici del loro carattere, ma gli aspetti po-
sitivi.
Una particolare forma di rifiuto è accampare delle pretese. Chi
accampa delle pretese si rifiuta di accettare e si sente grande. Se ac-
cettasse ciò che i genitori gli offrono, dovrebbe rinunciare alle proprie
pretese. Molti preferiscono mantenerle e fanno dunque fatica a sepa-
rarsi dai genitori. Se si crede presuntuosamente di dovere ancora ri-
cevere qualcosa dai genitori, si resta legati a loro senza però accettar-
GENITORI E FIGLI 39
eBook acquistato da rosalba faraci
li. Avanzare pretese nei confronti dei genitori viene purtroppo sugge-
rito spesso dai terapeuti, come ad esempio dalla famosa psicoanalista
Alice Miller1. Chi spreca tempo a immaginare come avrebbero potuto
essere migliori i genitori in passato o cosa avrebbero ancora potuto
dargli, perde l’opportunità di prendere l’essenziale.
Prendere possiede la straordinaria capacità di dividere. Chi pren-
de, dice anche: “Mi hai donato tanto, ed è sufficiente. Il resto lo faccio
da solo e ora vi lascio in pace”. Un tale atteggiamento rende indipen-
denti.
Prendere, come lo intende Bert Hellinger, è un’azione umile.
Per questo la distingue nettamente dall’accettare. Accettare è dignito-
so. Prendere significa invece approvare incondizionatamente qualco-
sa così com’è. Questo modo di prendere va al di là di qualsiasi mora-
le, del bene e del male.
Se qualcuno ha per madre una prostituta e nonostante ciò dice
dentro di sé: “Ti prendo come madre anche se sei una prostituta”, non
può più accettare la madre. Lo stesso vale se dice: “Hai commesso
molti errori educativi, ma ti prendo ugualmente come madre”. Accet-
tare la madre è possibile solo se il bambino dice alla madre con amo-
re: “Ti prendo, così come sei, come mia madre. Tu sei l’unica madre
giusta per me”. Finché prova dolore per la professione della madre, la
strada verso di lei resta sbarrata. Per poter accettare la madre deve su-
perare il dolore.
La psicoterapia vede spesso solo ciò che risulta evidente nel rap-
porto fra genitori e figli. Vi è spesso la tendenza a coltivare la rabbia
verso i genitori invece di guardare l’amore originario fra genitori e fi-
gli che vi si nasconde dietro. Spesso il motto è: “Grida la tua rabbia
contro tuo padre”. Al momento il cliente crede di togliersi un peso,
ma alla lunga si punirà per questo. Come già detto all’inizio, può di-
ventare rapidamente depresso. Se era già depresso prima della psico-
terapia e grida la sua rabbia contro i genitori, li allontanerà ulterior-
mente e il suo stato potrà peggiorare.
Durante la terapia accade spesso che il cliente dica: “Se solo i
miei genitori non mi avessero messo al mondo! Perché non ci hanno
pensato su di più? Adesso sono costretto a pagarne le conseguenze.
1. Alice Miller: Am Anfang war Erziehung [All’inizio c’era l’educazione], Fran-
kfurt 1980 e Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé. Riscrittu-
ra e continuazione, Bollati Boringhieri, 2002
40 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
Sarebbe meglio se non esistessi”. Queste parole mi appaiono come un
suicidio verbale, perché in questo modo rifiutiamo le possibilità che
ci sono state offerte.
Accettare i propri genitori ha un effetto benefico sul rapporto fra
genitori e figli. Un giovane uomo aveva accettato il padre durante una
seduta. Mesi dopo la moglie mi raccontò che gli incontri con i suoce-
ri non erano più carichi di tensione, ma si percepiva addirittura armo-
nia. I genitori trattavano il figlio in modo completamente diverso, an-
che se l’accettazione è avvenuta a loro insaputa. La maggior parte dei
genitori sarebbe colta di sorpresa nel sentire pronunciare queste fra-
si. Le rappresentazioni delle costellazioni familiari dimostrano però
che la loro anima le accetta. Tuttavia vi sono casi in cui è veramente
necessario dire qualcosa ai genitori.
Chi infligge un grave torto ai genitori o li disprezza profonda-
mente perde il diritto di godere del loro amore. Non può più andare
dal padre o dalla madre. In questi casi non resta che dire: “Mi dispia-
ce” o forse anche “Ti onoro”. Il profondo pentimento può essere di
grande aiuto. Riporto un esempio:
Venne da me un uomo tossicodipendente e sessodipendente. Dal
momento che teneva più o meno sotto controllo la tossicodipenden-
za, il suo obiettivo era risolvere il problema della dipendenza dal ses-
so. Mi raccontò come nella vita privata e lavorativa passasse da una ca-
tastrofe all’altra e fosse finito anche in tribunale. Tutto stava cadendo
a pezzi. Disse di voler iniziare una nuova vita. In passato era stato an-
che membro di un’organizzazione terroristica. Alle mie domande ri-
spose di non avere mai partecipato ad azioni omicide, ma solo a dan-
neggiamenti - e anche in questo caso non come esecutore materiale.
Nel periodo della sua attività terroristica non solo aveva disprez-
zato profondamente il padre, ma lo aveva trascinato pubblicamente
nel fango. Durante la rappresentazione entrò in contatto con il padre.
Percepì in tutto il corpo quanto lo avesse ferito. Chiesi al cliente di in-
chinarsi profondamente davanti al padre e di dirgli nella sua madre-
lingua asiatica2: “Mi dispiace tanto per tutto ciò che ti ho fatto”. Non
riuscì a pronunciare la frase, tuttavia dopo poco si mise a singhiozza-
re forte. “Non avevo mai pensato che le ferite che gli ho inflitto potes-
sero fargli così male. Non riesco proprio a esprimere quanto deve es-
2. L’uomo aveva abbandonato da molti anni il suo paese di origine in Asia per
trasferirsi in Germania.
GENITORI E FIGLI 41
eBook acquistato da rosalba faraci
sere stato terribile”. L’uomo si rotolò a terra per il dolore. Lo pregai di
guardare il padre negli occhi e di pronunciare la frase con forza. Dis-
se la frase, ma in tedesco.
Il terapeuta deve fare attenzione che le frasi più importanti ven-
gano pronunciate nella lingua madre del cliente. Quando lo dissi al-
l’uomo mi rispose: “In tedesco è molto più facile!”. Nella lingua madre
l’effetto emotivo è generalmente maggiore - fa più male. Nel mio lavo-
ro con gli stranieri ho notato che gli interessati scelgono preferibil-
mente il tedesco, che consente loro di mantenere una certa distanza.
Il cliente mi raccontò che anche il padre era sessodipendente. Il
figlio lo disprezzava per questo. Dietro l’odio e il disprezzo si nascon-
de il profondo legame con il padre. Rifiutando ossessivamente il pa-
dre, si diventa come lui. Se invece lo si accetta così com’è, non si è ob-
bligati ad assumere i suoi stessi comportamenti problematici. Quan-
do l’uomo disse al padre nella sua madrelingua: “Caro papà, sono esat-
tamente come te”, percepì chiaramente l’effetto risanatore di questa
frase. Qualche tempo dopo rividi il cliente. Mi disse che non avrebbe
mai creduto che la sua vita potesse cambiare in così poco tempo. Sen-
tiva una gioia di vivere completamente nuova e per la prima volta era
fiducioso di riuscire a risolvere i suoi problemi. Quando pensava al pa-
dre si sentiva profondamente colpito e pieno di vergogna. Dopo ven-
t’anni di lontananza si ripropose di trovare l’indirizzo del padre che vi-
veva all’estero. Sentiva il desiderio di manifestargli il proprio dispia-
cere, non solo interiormente, ma realmente. “Solo l’idea che legga
una mia lettera mi fa sentire bene” disse.
Gravi conseguenze sorgono anche se un figlio denuncia i geni-
tori o li cita in giudizio per costringerli a pagargli gli studi o per altre
pretese. Il figlio dovrà espiare quest’arroganza. Anche un bambino
abusato deve accettare i genitori così come sono per poter percorrere
in pace la propria strada. L’odio e la vendetta creano un legame forte,
coloro che invece amiamo ci rendono liberi. Anche i genitori possono
giocarsi il diritto all’amore dei figli, ad esempio sbarazzandosi di un fi-
glio con leggerezza.
Vi fu un caso in cui la madre di una giovane donna uccise il pa-
dre quando la figlia era ancora piccola. La rappresentazione mostrò
chiaramente che la madre aveva perso il diritto sulla figlia. In effetti
non vi era alcun contatto fra madre e figlia. Durante la rappresenta-
zione la figlia disse alla madre: “Ti congedo dal mio cuore con amore”.
42 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
Dopo che la donna finì in carcere, la bambina visse con la zia paterna.
Qui trovò un buon posto per vivere che non avrebbe trovato presso i
parenti della madre.
Quando i figli diventano genitori o partner dei genitori
Quando chi viene dopo vuole dare a chi viene prima, invece di pren-
dere, viene disturbato l’ordine del dare e del prendere all’interno del-
la famiglia. Se ad esempio in un matrimonio infelice la madre prende
dal figlio ciò che non riceve dal marito, il bambino subirà gravi con-
seguenze.
Un tale rovesciamento dell’ordine naturale fa diventare il bam-
bino “grande” e i genitori “piccoli”. Un bambino può sentirsi sicuro
solo se può alzare lo sguardo sui genitori e vederli forti. L’attaccamen-
to alla vita di questo tipo di bambino può essere caratterizzato anche
in età adulta da una forte insicurezza.
Se un bambino si trova a dover consolare i genitori, la sua ani-
ma ne pagherà le conseguenze. Un bambino è impotente davanti al ro-
vesciamento dell’ordine naturale. Si ritrova suo malgrado in una tale
situazione e ne deve sopportare le conseguenze. Questa posizione di
superiorità nei confronti dei genitori può tuttavia essere annullata
quando il bambino è cresciuto.
Il rovesciamento della situazione naturale si verifica spesso
quando un padre o una madre non hanno ricevuto qualcosa dai pro-
pri genitori e lo pretendono dai figli. Se, ad esempio, il padre rifiuta il
proprio padre, trasferisce questo sentimento sul figlio. Il bambino
non può più essere tale, ma deve diventare genitore.
Quando un bambino entra in confidenza con i genitori, che gli
rivelano aspetti intimi del loro rapporto, si autopunisce anche se non
ha nessuna colpa. Lo stesso vale anche per il rapporto fra nonni e ni-
poti. Ad esempio una cliente mi raccontò che la nonna le aveva rive-
lato, quando era bambina, dettagli intimi della vita del nonno, e già
adulta si sentiva ancora male per questo. Anche gli aborti non riguar-
dano coloro che vengono dopo. Un bambino abortito non fa general-
mente parte della cerchia dei fratelli, è una questione che riguarda so-
lo la coppia.
Se un bambino conosce troppe cose, può fare ciò che Hellinger
definisce “oblio spirituale”. Durante un seminario una donna raccon-
tò che la madre l’aveva resa partecipe del tradimento del padre e del
fatto che avrebbe abbandonato volentieri il marito portando con sé i
GENITORI E FIGLI 43
eBook acquistato da rosalba faraci
figli. La donna chiese a Hellinger se ciò non le avesse impedito di in-
chinarsi davanti ai genitori.
Hellinger rispose: “Il bambino non deve immischiarsi nelle que-
stioni dei genitori. La loro felicità o infelicità non è affar suo. I geni-
tori non devono renderlo partecipe. Se tua madre te lo ha detto, devi
dimenticarlo. E si può dimenticare”.
La donna: “Ah sì?”.
Hellinger: “È una questione di disciplina interiore. Ci si può
esercitare a dimenticare ritraendosi in se stessi. E a un tratto tutto
scompare. Lascia i tuoi genitori con il loro conflitto, guardali entram-
bi con amore e accetta da entrambi ciò che hanno da darti” (OL: 243).
Anche da adulti ci si può trovare di fronte a una tale situazione
nei confronti dei genitori. Quando questi ultimi raccontano ai figli co-
se che non li riguardano, il figlio può dire amorevolmente al genito-
re: “Ti prego non continuare a raccontarmi queste cose. Sono cose che
come figlio non devo sapere”. In questo modo il genitore torna a esse-
re grande e il figlio piccolo. È importante ricordare che l’adulto con-
tinua a sentirsi psichicamente bambino nei confronti dei genitori an-
ziani. Anche l’adulto resta figlio dei propri genitori. Sarebbe quindi
sbagliato dire: “Adesso che sono adulto, sono allo stesso livello dei
miei genitori”.
Oggi accade spesso che i genitori diventino compagni dei figli. Il
bambino ha la possibilità di conoscere molti amici e compagni. I ge-
nitori sono solo due. Non sono intercambiabili come i compagni di
gioco. Nel caso dei genitori single si instaura spesso una situazione
particolare. Quando ad esempio un figlio si trova nella posizione di so-
stituire il marito che manca alla madre, si punisce per questo, perché
è fedele anche al padre.
Le rappresentazioni delle costellazioni familiari dimostrano che
questi bambini fanno fatica ad abbandonare il ruolo che è stato loro
imposto. Un esempio: una giovane donna, diventata la confidente del-
la madre divorziata, percepì se stessa (durante una rappresentazione
con i simboli) “alta come un grattacielo” nei confronti della madre.
Sul foglio che rappresentava la madre, poteva percepire quest’ultima
che guardava in alto verso di lei. In una situazione del genere aiutano
l’oblio spirituale e frasi tipo “Cara mamma, ti prego, vedi in me tuo fi-
glio” e “Ti rispetto come madre, io sono solo un bambino”.
La cliente non pronunciò le frasi con la giusta convinzione. Nel-
44 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
le posizioni della madre e della figlia percepì chiaramente che la diffe-
renza di altezza non era cambiata. Solo pronunciando le frasi con
umiltà e amore si può assumere il ruolo che spetta a un bambino. Egli
rinuncia malvolentieri al grande potere che esercita.
Un altro esempio estremo: il cliente, un giovane uomo, aveva
portato via la compagna al padre che viveva da solo. Quando poco do-
po il rapporto finì, il ragazzo iniziò a soffrire di acne e di diverse fobie,
tra cui l’igiene compulsiva. Questo disturbo può essere considerato il
tentativo di lavare via la colpa e l’acne gli impediva di apparire attra-
ente agli occhi delle altre donne. In questo caso è utile affrontare la
colpa invece di evitarla.
Casi come questo nascondono però spesso una particolare dina-
mica. Il bambino porta via al genitore il nuovo partner perché è soli-
dale e fedele all’altro genitore. Visto così diventa innocentemente col-
pevole.
Gestire la sfera privata dei genitori
Ciò che i genitori hanno guadagnato o perso appartiene solo a loro e
non ha alcun rapporto con i figli. Può trattarsi di una scoperta scien-
tifica, un’onorificenza ufficiale, una colpa, un irretimento, una malat-
tia o una menomazione. I bambini vi partecipano solo parzialmente e
i genitori non possono e non devono darlo ai figli. Vale anche il con-
trario, i figli non possono prenderlo dai genitori. Le conseguenze di
tali aspetti personali fanno parte esclusivamente del destino dei geni-
tori e restano una loro responsabilità.
Se un bambino “attira” su di sé il bene e le esigenze personali del
padre e della madre senza avere vissuto un proprio destino e senza im-
pegno, pretende qualcosa senza averne pagato il prezzo.
Il dare e il prendere naturale all’interno della famiglia vengono
sovvertiti se chi viene dopo si fa carico di qualcosa di grave al posto di
chi viene prima, ad esempio quando un bambino prende su di sé una
malattia dei genitori. Chi viene prima non l’ha infatti ricevuta come do-
no da tramandare ai successori, ma fa parte del suo destino, è una sua
responsabilità e influisce anche sulla sua dignità. Se si apre a ciò che è
proprio e i figli glielo lasciano, si può sviluppare una forza positiva.
Della sfera privata dei genitori fa parte anche l’eredità che pos-
sono, ma non sono obbligati, a lasciare ai figli. Indipendentemente
dalle norme giuridiche che regolamentano questo aspetto, dal punto
di vista dell’ordine naturale ai figli non spetta alcuna eredità. Ciò si-
GENITORI E FIGLI 45
eBook acquistato da rosalba faraci
gnifica che non possono vantare alcuna pretesa. Chi riceve la promes-
sa di un’eredità da parte dei genitori, deve rallegrarsi e accettarla co-
me un dono. Sul tema dell’eredità Bert Hellinger ha scritto la seguen-
te lettera a una cliente:
“Le liti per questioni di eredità nascondono il fatto che nessuno
dei figli ne ha diritto. La soluzione per te sarebbe riconoscere di ave-
re ricevuto quanto basta e permettere ai tuoi genitori di gestire i loro
averi come desiderano.
Non è necessario che tu lo dica ai fratelli e alle sorelle che han-
no ricevuto di più, non è tuo compito quello di alleggerire la coscien-
za altrui se considerano il loro comportamento ingiusto e scorretto.
La tua anima resta libera e pura da entrambi i punti di vista. Inoltre
chi si preoccupa meno dell’eredità ha più energia da dedicare all’azio-
ne personale e spesso anche, comunque lo si voglia spiegare, una ma-
no più fortunata nella gestione o moltiplicazione di ciò che possiede”
(FWW: 106).
Durante un seminario Hellinger ha raccontato di un figlio che,
dopo avere ereditato tutto, voleva dividere il patrocinio con l’altro fra-
tello escluso dalla spartizione. Una delle partecipanti, Gloria, che era
stata esclusa dalla successione, insistette sull’argomento e voleva co-
noscere l’opinione di Hellinger.
Egli disse: “Non fa niente”. Gloria: “A me importa”. Hellinger:
“Devi dire: gli sta bene”.
Gloria: “Cosa ne faccio del rancore e della delusione? Il rancore
c’è”.
Hellinger: “Se vuoi puoi tenerlo stretto. Tuttavia se assisti con
tranquillità a ciò che accade ti renderai conto di avere ricevuto la par-
te migliore”.
Gloria: “Mi preoccupo soprattutto di come spiegarlo a mia fi-
glia”.
Hellinger: “Assolutamente no. Dille: Per me va bene così. Con
un bagaglio leggero si viaggia meglio” (OL: 306).
Assistere i genitori anziani
I genitori lasciano andare più facilmente i figli se questi promettono
di prendersi cura di loro in caso di bisogno e nella vecchiaia. Spesso
è il figlio minore a occuparsi dei genitori, in quanto non ha preso so-
lo da loro ma anche dai fratelli più grandi. Quando il figlio si occupa
46 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
dei genitori anziani dà e loro prendono. In questo modo si bilancia
leggermente lo squilibrio fra dare e prendere, anche se un figlio non
potrà mai restituire tutto ciò che ha ricevuto. Per molti figli è diffici-
le accettare l’idea di doversi occupare dei genitori anziani. Infatti
quando un adulto guarda i suoi genitori si sente come se avesse cin-
que o sei anni e anche i genitori lo vedono allo stesso modo. La solu-
zione è dire ai genitori: “Se avrete bisogno di me mi occuperò di voi
com’è giusto”.
Questa frase porta i figli al livello degli adulti, livello dal quale
possono rispettare i genitori come bambini e ciononostante fare ciò
che è giusto. Il bambino diventato adulto non può dedicarsi esclusiva-
mente ai genitori. Per questo i figli non possono sempre fare ciò che i
genitori pretendono da loro, ma generalmente è possibile fare ciò che
è “giusto”, cioè adeguato alla situazione concreta.
Nei secoli passati era sottinteso che i genitori anziani trovasse-
ro un posto nella famiglia. Nella società industriale del XX secolo vi
sono quasi solo famiglie piccole o incomplete. Spesso non vi è la pos-
sibilità di integrare i genitori nella famiglia esistente ed è quindi ne-
cessario cercare soluzioni alternative. Se i figli assicurano ai genitori
quanto detto all’inizio, sono liberi.
In questo contesto Hellinger ha raccontato la storia di una don-
na che avrebbe avuto la possibilità di prendere con sé la madre anzia-
na, ma si era rifiutata e la madre fu ricoverata in una casa di riposo.
Nel corso della stessa settimana una delle figlie di questa divenne ano-
ressica, si vestì di nero e si recò due volta la settimana a fare volonta-
riato in una casa di riposo. Nessuno comprese la relazione, nemmeno
la ragazza3. Questo esempio dimostra chiaramente che i figli si fanno
carico delle questioni lasciate in sospeso dai genitori.
Dell’anoressia mi sono occupato più dettagliatamente nel mio
libro Wenn Liebe allein den Kindern nicht hilft - Heilende Wege in
Bert Hellingers Psychotherapie [Quando l’amore non basta ai figli -
Percorsi curativi della psicoterapia di Bert Hellinger]. Il libro contie-
ne anche capitoli relativi a enuresi notturna, asma, allergie, balbuzie,
iperattività, problemi scolastici, paure e molto altro.
3. Bert Hellinger, Ordnung und Krankheit [Ordine e malattia], videocassetta,
Heidelberg 1994.
GENITORI E FIGLI 47
eBook acquistato da rosalba faraci
Aspetti particolari del rapporto fra genitori e figli
Figli illegittimi - la precedenza della nuova famiglia
Se un uomo genera un figlio con un’altra donna durante il matrimo-
nio, deve lasciare la moglie e trasferirsi dalla nuova compagna. Il nuo-
vo sistema ha sempre la precedenza sul precedente. Se l’uomo non lo
fa, tutte le persone coinvolte subiranno gravi conseguenze. Anche se
ha diversi figli dal primo matrimonio, deve andare con la nuova com-
pagna e con il figlio più piccolo. Resta comunque responsabile per gli
altri figli, ma un rapporto di coppia è possibile solo con la nuova com-
pagna. Per una moglie è un peso molto gravoso da sopportare, ma se-
condo l’esperienza di Bert Hellinger tutto il resto è molto peggio.
Se una donna concepisce un bambino con un altro uomo duran-
te il matrimonio, il figlio deve sempre stare con il padre naturale. Ge-
neralmente, in questi casi, il bambino è completamente al sicuro so-
lo con il padre. Questo fatto non può essere spiegato, ma tutto il resto
si dimostra essere peggio. Il male minore si rivela spesso una fortuna.
Ovviamente il matrimonio della donna è finito, anche se apparente-
mente continua a esistere. La possibilità di stare con l’altro uomo vie-
ne evidenziata dalla rappresentazione della costellazione familiare.
Durante un seminario un partecipante chiese l’opinione di Hel-
linger sul seguente caso: durante il matrimonio, una donna ha conce-
pì un figlio con un altro uomo. Il ragazzo ha oggi 26 anni e la sua esi-
stenza è stata taciuta alla famiglia. Bisogna rivelarla o no? Hellinger
rispose: “Sapere chi sono i nostri genitori fa parte dei diritti fonda-
mentali di ognuno di noi”.
Figli di genitori divorziati
Bert Hellinger ha scritto la seguente lettera a un uomo: “Il divorzio
determina lo scioglimento del rapporto di coppia, ma non del rappor-
to genitoriale. Se tua moglie chiede il divorzio, la cosa migliore è con-
cederlo. Salva almeno il rapporto con i figli” (FWW: 67).
L’ideale sarebbe che i genitori discutessero dopo il divorzio di
tutte le questioni riguardanti l’educazione dei figli. Il loro impegno di
genitori non cessa. La matrigna e il patrigno non hanno alcun diritto
di immischiarsi nell’educazione dei figli altrui.
Nella realtà il rapporto fra genitori divorziati non è dei migliori
e spesso si litiga addirittura per stabilire l’affidamento dei figli. Di nor-
ma i figli devono essere affidati al genitore che attraverso di loro ri-
48 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
spetta di più l’altro genitore. In base all’esperienza di Hellinger si trat-
ta spesso del padre, ma anche la madre può “guadagnarsi” l’affida-
mento dei figli rispettando in loro il marito. Durante un seminario è
stato chiesto cos’accade quando entrambi i genitori si rispettano in
egual misura. Hellinger rispose: “Se il rispetto è uguale non si arriva
al divorzio!”.
L’affermazione che spesso l’uomo rispetta di più la donna può
apparire insolita. Si tratta del più volte citato “nemico delle donne”,
del patriarca? Su questa domanda torneremo nel capitolo “Uomo e
donna”.
Particolarmente importante mi pare il suggerimento di Hellin-
ger che la decisione su chi debba crescere i figli spetta unicamente ai
genitori. Un bambino a cui viene chiesto con chi vuole stare, assume
una posizione troppo potente. Il divorzio, con tutte le conseguenze
che ne derivano è una questione che riguarda la coppia. Intrometter-
si non è un compito alla portata di un bambino.
Spesso l’autorità giudiziaria non tiene conto degli ordini del-
l’amore, altrimenti non permetterebbe che venga chiesto a un bambi-
no davanti a una corte con quale genitore vuole vivere. Dover sceglie-
re è un peso troppo gravoso per un bambino che ama entrambi i ge-
nitori. Indipendentemente da ciò che viene stabilito dal tribunale, il
bambino deve avere la certezza di poter conservare entrambi i genito-
ri. Oltre che in merito alle questioni relative all’affidamento, un bam-
bino non deve essere interpellato nemmeno sulla scelta di un nuovo
partner. Una giovane cliente si infuriò quando glielo feci notare: “In
qualità di figlia devo poter partecipare alla scelta di un nuovo compa-
gno di mia madre. Anch’io devo sopportarlo”. La madre si era effetti-
vamente lasciata consigliare e influenzare dalla figlia nella scelta del
partner. Dissi alla cliente: “Devi essere stata molto arrabbiata con tua
madre”. Ha confermato meravigliata. I figli si arrabbiano sempre
quando i genitori permettono loro di dominarli o li inducono a farlo,
perché vogliono dei genitori forti.
Un figlio deve accettare il partner scelto dal genitore separato,
ma non deve necessariamente amarlo. I processi descritti avvengono
a livello inconscio. A livello consapevole il figlio è molto lusingato
quando viene consultato per un consiglio e si compiace della propria
potenza, che però non gli compete in alcun modo.
GENITORI E FIGLI 49
eBook acquistato da rosalba faraci
Adozione
Le adozioni vengono considerate azioni altruistiche. In realtà sono
spesso azioni pericolose che richiedono un prezzo molto alto.
Se un bambino non può essere cresciuto dai suoi genitori, la
scelta dovrebbe ricadere sul parente più prossimo. Bisogna consulta-
re prima di tutto i nonni e poi gli zii e le zie. Con loro il bambino cre-
scerà bene e avrà la possibilità di ricongiungersi facilmente con i ge-
nitori, qualora la loro situazione dovesse cambiare. Se tale tentativo
fallisce, si può ricorrere a genitori affidatari o adottivi. In questo caso
sono veramente necessari e possono fare bene, ma in qualità di sosti-
tuti occupano comunque il secondo posto - indipendentemente da co-
me sono i genitori naturali. Il rispetto di tale ordine consente al bam-
bino di accettare e rispettare ciò che riceve dai genitori adottivi. Spes-
so i genitori adottivi si reputano migliori dei genitori naturali. In que-
sto caso il bambino solidarizza sempre con i genitori disprezzati e mo-
stra rabbia nei confronti di quelli adottivi. Quando un bambino viene
dichiarato adottabile, è spesso molto arrabbiato con i genitori. Se i ge-
nitori adottivi si sentono migliori, la rabbia del bambino si riversa su
di loro. Se invece si accontentano del secondo posto, la rabbia è indi-
rizzata verso i genitori naturali e si sviluppa un sentimento positivo
nei confronti dei genitori adottivi.
Le adozioni hanno successo se i genitori naturali vengono ri-
spettati fin da subito. È importante che la coppia disponibile all’ado-
zione chiarisca la situazione dei genitori naturali e dei loro parenti. A
tale scopo è bene non fidarsi esclusivamente delle informazioni forni-
te dalle autorità competenti.
Le adozioni portate a termine con leggerezza hanno sempre del-
le conseguenze. Se ad esempio si impedisce qualsiasi contatto fra il
bambino e i genitori naturali, da parte dei genitori adottivi viene spes-
so sacrificato il partner o un figlio per compensare il torto. È il prez-
zo da pagare. In caso di adozioni frettolose accade spesso che la madre
resti incinta e abortisca. È dunque necessario fare chiarezza sui moti-
vi che stanno alla base del desiderio di adottare un bambino.
Invece di adottare subito un bambino, può essere opportuno
pensare inizialmente all’affidamento, che è comunque qualcosa di
temporaneo. La paura dei genitori di poter perdere il bambino è infe-
riore in quanto se lo accudiscono bene resterà con loro.
Le rappresentazioni delle costellazioni familiari mostrano che
spesso i bambini adottati portano un peso nei confronti dei genitori
50 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
naturali, anche se non li conoscono nemmeno. Il posto più sicuro per
il bambino è in questo caso la famiglia adottiva. Bisogna inoltre tene-
re in considerazione che l’adozione ha un effetto simile all’aborto sul-
l’anima e non può semplicemente essere annullata.
Abuso sessuale
Le opinioni di Bert Hellinger su questo argomento contraddicono
completamente lo schema tradizionale di bene e male. Le sue opinio-
ni vengono spesso giudicate “scandalose” in quanto hanno la sfaccia-
taggine di porre l’accento sull’amore che ha condotto all’abuso e sul-
la funzione dell’abuso all’interno del sistema. Ovviamente l’incesto è
un atto di violenza e un abuso di potere, ma l’esperienza con le rap-
presentazioni delle costellazioni familiari dimostra che gioca un ruo-
lo anche l’amore disperato delle persone coinvolte.
Spesso l’incesto si verifica quanto in un rapporto di coppia sus-
siste uno sbilanciamento prolungato fra dare e prendere. Il seguente
esempio mostra una costellazione frequente: una donna separata por-
ta una figlia nel secondo matrimonio. Nella vita quotidiana al nuovo
marito viene richiesta una certa considerazione e collaborazione, an-
che se non si tratta di un figlio suo. Per questo dà alla donna più di
quanto riceve. Se poi la donna lo pretende a gran voce, l’equilibrio fra
dare e prendere viene disturbato ancora di più. Lentamente all’inter-
no della famiglia si crea un irresistibile bisogno di compensazione. La
bambina si trova dunque spesso in condizione di compensare il patri-
gno al posto della madre. In un secondo esempio, riferito dalla psico-
terapeuta Ilse Maly, la mancanza di equilibrio fra dare e prendere ha
costituito il fattore scatenante. Una cliente ha subito per sei anni in-
sieme alla sorella abusi sessuali da parte del padre. La donna aveva già
alle spalle numerose terapie e gruppi di autocoscienza senza però tro-
vare la liberazione interiore che cercava. Continuava a odiare il padre
e a idealizzare la madre.
La rappresentazione ha messo in evidenza che la madre aveva
perso il marito in guerra. Il secondo marito l’aveva sposata non tanto
per formare una famiglia propria, quanto per essere accudito. La vita
sessuale fra i coniugi era quasi inesistente poichè la donna era rima-
sta molto legata al primo marito. Inconsciamente aveva offerto la fi-
glia al marito come compensazione. Per amore verso i genitori en-
trambe le figlie avevano accettato.
Durante la rappresentazione, la cliente è riuscita a dire al padre:
GENITORI E FIGLI 51
eBook acquistato da rosalba faraci
“È stato molto difficile per me. Ora ti accetto come padre. Qualunque
cosa io abbia fatto, l’ho fatta per amore e quindi non ho alcuna colpa.
Lascio a te le conseguenze dell’abuso”4.
Le rappresentazioni dimostrano che l’anima della madre è con-
sapevole dell’abuso anche se lo tiene nascosto per anni. Spesso è uti-
le che un figlio abusato dica alla madre: “Cara mamma, per te lo fac-
cio volentieri”. In questo modo il bambino si rende conto della reale
dinamica. I figli sono talmente legati ai genitori da essere pronti ai più
grandi sacrifici pur di restare con loro e di sentirsi parte del sistema
familiare.
Si può arrivare all’incesto anche quando in un matrimonio la
moglie o il marito vogliono abbandonare la famiglia per seguire, ad
esempio, un fratello o una sorella morti. Dal momento che il deside-
rio di andarsene crea un senso di colpa, il figlio viene consegnato in-
consciamente all’altro come una specie di compensazione. La figlia
può ad esempio prendere il posto della madre, che - come nel citato
esempio - si rifiuta al marito e tende a uscire dal sistema. La rappre-
sentazione mostra un tacito accordo fra madre e figlia.
Anche se nei casi di incesto vi sono sempre due carnefici, uno in
primo e l’altro in secondo piano, la colpa ricade principalmente su chi
abusa direttamente del bambino. Senza riconoscere i propri irreti-
menti, il genitore sa esattamente cosa sta facendo.
Sarebbe opportuno che gli psicoterapeuti non guardassero allo
sdegno della società e alle norme giuridiche, ma solo a ciò che può aiu-
tare l’anima ferita del bambino. Visto lo spirito del tempo, ci vuole co-
raggio. Per i terapeuti è facile attaccare i carnefici, ma ciò ha gravi
conseguenze sulle vittime. I bambini prendono troppo volentieri la
colpa su di loro per amore verso i genitori. Se il carnefice viene puni-
to e - ancora peggio - è stato il bambino a fornire le prove, egli svilup-
perà un senso di lealtà ancora maggiore nei suoi confronti. La condan-
na del carnefice farà sentire il bambino colpevole, anche se non lo è.
A questo proposito un educatore mi ha raccontato che i bambi-
ni generalmente fanno di tutto per coprire il carnefice. Se si scopre
qualcosa, il bambino tende a essere solidale con la famiglia. Non è fa-
cile capire cos’accade ai bambini in questi casi.
La soluzione prevede che il bambino lasci la colpa ai genitori con
4. Intervista di Paula Elisabeth Mölk alla psicoterapeuta Ilse Maly pubblicata
sulla rivista “Die Tirolerin”, 1996.
52 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
amore. Durante la rappresentazione può dire al carnefice: “È stato ter-
ribile, lascio a te le conseguenze e ora faccio qualcosa di buono della
mia vita” e “Ora mi ritraggo da te”. Senza un tale atteggiamento, i rap-
porti con l’altro sesso saranno caratterizzati da liti, depressione, ten-
denze suicide, prostituzione e crimini.
Se l’incesto è un fatto recente e il terapeuta tratta direttamente
con gli interessati, può dire alla madre in presenza della figlia: “Danie-
la (o comunque si chiami la figlia) lo fa per la mamma”. La figlia dice
poi alla madre: “Per te lo faccio volentieri”. Generalmente l’incesto
cessa, perché ciò che era nascosto viene alla luce. Se l’uomo è presen-
te, viene chiesto alla figlia di dire: “Lo faccio per la mamma, come
compensazione”. Ora nessuno può più comportarsi come prima e la
figlia può tornare a sentirsi bene e innocente. Inoltre si può dire alla
figlia, raccontandole una storia adeguata, che la vita può continuare
bene anche dopo un’esperienza del genere.
Il fatto che l’incesto diventi di dominio pubblico non tabuizza so-
lo il “carnefice sullo sfondo”, ma anche il fatto che talvolta il bambino
vive l’abuso con desiderio. Generalmente il bambino non osa ammet-
terlo in quanto tutti gli dicono che è accaduto qualcosa di cattivo e di
grave. La sessualità viene demonizzata. È utile invece infondere al
bambino il coraggio di ammettere che vi sono stati anche dei momen-
ti belli, se sono stati effettivamente vissuti come tali. Il bambino ha bi-
sogno di essere rassicurato: “Anche se è stato bello, sei innocente”. Mo-
strarsi sdegnati e drammatizzare la situazione ha effetti peggiori.
Durante un seminario, una partecipante, che lavorava come psi-
coterapeuta con bambini vittime di abusi sessuali, ha raccontato che
i bambini che hanno vissuto l’abuso con desiderio, hanno spesso un
approccio “frivolo” con gli adulti. Ne è seguita una valanga di “non
può essere” e “è gravissimo” rivolti al bambino. Hellinger ha com-
mentato: “Se il bambino si rapporta in questo modo agli altri adulti è
come se dicesse ai genitori: ‘Sono una puttana e l’abuso è stata colpa
mia; non è necessario che abbiate una cattiva coscienza’. Il bambino
si comporta così per amore. Se parlo così al bambino, lui capisce di es-
sere stato buono anche in quel contesto. Bisogna sempre cercare
l’amore. Solo così si trova anche la soluzione” (OL: 280).
È importante che in età adulta il bambino abusato rispetti il suo
primo partner, quindi il genitore, in quanto la sessualità crea un lega-
me che va oltre il rapporto fra genitori e figli. Rinnegando il legame e
demonizzando i genitori non riuscirà a instaurare un rapporto di cop-
GENITORI E FIGLI 53
eBook acquistato da rosalba faraci
pia soddisfacente. I rapporti di coppia funzionano solo se il partner
precedente viene rispettato. Odiare e sminuire il genitore non fa altro
che rendere il legame più intenso. L’incontro con un potenziale par-
tner non avrà dunque alcuna possibilità di sviluppo.
Tuttavia il bambino, e qui si dimostra la complessità dell’argo-
mento, può essere arrabbiato con il proprio carnefice e addossargli la
colpa. Ci vuole molto coraggio, per questo Hellinger parla di “assu-
mersi la propria parte di responsabilità”. Il bambino può dire: “Mi hai
fatto un torto e lascio a te la colpa. Non spetta a me perdonarti”. Per-
donare significherebbe assumersi volontariamente la colpa del carne-
fice, che deve continuare a gravare su di lui. Tutto ciò può accadere
con calma e chiarezza - senza odio, propositi di vendetta e accuse. La
soluzione non viene dalla lotta, che non porta ad alcuna liberazione.
La lotta unisce sempre.
La maggior parte delle terapie adottate per trattare l’abuso ses-
suale è molto diversa da quanto presentato in queste pagine. Famosi
terapeuti della famiglia come Jay Haley e Cloé Madanes fanno ingi-
nocchiare il carnefice davanti alla vittima in modo che possa esprime-
re il proprio pentimento e le proprie scuse. La vittima può perdonar-
lo, se lo desidera. Anche gli altri membri della famiglia s’inginocchia-
no davanti alla vittima. Devono manifestare il proprio dolore e il pro-
prio pentimento per non avere fornito una protezione adeguata.
Durante il lavoro con il carnefice, Madanes discute con entrambi
i genitori sulle conseguenze future qualora egli si dimostrasse recidi-
vo. Insieme al carnefice mette a punto inoltre un programma detta-
gliato su come comportarsi qualora si presentassero nuovamente im-
pulsi sessuali sbagliati: andare al cinema, al ristorante, telefonare al te-
rapeuta, ecc.
Si può pensare ciò che si vuole, ma questa non è certo una tera-
pia che arriva alla radice del problema. Anche il fatto che tutti i mem-
bri della famiglia s’inchinino davanti alla vittima non ha un effetto po-
sitivo sulla sua anima - anche se la coscienza della vittima lo vive di-
versamente.
Madanes riporta un clamoroso successo della sua terapia: nel
96% dei casi il comportamento non è recidivo - nessuna ricaduta re-
gistrata (!!)5. Se si misura così il successo, si tratta certamente di una
5. Charlotte Wirl: Workshop mit Cloé Madanes: Sex, Love and Violence [Wor-
kshop con Cloé Madanes: Sesso, amore e violenza], in: M.E.G.a.Phon - Infor-
54 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
terapia efficace. Il “successo” può essere collegato però anche ad altre
domande: come si sviluppa successivamente la capacità di instaurare
rapporti di coppia? Come si sviluppa l’atteggiamento della vittima nel
tempo? Vi sono casi di depressione o abuso di stupefacenti? Come si
sviluppa il rapporto con i genitori e la famiglia? La vittima riesce a vi-
vere la sessualità con gioia? Non vi è alcuna statistica sull’efficacia del
lavoro di Hellinger sui casi di abuso sessuale o di grave patologia. Nel
suo lavoro con le persone gravemente malate, Hellinger parte dal pre-
supposto che l’effetto delle rappresentazioni durante la terapia sia po-
sitivo quando un cliente appare raggiante o sollevato. Ciò gli basta, il
resto è compito del cliente. Una verifica scientifica del lavoro con le
costellazioni familiari è a suo avviso impossibile, in quanto il cliente
è esposto a numerosi altri influssi, come il trattamento del medico,
l’incontro con amici o assistenti sociali. Chi o cosa agisce e qual è la
percentuale di successo nel tempo? Si tratta di un’argomentazione
talmente vasta da poter essere applicata a qualsiasi terapia.
Principi educativi
Chi non conosce quelle scene in cui i figli esasperano i genitori? Un
bambino sporca di tè tutto il soggiorno e continua a tirare i capelli al-
la madre.
“Christian, se non la smetti, vedi!”, grida la madre.
Il bambino sta zitto mezzo minuto, poi ride e ricomincia il gio-
chino.
“Christian! Per favore! Te l’ho già detto!”.
Il bambino sta calmo mezzo minuto e ricomincia a far arrabbia-
re la mamma.
“Quante volte ti devo dire che mi stai facendo arrabbiare!”. La
voce della madre diventa stridula, è vicina alle lacrime. “Se non la
smetti mi uccidi. Ti prego!”.
Le implorazioni della madre non sembrano toccare il figlio, che,
al contrario, si comporta sempre peggio e continua a punzecchiarla.
Perché i bambini sono così “crudeli”? In qualità di osservatore silen-
zioso, qualcosa in me si contrae. Dover assistere a questa scena mi
procura quasi un dolore fisico. Finalmente dopo un quarto d’ora arri-
va - anche se troppo tardi - un’illuminazione: “Questo è l’ultimo av-
mationsblatt der Milton Erickson Gesellschaft [Rivista della società Milton
Erickson], Nrr. 22/1995.
GENITORI E FIGLI 55
eBook acquistato da rosalba faraci
vertimento! Fallo un’altra volta e ti mando in camera tua!”.
Come prevedibile, Christian continua i suoi “giochetti psicolo-
gici”. Senza ulteriori spiegazioni la madre prende energicamente il
bambino e lo porta in camera sua. Finalmente gli adulti possono pro-
seguire la conversazione. Dopo mezz’ora la mamma va a vedere nella
cameretta. Christian è tutto felice e l’abbraccia forte. Ora è diventato
il bambino più bravo che si possa immaginare. La sua anima gridava
solo il bisogno di avere una madre forte, una madre capace di fissare
limiti chiari. Il bambino si sente protetto e sicuro solo se sente che i
genitori sono “grandi” e forti. Per raggiungere tale obiettivo il bambi-
no è disposto a fare un “grosso sforzo”.
Dal momento che i genitori tendono sempre più a diventare
amici dei figli, invece di genitori, i bambini sono sempre più potenti.
Di conseguenza non bisogna meravigliarsi se li tiranneggiano e si ar-
rabbiano, le azioni di disturbo sono solo un grido di aiuto: “Quando vi
deciderete a capire cosa voglio veramente?”. Ai genitori fa bene far ca-
pire chiaramente ai figli chi comanda. La madre del nostro esempio si
è fatta mettere per troppo tempo i piedi in testa dal figlio. È consiglia-
bile esporre chiaramente i propri principi ai figli.
Un altro esempio: una madre single aveva lasciato che il figlio di
16 anni assumesse il ruolo di marito sostitutivo. In questo modo il ra-
gazzo aveva un enorme potere e, a volte, la madre aveva addirittura
paura di lui. Tutte le decisioni importanti venivano prese da lui. Ciò
divenne evidente nel caso dell’acquisto di un’auto. Anche se la situa-
zione finanziaria della piccola famiglia non era affatto rosea, il figlio
decise quale auto comperare. Si trattava di una macchina costosa, e la
madre obbedì. Le difficoltà finanziarie fecero però pentire la madre di
avere lasciato la decisione al figlio. Mise a punto un piano per sfrutta-
re il periodo in cui il figlio sarebbe andato in vacanza con degli amici
per rivendere la macchina e acquistarne una più economica. La don-
na era però molto impaurita: “Cosa dirà mio figlio? Si metterà a gri-
dare e tutto sarà ancora peggio. Come posso spiegarglielo?”.
“Non devi spiegargli niente! - le risposi - fai quello che ritieni
giusto e mettilo di fronte al fatto compiuto. Se ti chiede delle spiega-
zioni, rispondigli con voce calma e gentile: ‘Faccio ciò che ritengo
giusto’. Poi cambia subito argomento”.
“Ma si tratta di una rivoluzione! Come potrà comprendere che
improvvisamente ho preso in mano le redini della situazione? Per tut-
ti questi anni è stato lui il capo. Non riesco a immaginare che possa
56 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
funzionare!”, gridò.
“Fallo e basta!”, le consigliai. “Poi mi racconterai com’è andata”.
Lo fece e fu alquanto sorpresa dalla reazione. Il figlio protestò un
po’, ma poi si mise a ridere e non insistette più. Non fece alcun accen-
no a una reazione rabbiosa. La madre si rese conto dalla mimica di
quanto il figlio fosse sollevato osservando la sua improvvisa forza!
Quest’esperienza la aiuterà in futuro ad assumere il ruolo di genitore,
seppur amorevole, e non di bambino nei confronti del figlio. L’anima
del figlio prova comunque un grande sollievo. Il normale sviluppo di
un figlio prevede ovviamente la violazione di alcuni divieti che lo ren-
dono colpevole. Se ad esempio lascia la famiglia e sceglie un partner
o una professione che i genitori non approvano, può sposarsi o impa-
rare il mestiere solo contravvenendo alle norme dei genitori. Come
già detto i figli non “sono” solo i loro genitori, ma portano con sé qual-
cosa di proprio di cui sono responsabili. Un bambino sviluppa una sa-
na forza dell’io se di tanto in tanto viola i divieti imposti dai genitori.
Spesso i genitori sperano dentro di sé che il figlio violi un divieto. Se
ciò non accade per lungo tempo, vi sono conseguenze gravi sia per i
genitori che per il figlio. Se al contrario i genitori permettono tutto,
come prevede l’educazione antiautoritaria, il figlio non è in grado di
sviluppare la propria forza interiore e si sente disorientato.
In questo caso il figlio può apparire molto egoista, ma lo è solo
in apparenza. Non si deve confondere un tale comportamento con la
forza dell’io. Ciò che un figlio dice e come si comporta rappresenta un
lato della medaglia, ciò che desidera veramente ne costituisce l’altro.
Se i bambini disturbano costantemente la pace all’interno della
famiglia, si può stare certi che vi è un altro livello in cui agiscono per
amore. Bert Hellinger ha tenuto una volta un corso in un centro per
ragazze difficili al quale partecipavano anche i loro genitori. Tutte le
rappresentazioni delle costellazioni familiari hanno mostrato la stes-
sa dinamica: “Preferisco scomparire io piuttosto che tu, cara mam-
ma/caro papà”. Nessuno, né gli educatori né i genitori si erano accor-
ti di quanto le ragazze amassero i loro genitori e cosa fossero disposte
a fare per loro. Quando se ne resero conto, gli educatori, i terapeuti e
i genitori compresero improvvisamente le cause dei loro problemi.
Una della ragazze era tossicodipendente e si era gettata dal tet-
to. La rappresentazione ha rivelato che in realtà era il padre che vole-
va morire. Egli, a sua volta, voleva seguire il padre morto. Dentro di
sé la figlia diceva al padre: “Meglio che muoia io piuttosto che tu”. La
GENITORI E FIGLI 57
eBook acquistato da rosalba faraci
soluzione sta nel dimostrare alla figlia che il suo dolore non può an-
nullare quello del padre. La sofferenza di un figlio rende tutto ancora
peggiore. La figlia può dire: “Caro papà, ti prego resta e benedicimi se
resto anch’io”.
Nell’educazione dei figli è importante tenere in considerazione
altri aspetti fondamentali. In ogni famiglia sia l’uomo che la donna
portano con sé i valori della famiglia di origine. Naturalmente questi
valori sono diversi. Il figlio segue e accetta come giusto ciò che è man-
cato o è stato giudicato importante dal padre e dalla madre nella fami-
glia d’origine.
Se ad esempio la madre s’impone con i suoi valori nell’educazio-
ne dei figli, questi ultimi seguono apparentemente la madre, ma di na-
scosto sono solidali con il padre. Il bambino segue apparentemente
ciò che gli viene imposto, ma segretamente realizza ciò che sta sullo
sfondo ed è proibito. I bambini non vogliono fare torto a entrambi i
genitori. Ciò accade inconsciamente. Lo si può notare anche quando
i bambini si alleano con il genitore più debole. Se ad esempio una ma-
dre separata dice alla figlia: “Cerca di non diventare come tuo padre!
È un traditore, peggio di così non puoi diventare!”, la figlia solidariz-
za con il padre. Non può che diventare come lui. Se la madre dice:
“Puoi diventare come me e puoi diventare anche come tuo padre”, la
bambina non è tenuta a farsi carico dell’aspetto problematico del pa-
dre. Se i genitori osservano i figli con attenzione, possono riconosce-
re dove e come sono amati da loro.
Ciò che riesce ai genitori nel loro rapporto “in termini di rispet-
to e amore nei confronti del partner, riesce anche nei confronti dei fi-
gli”. Ciò che non riesce loro nei confronti del partner, fallirà anche nei
confronti dei figli. Ciò che li infastidisce nel partner, li infastidirà an-
che nei figli (MFL: 150 segg.).
Tutto ciò suggerisce la seguente soluzione ai problemi educati-
vi: rispettandosi l’un l’altro i genitori rispettano anche il figlio. I geni-
tori possono inoltre accordarsi su un nuovo sistema di valori, che ten-
ga in considerazione i valori di entrambi. È così che nasce un nuovo
sistema di valori. Se i genitori sono d’accordo, il figlio si sente sicuro
e segue volentieri i genitori. Se invece la madre si aspetta dal figlio
sempre qualcosa di diverso rispetto a ciò che ha ricevuto dal marito,
il bambino sarà insicuro e confuso.
Un altro consiglio educativo riguarda il comportamento dei ge-
nitori quando commettono degli errori. Perché i genitori possano
58 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
continuare a essere grandi e i figli piccoli, non dovrebbero mai chie-
dere perdono. I figli si arrabbiano con i genitori in quanto la conces-
sione del perdono li mette automaticamente in una posizione di for-
za. Se hanno commesso un torto, i genitori possono comunque dire:
“Mi dispiace”.
Dal momento che i genitori non devono diventare piccoli davan-
ti ai figli, Hellinger non fornisce di regola un consulto in presenza di
questi ultimi. Nella terapia familiare classica è invece usuale che ge-
nitori e figli discutano insieme con il terapeuta. In questo caso può ac-
cadere che i figli giudichino i genitori deboli. A qualcuno può appari-
re eccessivo, ma Hellinger vede come un problema persino il fatto che
i figli sappiano che i genitori hanno consultato un terapeuta. Questi
principi sono validi anche quando i figli sono adulti.
Il movimento interrotto
Un’esperienza di perdita e separazione vissuta da un bambino a segui-
to, ad esempio, di un ricovero in ospedale in tenera età, causa un di-
sturbo. Un tale movimento interrotto si verifica di regola nei primi
anni di vita e si riferisce principalmente alla madre.
Quando, una volta adulto, il bambino si avvicina a qualcuno, ri-
corda inconsciamente l’interruzione e si manifestano i sentimenti e i
sintomi provati allora, quali rabbia, odio, tristezza, disperazione e ras-
segnazione. Possono presentarsi anche sintomi quali mal di testa e di
stomaco o contrattura. Spesso la decisione presa un tempo appare
problematica: “Non chiederò mai più niente nella vita” oppure “Non
mi mostrerò mai più debole”. Invece di proseguire il movimento fino
a raggiungere l’obiettivo, “l’adulto si ritrae o inizia un movimento cir-
colare fino a tornare al punto di partenza, è questo il segreto della
neurosi”, come afferma Hellinger (ZG: 215).
Un movimento interrotto si riconosce non solo dai suddetti sin-
tomi, ma anche dal rapporto con i genitori. In genere gli interessati
vogliono avere il meno possibile a che fare con il genitore verso il qua-
le il movimento è stato interrotto. Frequentemente parlano del geni-
tore in termini denigratori, interrompono qualsiasi contatto e affer-
mano di “non provare niente” nei confronti del padre o della madre.
Questa “mancanza di sentimenti” protegge il cliente dalla percezione
del dolore, che però viene solo represso.
Anche le fobie sono spesso sintomo di un dolore represso causa-
to da un movimento interrotto. Se un bambino ha perso il padre o la
GENITORI E FIGLI 59
eBook acquistato da rosalba faraci
madre perché si sono separati o sono morti, si arrabbia con il genito-
re. Dal momento però che il bambino è legato ai genitori dall’amore
originario, non accetta la rabbia, che si trasforma in paura. Il bambi-
no ha paura della rabbia e delle sue conseguenze e si rifugia nella pau-
ra. Già Sigmund Freud aveva individuato questa relazione: “La causa
più comune della nevrosi d’angoscia è una richiesta frustrata. La libi-
do non viene soddisfatta, non viene sfruttata; la libido repressa viene
sostituita dalla paura. Credo a ragione di poter dire che la libido insod-
disfatta si trasforma direttamente in paura. […]. La solitudine e il vi-
so sconosciuto [di un’altra persona] risvegliano la nostalgia verso la
madre; il bambino [ed anche l’adulto che verrà] non è in grado di do-
minare la libido, […] ma la trasforma in paura”6.
Bert Hellinger fa regredire il cliente fino all’infanzia per indivi-
duare l’evento che ha determinato l’interruzione del movimento.
Rappresenta poi il genitore in questione e prosegue la rappresentazio-
ne finché l’amore originario, che si è trasformato in rabbia e altri sen-
timenti, non riesce di nuovo a fluire apertamente come amore e biso-
gno della madre o del padre.
Durante un corso Hellinger ha spiegato come la madre può aiu-
tare il figlio a portare a compimento il movimento interrotto. Una ma-
dre era preoccupata per la figlia che la evitava e tornava a casa il me-
no possibile. Hellinger le disse di abbracciare la figlia come una ma-
dre abbraccia un figlio triste. Tuttavia doveva lasciare agire nella sua
anima solo l’immagine positiva, finché la soluzione non si fosse fatta
strada da sola. Dopo un anno, così raccontò la madre, la figlia tornò a
casa e l’abbracciò a lungo silenziosamente. Poi la figlia se ne andò.
Nessuna delle due disse nulla. Questo è un ottimo esempio per dimo-
strare l’effetto delle immagini positive.
In un altro caso Bert Hellinger scrisse a una donna: “I sentimen-
ti che descrivi mi paiono il risultato di un movimento interrotto, for-
se verso tua madre. Se ritornano, può essere utile prendere dolcemen-
te per mano il bambino che c’è in te e condurlo dove desidera il suo
cuore. Una frase che può aiutare è: ‘Mamma, ti onoro’”.
Circa un anno dopo la donna rispose: “Piango fra le braccia di
mia madre. Da qui viene la guarigione. Mi hai spianato la strada. Ti
ringrazio” (FWW: 86).
6. Sigmund Freud: Angst und Triebleben [Paura e vita istintiva], citato da: Ur-
sula Franke: Systemische Familienaufstellung [Costellazioni familiari siste-
miche], Wien 1996.
60 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMAI
eBook acquistato da rosalba faraci
Uo mini e do nn e
L’“uomo giusto” e la “donna giusta”
È
già stato scritto molto su come trovare l’“uomo giusto” e la
“donna giusta”. A una coppia indecisa se proseguire il proprio
rapporto, Hellinger raccontò la storia di un giovane uomo.
Egli non riusciva mai a decidersi ad acquistare un’auto, anche se gli
sarebbe piaciuto molto viaggiare. Decise di attendere un altro anno
per vedere se i modelli della stagione successiva fossero migliori. Tro-
vò altri difetti e attese un altro anno ancora.
È facile immaginare che la storia non abbia avuto un lieto fine.
L’uomo fu assalito dalla paura di fallire. Improvvisamente decise di
precipitarsi ad acquistare un’auto qualsiasi. Per la fretta fu investito
da un camion. Hellinger consigliò alla coppia: “L’uomo giusto e la
donna giusta si trovano raramente. In genere sono sufficienti un bra-
v’uomo e una brava donna” (FWW: 16).
Che fine fanno le inebrianti sensazioni legate all’amore e alla
passione? La storia non è forse un po’ troppo drastica? Sicuramente
non si può accusare Hellinger di minimizzare. Non solo nelle sue sto-
rie, che racconta spesso e volentieri, ma anche durante la terapia sot-
tolinea con forza gli effetti di determinati atteggiamenti.
La vita punisce davvero così severamente gli indecisi? Sulla ba-
se dell’esempio, il lettore può guardarsi intorno nella sua cerchia di
conoscenze. Che fine hanno fatto coloro che hanno preteso il massi-
mo dall’aspetto, dal carattere e dal grado di istruzione del partner?
Nella mia esperienza hanno generalmente relazioni brevi e insoddi-
sfacenti e restano soli.
eBook acquistato da rosalba faraci
Talvolta un matrimonio o un rapporto di coppia falliscono nono-
stante un grande amore. Non è sufficiente trovare la persona “giusta”.
L’amore non può essere solo passione, ma anche “testa”. Hellinger so-
stiene che l’amore senza testa finisca sempre male. Non lo dicevano
già i nostri nonni? Pare proprio che Hellinger non abbia grande con-
siderazione dell’amore e della passione.
Nella vita reale si può osservare come l’amore passionale non
può avere successo senza il rispetto degli ordini dell’amore. Ho già ci-
tato l’esempio di una donna che ha sposato un uomo che portava con
sé altri figli da un precedente matrimonio. In base all’ordine naturale
per l’uomo vengono prima i figli e poi la seconda moglie. L’amore può
funzionare solo se la donna si accontenta del secondo posto e rispetta
la precedenza dei figli. Ciò richiede sacrificio.
I rapporti di coppia falliscono spesso perché non ci si vuole ren-
dere conto di ciò che impongono gli ordini dell’amore. Questo non
può essere compensato nemmeno dall’amore romantico. Se l’amore
all’interno di un sistema va a scapito di altri membri, fa fatica a pro-
sperare o è addirittura destinato a fallire, a seconda del prezzo che ha
richiesto. I grandi romanzi della letteratura mondiale si basano pro-
prio su questo. Uomo e donna vivono nella dolce convinzione di esse-
re soli al mondo. Non prestano alcuna attenzione agli effetti che le lo-
ro azioni possono avere sugli altri membri del sistema familiare.
Un esempio: una cliente conobbe un uomo sposato con nume-
rosi figli. L’uomo divorziò, andò a vivere con lei e la sposò. I figli re-
starono con la madre. Tuttavia la passione del nuovo amore si esaurì
presto. Già dopo tre mesi nella donna si fece strada una sensazione
che esternò così: “Non mi sono sposata con una buona coscienza”.
Oggi una frase del genere mi farebbe subito drizzare le orecchie,
ma allora non conoscevo il metodo di Bert Hellinger. La coppia non
faceva altro che litigare per questioni apparentemente insignificanti
come ad esempio il disordine in bagno. Tuttavia quando la vita diven-
ta un “inferno” e “fra me e te si alza un muro”, queste piccolezze si-
gnificano qualcos’altro: nel nostro esempio rappresentano la colpa di
cui entrambi si erano fatti carico nei confronti della prima moglie e
dei figli. Essere felice con quest’uomo sarebbe stato possibile per la
donna solo a condizione di guardare consapevolmente negli occhi la
colpa e di rispettare il legame dell’uomo con la prima moglie. Duran-
te le visualizzazioni che feci allora con la cliente, l’uomo fuggiva sem-
pre da lei! Era chiaro dove andasse…
62 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Il “muro” che ci divide dal partner può dipendere anche da un
irretimento con la famiglia d’origine. Gli irretimenti inconsci con il
sistema d’origine determinano la “scelta” di costellazioni particolar-
mente difficili nel rapporto di coppia. La donna del nostro esempio è
cresciuta senza padre, inoltre, entrambi i nonni erano stati assassina-
ti. Conosceva solo per sentito dire una schiera di sorellastre e fratel-
lastri del padre. È chiaro che tutto ciò si ripercuote sul rapporto di
coppia.
La nostalgia del padre assente non può essere lenita dal partner.
Vi era inoltre la solidarietà con i membri assassinati della famiglia
d’origine.
Cosa rende un uomo uomo e una donna donna?
Secondo Hellinger un uomo diventa tale solo se ha una donna e la
donna diventa donna solo se ha un uomo. L’amore prevede che en-
trambi desiderino l’altro come uomo e donna. Se la decisione è in-
fluenzata da altri motivi, il rapporto di coppia è destinato a fallire. Gli
altri motivi possono essere il sostegno finanziario, trovare qualcuno
che cucini per noi, la comodità, il non doversi più preoccupare per il
bucato, l’impegno intellettuale, la confessione o il desiderio che pro-
prio quell’uomo o quella donna diventino in futuro la madre o il pa-
dre dei nostri figli.
Mi ricordo di un cliente che si era sposato per “altri” motivi. Era
vicino ai quaranta e continuava a vivere da solo. Alla donna che aveva
conosciuto lo legava una buona intesa, niente di più e niente di me-
no. Dopo che genitori e amici continuavano a spronarlo a decidersi fi-
nalmente a sposarla, cedette. In questo matrimonio c’era già il seme
del fallimento. Dopo dieci anni di tortura, l’uomo lasciò la moglie e
chiese il divorzio.
Generalmente il matrimonio di un uomo funziona solo se egli
riesce ad accettare nel proprio cuore il padre così com’è. Per la donna
vale lo stesso nei confronti della madre. Se una donna conosce un uo-
mo che non è ancora riuscito ad accettare il padre (inconsciamente)
non vede in lui l’uomo giusto. L’uomo riceve infatti il maschile dal pa-
dre: rifiutando il padre soffoca anche la parte maschile che c’è in lui.
Robert Bly scrisse nel suo libro, Per diventare uomini: come un
bambino spaventato si è trasformato in un uomo completo, che in ba-
se a una ricerca sulla popolazione americana, un giovane americano
intorno al 1940 doveva fare una sola cosa per diventare “uomo”: rifiu-
UOMINI E DONNE 63
eBook acquistato da rosalba faraci
tare il padre. I figli consideravano i padri dei sempliciotti di cui pren-
dersi gioco. Ciò che ne risulta è facilmente immaginabile: dei machi!
Lo stesso studio afferma che effettivamente i padri americani si aspet-
tavano di essere rifiutati dai figli.
Robert Bly è convinto che ai giovani uomini manchi la “linfa pa-
terna”. Il modo in cui Bly immagina che essi possano prendere tale
linfa è simile a quanto sostiene Hellinger: “Il padre dà e il corpo del fi-
glio - non la sua anima - riceve tale nutrimento a un livello profonda-
mente inconscio. (…). Lentamente comprende la canzone cantata
dalle cellule dell’uomo adulto (…)”1. Tuttavia prendere la linfa pater-
na non si limita, come sostiene Bly, al corpo.
Nel suo libro Bly descrive con chiarezza le conseguenze dell’as-
senza di linfa paterna e maschile. I giovani uomini restano per tutta la
vita affamati di energia paterna senza rendersene conto. Manca loro
qualcosa di determinante. Anche l’inconscio reagisce a tale situazio-
ne. Bly fa riferimento al sogno di un giovane di vent’anni “iniziato”
dalle donne. I genitori si separarono quando aveva dodici anni e lui re-
stò con la madre. Durante la giovinezza ebbe più contatti con donne
che con uomini e la situazione non cambiò nemmeno durante il pe-
riodo degli studi. Le sue amicizie più strette erano femministe dalle
quali era molto colpito. Successivamente si dedicò all’attività politica
e si impegnò a favore dei diritti delle donne.
Durante questo periodo fece un sogno: correva nel bosco insie-
me a un branco di lupi femmina (i lupi simboleggiano l’indipenden-
za). Insieme giunsero finalmente sulle rive di un fiume. Tutti i lupi
femmina guardarono nell’acqua e videro la propria immagine riflessa.
Quando però anche il giovane guardò nell’acqua non vide nulla2. Gli
mancava l’identità sessuale. Un uomo non la può trovare nelle donne.
Mi ricordo di un cliente intorno ai quarant’anni. Il suo atteggia-
mento lo faceva apparire un giovane intimidito ed effeminato. Solo re-
centemente aveva abbandonato la casa della madre. Il padre era mor-
to da dieci anni. Odiava la madre e definiva il padre un “debole” che
non poteva certo costituire un esempio. Indipendentemente da quan-
to debole il padre possa essere stato, un giovane riceve la “linfa ma-
schile” esclusivamente da lui.
1. Robert Bly, Per diventare uomini: come un bambino spaventato si è tra-
sformato in un uomo completo, Mondadori 1992.
2. Robert Bly, ibidem.
64 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
L’obiettivo del cliente era: “Voglio liberarmi della depressione,
ho bisogno di più autocoscienza e voglio finalmente diventare uomo”.
Quando iniziò a descrivere i lati negativi del padre, lo interruppi. Lo
pregai di raccontarmi alcuni ricordi positivi della sua infanzia legati
al padre. L’uomo inclinò la testa e raccontò un episodio in cui lui e il
padre si capivano bene. Improvvisamente iniziò a piangere.
Per lui era penoso rendersi conto che in realtà amava il padre.
“Non capisco - disse - lo rifiuto, come può essere?”.
Invece di discutere con lui, cercai di avvicinarlo maggiormente
all’amore per il padre con l’aiuto di un esercizio. Egli però non voleva
più provare amore e dolore in questo modo. Annullò l’appuntamento
successivo. In questo modo gli venne “risparmiata” la linfa paterna.
Nonostante i suoi quarant’anni, l’uomo non ha mai avuto un
rapporto di coppia o un rapporto sessuale con una donna. La sua fra-
se “Voglio finalmente diventare uomo” era intesa anche in questo sen-
so. Meno linfa paterna beviamo, meno interesse proviamo per le don-
ne. Le donne provano solo compassione per questi uomini e non so-
no attratti da loro.
Anima e animus
Nella valutazione della parte di noi che rappresenta il sesso opposto
Hellinger differisce completamente dallo psicologo C. G. Jung. Per
Jung l’anima rappresenta il potenziale femminile nell’uomo e l’ani-
mus il potenziale maschile nella donna. L’uomo sviluppa l’anima gra-
zie al rapporto con la madre e la donna l’animus attraverso il rappor-
to con il padre.
Per Jung la questione è essere consapevoli della parte di noi che
rappresenta il sesso opposto. Intuire la parte di noi che rappresenta il
sesso opposto, ci permette di tenere in pugno le emozioni e gli affet-
ti. In questo modo si diventa indipendenti, ma anche soli, “la solitudi-
ne dell’“uomo interiormente libero”, che nessun rapporto d’amore o
di coppia può più mettere in catene, per il quale l’altro sesso non co-
stituisce più un mistero originario in quanto ha imparato a conoscer-
ne le caratteristiche in se stesso”3.
Il punto di vista di Hellinger è completamente diverso. Afferma
che l’uomo e la donna presentano un modo di sentire e di pensare tal-
mente diverso da rendere impossibile l’esplorazione della parte di lo-
3. Jolande Jacobi, La psicologia di Carl G. Jung, Bollati Boringhieri, 1973.
UOMINI E DONNE 65
eBook acquistato da rosalba faraci
ro che rappresenta l’altro sesso come intende C. G. Jung. Per la don-
na l’uomo continua a restare un mistero e lo stesso vale per l’uomo.
Hellinger rifiuta l’idea di coltivare la parte di noi che rappresenta il
sesso opposto per dare maggiore importanza allo sviluppo del proprio
sesso. Ciò avviene accettando dal genitore la parte di noi che rappre-
senta il sesso opposto (vedi il capitolo “Prendere dai genitori”). Chi fa-
vorisce la parte di se stesso che rappresenta l’altro sesso non sfrutta le
possibilità del proprio sesso. Se un figlio maschio resta nella sfera del
femminile e della madre, non diventerà mai un uomo. Un uomo so-
vrastato dalla componente femminile prova meno comprensione per
le donne e generalmente non trova consensi né presso le donne né
presso gli uomini. Per le donne vale lo stesso principio. Per questo
Hellinger suggerisce di porre il bambino appena possibile nella sfera
d’influenza del genitore dello stesso sesso.
Non intende solo che una ragazza in età fertile riceva spiegazio-
ni dalla madre e non dal padre. Il padre deve porre interiormente la fi-
glia nelle mani della madre, in modo che possa bere più “linfa mater-
na”. Lo stesso vale per i figli maschi nei confronti del padre. Certa-
mente il genitore dell’altro sesso continua a occuparsi dei figli e a
mantenere un contatto amorevole. Se i genitori si comportano in que-
sto modo, fanno del bene ai figli. Una figlia sarà sempre meno in gra-
do di instaurare legami profondi quanto più resta nella sfera d’in-
fluenza del padre. Al contrario, quanto prima entra nella sfera d’in-
fluenza della madre tanto più facile sarà per lei instaurare legami.
Per quanto riguarda il concetto junghiano di anima e animus,
Hellinger arriva alla seguente conclusione: “L’anima è il risultato in-
teriorizzato del rifiuto del padre da parte del figlio; e l’animus è il ri-
sultato del rifiuto della madre da parte della figlia” (ZG: 102). Hellin-
ger ammette che questo approccio junghiano non merita un giudizio
così severo, in quanto per Jung anima e animus sono anche principi
cosmici. In essi Jung vede immagini inconsce dell’anima, che posso-
no essere comprese più facilmente, ad esempio, mediante visualizza-
zioni o analisi dei sogni. Affrontare questi due principi costituisce se-
condo Jung una tappa del processo di individuazione e non si riferisce
dunque solo all’uomo e alla donna. Grazie all’aiuto di animus e ani-
ma, l’uomo può stabilire un contatto fra il proprio inconscio indivi-
duale e l’inconscio collettivo4. Quest’audace impresa è, secondo Jung,
4. Per Jung si tratta del mondo delle immagini primordiali o “archetipi” che
66 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
tutt’altro che priva di rischi.
Inoltre Jung era pienamente consapevole che un’anima forte
rende l’uomo più femminile ed è dunque estremamente problemati-
ca. Così afferma ad esempio: “Per il figlio lo strapotere della madre na-
sconde l’anima, che crea talvolta un legame sentimentale indelebile e
compromette fortemente il destino dell’uomo (…)”5.
Jung consiglia di prendere coscienza di tale legame con il fem-
minile, ma non pensa di indirizzare l’uomo verso i padre. È questa la
differenza fondamentale rispetto a Hellinger. Il fatto che Jung non
comprenda l’importanza del genitore dello stesso sesso è legato alla
sua storia personale: egli era molto legato alla madre. Nel padre vede-
va un traditore per cui provare pietà. Fra loro, come afferma Jung, vi
era un abisso, “e non vedevo alcuna possibilità di colmare questo vuo-
to infinito”6. Tuttavia la “presa di coscienza” dell’anima attraverso
l’analisi del trauma è ben lungi dal sostituire l’accettazione del padre7.
L’uomo è al servizio del femminile e la donna segue l’uomo
La prima parte del titolo fa certamente piacere alle donne, la seconda
meno. Cosa intende Hellinger quando dice che la donna deve seguire
l’uomo? Lo intende letteralmente: quando ad esempio un uomo cono-
sce una donna che abita lontano, generalmente il rapporto fallisce
non appena lui si trasferisce da lei ed entra in contatto con i suoceri.
Il fatto che, invece, la donna si trasferisca dall’uomo non è certo una
garanzia di successo, ma ne aumenta le possibilità. Le eccezioni lo
confermano.
Se si prende sul serio questo concetto, si avranno conseguenze
di vasta portata sui matrimoni fra coppie di nazionalità, cultura o con-
fessione diverse. Da questo punto di vista sono generalmente le don-
ne e soprattutto i bambini a dover seguire l’uomo. Una donna tedesca
che sposa un turco deve sapere che i figli sono turchi nel loro cuore.
s’incontrano in fiabe e miti.
5. C. G. Jung, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Opere, Vol. 9/1, Bollati Bo-
ringhieri, 1997.
6. Ricordi, sogni, riflessioni di C.G. Jung raccolti ed editi da Aniela Jaffe, Riz-
zoli 1979.
7. Molti junghiani di oggi, come Verena Kast, non si attengono più alla rigida
definizione di animus e anima. Credono che le donne abbiano anche un’ani-
ma e gli uomini un animus. Di conseguenza un approccio junghiano (moder-
no) non è inconciliabile con la psicoterapia sistemica di Hellinger.
UOMINI E DONNE 67
eBook acquistato da rosalba faraci
Se si impedisce loro di entrare in contatto con l’islam e la cultura tur-
ca, si crea un conflitto nella loro anima.
Per Hellinger ciò “non ha nulla a che fare con il patriarcato. L’ef-
fetto dell’una e dell’altra soluzione si evidenzia nella pace che regna
improvvisamente e nella forza buona che si manifesta tutto d’un trat-
to all’interno della famiglia. L’unica eccezione è quando la famiglia
dell’uomo è segnata da destini particolarmente gravi” (OL: 460). In
questo caso i figli devono essere inseriti nella sfera d’influenza della
madre e della sua famiglia.
I critici di Hellinger si rallegrano di queste affermazioni, in
quanto sono convinti che confermino i loro pregiudizi. Basterebbe
che chi lo giudica frettolosamente guardasse la realtà e verificasse chi
ha ragione. “Se qualcuno è a conoscenza di esempi che attestino il
contrario, sono lieto di imparare” (OL: 185).
Il fatto che la donna segua l’uomo comporta naturalmente an-
che che la situazione lavorativa di quest’ultimo ha la priorità. Hellin-
ger vede la donna solo ai fornelli e ad occuparsi dei figli?
Innanzitutto mi pare importante sottolineare che Hellinger non
sminuisce, ma anzi apprezza le casalinghe, al contrario di quanto fan-
no la società e le donne stesse. Non giudica né positivamente né nega-
tivamente il fatto che gli uomini siano più attivi all’interno della fami-
glia e contribuiscano alle faccende domestiche e che le donne metta-
no al mondo meno figli e siano più impegnate professionalmente. Per
l’esperto terapeuta Hellinger si tratta di uno sviluppo sociale, che va
accettato così com’è.
Il fatto però che una donna rinunci alla maternità ha un grande
peso secondo Hellinger. Se una donna decide di non crearsi una fami-
glia e di non avere figli “perché disprezza o denigra la famiglia, i figli
e il marito, questa negazione sottrae qualcosa alla sua scelta. Se inve-
ce rispetta il proprio rifiuto a favore della carriera come qualcosa di
grande, esso aggiunge qualcosa alla sua scelta. Diventa più grande”
(OL: 51).
Credo che queste riflessioni confermino che è ingiusto attribui-
re a Hellinger un’ostilità nei confronti delle donne.
Ora arriviamo alla parte del titolo che crea meno problemi alle
donne: l’uomo è al servizio del femminile. Per Hellinger non si tratta
di una teoria, ma di una percezione. La donna costituisce il centro del-
la famiglia. Custodisce la vita e la tramanda. Ciò che l’uomo fa in pub-
blico è generalmente al servizio della famiglia. Rappresenta la fami-
68 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
glia all’esterno e provvede alla sua protezione e alle sue fondamenta.
Per questo gode di una certa precedenza per quanto riguarda le que-
stioni esterne, mentre la donna ha la precedenza in famiglia.
Hellinger evidenzia come alle donne vengano generalmente at-
tribuite maggiori competenze nelle questioni familiari. In caso di se-
parazione, i figli vengono affidati quasi automaticamente alla madre,
anche se potrebbero crescere altrettanto bene o addirittura meglio
con il padre. In caso di figli illegittimi, l’uomo non viene quasi tenu-
to in considerazione. Ha meno diritti, ma più obblighi. In queste que-
stioni familiari, afferma Hellinger provocatoriamente, “vige il ma-
triarcato” (AWI: 173). Giudica positivamente la moderna tendenza di
condividere sempre più l’educazione dei figli.
Le rappresentazioni delle costellazioni familiari mostrano chia-
ramente se per il bene di tutti è meglio che al primo posto vi sia l’uo-
mo o la donna. Se tutti si sentono meglio quando la donna si trova al-
la sinistra dell’uomo, significa che la precedenza deve essere conces-
sa all’uomo. Se invece l’uomo si trova alla sinistra della donna, è lei ad
avere il primo posto. Nel 70% dei casi durante la rappresentazione i
rappresentanti si sentono meglio quando l’uomo si trova a destra, nel
30% dei casi quando è la donna a trovarsi a destra.
Se Hellinger fosse realmente un sostenitore del patriarcato, di-
rebbe: “Gli uomini dovrebbero essere al primo posto in quanto tali”.
Nulla gli è più lontano. Al contrario, chiede con quale costellazione di
coppia si sentano tutti al meglio. Nel 70% dei casi ciò avviene appunto
quando l’uomo ha la precedenza sulla donna. Che ci piaccia o no è tut-
ta un’altra questione. Nel restante 30% dei casi in cui la donna deve
stare al primo posto, vi sono spesso una o più persone escluse nella fa-
miglia d’origine della donna, che devono essere riportate nel sistema.
Parlando di gerarchia bisogna ripetere ancora una volta che
l’uomo e la donna, che non sono legati da un rapporto genitori-figli,
sono alla pari. La gerarchia si riferisce alla funzione svolta dall’uomo
e dalla donna all’interno della famiglia. Chi garantisce la sicurezza
della famiglia si trova generalmente al primo posto. Nella maggior
parte dei casi si tratta dell’uomo.
La donna rispetta meno l’uomo di quanto quest’ultimo
rispetti la donna?
Come abbiamo già visto per la questione dei figli in caso di separazio-
ne, Hellinger è del parere che spesso le donne rispettino meno gli uo-
UOMINI E DONNE 69
eBook acquistato da rosalba faraci
mini di quanto facciano questi ultimi nei confronti delle donne. Ed
ecco che si ripropone la domanda: Hellinger discrimina le donne?
La sociologa della famiglia Marianne Krüll ha detto quanto se-
gue di Hellinger in Psychologie heute [Psicologia oggi]: “Ciò che Bert
Hellinger esprime riguardo al rapporto fra uomo e donna rappresen-
ta, a mio avviso, un pensiero patriarcale acritico del XIX secolo”. Allo
stesso tempo afferma, dimostrando la propria correttezza: “Sono mol-
to impressionata dal suo lavoro con i malati gravi. Possiamo notare
come queste persone vengano condotte al punto centrale della loro
problematica esistenziale. Sono sicura - di alcuni lo so per certo - che
alcuni portano con sé un impulso estremamente positivo grazie all’in-
tervento, talvolta molto breve, di Bert Hellinger”8.
Anch’io ero molto scettico quando ho sentito per la prima volta
quest’idea di Hellinger. Tuttavia tutte le rappresentazioni che ho con-
dotto o a cui ho partecipato come rappresentante od osservatore han-
no dimostrato tale tendenza. Naturalmente lo si potrebbe spiegare af-
fermando che i rappresentanti assumono inconsciamente e rappre-
sentano il punto di vista del terapeuta. Queste argomentazioni met-
terebbero però in discussione il metodo delle costellazioni familiari
nel suo complesso. L’esperienza pratica dimostra che il risultato del-
le rappresentazioni non è solo vero9, ma spesso anche totalmente ina-
spettato per gli interessati - e anche per il terapeuta. La tendenza ri-
scontrata non permette certo di mettere a punto una regola per il
comportamento femminile, e Hellinger non vuole nemmeno essere
compreso in questo modo. Per lui l’importante è che uomini e donne
si rispettino.
Hellinger spiega il minore rispetto manifestato tendenzialmen-
te dalle donne nei confronti degli uomini con il fatto che le esperien-
ze della gravidanza e del parto le rende consapevoli della loro partico-
lare importanza. Dal punto di vista biologico hanno ottenuto il ruolo
più importante. L’uomo non sperimenta queste esperienze così pro-
fonde e si deve accertare in altro modo del proprio essere maschio. Gli
uomini devono impegnarsi attivamente, generalmente nella società
con altri uomini, per percepire il proprio essere uomini.
8. Pensiero patriarcale acritico - conversazione con la sociologa della fami-
glia Marianne Krüll, in Psychologie heute [Psicologia oggi] 6/95.
9. Vedi il sottocapitolo “Il terapeuta può influenzare ciò che avviene durante
la rappresentazione?” nell’introduzione.
70 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Parità
Al contrario del rapporto fra genitori e figli, i partner sono allo stesso li-
vello. Se ciononostante uno dei due si cala nel ruolo di bambino e si
aspetta dall’altro un comportamento da genitore, il rapporto ne risente.
Se la moglie dice ad esempio al marito: “Senza di te non posso
vivere!”, si tratta di un comportamento che viola la parità fra i partner
e impone all’uomo di lasciare la donna. La pretesa di essere accuditi
costantemente da qualcuno è una pretesa infantile.
Della parità fa parte anche la questione se l’altro può restare co-
m’è. Se iniziamo una relazione o ci sposiamo con la prospettiva di
cambiare l’altro, ci siamo già calati nel ruolo di genitori. Con questa
prerogativa è impossibile costruire un rapporto di coppia stabile e du-
raturo.
Anche il modello di dare e prendere deve essere rispettato nel
rapporto. Se uno si limita a dare e l’altro a prendere, si crea un rappor-
to genitori-figli e non un rapporto di coppia. In un rapporto di coppia
è opportuno anche prestare attenzione a non dare più di quanto l’al-
tro voglia e possa restituire. Dell’amore fra uomo e donna fa parte in-
fatti anche uno scambio alla pari. L’amore deve essere corrisposto, al-
trimenti crollano le fondamenta del rapporto. Visto così, è vero il con-
trario di quanto afferma Peter Lauster nel suo libro L’amore e il senso
della vita: “Il fatto che l’amore non venga ricambiato non mi causa al-
cuna frustrazione se non me lo aspetto, se non spero nulla. L’ego ha
trovato pace, qualsiasi tentativo di rafforzare l’io è concluso. In questo
momento sono illuminato e libero, l’energia vitale può fluire (…). In
questo momento regnano massima soddisfazione e saggezza”10.
Nutro seri dubbi che tale atteggiamento possa renderci “illumi-
nati e liberi”. Certamente non consente di costruire un legame fra un
uomo e una donna. Per quanto riguarda il dare e il prendere, vi ricor-
do nuovamente l’esempio della donna che finanzia gli studi del par-
tner. Se l’uomo non restituisce tutto ciò che ha ricevuto fino all’ulti-
mo centesimo, è probabile che il rapporto fallisca.
Del principio di compensazione nel rapporto e nel matrimonio
fa parte anche la compensazione nel male. Se uno fa qualcosa all’al-
tro, quest’ultimo deve pretendere qualcosa che faccia male, anche se
non proprio altrettanto (vedi capitolo “Colpa e innocenza”).
10. Peter Lauster, L’amore e il senso della vita: miti e pregiudizi, affetti e gio-
ie, gelosie e separazioni, GB 1994.
UOMINI E DONNE 71
eBook acquistato da rosalba faraci
Sessualità
Bert Hellinger definisce l’atto sessuale “l’atto umano più grande”.
Nessun’altra azione umana è più in armonia con gli ordini dell’amo-
re e la pienezza della vita e ci pone maggiormente al servizio del tut-
to della terra” (MFL: 152). Nessuna azione umana porta con sé così
tanta gioia e dolore ed è così piena di rischi e di conseguenze. Niente,
afferma Hellinger, “ci rende così sapienti e saggi, umani e grandi” di
quando un uomo e una donna “si abbracciano e si riconoscono con
amore”.
Hellinger non denigra la sessualità, come credono alcuni critici,
che lo definiscono conservatore, ma le conferisce il massimo valore
nell’ambito delle azioni umane. La sessualità si manifesta anche in
presenza della morte, perché solo dove c’è morte, esiste anche la ses-
sualità. In tempi passati la sessualità era maggiormente legata alla
morte, una donna può tuttora morire di parto o a seguito della gravi-
danza. Inoltre la nascita di un bambino ci fa capire che, prima o poi,
anche noi faremo spazio morendo.
Il “compimento dell’atto d’amore”, come lo definisce Hellinger,
crea un legame fra uomo e donna che supera per intensità persino il
rapporto fra genitori e figli. La sessualità ha per Hellinger la preceden-
za sull’amore, in quanto le gravidanze iniziano indipendentemente
dal fatto che la sessualità si sia basata sull’amore o solo sul desiderio.
Una donna che resta incinta a seguito di un rapporto sessuale occasio-
nale, è profondamente legata a quest’uomo (naturalmente lo stesso
vale anche per lui). Anche se la donna abortisce (vedi sottocapitolo
“Aborto”) e perde completamente di vista l’uomo, la rappresentazione
della costellazione familiare mostra chiaramente quanto profondo sia
il legame.
Non ogni rapporto sessuale crea un legame che dura tutta la vi-
ta. La rappresentazione delle costellazioni familiari tuttavia mostra
chiaramente se l’ex partner appartenga o meno al sistema attuale.
Quando una donna ha concepito un figlio con un uomo, sussiste sem-
pre un legame, anche se non se ne vuole prendere coscienza.
L’importanza del partner precedente
Il legame fra uomo e donna è talmente profondo da non poter essere
semplicemente sciolto quando i due si separano e iniziano una nuova
relazione. Il rapporto successivo non crea un legame altrettanto pro-
fondo quanto il primo, anche se l’amore e la felicità possono essere su-
72 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
periori. Come riconoscere la profondità del primo legame? La si può
riconoscere a posteriori. Al momento della prima separazione, la col-
pa e il dolore sono più intensi rispetto a quelli causati da una separa-
zione successiva e così via per eventuali altre separazioni.
Hellinger resta sempre un moralista? Veniamo “puniti” per il
fallimento del primo matrimonio o rapporto di coppia? Hellinger par-
te sempre da ciò che percepisce. I successivi matrimoni o rapporti di
coppia possono senza dubbio essere più felici, ma il dolore della sepa-
razione non ha la stessa intensità. È questa per lui la realtà.
Non è vero che una persona separata o divorziata può unirsi fe-
licemente a un altro partner solo dopo avere “elaborato” interiormen-
te il primo rapporto. Credo che nessuno possa contraddire questo da-
to di fatto.
Molti sono convinti che il fattore tempo sia sufficiente a portare
a termine tale “elaborazione”. Ciò viene confutato dall’esperienza.
Hellinger spiega più precisamente ciò che accade nelle separazioni: il
legame che ci unisce al primo partner deve essere rispettato e i nuovi
partner devono essere consapevoli di “venire dopo” i precedenti e di
essere in qualche modo colpevoli nei loro confronti. Il fallimento del
precedente rapporto dipende, infatti, dal partner attuale, il nuovo rap-
porto di coppia nasce a spese del precedente.
Ad esempio una donna che si risposa deve rispettare il preceden-
te compagno. Deve accettare pienamente ciò che lui le ha donato. In
questo modo può portare il buono del primo rapporto nel secondo.
Entrambe le parti devono inoltre assumersi la propria parte di respon-
sabilità. Anche il secondo marito della donna può fare qualcosa. Den-
tro di sé può dire al primo marito: “Ho questa donna a tue spese e lo
rispetto. Tu sei il primo e io il secondo. Ora la prendo come mia spo-
sa”. Se dal secondo matrimonio nascono dei figli, si può chiedere al
precedente partner di guardarli con benevolenza.
Di regola tutto ciò non accade, in quanto queste relazioni sono
sconosciute. Anche i bambini ne pagano le conseguenze, in quanto in
questi casi rappresentano il partner precedente che non è stato rispet-
tato. Inconsciamente si fanno carico dei suoi sentimenti e possono di-
ventare piuttosto ribelli, se, ad esempio, il precedente partner prova
ancora rancore.
Generalmente l’ex marito viene rappresentato da un figlio nato
dal secondo matrimonio. Se invece nascono solo femmine, sarà co-
munque una di loro a farlo. La ragazza avrà gravi difficoltà a diventa-
UOMINI E DONNE 73
eBook acquistato da rosalba faraci
re completamente donna. Vale anche il contrario: una precedente
compagna viene rappresentata da una bambina, ma se nascono solo
maschi, sarà uno di loro a farlo e avrà problemi simili per quanto ri-
guarda l’identità sessuale. Talvolta l’omosessualità deriva da questa si-
tuazione. Un esempio a tale proposito: una donna era sposata e aveva
due figli. Prima di sposarla il marito aveva vissuto per vent’anni con
un’altra donna, che poi aveva lasciato. Una rappresentazione con i
simboli ha dimostrato che il figlio più giovane si era identificato con
la prima moglie. Chiesi alla madre se temesse che il figlio potesse di-
ventare omosessuale. In effetti aveva sempre avuto questo timore.
L’identificazione con l’altro sesso è difficile da sopportare. Venni
a sapere che il ragazzo veniva sottoposto già da tempo a cure psichia-
triche per problemi comportamentali. Durante la rappresentazione,
la madre ha reso onore alla prima moglie a spese della quale si era spo-
sata. Al figlio minore disse: “Non hai niente a che fare con la prima
moglie di tuo padre, io sono tua madre!”. Suggerii alla donna di con-
tinuare a ripetere questa frase dentro di sé al figlio. Dopo alcune set-
timane riferì che il ragazzo continuava a migliorare e i problemi com-
portamentali erano scomparsi.
In un altro caso una cliente aveva numerose figlie, di cui una
soffriva di neurodermite. Durante la rappresentazione della costella-
zione familiare la bambina non era orientata né verso il padre né ver-
so la madre, ma verso il precedente partner della cliente. La bambina
era solidale con lui, perché la madre aveva abortito tanti anni prima
contro la sua volontà e lo aveva lasciato. Il dolore dell’uomo era pas-
sato alla bambina. Fino al momento della rappresentazione la donna
non si era resa conto di essere colpevole nei confronti del primo com-
pagno. Le consigliai di contattarlo per manifestargli il suo dispiacere
per la colpa che aveva commesso. L’uomo viveva all’estero e la donna
non riuscì a trovare il suo indirizzo. Affrontò però interiormente que-
st’avvenimento passato. Un anno dopo la donna mi informò che la
neurodermite della figlia era guarita.
Se la bambina fosse stata adulta, avrebbe potuto dire al padre du-
rante la rappresentazione: “Non ho niente a che fare con quell’uomo
(indicando il precedente partner della madre), sei tu mio padre”. Que-
sta frase consente anche al padre di ripristinare il rapporto naturale
con la figlia. Se è invece un figlio maschio a rappresentare il preceden-
te partner della madre, il padre vede in lui un rivale. Senza questa fra-
se e un atteggiamento risolutorio è impossibile instaurare un rappor-
74 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
to rilassato fra padre e figlio. In questo caso il figlio assumerebbe il
ruolo di partner nei confronti della madre con conseguenze altrettan-
to gravi. Nel caso della bambina una seconda frase rivolta alla madre
sarebbe: “Non ho niente a che fare con quell’uomo (indicando l’uo-
mo), mio padre è lì (guardando il padre)”. Durante la rappresentazio-
ne dissi alla madre di ripetere alla bambina: “D’ora in poi me ne occu-
però io. Tu non hai nulla a che fare”. I precedenti rapporti di coppia
dei genitori non riguardano il figlio. Ciononostante essi si fanno cari-
co inconsciamente per amore delle questioni lasciate in sospeso dai
genitori.
Hellinger afferma che i bambini che ricevono la vita a spese di
precedenti partner dei genitori hanno la vita più difficile della mag-
gior parte di noi: “In queste situazioni, per rispettare tutti, il bambi-
no cerca la compensazione fra perdita e guadagno facendosi carico
della perdita”. Questa “perdita” può assumere le forme più svariate:
fallimento nella vita lavorativa, nel rapporto di coppia o malattie.
Mi ricordo di una cliente che doveva la propria vita al fallimen-
to dei precedenti matrimoni del padre e della madre. I genitori aveva-
no avuto rispettivamente due figli. Aveva dunque ottenuto la vita a
scapito di sei persone. La sua rappresentante si trovava isolata duran-
te la rappresentazione e non osava alzare la testa. Provava una profon-
da tristezza e disse: “Mi sento profondamente colpevole. In realtà non
dovrei nemmeno esistere”. Così misi la cliente al posto della rappre-
sentante e la pregai di dire a ognuno: “Io sono l’ultima nata e rispetto
il fatto che tu venga prima di me”. A questo punto tutti e sei i prece-
denti membri della famiglia la rassicurarono: “Anche tu puoi avere un
buon posto”. La cliente rimase molto colpita e stentò a crederci. Il fat-
to che entrambi i genitori avessero lasciato le loro famiglie e l’avesse-
ro desiderata profondamente non cambiava una virgola delle relazio-
ni esistenti. Essere l’ultimo di una lunga schiera di fratelli e sorelle,
nati tutti dagli stessi genitori, è tutta un’altra cosa.
Ciò che Hellinger ha constatato riguardo ai partner precedenti e
ai figli nati da relazioni successive, era già conosciuto - per lo meno
per quanto riguarda le ripercussioni sui figli. La mistica cristiana Il-
degarda di Bingen era dell’opinione che i figli nati da unioni successi-
ve avessero la vita difficile. Nel suo linguaggio arcaico e ricco di me-
tafore scrisse:
“Se un uomo e una donna dimenticano un’unione legittima e
intrecciano con ardente passione un altro rapporto illegittimo, l’uo-
UOMINI E DONNE 75
eBook acquistato da rosalba faraci
mo mescola il proprio sangue, il sangue della legittima moglie, con
un’altra donna e analogamente la donna mescola il proprio sangue, il
sangue del legittimo marito, con un altro uomo. I figli che nascono da
coniugi legittimi o illegittimi saranno spesso infelici, in quanto origi-
nati da un concepimento che ha unito civiltà e sangue diversi. Questi
genitori vengono dunque giudicati trasgressori del giusto ordine da-
vanti a Dio”11.
Come Hellinger anche Ildegarda parla di ordine violato. Ildegar-
da adduce una motivazione religiosa, mentre Hellinger si basa più su
ciò che viene evidenziato dalle rappresentazioni delle costellazioni fa-
miliari e cioè che l’anima dei bambini solidarizza con il precedente
partner dei genitori.
Ciò che Ildegarda definisce “sangue” viene oggi messo in rela-
zione con “l’anima”. È proprio ciò di cui parla Hellinger! L’anima di
coloro che hanno ricevuto la vita a spese di molte altre persone fatica
ad accettare la vita a cuor leggero nei confronti di coloro che hanno
precedenza su di loro. Al contrario di Ildegarda, Hellinger propone
una soluzione terrena. Il cliente può dire a tutti gli altri: “Ho ricevu-
to la vita a spese di voi tutti. Lo rispetto. Non deve essere stato inuti-
le”. Certo non è facile.
L’arte di separarsi bene
Come già detto in caso di separazione è importante che al momento
dell’addio entrambi si assicurino di portare con sé nel futuro il buono
e il bello del rapporto. Quando ci si trova davanti a un cumulo di ma-
cerie non è certo facile vedere il bello, si ricorda piuttosto il periodo
logorante che ha condotto alla separazione. Spesso ci si chiede: “C’è
stato qualcosa di buono? Come ho potuto essere così cieco?”. Al mo-
mento dell’addio aiuta pensare al periodo iniziale del rapporto, che
porta con sé le esperienze più belle.
Molte coppie non lo fanno. Chi si lascia con odio, spesso non è
aperto per iniziare un altro rapporto. Certo, portare con sé il bello co-
me regalo nel futuro fa male. Proprio per questo se ne parla così po-
11. Thomas Schäfer, Leben, Werk und Musik der Hildegard von Bingen [Vi-
ta, opere e musica di Ildegarda di Bingen], con il Cd A feather of the breath
of God [Un anelito del respiro di Dio], München 1996, e Hildegard von Bin-
gen: Heilwissen [Conoscenza che guarisce], edito da Manfred Pawlak, Frei-
burg 1994.
76 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
co. Questo dolore è necessario e chi lo attraversa è di nuovo maturo
per un nuovo legame. Allo stesso modo è importante anche che en-
trambi affrontino la loro parte di colpa al momento dell’addio.
Cercare i colpevoli dopo una separazione serve generalmente so-
lo ad allontanare il dolore. In particolare il fallimento di un matrimo-
nio quando i figli sono ancora piccoli è legato a un profondo dolore.
Naturalmente anche i bambini sono coinvolti nella separazione. Una
ricerca riguardante le conseguenze delle separazioni sui bambini ha
evidenziato che il primo impulso dei bambini è: “Devo avere sbaglia-
to qualcosa, per questo i miei genitori si separano”. I bambini preferi-
scono essere colpevoli piuttosto che dare la colpa ai genitori. Per que-
sto essi provano sollievo se i genitori dicono: “Noi come coppia abbia-
mo deciso di separarci. Restiamo comunque i vostri genitori e voi sa-
rete sempre i nostri figli” (OL: 47 segg.). Hellinger afferma che se una
coppia affronta il dolore, può separarsi con tranquillità e affrontare al
meglio tutte le questioni, prima fra tutte l’affidamento dei figli.
Tuttavia, l’odio rappresenta solo l’altro lato dell’amore e del do-
lore e nasce quando una persona si sente ferita nell’amore. Chi colti-
va l’odio, non ha accesso all’amore. La soluzione sarebbe: “Ti ho mol-
to amato. Mi fa molto male”. Dopo una frase del genere, l’odio scom-
pare ed è possibile riconciliarsi. L’odio, invece, non può essere segui-
to dalla riconciliazione, perché esso ci fa perdere proprio ciò che desi-
deriamo raggiungere.
Naturalmente si pone la domanda di quando una separazione
rappresenta la soluzione migliore e a quali condizioni si può tentare
un nuovo inizio con il partner. Quando una coppia si rivolge a Bert
Hellinger e afferma di non poter più vivere insieme, egli verifica quan-
to impegno essi siano ancora disposti a profondere. Se l’idea della se-
parazione causa loro grande dolore, una riconciliazione è ancora pos-
sibile. Se invece non fa più male, regna l’indifferenza, che costituisce
il più grande nemico dell’amore.
Rabbia nei confronti del partner
La rabbia nei confronti del partner può avere molte ragioni, come ad
esempio un dolore che non si vuole ammettere. Tuttavia la rabbia che
colpisce il partner affonda spesso le proprie radici nella storia perso-
nale ed è dunque rivolta contro la persona sbagliata. Una donna, quan-
do era bambina, fu ricoverata per lungo tempo in una clinica pediatri-
ca da sola. In una situazione del genere il bambino prova rabbia nei
UOMINI E DONNE 77
eBook acquistato da rosalba faraci
confronti della madre assente e si verifica l’interruzione del movimen-
to già descritta precedentemente. Tutto ciò ci accompagna nell’età
adulta. La rabbia precoce contro la madre viene riversata sul marito,
che pure è assolutamente innocente. La soluzione è portare a termi-
ne il movimento interrotto verso la madre.
Non sarebbe invece d’aiuto che la donna gridasse la sua rabbia
contro il marito durante una seduta di psicoterapia. Non è questo il
problema. Non farebbe che peggiorare la situazione. Coltivare l’odio è
facile, perché ci evita di affrontare il dolore che c’è dietro. Se invece si
dice: “Mi fa male”, si giunge a un altro livello.
L’odio può rappresentare un sostitutivo anche da un altro pun-
to di vista. Se ad esempio ho fatto qualcosa a qualcuno, la rabbia può
servire a evitare di affrontare la colpa. Se si è evitato di dover prende-
re o pretendere qualcosa dal partner, ci si arrabbia talvolta con lui, in-
vece che con se stessi. La rabbia diventa un sostitutivo della giusta
azione.
Naturalmente vi è anche una rabbia positiva. Se qualcuno mi at-
tacca ingiustamente, la rabbia mi aiuta a difendermi o a impormi. La
rabbia svanisce dopo avermi permesso di agire.
Come influiscono i figli o l’assenza di figli
sul rapporto di coppia?
Per Hellinger è fuori discussione che l’uomo e la donna siano orien-
tati verso una terza persona: sui figli. Il maschile e il femminile “si
completa solo in un figlio”. Secondo Hellinger essere uomo ed essere
donna sono legati alla paternità e alla maternità. Il rapporto di coppia
ha comunque la precedenza sulla genitorialità, in quanto è nato pri-
ma. Solo se i genitori rispettano tale gerarchia, tutti si sentono bene.
Se invece il figlio, come accade oggi in molte famiglie, costituisce il
centro della famiglia, si sentono tutti insicuri, in particolare il bambi-
no. È così che nascono i “piccoli tiranni”, come descrive Irina Prekop,
la fondatrice della terapia dell’abbraccio.
Vi è un’altra condizione che consente ai figli di crescere bene: “il
rispetto e l’amore che i genitori riescono a dare al partner, saranno in
grado di dare anche ai figli”. Ciò che non riescono a dare al partner,
non riusciranno a dare nemmeno ai figli. Ciò che li disturba nel rap-
porto, li disturberà anche nei figli (MFL: 150 segg.).
Il fatto che il rapporto fra uomo e donna sia orientato verso i fi-
gli può forse apparire semplicistico e antiquato. Tuttavia l’andamento
78 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
di un rapporto di coppia è fortemente influenzato da come viene af-
frontato quest’argomento.
Un uomo sui quarant’anni si lamentava con me che il rapporto
con la fidanzata coetanea, che continuava da più di vent’anni, non
funzionava più. Provavano indifferenza l’uno per l’altro e continuava-
no a vivere insieme solo per abitudine. Questa coppia si era persa al-
cune cose, quando vi era ancora tempo per farle. Alcuni temono la fe-
de nuziale come il demonio l’acqua santa. Essa dimostra invece che la
coppia è consapevole dell’appartenenza l’uno all’altro e consente di
mostrare il legame all’esterno. Il matrimonio rappresenta un’inizia-
zione che rende vincolante il rapporto di coppia.
I rapporti di coppia non sono statici e in determinati momenti la
coppia raggiunge dei punti di svolta. Spesso ci si rende conto che è ar-
rivato il momento di sposarsi o di avere dei figli, ma si evita di farlo.
Oltrepassare una fase così importante con indifferenza può costituire
la condanna a morte del rapporto. Il rifiuto del matrimonio deriva ge-
neralmente dalla mancata separazione dalla famiglia d’origine. Lui o
lei vogliono semplicemente continuare a essere bambini. Chi esclude
a priori l’impegno del matrimonio, non accetta il legame in quanto lo
relativizza. Il rapporto di coppia non è più in grado di ottenere il po-
sto che gli spetta nello sviluppo e nella maturazione personale12.
Un altro punto essenziale che la coppia ha ignorato è la questio-
ne dei figli. “In effetti - disse l’uomo - avrei certamente immaginato di
poter avere dei figli. Tuttavia in tutti questi anni non ne abbiamo mai
parlato”. Ora era troppo tardi. Erano sempre sfuggiti alla lotta consa-
pevole a favore o contro la nascita di un figlio con una conseguente
stagnazione del rapporto. I due non avevano capito che l’amore non è
un dato di fatto, ma si basa sulla crescita. Evitando la crescita e i pas-
si a essa collegati, le fondamenta del rapporto vacillano.
Cosa fare invece se un uomo o una donna non possono avere
bambini per motivi medici e il partner desidera dei figli? In questi casi
Hellinger sostiene che l’altro ha il diritto di andarsene. Se decide di re-
stare, il partner deve rispettare la rinuncia ai figli. Se ad esempio un
uomo, come dice Hellinger, “non riesce a portare a compimento l’amo-
re”, la donna ha il diritto di lasciarlo e cercarsi un altro uomo. Tutto
ciò può apparire spietato, ma è coerente se il rapporto fra uomo e don-
12. Queste e altre domande sono state trattate dettagliatamente da Hans Jel-
louschek nel suo libro L’arte di vivere in coppia, MA.GI. 2003.
UOMINI E DONNE 79
eBook acquistato da rosalba faraci
na deve essere orientato verso i figli. “Crudele” e coerente fu anche il
consiglio che Hellinger offrì a una donna a cui la maternità non era ne-
gata per motivi medici, ma per il rifiuto di avere un figlio proprio.
“Se tuo marito vuole un figlio e tu no, significa che il vostro rap-
porto è finito. Devi considerarlo coma la conseguenza della tua deci-
sione, altrimenti lo inganni. Se ciononostante tuo marito decide di re-
stare con te, devi manifestargli espressamente il tuo rispetto” (OL: 52).
Una volta la maternità era la cosa più ovvia del mondo. Le don-
ne si realizzavano mettendo al mondo molti figli ed erano rispettate
nel loro ruolo di casalinghe e madri. Oggi molte donne rinunciano al-
la maternità a favore della carriera, senza rendersi conto che in que-
sto modo si privano di un’esperienza essenziale per lo sviluppo della
loro femminilità. Se una donna giunge alla conclusione che per lei
non è possibile una maternità appagante, Hellinger le consiglia di ela-
borare la frustrazione della perdita per “arricchire qualsiasi altra sua
azione. Se intraprende una carriera con questa consapevolezza, si sen-
tirà più realizzata di quanto sarebbe possibile se dicesse con disprez-
zo: ‘Cosa m’importa di bambini, chiesa e cucina’. O se considerasse un
progresso ciò che invece rappresenta anche una perdita” (AWI: 186).
Queste frasi sono valse a Hellinger la nomea di conservatore.
Non sarebbe però giusto attribuirgli il desiderio di tornare ai “bei vec-
chi tempi”. Il suo modo di vedere deriva dall’osservazione della realtà,
che non possiamo e non dobbiamo cambiare. Ci stimola a guardare
ciò che abbiamo perso e ad attribuirgli “un posto nel nostro cuore”.
Ricordando e affrontando ciò che è possibile, conferiamo profondità
alle nostre azioni (AWI: 187).
Mio nonno aveva undici fra fratelli e sorelle. Nel paese dove vi-
veva non era un caso isolato. Nella società attuale, con tutti i suoi bi-
sogni, ciò diventa irrealizzabile. Hellinger desidera mostrarci la pie-
nezza che abbiamo perso.
Fecondazione assistita e sterilizzazione
Il nostro tempo ha ceduto al delirio d’onnipotenza. Oggi diamo per
scontate cose che - almeno secondo me - non lo sono affatto.
Una coppia lesbica stava decidendo se rivolgersi ad una banca del
seme per avere un figlio. La due donne volevano infatti “diventare una
vera famiglia”! Se fossero riuscite ad avere un figlio, vi sarebbero sta-
te gravi ripercussioni sia per la madre che per il bambino. Basta pen-
sare che il bambino diventerà grande. Come si sentirà senza padre?
80 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Dubito che si possa definire ingenuità, in ogni caso è spavento-
so che lo sviluppo della medicina fornisca sempre più occasioni all’uo-
mo per essere infelice.
Anche una donna, che a causa della sterilità del marito, si affida
all’inseminazione con il seme di un altro uomo mette fine al matri-
monio. Sono cose da non prendere alla leggera. Un’inseminazione ar-
tificiale con il seme del marito non mette invece in pericolo il matri-
monio.
Gravi sono anche le conseguenze della sterilizzazione. In occa-
sione di un discorso in pubblico Hellinger si è espresso così su questo
argomento: “Se un uomo e una donna si sono fatti sterilizzare prima
dell’inizio di un rapporto, non può nascere un legame. Tali rapporti
non sono vincolanti e in caso di separazione il dolore è minimo”.
Nella successiva tavola rotonda il pubblico aveva la possibilità di
porre delle domande. Uno dei presenti era “molto preoccupato” per
ciò che aveva sentito, in quanto si era fatto sterilizzare ed era separa-
to. Hellinger gli disse:
“Le azioni hanno delle ripercussioni. Non si può più tornare in-
dietro. Se però si affrontano le conseguenze13, è possibile trarre una
grande forza che ci permette di fare cose che altrimenti non avremmo
fatto. La forza può agire solo affrontando la perdita. È invece finita con
ciò che è stato iniziato”.
Aborto
Dal momento che l’uomo e la donna sono orientati verso i figli, un
aborto non può non avere conseguenze sulla coppia. Se viene pratica-
to un aborto, il rapporto è destinato a fallire. Chi guarda la vita con oc-
chi attenti, troverà numerose conferme.
Riporto uno dei tanti esempi che ho incontrato: una donna so-
steneva che lei e il marito provavano indifferenza l’uno per l’altro. Lui
dormiva in una stanza al piano terra, mentre lei si era sistemata nel
sottotetto. La coppia si vedeva raramente. Ognuno viveva la propria
vita. Anche se sulla carta il matrimonio era ancora valido, dentro di lo-
ro era finito già da molto tempo. Le chiesi cosa fosse successo. “Nien-
te”, rispose la donna. Posi altre domande, senza approdare a nulla.
Poi mi informai da quanto tempo la situazione fosse così dispe-
13. Ciò comporta anche che l’uomo deve accettare il dolore della perdita e non
fare finta di nulla.
UOMINI E DONNE 81
eBook acquistato da rosalba faraci
rata. Lei rispose: “da circa sette anni”. Continuai a indagare e infine la
donna mi disse di avere avuto un aborto sette anni prima. Quando le
avevo chiesto cosa fosse accaduto, non le era venuto in mente. Nella
sua coscienza l’aborto non aveva alcuna importanza. Per molti l’abor-
to costituisce un metodo anticoncezionale. Le rappresentazioni delle
costellazioni familiari mostrano invece un’altra realtà.
La donna del nostro esempio non era d’accordo sull’aborto, ma
il marito la costrinse. Il ventre di una donna appartiene però solo a lei
- a nessun altro. Per questo sono entrambi colpevoli. Hellinger sostie-
ne che generalmente un aborto mette fine al rapporto. Con l’aborto si
rifiuta anche il partner, in fondo un bambino è frutto anche dell’altro.
Abortire significa dunque: “Ora siamo divisi come coppia”. Le donne
si puniscono spesso sviluppando malattie anche se la loro coscienza
può essere totalmente a favore dell’interruzione di gravidanza.
Un’altra cliente aveva intenzioni suicide ed era gravemente de-
pressa. Diverse psicoterapie non avevano avuto alcun esito. Un’anali-
si del sistema attuale mostrò che aveva abortito cinque volte - sempre
con uomini diversi. Nell’ultimo caso si era trattato di vero e proprio
omicidio. Al settimo mese di gravidanza la donna si era rivolta a un
medico per abortire dato che non voleva il bambino. Il medico l’ac-
contentò e fece passare il tutto per un parto prematuro con morte del
feto. Per numerosi casi analoghi egli fu poi arrestato. La donna non si
era mai posta il dubbio di avere avuto un comportamento colpevole.
Tuttavia, la sua anima non aveva dimenticato i bambini abortiti e so-
prattutto l’ultimo ucciso. Durante una rappresentazione con i simbo-
li sperimentò quanto male si sentissero i bambini assumendo la loro
posizione. “Li ho sempre odiati! Ho sempre evitato di pensare a loro”,
disse. In questo caso una terapia che affronti solo i sintomi della de-
pressione è destinata a fallire.
Fortunatamente, è possibile trattare correttamente gli aborti.
Una mia cliente fece intuitivamente la cosa giusta: la rappresentazio-
ne del suo sistema attuale con i simboli aveva mostrato chiaramente
il rapporto positivo del bambino abortito con la madre. Durante la
rappresentazione i bambini abortiti sono spesso vacillanti al loro po-
sto. Chiesi alla donna come si fosse sentita. “Male”, rispose. “Ho sof-
ferto per molto tempo e mi sono occupata molto del bambino”. Il rap-
porto con il partner era finito. Se si fosse comportato come la donna,
sarebbe stato possibile ricominciare.
La donna si era comportata come suggerisce Hellinger in caso di
82 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
aborto. Durante una rappresentazione chiede ad esempio alla donna
di dire: “Mio caro bambino! Ora ti riservo un posto nel mio cuore” e
“Mi dispiace. Rispetto il tuo sacrificio”, oppure “Lo accetto come re-
galo”. In questo modo il bambino morto si sente rispettato. La sua
morte non è stata inutile.
In caso di aborto all’interno di un rapporto di coppia esistente,
Hellinger consiglia di mostrare al bambino per un periodo prolunga-
to (circa un anno) la vita: fiori, uccelli, fratelli e sorelle, l’ambiente in
cui sarebbe cresciuto… Chi lo fa con amore, viene confortato con un
dolore che risana. Quando i tempi sono maturi, i genitori si congeda-
no dal figlio. Poi tutto ciò deve arrivare a una fine. Il bambino si è fi-
nalmente riconciliato. Per la coppia il primo rapporto è concluso, ma
è possibile cominciarne un altro con la stessa persona. A un semina-
rio tenuto da Hellinger partecipò una donna che aveva subito nume-
rosi aborti. Hellinger le disse: “Non riuscirai più a creare un rapporto
di coppia. Te lo sei giocato”.
Al termine Hellinger commentò: “Le mie affermazioni sono im-
possibili. Se mi fossi espresso con cautela, non avrebbe saputo orien-
tarsi. Ora deve affrontare ciò che ha fatto. Non voglio saperne più nul-
la. È assolutamente irrilevante. Mostrandomi un interlocutore senza
pregiudizi l’ho rispettata. Si tratta di una forma di rispetto. Ciò che ho
detto è giusto, ma non ci credo. C’è una grande differenza. Non mori-
rei per questo, ma al momento è ciò che sento” (ZG: 205).
Credo che questa citazione mostri ciò che sta dietro al “modo
autoritario” e alla “durezza” di Hellinger. Egli non è un terapeuta che
si mantiene impersonale per non pestare i piedi ai clienti. Pretende
molto da loro - tutto il resto sarebbe una mancanza di rispetto nei
confronti di chi chiede aiuto. I critici di Hellinger devono tenere pre-
sente che il cliente può dire in qualsiasi momento: “Quel Hellinger è
matto! Continuo come ho sempre fatto”. In questo caso la responsa-
bilità è del cliente, non del terapeuta. Anche partendo dal presupposto
che i consigli di Hellinger possano essere dannosi, il cliente è respon-
sabile delle proprie azioni. Tutto il resto è un abuso della propria po-
sizione. Se qualcuno mi suggerisce di andare a sbattere contro un
muro di cemento per guarire il mal di testa, mi pongo la domanda: di
chi è la responsabilità? Di chi mi ha dato il consiglio o mia, che l’ho
seguito senza riflettere?
In caso di aborti frequenti è possibile notare che la felicità ab-
bandona il rapporto di coppia. Un esempio: mi ricordo di una rappre-
UOMINI E DONNE 83
eBook acquistato da rosalba faraci
sentazione con i simboli, che ha mostrato un caos incredibile. La don-
na era rimasta incinta di diversi uomini e aveva subito numerosi abor-
ti. C’erano inoltre diversi partner con i quali non aveva concepito al-
cun figlio. Non appena la donna ebbe finito di disporre le persone e si
rese conto del quadro che ne era derivato, disse spontaneamente: “Os-
servando tutto questo capisco come mai nulla funziona”. Viveva sola
da molti anni.
Desidero terminare accennando agli aspetti socioculturali del-
l’aborto. In Cina, dove l’aborto rappresenta quasi una strategia di so-
pravvivenza, questa misura avrebbe forse un altro significato (vedi
AWI: 127).
Fedeltà e infedeltà
Chi si aspetta che Hellinger giudichi la fedeltà dal punto di vista mo-
rale, sarà probabilmente deluso. Durante un seminario disse:
“Cosa c’è di tanto terribile se qualcuno instaura un’altra relazio-
ne? Chi rimane ferito? L’innocente si comporta come se avesse diritto
di tenere l’altro per sempre. Si tratta di una presunzione. Invece di
tentare di trattenere l’altro con amore, lo perseguita. E l’altro dovreb-
be tornare? Non può più. Se l’innocente si è vendicato troppo, il col-
pevole non può più tornare da lui. Quindi sono a favore dell’umanità
e della misura” (OL: 219).
Dalla fedeltà può nascere del male e dall’infedeltà del bene. Di-
pende dalle circostanze. La richiesta di fedeltà incondizionata è spes-
so legata al fatto che chi la pretende si comporta da genitore. In que-
sto modo viene messa in discussione la parità fra i partner. L’altro cer-
ca quindi un’amante per rivivere un rapporto fra pari. È colpevole per
questo? Se al contrario uno dei partner non è ancora riuscito a sepa-
rarsi dai genitori, cerca la madre o il padre al di fuori del rapporto. An-
che il rapporto con un fratello o una sorella può talvolta compromet-
tere il rapporto di coppia.
Un esempio: una donna non dormiva più già da molto tempo con
il marito. Anche i contatti più teneri le davano fastidio e l’uomo ne sof-
friva molto. Alla fine non ce la fece più e trovò un’amante, ma conti-
nuò a vivere con la moglie e i figli. Durante la rappresentazione, la
moglie era attratta dal fratello morto che aveva cresciuto quasi come
una madre. Era morto per un tragico incidente. Il marito non la inte-
ressava quasi.
Durante la rappresentazione non riuscì a dire al fratello: “Tu sei
84 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
morto. Io vivo ancora un po’, poi morirò anch’io” oppure “È stato ter-
ribile, ma pensando a te andrò avanti bene. Ti prego guarda la nostra
famiglia con benevolenza”. Non volle nemmeno provare a posizionar-
si vicino al marito. “È troppo vicino”, disse. Voleva stare con il fratel-
lo. Anche quando si rese conto che il fratello era molto rattristato dal
suo comportamento, non cambiò nulla.
Se il matrimonio fallisce, una persona all’esterno può giudicare
colpevole il marito che tradisce, ma dalla rappresentazione appare
chiaro perché ha trovato un’amante. La rappresentazione ha dimo-
strato inoltre che i figli si sentivano più sicuri dalla parte del padre che
della madre.
In caso di infedeltà spesso l’uno accusa a gran voce l’altro. Se
l’innocente parla del partner con amici e parenti in termini quali: “Io
sono il buono, lui il maiale”, lo perderà. La soluzione consiste nel per-
mettere al partner di tutelare la propria immagine e dargli l’opportu-
nità di rimettere a posto le cose.
Una fedeltà intesa correttamente nasce dall’amore, non dalla co-
strizione. Per Hellinger fedeltà significa: “rispettami e dimostrati affi-
dabile per ciò che dobbiamo fare insieme”. Ciò vale in particolare
quando ci sono dei figli. Nelle coppie senza figli la fedeltà ha un valo-
re inferiore.
Al di là di tutto quanto detto, la freccia di Cupido può colpirci
quando meno ce lo aspettiamo. In presenza di fedeltà e affidabilità nei
confronti del partner, un tale rapporto esterno può, in determinate
circostanze, avere effetti benefici. Questo argomento viene trattato
anche in una lettera che Hellinger scrive a un cliente. Il suo punto di
vista è talmente particolare e pieno di saggezza da rendere opportuno
riportarla integralmente:
“La prima cosa è non dire nulla del tuo passo falso, altrimenti
scarichi sugli altri il peso che spetta a te portare. La seconda cosa è che
delle due relazioni, una prevale nettamente. L’altra sembra solo più
bella, perché la vivi senza il senso di responsabilità legato a tutta la
faccenda. Terzo, la nuova relazione è stata importante per te. Prendi-
la dunque come un regalo. Tuttavia può conservare il suo valore solo
se la concludi ora” (FWW: 28).
UOMINI E DONNE 85
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Dinam iche ch e
fa nn o a mmalar e
I
l legame fra i membri della famiglia fa sì che chi nasce dopo
vuole trattenere chi è nato prima per impedirgli di andarsene.
Spesso chi nasce dopo vuole seguire i membri della famiglia
morti, soprattutto se chi è nato prima ha avuto un destino particolar-
mente difficile. Allo stesso modo questo profondo legame fa ammala-
re i bambini sani quando i genitori soffrono. I figli vogliono essere si-
mili ai genitori. Se i genitori sono malati o si sono resi colpevoli, i fi-
gli vogliono inconsciamente fare lo stesso. Quando in una famiglia vi
sono infelicità, colpa o gravi malattie, anche i figli vogliono sentirsi
partecipi. Per garantirsi l’appartenenza al sistema familiare sono di-
sposti a fare molti sacrifici.
In questo modo i figli rinunciano spesso alla felicità e alla salu-
te. Sono convinti che rinunciando a una vita piena possano salvare la
felicità e la salute degli altri. A tutto ciò non contribuisce solo il lega-
me, ma anche l’esigenza di compensazione fra vantaggi, felicità, salu-
te, vita e innocenza degli uni e svantaggi, infelicità, malattia, morte e
colpa degli altri. La compensazione avviene quando coloro a cui le co-
se vanno bene fanno in modo di essere anch’essi infelici.
Talvolta le storie familiari continuano così per molti anni. Nella
famiglia di un cliente accadeva sempre che la figlia maggiore restasse
incinta al di fuori del matrimonio per sposare poi un altro uomo. L’ana-
lisi dell’albero genealogico mostrò che questa tradizione continuava
ininterrotta dal XVI secolo. Inconsciamente i figli dicono: “Voglio di-
ventare come…”, ad esempio come la madre gravemente malata o co-
me il padre morto prematuramente di tumore. I figli si augurano quin-
eBook acquistato da rosalba faraci
di “magicamente” la malattia e la morte. Per questo, oltre all’interven-
to medico, può essere utile analizzare le dinamiche interiori dei mala-
ti con l’aiuto delle rappresentazioni delle costellazioni familiari.
Osserviamo ora in dettaglio le dinamiche che possono fare am-
malare fisicamente e/o psichicamente.
Meglio io di te
Una paziente cinquantenne era malata di cancro al seno in fase termi-
nale. Tutto il suo corpo era pieno di metastasi e sapeva che la morte
non avrebbe tardato ad arrivare.
Raccontando la storia della sua famiglia affermò di vedersi anco-
ra al letto di morte della madre. Allora aveva diciassette anni. La ma-
dre era malata di tumore e soffriva molto. La figlia le teneva la mano
e pensava: “Io potrei sopportare il tumore meglio di te! Perché solo tu
e non io?”. Se ne ricordava come se fosse stato ieri.
Bert Hellinger definisce questa dinamica “Meglio io di te”.
Più di tre decenni dopo il suo desiderio è stato esaudito, ma il do-
lore della madre non ha certamente potuto mitigarlo. Al contrario: le
rappresentazioni delle costellazioni familiari dimostrano sempre che
il rappresentante della morte è molto infelice se chi è nato dopo ag-
giunge dolore a dolore. La frase pronunciata dalla cliente: “Tu sei
morto, io vivo ancora un po’, poi morirò anch’io” ha qualcosa di ricon-
ciliante. A seconda delle circostanze sarebbe possibile pronunciare
un’altra frase: “Ti prego benedicimi anche se resto”. Se una persona
viva riesce a pronunciare queste frasi, il rappresentante del morto rea-
gisce spesso con sollievo perché sa di poter stare bene all’interno del-
la famiglia. Paradossalmente, avvicinarsi ai morti e parlare con loro
amorevolmente aumenta la propria forza vitale.
Alcuni fanno fatica a pronunciare le frasi risolutive. Se si chiede
al cliente di guardare il morto negli occhi e di dirgli: “Ti seguo per
amore”, oppure, “Per amore sto male anch’io”, qualcosa si può mette-
re in movimento in quanto queste frasi rispecchiano la realtà. Dicen-
do la verità, fatto percepito da alcuni come una provocazione, il mala-
to si rende conto probabilmente che il suo sacrificio non serve né a se
stesso né al morto.
Il malato può rendersi conto che il suo amore non è in grado di
superare i confini fra se stesso e il morto e che tali limiti devono esse-
re rispettati. Il morto ha il diritto di essere considerato una persona a
sé stante. Non vuole affidarsi unicamente all’amore di chi resta. Per
88 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
rispettare il morto come essere a sé stante, Hellinger fa ripetere una
frase tipo “Me ne faccio carico al tuo posto”, finché il malato non per-
cepisce il morto come una persona autonoma.
Le frasi “Meglio io di te” o “Me ne faccio carico al tuo posto” con-
ducono allo scopo. Talvolta accade che chi esegue la rappresentazione
pronunci queste frasi con profonda nostalgia. Hellinger lo rispetta, il
suo compito è quello di rendere visibile l’amore del figlio. Chi parteci-
pa a una scena del genere durante un seminario, può restare molto
scosso, ma essa determina talvolta un nuovo orientamento nel malato
dopo settimane o mesi. La consapevolezza della vecchia forma d’amo-
re, che ci ha fatti ammalare, può anche essere in grado di guarire.
Ti seguo
Secondo l’esperienza di Hellinger, nell’esempio della donna morta di
cancro entra generalmente in gioco anche una seconda dinamica. Se
i genitori decidono di andare incontro alla morte e i figli vogliono im-
pedirlo con “Meglio io di te”, nei genitori è spesso presente un’altra
frase: “Ti seguo”. I genitori la pronunciano come figli adulti nei con-
fronti dei genitori, dei fratelli o delle sorelle morti prematuramente o
a seguito di gravi patologie e li seguono nella malattia o nella morte.
Se un figlio vede che i genitori vogliono seguire un morto o un
malato, può dire: “Caro papà, cara mamma, anche se tu vai, io resto”,
oppure “Anche se tu vai, ti rispetto. Resti sempre mio padre, resti sem-
pre mia madre”. Se uno dei genitori si è suicidato: ”Mi inchino davan-
ti alla tua decisione e al tuo destino. Resti sempre mio padre, resti
sempre mia madre; e io resto sempre tuo figlio” (OL: 375/376).
La fede cristiana può essere talvolta nemica della vita?
Sia “Meglio io di te” che “Ti seguo” vengono pronunciati con la mi-
gliore coscienza, in quanto l’interessato si sente in armonia con la
propria famiglia. Mi pare sorprendente che sia proprio un ex missio-
nario cattolico a sottolineare l’effetto talvolta patologico della fede
cattolica tradizionale. Le due frasi riportate sopra corrispondono in-
fatti al modello cristiano. Hellinger cita le parole del Vangelo secondo
Giovanni: “Nessuno possiede un amore più grande di colui che offre
la propria vita per i suoi amici”, e richiama l’esortazione di Gesù ai
propri discepoli di seguirlo sul cammino della sofferenza. Precisa-
mente il messaggio di Gesù è il seguente: amore e morte portano re-
denzione. La vita di numerosi santi conferma ai credenti che ci si può
DINAMICHE CHE FANNO AMMALARE 89
eBook acquistato da rosalba faraci
fare carico di malattie e morte al posto di altre persone. Raccogliere-
mo i frutti di tutto nell’aldilà.
L’idea diffusa nel cristianesimo di poter incontrare nuovamente
i morti nell’aldilà, favorisce talvolta la tendenza ad apprezzare di me-
no la vita. La fede nella vita nell’aldilà oppure, come in Asia, nella rein-
carnazione, può farci sottovalutare ciò che c’è qui e ora.
Un capitolo del libro di Hellinger Ordini dell’amore è intitolato
“Del cielo che fa ammalare e della terra che guarisce”. “Cielo” signifi-
ca in questo caso fede cristiana e “terra” sta per amore rivolto al di
qua, che accetta completamente la vita - fino all’ultimo giorno e con
tutto ciò che comporta.
Si potrebbe ribattere che anche Hellinger parte dal presupposto
che vi sia una vita oltre la morte in quanto mette in scena i morti du-
rante le rappresentazioni delle costellazioni familiari e si orienta in
base alla loro reazione. Tuttavia tale obiezione porta nella direzione
sbagliata. La vita oltre la morte non rappresenta solo un “continuare
a vivere in condizioni diverse”.
Le reazioni dei rappresentanti dimostrano che i morti continua-
no ad agire, tuttavia in modo diverso rispetto ai vivi. Il morto è assen-
te, ma continua a esistere. In questo contesto Hellinger cita volentie-
ri il filosofo Martin Heidegger: “Da ciò che è nascosto viene alla luce
qualcosa in ciò che è manifesto che poi ritorna nascosto. Ciò che è na-
scosto è presente come ciò che è nascosto. Ma non scompare. Riemer-
ge e ritorna indietro” (SBK: 159).
Anche la vita scaturisce da ciò che è nascosto, finché non si rituf-
fa in questo regno. Ciò che conta non è ciò che viene transitoriamente
alla luce, ma il grande regno di ciò che non può essere riconosciuto.
Hellinger è convinto che i morti agiscano sulla nostra sfera da
questo regno nascosto. “Se i morti vengono ricordati con benevolenza,
hanno un effetto positivo sui vivi. Se invece una famiglia nega a un
morto l’appartenenza al sistema, ad esempio tabuizzandolo, l’effetto
sui vivi sarà problematico. Metaforicamente tali relazioni vengono rap-
presentate nelle storie di fantasmi e spiriti. Gli spiriti sono esseri a cui
è stata negata l’appartenenza. Bussano finché viene loro concesso un
posto. Non appena lo ricevono, si quietano e influiscono positivamen-
te sui vivi” (cfr. AWI: 76).
Ricordare benevolmente un membro della famiglia dopo la sua
morte è possibile affrontando il grande dolore del commiato. Tuttavia
molti cercano di evitare tale dolore per molto tempo e tentano di con-
90 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
solarsi con la concezione cristiana, che vede un nuovo incontro dopo
la morte. Dirsi addio veramente è possibile solo ammettendo di non
sapere nulla di ciò che viene dopo. Il pensiero di un nuovo incontro è
solo una supposizione e impedisce il corretto commiato.
Se è impossibile accomiatarsi nel bene, il morto viene sovracca-
ricato inutilmente. Questo punto di vista non è sostenuto solo da nu-
merosi poeti, come Rainer Maria Rilke, ma anche dalla saggezza delle
fiabe popolari. La seguente fiaba dei fratelli Grimm ne è un esempio.
La camicia del morto
Una madre aveva un bambino di sette anni, così bello e gra-
zioso che non poteva guardarlo senza volergli bene, ed ella
lo amava più di ogni altra cosa al mondo. Ora avvenne che
egli si ammalò all’improvviso e il buon Dio lo chiamò a sé;
la madre non poteva consolarsi e piangeva giorno e notte.
Era stato sepolto da poco quando il bimbo, di notte, prese a
mostrarsi proprio là dove se ne stava a giocare quand’era vi-
vo; se la madre piangeva, piangeva anche lui, e quando ve-
niva il mattino spariva. Ma poiché la madre non cessava di
piangere, una notte egli le apparve con la bianca camicia da
morto con la quale era stato messo nella bara, e con la co-
roncina in testa; si sedette ai suoi piedi, sul letto e disse:
“Ah, mamma, non piangere più, altrimenti non posso ad-
dormentarmi nella bara: la mia camicia da morto è sempre
bagnata delle tue lacrime che vi cadono tutte sopra”. Al-
l’udire queste parole la madre si spaventò e non pianse più.
E la notte dopo il bambino tornò con una candelina in ma-
no e disse: “Vedi? La mia camicina è quasi asciutta, e io ri-
poso nella mia tomba”. Allora la madre offrì il suo dolore a
Dio, lo sopportò con pazienza e in silenzio, e il bimbo non
tornò, ma dormì nel suo lettino sotto terra1.
Leggendo questa fiaba si può essere portati a pensare che non
1. Jacob e Wilhelm Grimm, Fiabe, Mondadori 1994. Ho affrontato dettaglia-
tamente questa fiaba nel libro Der Mann der tausend Jahre alt werden wollte
- Märchen über Leben und Tod aus Sicht der Systemischen Psychotherapie
Bert Hellingers [L’uomo che voleva vivere mille anni - fiabe sulla vita e la mor-
te dal punto di vista della psicoterapia sistemica di Bert Hellinger], München,
1999 e 2002.
DINAMICHE CHE FANNO AMMALARE 91
eBook acquistato da rosalba faraci
solo i morti influiscono sul regno dei vivi ma anche, al contrario, i vi-
vi sul regno dei morti.
Espiazione della colpa personale
Se un automobilista sopraggiunge a grande velocità in prossimità di
un parco giochi e causa la morte di un bambino, in genere non riesce
più a godersi la vita. Di fronte a un bambino morto sembra impossibi-
le continuare ad avere una vita felice.
Tuttavia una soluzione c’è. Consiste nell’affrontare la gravità
della propria colpa e accettarne tutte le conseguenze. Ciò fa molto ma-
le. Se l’uomo fa qualcosa di buono rispetto alla colpa commessa, ciò
che è accaduto non è stato inutile. La morte del bambino sarebbe in-
vece inutile se l’uomo dicesse: “Dopo tutto quest’orrore la mia vita
non ha più senso”. Depressione, malattia e dolore sono in fondo un
modo semplice per affrontare ciò che è accaduto. La grandezza sareb-
be invece fare ancora qualcosa di buono nella vita nonostante la gra-
ve colpa. In questi casi, il rappresentante di un bambino morto non è
contento di constatare che il colpevole non sfrutta la propria vita.
Hellinger afferma che nella gestione di una colpa personale, la
fede cristiana tradizionale è nemica della vita. Il cristianesimo sostie-
ne infatti la necessità di eliminare la propria colpa. Se invece la affron-
tiamo, essa può diventare fonte di forza. I sensi di colpa nascono solo
in coloro che si rifiutano di confessare la propria colpa. Essa persiste
solo se si cerca di ignorarla e di trovare delle giustificazioni.
Mentre l’ammissione di colpa rafforza chi l’ha commessa, i sen-
si di colpa riescono solo a indebolirlo. Chi accetta la propria colpa può
realizzare cose altrimenti impossibili.
Espiare una colpa altrui
Solo se il carnefice accetta personalmente la colpa si avranno conse-
guenze positive. Se invece chi nasce dopo si fa carico della colpa di un
suo predecessore, ne risulterà indebolito e infelice. Per una migliore
comprensione rimando alla lettura della storia “Il vendicatore” (vedi
pag. 24).
Queste dinamiche sono presenti anche nelle famiglie dei crimi-
nali di guerra. Coloro che nascono dopo si fanno carico, per amore,
della colpa di un carnefice. Durante le rappresentazioni delle costella-
zioni familiari è toccante constatare come il carnefice si senta ancora
peggio se suo figlio si fa carico della sua colpa.
92 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Infelicità come prezzo per la salvezza da un pericolo
Non riusciamo a comprendere perché durante un disastro aereo o un
altro grave evento alcuni si salvano mentre altri muoiono. Spesso i so-
pravvissuti non hanno più il coraggio di essere felici. Se ad esempio
dei minatori restano imprigionati in una galleria, i sopravvissuti si
chiedono: “Cos’ho fatto per essere risparmiato dal destino?”. La solu-
zione sarebbe considerare la propria vita dal momento della salvezza
come un dono, come una “seconda vita” e ringraziare per questo. So-
lo così si può continuare a vivere normalmente, ma un tale atteggia-
mento richiede umiltà di fronte al destino.
La stessa dinamica si presenta in chi ha rischiato di annegare o
comunque di morire da bambino. Se dopo la salvezza, i genitori si di-
menticano di ringraziare insieme al bambino per la nuova vita ricevu-
ta, la vita del figlio proseguirà spesso con scarsa determinazione. Con-
tinuerà a vivere in modo distaccato anche da adulto. Invece di dire in-
consciamente: “Ah, in realtà, dovrei essere morto, come posso conti-
nuare a vivere felice?”, potrebbe affermare: “Ringrazio il destino di
aver ricevuto un’altra occasione. La sfrutterò”.
Questi casi dimostrano l’importanza dell’atteggiamento perso-
nale.
Vengo con te
Al cospetto di una persona morente, in particolare quando un bambi-
no vede morire il padre o la madre, è difficile continuare a vivere co-
me se nulla fosse. Molti preferiscono seguire la persona morta.
La madre di un’eroinomane soffriva di tumore ed era vicina alla
morte. Durante la rappresentazione Hellinger chiese alla ragazza di
dire alla madre “Vengo con te”. Questa frase centrò il nocciolo della
questione e la ragazza la pronunciò in modo del tutto convincente. A
questo punto la rappresentazione venne interrotta. Anche se sembra-
va quasi impossibile, dopo la morte della madre la ragazza si disintos-
sicò. La verità portata alla luce riuscì a cambiare le cose.
In un altro esempio la dinamica non è “Vengo con te”, ma “Ven-
go anch’io”. Una donna malata di tumore al seno disse questa frase al
figlio abortito, concepito durante un rapporto prematrimoniale. In
questo esempio non è chi viene dopo a seguire il predecessore, ma il
contrario. Non solo in caso di aborto, ma anche quando un bambino
muore in tenera età a seguito di un incidente o di una grave malattia,
i genitori mostrano spesso questa dinamica.
DINAMICHE CHE FANNO AMMALARE 93
eBook acquistato da rosalba faraci
In questo esempio Hellinger posizionò la donna vicino al rappre-
sentante del primo partner. Davanti a loro, sul pavimento, sedeva il
bambino abortito che si appoggiava ai genitori. Dal modo in cui la
donna lo guardò e reagì emotivamente fu possibile percepire quanto
profondamente fosse legata a lui e si manifestò il suo desiderio di se-
guirlo. Hellinger chiese all’uomo e alla donna di appoggiare una ma-
no sul capo del bambino.
Poi Hellinger disse alla donna: “Devi guardarlo, il bambino. Di-
gli: “Vengo anch’io’”
Helen: “Vengo anch’io”. (Piange)
Hellinger: “Guardalo”.
Helen: “Vengo anch’io”.
Hellinger: “La frase è vera?”.
Helen: “Non voglio”.
Hellinger: “Ho chiesto se è vera”.
Helen: “Si”.
Hellinger (dopo un po’): “Basta così. Prendi seriamente ciò che
senti”.
(Helen annuisce)
Hellinger: “Bene, è tutto” (SBK: 47).
Molti dei partecipanti si arrabbiarono perché il terapeuta non
“aveva fatto di più”. A questo proposito Hellinger disse:
“La domanda è: cosa agisce? Io? O cos’altro?
È la realtà ad agire, quando viene alla luce e viene affrontata. Se
qualcuno agisce senza tenere conto della realtà, la disprezza e si sosti-
tuisce a lei. Le conseguenze sono gravi.
La realtà, che viene guardata e rispettata, ci è amica. Il terapeu-
ta che vuole fare qualcosa senza tenere conto della realtà, danneggia
il paziente e impedisce la soluzione. S’innalza al di sopra della realtà”
(SBK: 48).
Morire al posto di qualcuno nel rapporto di coppia
Bert Hellinger riporta un esempio a proposito di questa dinamica. Una
donna soffriva di diversi tumori e non riusciva quasi più a parlare. Du-
rante la rappresentazione della famiglia attuale disse: “Mio marito si è
sparato vent’anni fa”. L’uomo era già stato sposato e aveva avuto due
figli dalla prima moglie. Furono rappresentate anche queste persone.
La prima moglie e l’uomo erano uno di fronte all’altro. Il rappresen-
tante dell’uomo disse: “Riesco solo a guardare i suoi piedi”. La rappre-
94 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
sentante della donna disse di provare il desiderio di “volare”. Secondo
l’esperienza di Hellinger quando qualcuno vuole abbandonare una
rappresentazione e volare, significa che vuole suicidarsi.
Hellinger pregò l’uomo di inginocchiarsi ai piedi della moglie.
La donna cominciò a tremare. Iniziò a singhiozzare forte e si coprì il
viso con le mani. Hellinger chiese alla donna di dire: “Lo prendo da te
come un dono”. Aveva colto nel segno, infatti, l’uomo si era ucciso al
posto della donna che aveva voluto continuare a vivere. L’uomo era
morto al suo posto.
Questo caso pone numerosi quesiti. Come può accadere che un
uomo si uccida al posto della prima moglie, anche se è già separato e
convive con un’altra donna? Com’è possibile che una persona si sacri-
fichi per il partner? Non esiste risposta a queste domande, ma l’esem-
pio precedente dimostra chiaramente quanto profondo fosse il legame
con la prima moglie. In un altro esempio si tratta di ammalarsi al po-
sto di un altro. Durante uno dei miei seminari, un uomo, Victor, rac-
contò di soffrire di una grave forma di reumatismi. Dal momento che
il suocero viveva con lui ed era evidentemente molto influente, venne
aggiunto alla rappresentazione. Venne scelta anche una rappresen-
tante per i reumatismi, che fu posizionata vicino a Victor. Poco dopo
il rappresentante del suocero disse con veemenza: “Quella lì (i reuma-
tismi) appartiene a me!”. La rappresentante dei reumatismi si rivolse
alla donna e al suocero e disse: “È questo il mio posto, non ho nulla a
che fare con quell’uomo (Victor)!”.
A seguito di domande più precise, Victor raccontò che la madre di
sua moglie morì prematuramente di un’infiammazione polmonare,
quando la moglie aveva due anni. Il vedovo, il suocero di Victor, non riu-
scì a superare la perdita e si aggrappò alla figlia. Quando i genitori del-
la moglie si accomiatarono e la donna fece lo stesso, la rappresentante
dei reumatismi disse: “Ora sono inutile!”. Nel caso di questa dinamica
è importante che il partner, che porta un peso al posto dell’altro, lo
guardi negli occhi e dica: “Rispetto il tuo fardello e lo lascio a te”. Mesi
dopo Victor venne nel mio studio con la moglie. Disse che i reumatismi
si erano ridotti del 50%. Alla mia domanda cosa ne fosse del restante
50% rispose: “Se lo lascio a mia moglie, ho paura che si ammali!”. Ciò
dimostra quanto sia difficile lasciare al partner ciò che gli compete2.
2. Questo esempio è stato tratto da Thomas Schäfer, Wenn Dornröschen
nicht mehr aufwacht [Quando la Bella Addormentata non si sveglia più],
München 2001.
DINAMICHE CHE FANNO AMMALARE 95
eBook acquistato da rosalba faraci
Come riconoscere gli irretimenti sistemici
Quando i problemi irrisolti del passato influiscono sui rapporti uma-
ni successivi, è impossibile comprendere i comportamenti e le emo-
zioni dell’interessato nel presente. L’identificazione con qualcosa del
passato viene percepita come un “essere fuori da se stessi”. Spesso le
persone coinvolte appaiono come dei posseduti in trance. Quando
una persona mostra sentimenti e reazioni che non trovano una spie-
gazione nella situazione attuale, è possibile che vi siano degli irreti-
menti con vecchi problemi familiari. L’esperienza porta Hellinger ad
affermare che i fanatici della giustizia sono spesso irretiti sistemica-
mente. Chi combatte forzatamente e con fanatismo per qualcosa, ge-
neralmente combatte per qualcuno del suo sistema. Grazie all’espe-
rienza il terapeuta è in grado di capire se i problemi siano legati allo
sviluppo psicologico, come ad esempio a un evento traumatico, o al-
le generazioni precedenti. Hellinger paragona questa capacità al-
l’orecchio musicale.
96 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Ma la tti e
psico soma tich e
e s i nto mi f i si c i
Introduzione
Q uando qualcuno si ammala è perché qualcosa dentro di noi ha
assunto un ordine disfunzionale. Già nell’antichità e durante
il Medioevo, le malattie erano considerate un disturbo del-
l’anima, dell’atteggiamento verso la vita o della vita familiare. Dal
punto di vista religioso, le malattie erano considerate una conseguen-
za dei peccati.
Dal punto di vista sistemico, i “peccati” rappresentano delle vio-
lazioni dell’ordine. Secondo Bert Hellinger mettere “in ordine” signi-
fica:
u accogliere coloro che fanno parte di un sistema;
u rispettare coloro che sono stati e sono disprezzati;
u allontanare coloro che hanno compromesso l’appartenenza al
sistema (SBK: 142);
u non farsi carico di una colpa altrui;
u riconoscere la propria colpa.
L’esperienza di Hellinger con i malati gravi dimostra che qualco-
sa è sempre fuori posto all’interno del sistema familiare. Generalmen-
te la gravità di una patologia è collegata alla gravità del destino della
famiglia.
Delle dinamiche analizzate nel capitolo precedente, sono soprat-
tutto “Meglio io di te” e “Ti seguo” a causare malattie. Diabete, tumo-
re, sclerosi multipla e molte altre gravi patologie sono spesso determi-
eBook acquistato da rosalba faraci
nate da tali dinamiche. Oggi va di moda analizzare le malattie dal pun-
to di vista psicologico e interpretarne i sintomi dal punto di vista sim-
bolico. In questo contesto, Bert Hellinger ha accennato a un punto
importante: è sbagliato che un malato creda di dover riconoscere so-
lo l’aspetto psicologico della patologia per poter guarire.
Hellinger sostiene che non tutte le malattie possono essere mes-
se in relazione agli eventi sistemici all’interno della famiglia. Spesso
un malato si domanda: “Cos’ho fatto per meritarmi il cancro? Qual è
il collegamento sistemico e psicologico?”. La mentalità che si nascon-
de dietro a queste domande corrisponde allo spirito costruttivistico
del nostro tempo, già descritto nella prefazione: “Finché ottengo solo
determinate informazioni, posso rimettere tutto a posto; la salute è
programmabile: basta sostituire il vecchio input dannoso con uno mi-
gliore”. Se il metodo non funziona, il malato trae conclusioni assolu-
tamente sbagliate. Fino all’ultimo è convinto di non essere riuscito a
portare a termine una “riprogrammazione” abbastanza radicale.
Con questa mentalità, il malato evita di affrontare la malattia
causata dal destino e la morte ormai imminente. In base all’esperien-
za, Hellinger sostiene che tale atteggiamento dell’anima è dannoso, in
quanto nasconde una presunzione. La maggior parte di noi cade vitti-
ma del delirio di onnipotenza tipico dei nostri giorni.
Invece di riprendere il controllo il più rapidamente possibile e di
cedere alla curiosità, il malato deve avvicinarsi con rispetto e umiltà
alle forze del destino. Un tale atteggiamento non è certo garanzia di
guarigione, ma offre una possibilità.
Un malato in pericolo di vita può ad esempio immaginare, come
suggerisce Hellinger, la morte come “amica e custode della vita” al
proprio fianco. Di tanto in tanto può inchinarsi di fronte a lei.
Segue un esempio di come Bert Hellinger affronta nei seminari
le persone che credono nella programmabilità della salute. Una don-
na malata di tumore al seno aveva rappresentato tempo prima la sua
famiglia attuale. Durante un successivo seminario voleva rappresen-
tare anche la famiglia d’origine. Sei mesi prima si era sottoposta a un
esame clinico che aveva rivelato la presenza di cellule tumorali nel mi-
dollo osseo: “Voglio ancora lavorarci sopra. Voglio guarire completa-
mente”, disse. Hellinger rispose che forse si aspettava un po’ troppo.
Lotte: “Sono venuta qui apposta da Monaco”.
Hellinger: “Come pensi che mi senta ascoltando queste parole?”
Lotte: “Una volta mi hai detto di ritornare da te per rappresenta-
98 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
re la mia famiglia d’origine”.
Hellinger: “Confermo le mie parole, ma non è così. Aspettando-
ti ciò che tu ti aspetti segui una direzione sbagliata” (SBK: 157).
Nel corso del colloquio Hellinger chiese cosa le aveva suggerito
allora. Rispose di avere una sorella morta prima della sua nascita di
cui portava il nome. In relazione a questa sorella le aveva suggerito di
lasciare agire la “grande anima”, cosa che secondo lei era accaduta.
Aveva instaurato un profondo contatto interiore con la sorella. Inoltre
aveva abbandonato il nome che aveva scelto al posto di quello della so-
rella per assumere il suo vecchio nome. Hellinger le chiese se si sen-
tiva maglio lei o la sorella.
Lotte: “Io. Sono ancora qui”.
Hellinger: “Secondo te io chi credo si senta meglio?”.
Lotte: “Lei”.
Hellinger: “Esatto”.
Lotte (dopo una lunga pausa): “Mi è venuto il batticuore”.
Hellilnger: “Bene. Per ora basta. Lo affronteremo nuovamente
in seguito” (SBK: 158).
Rivolto al gruppo, Hellinger ha sottolineato che la frase chiave,
che fa ammalare, è la seguente: “Voglio guarire completamente”.
“Questa frase blocca l’energia e impedisce alle forze che agiscono nel-
l’anima di svilupparsi. Se Lotte smetterà di credere di stare meglio
della sorella morta, potrà raggiungere un livello superiore. Qui non è
importante (…) che lei guarisca. Si tratta di un livello in cui questa
differenza non conta. E così avviene qualcosa di risanante. Solo a que-
sto livello” (SBK: 158).
Occupiamoci ora di alcune malattie e disturbi psicosomatici.
Non si tratta di elencare definizioni degli irretimenti sistemici, ma di
individuare le relazioni interiori con le patologie, che si sono manife-
state in passato durante le rappresentazioni delle costellazioni fami-
liari. Non si tratta dunque di eventi statici, che rivendicano un qual-
siasi diritto.
Tutte le malattie descritte di seguito possono avere anche
un’origine diversa.
Quando potremo vantare un’esperienza di diversi decenni con le
costellazioni familiari, sarà possibile fare affermazioni più precise.
Quasi ogni anno si svolgono diversi congressi e convegni in Eu-
ropa e nel resto del mondo sulle costellazioni familiari. In queste oc-
casioni migliaia di colleghi si scambiano opinioni ed esperienze.
MALATTIE PSICOSOMATICHE E SINTOMI FISICI 99
eBook acquistato da rosalba faraci
Tumore
Questa patologia è legata a un profondo tabù. Non se ne parla, anche se
il tasso d’incidenza della malattia continua ad aumentare. Spesso i ma-
lati si chiedono cosa hanno “sbagliato” per essere “puniti” in questo mo-
do. Le origini della malattia si trovano invece molto più in profondità.
Nel caso del cancro, come anche di altre malattie mortali, la per-
sona colpita si sente spesso responsabile al posto di altri membri del-
la famiglia che hanno vissuto qualcosa di grave. Da questo profondo
legame nasce, così dice Hellinger un po’ provocatoriamente, una “co-
munità di santi” (SBK: 21). Qui Hellinger fa riferimento alla già cita-
ta concezione religiosa secondo la quale possiamo salvare gli altri dal
dolore grazie al dolore. Ricordiamo qui la donna malata di tumore ci-
tata nel capitolo V: “Meglio io di te”.
Tipico di tale condivisione del dolore è il caso di una cliente. La
donna era stata operata di tumore al seno e non aveva avuto finora al-
cuna ricaduta. La rappresentazione della sua famiglia d’origine aveva
mostrato il profondo legame con il fratello morto. Egli si era amma-
lato in giovane età di una forma aggressiva di tubercolosi ed era mor-
to in circostanze molto dolorose. Durante la rappresentazione disse al
fratello di voler fare ancora qualcosa della propria vita in sua memo-
ria. Molto tempo dopo la rappresentazione, la paziente mi raccontò di
essersi sentita come liberata. La sua depressione sembrava scomparsa
e il rapporto con tutti i membri della sua famiglia era migliorato.
Il lavoro con i malati di tumore ha dimostrato inoltre che spes-
so essi non accettano la sorgente della vita. Hanno problemi ad accet-
tare i genitori così come sono. Hellinger ha scoperto anche che spes-
so i malati di cancro sopportano tutto pur di essere amati, ignorando
completamente i propri limiti. Mi ricordo di due pazienti affette da tu-
more che corrispondono alla descrizione di Hellinger. Entrambe le
donne facevano di tutto pur di non subire un rifiuto. Nei rapporti so-
ciali si sottomettevano costantemente agli altri e accettavano sempre
le opinioni altrui anche quando erano completamente diverse dalle
proprie.
Secondo l’esperienza di Hellinger sono principalmente le clien-
ti affette da tumore al seno a non accettare i genitori. In particolare si
rifiutano di accettare la madre e di inchinarsi davanti a lei. Una don-
na malata di cancro si rivolse così a Hellinger durante un corso: “È più
facile che tu veda gli angeli piuttosto che vedere me inchinarmi da-
vanti a mia madre”. Molti partecipanti furono sconvolti da questo in-
100 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
tervento terapeutico, ma al termine del seminario la donna aveva im-
parato a inchinarsi davanti alla madre. Un anno dopo guarì (SBK: 88).
La mancanza di rispetto nei confronti dei genitori gioca spesso
un ruolo determinante per quanto riguarda il tumore. In un caso di
cancro al midollo osseo (OL: 410 e segg.), un uomo si rifiutò di inchi-
narsi profondamente davanti al padre. Il padre lo escluse dal sistema
e il figlio disse inconsciamente: “Meglio che vada io piuttosto che tu”.
Questo atteggiamento consapevole nei confronti del padre era in real-
tà di profondo disprezzo. Preferiva morire piuttosto che inchinarsi da-
vanti a lui.
Anche a livello di rapporto di coppia, la mancanza di rispetto nei
confronti del partner può essere legata all’insorgenza di un tumore.
Nel suo libro Ordini dell’amore (OL: 464 e segg.), Hellinger racconta
la storia di una donna malata di tumore al seno che non provava alcu-
na compassione per gli uomini - né per il partner precedente né per
quello attuale. In alcuni casi il tumore alla mammella può costituire
l’espiazione di un torto inflitto agli uomini.
Dipendenza
Dipendenza da alcol e stupefacenti
Secondo Hellinger la dipendenza da alcol e stupefacenti è spesso la
conseguenza della mancata accettazione del padre. Alcuni sviluppano
una dipendenza quando la madre dice loro: “Ciò che viene da tuo pa-
dre non serve a nulla. Prendi solo da me!”. Dietro a tale atteggiamen-
to si nasconde il disprezzo per il marito. Il bambino è fedele a entram-
bi i genitori. Si vendica nei confronti della madre che denigra il padre
e prende troppo da lei. Si ricordi qui la storia della ragazza tossicodi-
pendente dell’istituto che voleva morire al posto del padre (capitolo
“Genitori e figli”, sottocapitolo “Principi educativi”).
Dal momento che per la soluzione delle dipendenze è spesso il
padre a giocare il ruolo fondamentale, Hellinger preferirebbe che i
tossicodipendenti venissero curati da uomini invece che da donne.
Se è una donna a svolgere la terapia, si mette spesso fra il clien-
te e suo padre, impedendo così la soluzione. L’accesso al padre può es-
sere garantito al meglio da un uomo. Se una terapeuta è in grado di
attribuire al padre del cliente un buon posto nel suo cuore, è anche in
grado di rappresentarlo, dopo tutto si tratta di immagini interiori po-
sitive (ZG: 290).
MALATTIE PSICOSOMATICHE E SINTOMI FISICI 101
eBook acquistato da rosalba faraci
Spesso i dipendenti da alcol e stupefacenti hanno perso il padre
prematuramente. Hellinger suggerisce agli alcolisti di tenere davanti
a sé una foto del padre e di dire: “Salute, papà, insieme a te mi piace”.
e di bere finché ne hanno voglia. Per alcuni questa terapia può sem-
brare uno stupido scherzo, ma se il malato esegue l’esercizio seria-
mente al cospetto del padre, ottiene un effetto profondo.
Bulimia
La bulimia causa un bisogno di cibo superiore alla media (“attacchi
compulsavi di fame”) che si concludono con il vomito provocato.
Le dipendenze in generale, e la bulimia in particolare, sono cu-
rabili, se il paziente impara a prendere anche dal padre davanti alla
madre. Nelle famiglie con casi di bulimia, il padre conta generalmen-
te poco. Il figlio mangia per fedeltà nei confronti della madre e vomi-
ta per fedeltà nei confronti del padre denigrato.
Durante una rappresentazione con una paziente bulimica la so-
luzione è stata di dire alla madre con coraggio: “Per me il papà è im-
portante quanto te” (FS: 268).
Nel caso della bulimia, prendere dal padre è da intendersi in sen-
so letterale. Quando una paziente bulimica è colta da un attacco di fa-
me, Hellinger consiglia di comprare tutto ciò che il suo cuore deside-
ra, di mettere tutto di fronte a sé e di guardarlo con gioia. Prima di ini-
ziare a mangiare può immaginare di sedersi sulle ginocchia del padre
e di prendere il cibo da lui a piccole cucchiaiate. Prima di ogni bocco-
ne guarda il padre negli occhi e dice: “Con te, caro papà, mi piace. Da
te lo prendo volentieri”. Tuttavia tale esercizio non è facile. Se lo si
prende seriamente, talvolta il solo pensiero è efficace. Una donna bu-
limica scrisse a Hellinger una lettera di ringraziamento per il consi-
glio ricevuto.
“Ti ringrazio della rapida risposta e soprattutto del consiglio del
cucchiaino e di accettare. L’ho sperimentato subito e continuo a farlo
con grande giovamento. Sono tornata subito a mangiare normalmen-
te, come non facevo più da dieci anni!!! Quando mi viene voglia di
mangiare, penso al cucchiaino e l’impulso svanisce” (FWW: 118).
Anoressia
Le rappresentazioni delle costellazioni familiari di persone anoressi-
che dimostrano spesso che il padre tende a uscire dalla famiglia per se-
guire, ad esempio, un membro della sua famiglia di origine morto pre-
102 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
maturamente. In un caso come questo l’anoressica dice: “Preferisco
sparire io, piuttosto che tu, caro papà”. La guarigione può venire da
frasi tipo “Ti prego resta e benedicimi, anche se te ne vai”, al padre e
alla madre “Resto con te, cara mamma”.
Vi sono casi in cui le figlie anoressiche rivolgono la frase “Prefe-
risco sparire io piuttosto che tu” alla madre e non al padre. Nel libro
“Ordini dell’amore” viene descritto il caso di un giovane che aveva so-
lidarizzato con la madre in questo modo (OL: 488).
La psicoterapia, anche la psicoterapia classica della famiglia, ha
creduto per lungo tempo che l’anoressia fosse determinata da un rap-
porto critico fra madre e figlia. Spesso la colpa della malattia viene at-
tribuita alla madre. Tuttavia qualsiasi interpretazione che sminuisce
un membro della famiglia, rende la soluzione più difficile. Le rappre-
sentazioni delle costellazioni familiari dimostrano che la guarigione
viene dalla madre se la figlia le dice: “Resto con te”.
Il frequente passaggio dall’anoressia alla bulimia ha la seguente
origine: l’anoressica non è ancora convinta di restare. Mangia per re-
stare e vomita per andarsene. La soluzione consiste nel dire al padre
o alla madre quando prova il desiderio di vomitare: “Caro papà, io re-
sto” oppure “Cara mamma, io resto”.
Obesità
La rappresentazione della costellazione di una donna obesa ha mo-
strato che si era identificata con la prima moglie del padre e voleva
seguirla. Chi desidera al tempo stesso vivere e morire può, ad esem-
pio, abbuffarsi di cibo per precauzione. Mangia un po’ di più di quan-
to il corpo richieda in quanto mangiare significa: “Io resto”. Quando
si è consapevoli di poter restare, si può tornare a mangiare normal-
mente. Ciò è possibile disidentificandosi con amore. Chi invece teme
di essere costretto ad andarsene, preferisce mangiare un po’ di più.
Quando la persona obesa ha fame, Hellinger consiglia di dire: “Io re-
sto” (FS: 306).
Un altro esempio: una cliente obesa raccontò di avere perso la
madre poco dopo il matrimonio. Le due donne erano molto legate. La
madre era semplicemente caduta a terra morta. Nessuno si aspettava
che morisse. In seguito la donna divenne obesa e anche suo figlio di-
venne molto grasso. Anche in questo caso l’eccesso di cibo può essere
considerato una precauzione per evitare di seguire troppo presto una
persona.
MALATTIE PSICOSOMATICHE E SINTOMI FISICI 103
eBook acquistato da rosalba faraci
Certamente questi suggerimenti non costituiscono una verità
assoluta. In caso di obesità è necessario un approccio medico e natu-
ralmente vi possono essere anche numerose altre cause psichiche.
Depressione
Il capitolo sull’accettazione dei genitori riporta numerosi esempi sul-
l’origine della depressione. Essa è spesso causata dal disprezzo nei
confronti dei genitori. Più si è arrabbiati con i genitori, meno forza ge-
nitoriale si prende da loro e più si diventa depressi. La depressione sva-
nisce se si accettano i genitori così come sono con amore.
La mancata accettazione dei genitori può essere causata anche
da dinamiche diverse. Un esempio: una donna soffriva di una grave de-
pressione da quando era ragazza. Una rappresentazione con i simboli
dimostrò che s’identificava con la prima fidanzata del padre, che ave-
va subito un grave torto. Il padre l’aveva lasciata perché il nonno non
la giudicava all’altezza del figlio. La cliente stava ora pagando per il
trattamento ingiusto riservato alla donna. Sul simbolo che rappresen-
tava se stessa, la cliente sentì una forte vicinanza con la donna. Guar-
dò i membri della famiglia e poi la prima fidanzata del padre e disse:
“Proprio in questo momento provo quel tipico senso di depressione”.
Guardando i genitori affermò: “Mi sento come Cristo. Devo fare in mo-
do che i miei genitori restino insieme”.
Questa sensazione di doversi sacrificare per gli altri dimostra
che l’io si è adultizzato. In un caso come questo il bambino deve ritor-
nare ad assumere il ruolo che gli compete: “Vi accetto e vi rispetto co-
me miei genitori. Vi prego vedete in me vostro figlio”. Nel suo ruolo
di figlio deve abbandonare il proposito di salvare il matrimonio dei ge-
nitori in quanto le questioni legate alla coppia riguardano solo i par-
tner. I bambini che s’immischiano nel matrimonio dei genitori fini-
scono sempre per stare male.
La donna reagì con particolare intensità quando disse alla ma-
dre: “La fidanzata di papà è una cosa. Tu sei mia madre e tu sola sei
quella giusta per me. Ti prego accettami come tua figlia”. La donna
aveva un buon rapporto con la madre, ma in quel momento pianse di
gioia e apparve raggiante. “È come se un peso enorme mi cadesse di
dosso”, affermò. Al padre disse: “La tua precedente fidanzata non è af-
far mio, mia madre è lì” (indicandola). La donna non riusciva ad ac-
cettare la madre come tale in quanto si identificava con la fidanzata
del padre e la madre vedeva in lei una rivale. L’identificazione di que-
104 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
st’irretimento ha aperto la strada verso la madre e il padre.
Per quanto riguarda la sensazione di doversi sacrificare per gli
altri, è venuto alla luce qualcos’altro. La madre era attratta dal padre
morto di tumore. La figlia se n’è resa conto e attraverso il suo dolore
voleva assumere il ruolo di salvatrice della madre e del matrimonio
dei genitori. In questo caso è utile chiedere la benedizione della ma-
dre anche se si resta.
Alcuni mesi dopo la cliente raccontò di avere superato la depres-
sione e di attraversare una fase di grande cambiamento.
Le cause delle gravi depressioni vanno tuttavia oltre ciò che è
stato detto. Spesso sono legate a un profondo dolore all’interno della
famiglia. Ad esempio, entrambi i genitori di una cliente gravemente
depressa erano sopravvissuti al campo di concentramento di Au-
schwitz.
Psicosi
Le psicosi nascondono spesso tabù mantenuti segreti per molto tempo
all’interno della famiglia. Spesso si tratta di omicidio o altri crimini.
Volkmar e Luise partecipano al gruppo a causa del figlio mag-
giore Willi in cura da molto tempo per problemi comportamentali.
La terapia non ha sortito però alcun effetto. Willi è inoltre trascura-
to dal punto di vista igienico. Non è stata fatta alcuna diagnosi preci-
sa. La rappresentazione della costellazione familiare ha dimostrato
che Willi si sente escluso e ne soffre. Luise racconta di un fratello del
padre, ultimo di cinque fratelli. Appena prima dell’inizio del semina-
rio è venuta a conoscenza della seguente storia: appena dopo la na-
scita del terzo figlio la nonna disse: “Buttatelo nella spazzatura, non
voglio più figli maschi, voglio una femmina”. La donna non si occu-
pò quasi del quinto maschio, nato molto gracile. Non si occupò nem-
meno della sua igiene e non lo accettò mai veramente come figlio.
Non si sa nemmeno se lo nutriva a sufficienza. Il bambino morì pre-
sto e nessuno parlò più di lui in famiglia. È evidente che Willi si iden-
tifica con il prozio ucciso. Il suo destino lo “fa sentire pazzo”. Ho rac-
contato in dettaglio questa storia nel mio libro Wenn Liebe allein den
Kindern nicht hilft [Quando l’amore non è sufficiente ad aiutare i
bambini].
Le psicosi possono avere diverse origini. Spesso gli psicotici si
identificano con persone del sesso opposto. Ad esempio una ragazza è
stata ricoverata in psichiatria perché s’identificava con il gemello del
MALATTIE PSICOSOMATICHE E SINTOMI FISICI 105
eBook acquistato da rosalba faraci
padre morto. L’identificazione con l’altro sesso determina spesso an-
che omosessualità.
Un’altra causa delle psicosi è l’identificazione con precedenti
partner dei genitori, che hanno avuto un destino particolarmente dif-
ficile. Anche nel caso in cui un bambino assume il ruolo di partner
della madre o del padre, ad esempio nel caso di genitori single, si pu-
nisce con la pazzia. Altre forme di autopunizione possono essere la
criminalità, la prostituzione o il suicidio.
Anche se in una famiglia vi sono molti membri morti prematu-
ramente possono manifestarsi casi di pazzia. A tale proposito Hellin-
ger racconta il caso di una ragazza schizofrenica. Quando nella rap-
presentazione sono stati aggiunti una sorella della madre e un fratel-
lo della ragazza morti prematuramente, la rappresentante della schi-
zofrenica si è sentita subito normale (AWI: 85).
In base alla mia esperienza, la schizofrenia e la paura di diventa-
re schizofrenici possono nascere dall’identificazione con un membro
psicotico della famiglia. Riporto l’esempio di una rappresentazione
con i fogli di carta: una donna era molto depressa e temeva di diven-
tare schizofrenica. La rappresentazione mostrò che s’identificava con
la sorella psicotica della madre; nessuno aveva mai parlato di questa
zia che si era suicidata in una clinica psichiatrica. Anche la madre del-
la cliente era stata ricoverata più volte per attacchi psicotici.
Data la gravità di tale destino, la giovane donna non aveva osato
essere “normale” e felice. Stando male dimostrava amore nei confron-
ti dei membri psicotici della famiglia. Durante la rappresentazione la
misi di fianco alla madre e le dissi di immaginare che la madre la pren-
desse per mano e che entrambe s’inchinassero di fronte alla zia schi-
zofrenica dicendole: “Ti rispetto. In tua memoria faccio qualcosa di
buono nella mia vita”. La cliente pianse e sentì chiaramente la bene-
dizione della zia. Riuscì di nuovo a sorridere.
Dopo la rappresentazione mi disse di essersi sempre resa conto
di tale relazione. Già da bambina si era sentita molto legata alla zia e
al suo destino. Dal momento che possedeva ancora una foto della zia,
la incoraggiai ad appenderla in casa. Quando i membri tabuizzati del-
la famiglia tornano a essere guardati, possono costituire una benedi-
zione per coloro che vengono dopo di loro.
Disturbi cardiaci
Faccio nuovamente riferimento alla rappresentazione del cliente con
106 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
disturbi cardiaci1. L’amore represso per il figlio che non vedeva da
trent’anni si è manifestato con disturbi cardiaci psicosomatici.
Bert Hellinger scrisse a un paziente con disturbi cardiaci: “I di-
sturbi cardiaci indicano generalmente un’attenzione repressa. Non
appena si manifesta, scompaiono” (FWW: 126). Spesso le attenzioni
vengono trattenute perché si teme che vengano rifiutate o non giun-
gano a destinazione. Di una piena attenzione si può parlare solo quan-
do l’arrivo a destinazione non è importante: “Giungere a destinazione
non aggiunge nulla all’attenzione, e il mancato arrivo a destinazione
non le toglie nulla” (FWW: 126).
Nausea
Secondo l’esperienza di Hellinger, la nausea nasconde spesso senti-
menti repressi, in particolare degli insulti. Essi provengono general-
mente dal passato e, se espressi apertamente, immaginando di pro-
nunciarli guardando una persona negli occhi, la nausea scompare. Si
prova un senso di nausea anche di fronte a una colpa a cui si cerca di
sottrarsi.
Mal di schiena
Hellinger afferma che i dolori di schiena possono essere curati facil-
mente se si escludono cause somatiche, come ad esempio un’atrofia
congenita della spina dorsale. È sufficiente inchinarsi profondamente
guardando il pavimento! Il punto è scoprire davanti a chi. Inchinarsi
significa “Ti onoro”.
L’attuale interpretazione del mal di schiena va in tutt’altra dire-
zione: si pensa che una persona porti pesi eccessivi. Chi si carica in-
consapevolmente un peso eccessivo sulle spalle, percepisce questa
pressione come mal di schiena o ernia del disco. In queste situazioni
è utile pensare a cosa ci si è caricati sulle spalle e perché.
Hellinger non condivide questo punto di vista. Se questa fosse
l’interpretazione corretta, molte meno persone soffrirebbero di dolo-
ri alla schiena. In base alla sua esperienza, il mal di schiena migliora
se ci si immagina di inchinarsi di fronte a una determinata persona.
Spesso si tratta della madre o del padre, talvolta di entrambi.
Un lettore di questo libro mi scrisse: “Dopo avere letto il capito-
1. Vedi capitolo “Come avere successo nelle relazioni di coppia”, sottocapito-
lo “Il legame”.
MALATTIE PSICOSOMATICHE E SINTOMI FISICI 107
eBook acquistato da rosalba faraci
lo “Mal di schiena” si sono reso conto immediatamente di fronte a chi
avrei dovuto inchinarmi. I dolori che mi affliggevano da decenni sono
scomparsi!”.
Mal di testa ed emicrania
In presenza di emicrania aiuta immaginare di rivolgersi ad altre per-
sone, soprattutto alla madre. La causa psicodinamica del mal di testa
e dell’emicrania è un “amore bloccato”.
Hellinger suggerì a una cliente di rivolgersi alla persona amata
allungando le braccia in avanti e di “accettare l’amore con tutto ciò
che ne fa parte e che il cuore desidera” (FWW: 125 segg.).
Durante un seminario, una donna raccontò di soffrire di forti
mal di testa. Hellinger le diede alcuni consigli pratici, che il lettore
può sperimentare personalmente.
“Sai cosa significa il mal di testa? Amore bloccato. Dove deve ar-
rivare questo amore? Espirare può essere un sistema per farlo deflui-
re, anche guardare amichevolmente può essere utile. Si, guarda verso
di me amichevolmente! Buongiorno! (…). Un altro sistema è farlo de-
fluire attraverso le mani” (ZG: 288).
Basta allungare le mani rivolte verso l’alto e immaginare come
l’amore fluisca attraverso di esse. La donna raccontò di avere spesso la
sensazione di non amare abbastanza il marito. Se però immaginava di
essere al suo fianco, la sensazione scompariva. L’amore bloccato sem-
bra essere rivolto al partner mentre spesso indica una madre o un pa-
dre rifiutati.
Neurodermite
La neurodermite è una particolare forma di eczema. La malattia si
manifesta generalmente in età infantile, ma può scatenarsi anche suc-
cessivamente. Compaiono macchie rotonde o allungate talvolta cir-
condate da una zona marroncina. Vengono colpiti spesso il viso, il col-
lo e le estremità. Chi ne soffre è afflitto in particolare da prurito e de-
squamazione. Dal punto di vista delle relazioni sociali, il malato sof-
fre molto quando ha il viso arrossato dall’eczema.
Bert Hellinger è dell’opinione che chi soffre di neurodermite ha
spesso bisogno della benedizione di un precedente partner del padre o
della madre. Un esempio: una donna soffriva da molto tempo di neu-
rodermite. La rappresentazione della sua costellazione familiare evi-
108 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
denziò che si identificava con la precedente fidanzata del padre. Il pa-
dre si era fidanzato con lei nascondendole una grave infezione morta-
le da cui era affetto. Quando la donna lo scoprì si sentì ingannata.
L’uomo guarì, ma lei lo lasciò per avere tradito la sua fiducia. Senza
tale separazione l’uomo non avrebbe conosciuto la futura moglie e la
cliente non sarebbe nata. La cliente aveva dunque ricevuto il dono del-
la vita a spese della precedente fidanzata. A causa dell’identificazione,
il padre non l’aveva mai vista come figlia, ma come la fidanzata di al-
lora e la madre come una rivale, invece di vedere in lei una figlia . Sei
mesi dopo la rappresentazione rividi la cliente. La sua neurodermite
era scomparsa.
La neurodermite può naturalmente avere numerose cause siste-
miche. Non sempre si tratta di identificazione con un precedente par-
tner dei genitori. Un esempio: una donna aveva un figlio piccolo affet-
to da neurodermite. Essendosi occupata approfonditamente della ma-
lattia del figlio, si rese conto da sola che essa dipendeva dalla rabbia
che provava nei confronti del padre del bambino. Si era separata ed era
ancora arrabbiata con lui. Più rabbia provava, più il bambino stava
male. Quando si rese conto dell’effetto deleterio della sua rabbia e si
fece carico della sua parte di colpa, la neurodermite scomparve.
Anche all’interno di un matrimonio e di un rapporto di coppia
ancora esistenti, la rabbia nei confronti del partner può causare la
comparsa della neurodermite in un figlio.
MALATTIE PSICOSOMATICHE E SINTOMI FISICI 109
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Sp i ri tu al it à
e re li gi o ne
Il maestro Lin-Chi diceva:
Sii ciò che sei,
non serve essere speciali.
Mangia il tuo nutrimento,
alleggerisci le tue viscere,
aggiungi acqua,
indossa i tuoi abiti.
E quando sei stanco,
va a dormire.
Gli stolti mi troveranno ridicolo,
ma i saggi capiranno1.
S
econdo Hellinger la frase di Friedrich Nietzsche “Dio è morto”
non è un’affermazione, ma l’esito dell’osservazione della realtà.
Dio si è allontanato dagli uomini. Ciò che prima veniva perce-
pito come forza efficace, oggi non esiste più. Anche le persone pie si
sono rese conto che Dio si è allontanato.
Al posto di Dio viene percepito un vuoto. Anche nelle chiese
molti non sentono più la sua presenza. Hellinger è convinto che un
atteggiamento realmente religioso dovrebbe accettare il vuoto. Si
tratterebbe “dell’azione religiosa più profonda che si possa immagina-
1. Guntram Colin Goldner, Zen in der Kunst der Gestalt-Therapie [Lo zen
nell’arte della terapia gestaltica], Augsburg 1986.
eBook acquistato da rosalba faraci
re”. (Incontro con Tilman Moser e Fritz Simon, Heidelberg 1996). A
tale proposito il libro di Hellinger Verdichtetes [Ciò che si concentra]
riporta i seguenti aforismi:
Lo sguardo al cielo è rivolto nel vuoto
Dio, ci lamentiamo,
si è ritratto dal mondo.
Se n’è andato anche dalla Bibbia.
Non possiamo pregare
il Dio che si è allontanato.
Per Hellinger una persona tradizionalmente religiosa è quella
che si rende conto della dipendenza da forze incontrollabili. Assume
un determinato atteggiamento nei confronti della nascita e della mor-
te. Nel migliore dei casi, afferma Hellinger, si tratta di un atteggia-
mento di rispetto e umiltà per ciò che non comprendiamo.
Molte persone religiose tentano di cambiare questa situazione di
impotenza attraverso riti, sacrifici o preghiere. In questo modo pos-
siamo da una parte accettare ciò che c’è di più grande e dall’altra in-
fluenzarlo. Hellinger vede in questo un controsenso. Uno “snatura-
mento della religione” nasce quando si tenta di comprendere il miste-
ro e tenerlo in pugno, invece di accettarlo (trasmissione radiofonica
su Bayern 2, 1996).
Hellinger differenzia fra “religione naturale” e religione rivela-
ta. Coloro che vengono rivelati fanno un’esperienza religiosa partico-
lare e ne annunciano il frutto a coloro che non la vivono. Gli altri de-
vono credere senza sperimentare di persona. La fede in un Dio rivela-
to è sempre, in ultima analisi, la fede in una persona.
Hellinger afferma che Gesù Cristo ha rivelato, ma ha suggerito
ad altri cose che avrebbero potuto percepire personalmente in deter-
minate condizioni. I suoi discepoli e gli apostoli hanno preso poi il suo
posto. Ad esempio nel caso di Paolo, Hellinger ha l’impressione che
non gli importi nulla di Gesù, quanto piuttosto delle sue concezioni
personali. Gesù viene poi rappresentato come colui che viene rivela-
to, anche se in realtà non prende mai la parola. La “religione natura-
le” si espone invece al mistero, senza pretesa di comprendere.
112 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
La fede in un Dio della rivelazione viene trasmessa culturalmen-
te dalla famiglia in cui nasciamo. Il bisogno di appartenenza alla fami-
glia fa in modo che il figlio condivida le concezioni religiose dei geni-
tori. Chi abbandona questa fede per abbracciarne un’altra o per orien-
tarsi verso l’ateismo abbandona anche la famiglia. Ciò vale soprattut-
to quando l’atteggiamento religioso viene considerato di grande im-
portanza all’interno della famiglia.
Chi abbandona una religione, mussulmana o cristiana che sia, si
sente in colpa. Il senso di colpa è maggiormente legato alla funzione
sistemica della religione che ai suoi contenuti. La religione ha l’obiet-
tivo di tenere uniti determinati gruppi. Membro del gruppo può esse-
re solo chi condivide la stessa religione. In molti gruppi, soprattutto
quelli legati alla religione rivelata, professare la stessa fede costituisce
la prerogativa della sopravvivenza. Gli apostati non vengono solo
esclusi, ma anche uccisi. Lo stesso vale per le ideologie che si compor-
tano come una religione rivelata, come ad esempio il marxismo. A
causa delle conseguenze, grandi sono l’obbligo di riconoscimento e la
paura dell’esclusione, sia per i gruppi ideologici che religiosi.
La religione rivelata rappresenta un elemento di socializzazione
della persona. Per appartenere al gruppo l’uomo crede a qualcosa che
viene tramandato, non a qualcosa che ha scoperto o sperimentato.
Hellinger condivide questa forma di religione come una fase dello svi-
luppo dell’uomo, in quanto non solo causa dolore, ma trasmette an-
che dei valori.
La religione naturale o, come la definisce talvolta Hellinger, “la
fede creatrice” prevede l’accettazione del mondo così com’è. Unisce
gli uomini invece di escluderli. Mentre la fede rivelata erige limiti, la
fede creatrice non pone alcuna limitazione. Chi rispetta le cose così
come sono (fede creatrice) non può più restare solo nel suo gruppo.
Deve superare i limiti della famiglia e del gruppo e aprirsi a qualcosa
di più grande (ZG: 318).
La strada verso la religione naturale viene spianata dalla devo-
zione personale comune a tutte le religioni, che rispetta i riti della
nuova fede, ma le è superiore nei contenuti. Le correnti mistiche del-
l’Islam e del cristianesimo sono talmente simili da annullare apparen-
temente le differenze rispetto alla religione originaria. Oltre i limiti
dei sistemi di fede tramandati vi è un’esperienza religiosa personale
accessibile a tutti. Per questo Hellinger la definisce “religione natura-
le”. Al contrario delle altre religioni, essa non ha pretese di superiori-
SPIRITUALITÀ E RELIGIONE 113
eBook acquistato da rosalba faraci
tà, di potere e di evangelizzazione, perché ciascuno è un essere a sé
stante. Questa religione naturale si trova al termine dello sviluppo re-
ligioso dell’uomo ed è legata a un grande impegno personale. In par-
ticolare esige la rinuncia alla protezione del gruppo (incontro con Til-
man Moser e Fritz Simon, Heidelberg 1996).
Secondo l’esperienza di Hellinger, chi rinuncia alla fede traman-
data o diventa ateo ha spesso un cuore più compassionevole rispetto a
chi si definisce esoterico e legato a una determinata religione. Quan-
do lavorava in Sudafrica, Hellinger si meravigliava spesso di “quanto
buone potessero essere le persone non legate ad alcuna fede” (AWI:
44). Prima credeva che solo le persone con una fede religiosa potesse-
ro essere buone, in quanto la fede mantiene retti e crea un atteggia-
mento morale. L’esperienza ha invece dimostrato il contrario.
La religione viene vissuta anche diversamente. Dal profondo
possono emergere opinioni che hanno qualcosa di spaventoso: si sen-
te una vocazione che deve essere seguita, senza poter comprendere la
relazione con il tutto.
Hellinger la definisce un’“esperienza religiosa”. Al cospetto di
una tale esperienza bisogna essere estremamente cauti. Se si mantie-
ne una distanza fra l’esperienza e il mistero che vi si nasconde dietro
e se si mantiene la massima distanza dai sentimenti e dalle esperien-
ze, è possibile sentire fluire una particolare forza dall’esterno. Secon-
do Hellinger quest’armonia con la terra così com’è, è “vicinissima al-
la terra” - non al cielo (discussione in occasione del congresso di psi-
coterapia del 1996 a Vienna).
Accettare il mondo così com’è causa dolore. È molto più facile
dire: “Come può un Dio giusto permettere tutta quest’infelicità?”.
Molti credono che Dio, se esiste, debba essere un Dio giusto. Tuttavia
chi dice che è così? In fondo quest’idea è solo un’esigenza dell’uomo.
Il mistero della giustizia e dell’ingiustizia non può essere risolto dal-
l’uomo. Se lo accetto, afferma Hellinger, “l’effetto che ha su di me è
molto più profondo rispetto alla ricerca di un Dio giusto”. (trasmissio-
ne radiofonica su Bayern 2, 1996).
Se accetto le guerre, gli stermini di massa, i disastri aerei e le ca-
tastrofi naturali come qualcosa che appartiene al mondo, senza giudi-
carli come qualcosa di terribile, ma inserendomi in un contesto più
ampio, mi metto in una posizione in cui smetto di lottare. In questo
modo si crea armonia con le contraddizioni e si riesce a raccogliersi
interiormente. Paradossalmente proprio quest’accettazione offre tal-
114 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
volta la possibilità di fare qualcosa di buono.
Lo sviluppo religioso personale inizia dalla purificazione delle
immagini ricevute. Le più importanti immagini che riceviamo dalla
religione sono rappresentazioni di esperienze vissute. Ad esempio
guardiamo Dio come un bambino guarda il padre o la madre. Lo pre-
ghiamo e ci fidiamo di lui, ma al tempo stesso temiamo la sua poten-
za superiore. Abbiamo paura anche di scoprire di più su Dio, in quan-
to crediamo che non sia compito nostro. Quest’atteggiamento corri-
sponde al rapporto fra genitori e figli.
È molto diffusa l’opinione che con Dio si possa trattare. Vi sono
persone che siglano un patto con Lui, come si stipula un contratto
terreno. “Pagano” recitando più preghiere o devolvendo grosse cifre
per una buona causa. In cambio ricevono qualcosa da Dio, come ad
esempio la guarigione da una grave malattia. Questo comportamento
si basa sul già citato modello dello scambio fra gli uomini. Per quan-
to riguarda il rapporto di coppia o un rapporto commerciale alla pari,
ciò significa che tutti danno e tutti prendono e così il rapporto fiori-
sce. Queste concezioni fanno sì che i virtuosi vadano in paradiso e i
peccatori all’inferno.
Vi sono anche persone che si comportano con Dio come dei ge-
nitori verso il figlio. Elencano tutto ciò che fa di male e che dovrebbe
fare meglio.
Un’ulteriore rappresentazione di esperienze vissute nel rappor-
to con Dio è costituita dalla concezione diffusa nella mistica che pre-
vede un contatto con il mistero divino. Nelle cantate di Bach vi sono
dei brani in cui il soprano canta: “Mi sottometto docilmente al Reden-
tore”. Il “matrimonio mistico” e “l’amore sacro” sono stati creati su
un modello umano.
Secondo Hellinger, tutte queste rappresentazioni di esperienze
vissute nel rapporto con Dio sono discutibili. L’accesso alla religiosità
è possibile solo abbandonando tutte queste immagini. Prendere sul
serio la religione secondo Hellinger significa cercare il Dio dentro di
noi e onorarlo attraverso il rispetto per la vita. Osservare il mistero
senza volerlo comprendere consente alla forza di fluire. Per quanto ri-
guarda il rapporto con la religiosità, Hellinger ha abbozzato due im-
magini. Una di esse mostra una strada che può essere percorsa la-
sciandosi tutto alle spalle. L’altra è la seguente: non vi è alcuna stra-
da, in quanto tutto ciò che è importante è nel presente (discussione in
occasione del congresso di psicoterapia del 1996 a Vienna). Quest’ul-
SPIRITUALITÀ E RELIGIONE 115
eBook acquistato da rosalba faraci
tima immagine può ricordare a molti il buddismo zen.
Sia nel buddismo zen che in numerosi percorsi mistici le espe-
rienze religiose vengono lasciate subito alle spalle. L’atteggiamento
dei mistici è il seguente: mi lascio alle spalle tutte le esperienze e mi
apro a ciò che è sconosciuto.
A tale proposito cito un antico maestro del buddismo tibetano:
Nessun pensiero,
Nessuna riflessione,
Nessun’analisi,
Nessun obiettivo:
Lascia che si mostri da solo2.
Maestro Tilopa
Chi afferma di avere avuto un’esperienza religiosa viene guarda-
to con grande scetticismo da Hellinger. A un seminario partecipò un
uomo affetto da sclerosi multipla. Si stava separando dalla famiglia.
Da ragazzo fu coinvolto in un grave incidente stradale durante il qua-
le osservò il proprio corpo mentre fluttuava3. Poteva vedere tutto an-
che se aveva perso conoscenza. Nel suo caso era fuori discussione che
si trattasse di un’esperienza religiosa. Hellinger gli disse: “Ti sei rifiu-
tato di ritornare sulla terra. E ciò ha avuto gravi conseguenze sulla tua
famiglia. Sei completamente distaccato”. (discussione in occasione
del congresso di psicoterapia del 1996 a Vienna). Hellinger sostiene
che per quest’uomo l’azione religiosa sarebbe stata ritornare alle azio-
ni quotidiane.
In tempi di esoterismo e “New Age” è diffusa l’idea di favorire le
esperienze religiose. Hellinger afferma che se qualcuno medita perché
desidera fare esperienze spirituali, sminuisce la spiritualità. Si trova
di fronte a un profondo contrasto, in quanto disprezza ciò che deside-
ra raggiungere.
Hellinger non sminuisce però l’importanza della meditazione.
Tuttavia essa non rafforza la spiritualità, ma, grazie al raccoglimento,
può affiancarsi come qualcosa di naturale a ciò che è già in armonia
con il mondo. La meditazione non rappresenta il cammino per entra-
re in armonia con qualcosa di più grande, ma essendo in armonia con
2. Alan Watts, La via dello Zen, Milano 1971.
3. In ambito esoterico ciò viene definito “esperienza extracorporea”.
116 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
qualcosa di più grande, sento il bisogno di raccoglimento. Esso non è
mai slegato dall’azione. Serve, ad esempio, a prepararsi per qualcosa
di difficile. La meditazione permette a ciò che mi servirà per agire, di
fluire verso di me. Hellinger sostiene che una meditazione orientata
al nulla indebolisce, in quanto ha perso il contatto con le azioni quo-
tidiane. Quando qualcuno si allontana dal quotidiano per concentrar-
si ad esempio sulla propria illuminazione, Hellinger diventa sospetto-
so. Per lui la forza si trova nelle azioni quotidiane: cos’accade nel rap-
porto di coppia e nel matrimonio, con i figli, nelle questioni di lavo-
ro? Quando guardo le persone in meditazione, così dice Hellinger,
“molti mi appaiono estremamente leggeri. Hanno poco peso (interio-
re) (…) in confronto a chi assolve il suo duro lavoro. Un contadino che
dà da mangiare alle mucche al mattino presto per poi andare a lavo-
rare nei campi… che peso ha in confronto a chi dice: ‘Io medito’”
(AWI: 66).
“Spirituale” ed “esoterico” non sono la stessa cosa per Hellinger.
L’esoterismo limita, mentre la spiritualità si estende in lontananza.
Un esoterico si considera generalmente migliore delle altre persone,
mentre una persona spirituale no. L’esoterico vuole scoprire qualcosa
per poterla sfruttare. In questo modo si erge sopra gli altri e perde il
contatto con le azioni quotidiane della vita (AWI: 69). Tuttavia l’acces-
so alla profondità e alla saggezza non può essere imposto, ma si trova
senza alcun impegno.
Secondo Hellinger una persona malata vede nell’esoterismo un
modo per non dovere guardare in faccia il dolore e la morte. La ma-
lattia e il dolore sono stati inutili se si è convinti di doversi convertire
a Dio dopo avere superato una grave malattia. Ci si allontana dal-
l’esperienza della vicinanza della morte e si ringraziano invece Shiva,
Vishnu o la Madonna. In questo modo ci viene sottratta forza. Una
profonda spiritualità si manifesta proprio in un rapporto aperto e pri-
vo di tabù con la morte, a cui non viene attribuita eccessiva importan-
za. Basta accettarla quando arriva il momento.
SPIRITUALITÀ E RELIGIONE 117
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Il ra pp or to
co n la m ort e
L a spiritualità non può essere separata dalla morte. Nella nostra
cultura la morte è sempre legata a paure. Hellinger sostiene
che la vita viene considerata una proprietà personale, separata
dalla morte, da sfruttare al massimo. Tuttavia, la vita può essere vista
anche dal punto di vista della morte. Ciascuno di noi viene coinvolto
dalla vita per poi essere lasciato nuovamente cadere. Al termine della
vita ritorniamo a qualcosa su cui non è possibile fare affermazioni. In
confronto all’essere e alla profondità da cui siamo venuti grazie ai no-
stri genitori, la durata della vita è breve e transitoria.
Da questo punto di vista la morte prematura di un bambino non
costituisce nulla di grave. Sia la persona che muore a 85 anni che il
bambino che vive solo un anno ritornano entrambi a ciò di cui non
conosciamo l’essenza. In questo senso sono uguali.
La nostra vita quotidiana acquisisce forza se vissuta come qual-
cosa di transitorio. Il tempo che ci è concesso fino alla morte può es-
sere considerato un dono. Partendo da questo presupposto, il tempo a
nostra disposizione può essere riempito in modo completamente di-
verso, senza contrapporre la vita alla morte. Se consideriamo la mor-
te come un’amica, riusciamo a guardare con rilassatezza alla transi-
torietà (SBK: 69). Ciò ci permette inoltre di affrontare meglio la mor-
te all’interno della famiglia. Se perdiamo una persona amata, è impor-
tante attribuirle un posto nel nostro cuore. Rendere omaggio alla
morte influisce positivamente su tutti i membri della famiglia.
La separazione ha successo se accettiamo il profondo dolore del
commiato invece di evitarlo. Fuggendo davanti al dolore, restiamo
eBook acquistato da rosalba faraci
profondamente legati al morto e non riusciamo più a vivere. Un esem-
pio a tale proposito: una donna ha perso il marito da vent’anni, ma
sembra sia appena morto. Quando racconta del marito, le sue guance
sono rigate di lacrime. La donna ha sempre rifuggito il dolore profon-
do. Perfino la camera da letto del morto non ha subito alcuna modifi-
ca. Non ha accettato la morte del marito. Come prevedibile non si è
mai risposata e non ha mai iniziato un nuovo rapporto di coppia. Tut-
tavia tale “solidarietà” non serve né ai morti né ai vivi.
Un altro esempio: una donna vicina alla quarantina non aveva
mai avuto rapporti sessuali con un uomo. Il padre, a cui era molto le-
gata, morì di una grave malattia quando lei era una ragazza. Allora si
rifiutò di partecipare al funerale. Non volle vedere il padre morto cre-
dendo di non sopportarne la vista. In questo modo perse l’occasione di
accomiatarsi da lui. Anche negli anni a venire non si recò mai al cimi-
tero. Per molto tempo sentire pronunciare la parola “padre” la faceva
piangere disperatamente, ma si trattava solo di “lutto secondario”.
Queste lacrime non rafforzano, ma indeboliscono. La donna non riu-
sciva a pronunciare la frase: “Sei morto, caro papà, io vivo ancora un
po’, poi muoio anch’io”. “Non riesco a dire ‘morto’”, disse, e, in effet-
ti, dopo così tanto tempo il padre non era ancora nella tomba. Viveva
pensando a lui come se fosse vivo e non c’è da meravigliarsi che nes-
sun altro uomo avesse avuto una chance. Successivamente riuscì a
pronunciare la frase e a sentire il dolore che da essa scaturiva. Fu emo-
tivamente molto colpita dal fatto che durante la rappresentazione il
padre non fosse affatto contento della sua solidarietà.
Già nel Medioevo le persone vivevano un lutto spontaneo e dolo-
roso. Ciò che si racconta di Carlo Magno, può essere considerato tipi-
co del tempo. Quando l’imperatore giunse al campo di battaglia di
Roncisvalle, non riuscì a trattenere le lacrime. Quando vide il nipote
morto “tremò di dolore”. Scese da cavallo, abbracciò la salma più for-
te che poté e si accasciò sul corpo. Quando ritornò in sé, si abbando-
nò “ai più profondi gesti di dolore”1. Anche i soldati presenti piansero
e singhiozzarono forte.
Un altro resoconto del tempo riporta che la persona in lutto
“stringe al petto il morto con tutte le forze”. In questo modo entra in
contatto con il dolore che consente di consolarsi della perdita.
L’importanza di un immediato contatto con la salma per l’elabo-
1. Philippe Ariès, Storia della morte in Occidente, Milano 1998.
120 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
razione del lutto è dimostrata dall’esperienza del proprietario di una
società di pompe funebri americana. Dall’esperienza della sepoltura
del padre si rese conto che gli addetti ai lavori fanno il possibile per
evitare a chi resta di elaborare il lutto. Ciò fa più male che bene2.
Dopo la sepoltura del padre, egli si dedicò al proprio lavoro in
modo completamente diverso. Sgravava chi resta solo del minimo in-
dispensabile e lo spronava a partecipare il più attivamente possibile al-
la sepoltura. In questo modo è possibile percepire il profondo dolore
che guarisce l’anima e consente di continuare a vivere bene. Egli spro-
nava ad esempio i parenti a toccare il corpo del defunto nella bara o
almeno a guardarlo. In questo modo è possibile afferrare la realtà del-
la morte. Chi guarda la morte negli occhi in questo modo, può viver-
la profondamente.
Se il dolore di chi resta non vuole cessare, significa che vi è rab-
bia nei confronti del morto, sostiene Hellinger. In questo caso può
aiutare pronunciare la frase: “Rispetto la tua vita e la tua morte”. Tal-
volta accade che qualcuno si faccia carico del lutto non elaborato di
un altro membro della famiglia. Altre volte chi resta è debitore di
qualcosa nei confronti del morto.
A conclusione di questo capitolo, riporto una storia di Bert Hel-
linger sulla morte.
L’ospite
In qualche luogo, molto lontano da qui, in quello che una
volta fu il Vecchio West, un uomo attraversò con uno zai-
no in spalla una zona vasta e spopolata. Dopo lunghe ore di
marcia - il sole era ancora alto e la sua sete divenne gran-
de - vide una fattoria all’orizzonte “Grazie a Dio - pensò -
finalmente una persona in questa solitudine. Ora gli chie-
do da bere e magari possiamo sederci sulla veranda a
chiacchierare, prima che io prosegua il mio cammino”. E
già si immaginava quanto sarebbe stato bello.
Tuttavia mentre si avvicinava vide che il contadino era occu-
pato nel giardino davanti a casa e fu preso dai primi dubbi:
“Probabilmente ha molto da fare e non vuole essere distur-
2. Roy e Jane Nichols, Begräbnisse - eine Zeit der Trauer und Reife [Funerali
- un momento di lutto e maturazione] in Elisabeth Kübler-Ross, Reif werden
zum Tode [Essere maturi per la morte], Stuttgart 1989.
IL RAPPORTO CON LA MORTE 121
eBook acquistato da rosalba faraci
bato; potrebbe pensare che io sia sfacciato…”. Quando giun-
se al cancello del giardino, si limitò a salutare e proseguì.
Il contadino dal canto suo lo vide già da lontano e tutto
contento pensò: “Grazie a Dio! Finalmente una persona in
questa solitudine. Spero che venga qui. Berremo qualcosa
insieme e magari ci siederemo sulla veranda a chiacchiera-
re prima che riparta”. Entrò in casa per mettere delle bibi-
te al fresco.
Quando però vide lo straniero avvicinarsi, iniziò a dubita-
re. “Sicuramente avrà fretta e non vorrà essere disturbato;
potrebbe pensare che io sia sfacciato. Forse però ha sete e
verrà da me di sua spontanea volontà. La cosa migliore è
andare in giardino e fare finta di avere da fare. Lì mi vedrà
sicuramente e se vuole veramente venire qui lo farà”.
Quando invece lo straniero gli rivolse solo un cenno e pro-
seguì, disse: “Che peccato!”
Lo straniero continuò a camminare. Il sole era sempre più
alto e la sua sete aumentava. Passarono ore prima di scor-
gere un’altra fattoria all’orizzonte. L’uomo disse fra sé:
“Questa volta andrò dal contadino, a costo di apparire im-
portuno. Ho una tale sete, ho assolutamente bisogno di be-
re qualcosa”.
Anche il contadino lo scorse da lontano e pensò: “Spero
proprio che non venga qui. Ci manca solo questa. Ho mol-
to da fare e non ho tempo di occuparmi degli altri”. Così
proseguì con il lavoro senza alzare lo sguardo.
Lo straniero lo vide nel campo, si diresse verso di lui e disse:
“Ho molta sete. Ti prego dammi da bere”. Il contadino pen-
sò: “Ora non posso mandarlo via, in fin dei conti sono an-
ch’io un uomo”. Così lo condusse in casa e gli offrì da bere.
Lo straniero disse: “Ho guardato il tuo giardino. Si vede
che qui c’è la mano di un esperto che conosce le piante e
ciò di cui hanno bisogno”. Il contadino si rallegrò e rispo-
se: “Vedo che anche tu ci capisci qualcosa”. Entrambi si se-
dettero e conversarono a lungo.
Poi lo straniero si alzò e disse: “È tempo che prosegua il
mio cammino”. Il contadino rispose: “Guarda, il sole è ca-
lato. Dormi qui questa notte, così ci sediamo sulla veranda
a chiacchierare. Potrai proseguire domani”. Lo straniero
122 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
acconsentì. La sera si sedettero sulla veranda e il vasto pae-
saggio fu illuminato dalla luce serale. Quando diventò
buio, lo straniero iniziò a raccontare di come il mondo fos-
se cambiato da quando si era reso conto che qualcuno lo
seguiva passo passo. All’inizio, non credette che qualcuno
lo accompagnasse costantemente. Che l’altro si fermasse
quando anche lui si fermava e che si alzasse quando lui
proseguiva. Aveva impiegato parecchio tempo per capire
chi fosse il suo accompagnatore. “Il mio fedele accompa-
gnatore - disse - è la morte. Mi sono talmente abituato al-
la sua presenza che non voglio perderla. È la mia amica più
cara e più fedele. Quando non so cos’è giusto e come anda-
re avanti, mi fermo un attimo e la prego di darmi una ri-
sposta. Mi apro davanti a lei come un tutto, con tutta la su-
perficie possibile; so che lei è lì e io sono qui. E senza espri-
mere alcun desiderio, attendo che mi giunga un consiglio.
Se sto in raccoglimento e l’affronto con coraggio, dopo un
po’ mi giunge una parola, come un lampo che illumina il
buio e tutto mi è chiaro”.
Il contadino non comprese e guardò a lungo nella notte.
Poi anch’egli vide la sua accompagnatrice, la morte, e s’in-
chinò davanti a lei. Gli parve che ciò che gli rimaneva del-
la sua vite fosse cambiato. Prezioso come l’amore che sa di
dover dire addio, e come l’amore pieno fino all’orlo.
La mattina dopo mangiarono insieme e il contadino disse:
“Anche se te ne vai, restami amico”. Poi uscirono all’aper-
to e si strinsero la mano. Lo straniero proseguì per la sua
strada e il contadino ritornò al suo campo (MFL: 67).
IL RAPPORTO CON LA MORTE 123
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Ap pen d i ce 1
Il p erc or so
di B er t H el l in ger
verso le costellazioni
fa mi li a ri
B ert Hellinger è nato nel 1925. Inizialmente studiò filosofia,
teologia e pedagogia. Il suo orientamento religioso lo portò a
entrare in un ordine e a recarsi poi in Sudafrica come missio-
nario. L’attività di missionario e padre spirituale lo segnò profonda-
mente. Fu un periodo di intenso lavoro e disciplina ferrea. L’abbando-
no dell’ordine all’inizio degli anni Settanta e lo studio della psicotera-
pia non rappresentarono uno strappo, ma un’opportunità di sviluppo.
Né da parte sua né da parte dell’ordine vi fu alcuna resistenza. Hellin-
ger ricorda con sentimenti positivi quei tempi e continua a mantene-
re i contatti con gli amici di allora. Dice: “Posso rispettare ciò che ho
ricevuto laggiù e posso rispettare anche ciò che ho fatto”. Grazie alla
lunga permanenza presso gli Zulù ha imparato il rispetto reciproco e
la pazienza. Presso questa popolazione è sottinteso che non si debba
far fare brutta figura agli altri. Era rimasto anche molto impressiona-
to da come vengono trattati i bambini e di quanto naturalmente i ge-
nitori facciano valere la propria autorità sui figli. Altrettanto ovvio
presso gli Zulù è il rispetto dei figli per i genitori. Hellinger non ha
mai sentito qualcuno denigrare i propri genitori.
Prima di ritornare in Germania, Hellinger ebbe modo di incon-
trare degli esperti in dinamiche di gruppo che avevano studiato negli
Stati Uniti e tenevano corsi per gli ecclesiastici. Hellinger applicò di-
rettamente nella scuola quanto appreso durante i seminari. A quei
tempi non aveva ancora pensato alla psicoterapia.
Un’importante esperienza in Europa fu il primo seminario sulla
terapia gestaltica condotto da Ruth Cohn in Germania. Ciò lo portò a
eBook acquistato da rosalba faraci
prendere una decisione che avrebbe segnato la sua vita futura.
Hellinger decise di intraprendere una formazione psicoanalitica
a Vienna. Fu allora che conobbe il libro di Arthur Janov, The primal
scream [Il grido primordiale]. Hellinger fu profondamente impressio-
nato dalla capacità di Janov di affrontare direttamente i sentimenti
principali. Sperimentò il metodo di Janov nei suoi seminari sulle dina-
miche di gruppo, infine decise di dedicarsi alla terapia primaria con Ja-
nov negli Usa dopo avere concluso la formazione psicoanalitica. Nove
mesi di studio gli insegnarono a tenere sotto controllo i sentimenti.
Presto individuò dei punti deboli nella terapia primaria. Percepì
che i terapeuti e i clienti si lasciavano spesso guidare unicamente dai
sentimenti, impedendo di fatto la soluzione dei problemi. Ciò che di
prezioso Hellinger ha mantenuto della terapia primaria è il modo di
gestire i partecipanti ai gruppi. A nessuno è concesso fare commenti
sui processi altrui. Talvolta, manifestando i propri sentimenti non si
ottiene alcuna risonanza dagli altri. È dunque necessario affrontarli
da soli. I commenti sviano spesso dalla propria situazione psichica.
Successivamente Hellinger si rese conto che i sentimenti inten-
si che emergono dalla terapia primaria riguardano quasi tutti il padre
e la madre o più precisamente l’amore primordiale verso i genitori. Do-
lore e rabbia servono spesso solo a scacciare il dolore che scaturisce dal
movimento interrotto durante l’infanzia1. Talvolta i sentimenti vengo-
no considerati personali. Tuttavia in questo modo si fa torto al cliente.
Hellinger si ricorda di una cliente sottoposta a terapia primaria. Mo-
strava sentimenti che gli risultavano incomprensibili. Successivamen-
te comprese che i sentimenti della donna non erano in realtà suoi, ma
provenivano da qualcun altro all’interno del sistema familiare.
Nel periodo di contrasto con la terapia del grido primordiale di
Janov, Hellinger venne in contatto con l’analisi transazionale.
Un’esperienza chiave per lo sviluppo del metodo delle costellazioni fa-
miliari fu la lettura del libro di Eric Berne Ciao!…e poi? Il lavoro di
Berne è incentrato soprattutto sulla ricerca dei copioni di vita dei
clienti. È possibile evincere tale modello ponendo domande al cliente
relative all’opera, al romanzo, al film, al fumetto, alla fiaba o al mito
che maggiormente lo hanno impressionato nella prima infanzia e a
un’altra storia che lo coinvolge attualmente. Confrontando le due sto-
rie si trovano spesso elementi comuni che si riferiscono al progetto di
1. Vedi il capitolo “Genitori e figli”, sottocapitolo “Il movimento interrotto”.
126 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
vita nascosto. Secondo Eric Berne tali copioni di vita hanno origine
dai messaggi verbali e non verbale trasmessi dai genitori ai figli.
Hellinger si rese presto conto che i copioni di vita non possono
sempre essere messi in relazione con i messaggi dei genitori. Alcuni
copioni si rifanno a precisi avvenimenti all’interno del sistema fami-
liare, come ad esempio il suicidio tabuizzato di una sorella della ma-
dre. Hellinger aggiunge dunque al punto di vista di Berne una “pro-
spettiva multigenerazionale”. Dopo una lunga esperienza in questo
campo, Hellinger scoprì le regole dell’identificazione con destini e av-
venimenti passati all’interno di un sistema familiare. Hellinger è con-
vinto che la maggior parte dei problemi affrontati dalla psicoterapia
non siano determinati dallo sviluppo psicologico, ma siano sistemici.
Molti problemi non sono dunque legati a esperienze personali, ma de-
rivano dall’identificazione con destini passati di altre persone.
Seguono alcuni esempi di copioni di vita. Nel caso della fiaba
Hans im Glück (La fortuna di Gianni) spesso un nonno ha perso il suo
patrimonio. Si può pregare interiormente il nonno: “Ti prego, bene-
dicimi, se io lo tengo”. Nella fiaba Il lupo e i sette capretti, la mamma
dice ai figli: “Guardatevi dal papà cattivo!”
Cappuccetto Rosso mostra alla madre la corruzione del bambi-
no da parte del padre. Nella realtà si può trattare anche di un altro pa-
rente più anziano. Sterntaler e Der fliegende Robert rappresentano
spesso il copione di vita di persone anoressiche. In La bella addor-
mentata nel bosco, si tratta della fata non invitata dal re, che dal pun-
to di vista sistemico rappresenta probabilmente una moglie preceden-
te non rispettata, che viene rappresentata dal bambino.
La fiaba Tremotino rappresenta più il copione di un trauma che
una storia sistemica. La fiaba descrive l’esperienza di crescere senza
madre e di essere abbandonati dal padre. Nella generazione successi-
va accade spesso che una figlia abbandoni il proprio figlio. Se qualcu-
no cita questo copione gli si può chiedere se lui o un altro bambino
della famiglia siano stati abbandonati. Probabilmente ne risulterà che
si sente come il bambino abbandonato.
Segue un altro esempio tratto dalla letteratura mondiale: nel
Faust di Goethe, qualora vi sia un riferimento al copione di vita di una
donna, la domanda è la seguente: “Quale uomo ha imbrogliato quale
donna?”.
L’esperienza ha insegnato a Hellinger che una storia che rappre-
senta un copione per qualcuno, deve essere presa letteralmente. Un
APPENDICE I 127
eBook acquistato da rosalba faraci
partecipante a un seminario una volta citò come copione il mitico
eroe Ulisse. L’uomo aveva una fidanzata il cui padre gli aveva dato una
barca con cui lasciò la donna, come Ulisse l’amata ninfa Calipso, per
raggiungere l’Africa.
Ad un altro partecipante piaceva moltissimo Otello. Tuttavia non
si può avere vissuto la storia di Otello da bambini. Così Hellinger chie-
se all’uomo: “Quale uomo della tua famiglia ha ucciso qualcuno per
gelosia?” (OL: 499). Era stato il nonno. Dopo che la moglie lo aveva
tradito, aveva ucciso l’amante. Da allora per i copioni di vita Hellinger
si chiede sempre se si riferiscono a esperienze personali, ad esempio a
traumi infantili come nel caso di Tremotino o a esperienze vissute da
altri membri della famiglia.
Anche l’opinione di Hellinger sui sogni si è modificata attraver-
so il lavoro sui copioni di vita. Gli incubi e altri tipi di sogni hanno tal-
volta una relazione con le esperienze di un membro della famiglia. La
psicoanalisi junghiana abbina ad esempio le figure oniriche, come un
assassino o un’altra figura negativa, alla propria persona. Si parla in
questo caso di “zona d’ombra” messa in luce dal sogno. L’ombra rap-
presenta gli aspetti negativi e nascosti della psiche.
Il fatto che vi possano essere diverse interpretazioni mi fu chia-
ro durante un seminario sui sogni. Un partecipante depresso con in-
tenti suicidi raccontò di incubi che lo tormentavano da anni. General-
mente vedeva due o tre uomini intorno a un patibolo. Anche poco pri-
ma del seminario sognò di dover salire sul patibolo a cui erano già sta-
ti impiccati tre uomini. Aveva in mano un coltello con cui voleva ta-
gliare il cappio intorno al collo dei morti. Nel sogno la salita sul pati-
bolo era una fatica sia psichica che fisica. Nulla gli appariva più impor-
tante che “liberare” finalmente quei corpi.
Mentre saliva sul patibolo vedeva stranamente in lontananza il
suo psicoanalista che lo osservava. L’uomo guardava lo psicanalista e
diceva tra sé: “È un traditore!” Infine gli gridava: “Non mi puoi aiuta-
re!”. L’uomo si svegliava bagnato fradicio di sudore appena prima di
riuscire a tagliare il cappio intorno al collo dei cadaveri.
Alle mie domande l’uomo rispose che numerosi membri maschi
della sua famiglia si erano suicidati. Lo psicanalista, che lo aveva in
cura da diversi anni, cercava di interpretare l’incubo a livello persona-
le. Tuttavia i sogni non trovavano alcuna spiegazione nelle esperienze
dell’uomo durante l’infanzia. Durante una seduta l’uomo stesso disse
allo psicanalista che la causa doveva essere un’altra in quanto si sen-
128 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
tiva sempre peggio. Lo psicanalista non modificò la propria interpre-
tazione. Il sogno mostrava chiaramente che il punto di vista del tera-
peuta non era di nessun aiuto. Nel caso di questo cliente si trattava di
rispettare i suicidi nel sistema familiare. Quest’esempio dimostra co-
me il metodo sistemico di Hellinger possa spesso aiutare a risolvere
casi disperati.
Un’altra tessera del puzzle, che ha portato Hellinger sulla strada
delle costellazioni familiari fu la lettura del libro di Boszormenyi Na-
gy Unsichtbare Bindungen [Irretimenti invisibili]. Questo testo af-
fronta l’idea della compensazione all’interno del sistema familiare che
si protrae per diverse generazioni. Successivamente Hellinger si oc-
cupò della terapia familiare che stava prendendo sempre più piede ne-
gli anni Settanta. Frequentò un seminario tenuto da Ruth McClendon
e Les Kadis. Successivamente assistette a rappresentazioni di costel-
lazioni familiari condotte da Thea Schönfeld. Durante la stesura della
presentazione di Colpa e innocenza nei sistemi si rese improvvisa-
mente conto che esiste un ordine originario: chi viene prima ha la
precedenza su chi viene dopo. A questo punto Hellinger iniziò con la
metodologia da lui sviluppata.
Il lavoro di Hellinger è caratterizzato dal raccontare storie.
Quando il lavoro con un cliente si blocca, racconta volentieri una sto-
ria spiritosa o che induce a riflettere. Durante il racconto il cliente
non ha più a che fare direttamente con Hellinger, ma con i personag-
gi della storia. Questa maggiore distanza rispetto al terapeuta può tal-
volta mettere in moto qualcosa nel cliente. A volte Hellinger non rac-
conta la storia rivolgendosi direttamente al cliente, ma a un terzo.
Questo modo di lavorare indiretto, proprio come il raccontare storie,
si rifà al terapeuta americano Milton Erickson.
Erickson accettava le persone così com’erano ed era dotato di
una straordinaria capacità di percezione. Comprendeva i segnali più
nascosti del corpo. Alcuni lo hanno forse già sperimentato nella vita
quotidiana: talvolta rispondiamo affermativamente a una domanda
mentre scuotiamo leggermente il capo a indicare un no. L’inconscio
pensa spesso in modo totalmente diverso rispetto alla coscienza. La
capacità di Erickson di comprendere il linguaggio dell’inconscio è di-
venuta leggendaria. Osservando a lungo una donna percepì, ad esem-
pio, dei cambiamenti minimi nella mimica e nel portamento: si con-
gratulò con lei per la gravidanza. La donna rimase sorpresa in quanto
non percepiva alcun sintomo. Tuttavia una visita medica confermò la
APPENDICE I 129
eBook acquistato da rosalba faraci
percezione di Erickson. Una volta egli riconobbe un travestito da co-
me eliminò un pelucco dalla manica: non ruotava il gomito all’ester-
no come fanno generalmente le donne2.
Hellinger ha imparato da Jeffrey Zeig, Stephen Lankton e altri
allievi di Milton Erickson a fare caso a questi segnali impercettibili. I
segnali del corpo sono spesso in contrasto con le affermazioni consce
del cliente. Se ad esempio Hellinger chiede a un malato di tumore se
ha ancora speranza, non si fida della risposta verbale che è spesso “sì”,
ma di quella non verbale: se il sì viene pronunciato senza determina-
zione e l’espressione del viso mostra rassegnazione, è questa l’infor-
mazione importante. La sorprendente sicurezza mostrata da Bert Hel-
linger durante le rappresentazioni delle costellazioni familiari è lega-
ta principalmente all’efficacia delle sue percezioni distaccate, ma al
tempo stesso piene di partecipazione emotiva.
2. Jeffrey Zeig, Die Weisheit des Unbewussten - Hypnotherapeutische Lektio-
nen bei Milton H. Erickson [La saggezza dell’inconscio - lezioni di terapia ip-
notica di Milton H. Erickson], Heidelberg 1995.
130 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Ap pen d i ce 2
Le rap pr esen tazio ni
de ll e c os te l la zi on i
fa mi li a ri
“P
referisco andare io piuttosto che tu, cara mamma!”.
Esempio di una cliente che soffre da anni di diabete a cui è
stata recentemente diagnosticata la sclerosi multipla1.
Bert Hellinger chiede al pubblico se un malato grave vuole rap-
presentare la sua famiglia. Si fa avanti una donna che soffre di diabe-
te da quando è ragazza e a cui è stata recentemente diagnosticata la
sclerosi multipla. La donna sale sul palco e si siede vicino a Bert Hel-
linger2.
H.: “Sei sposata?”.
Brigitte: “No”.
H.: “Figli?”.
Brigitte: “No”.
H.: “È accaduto qualcosa di particolare nella tua famiglia d’ori-
gine?”.
Brigitte: “Mio padre è morto quando avevo cinque anni. (Pausa)
Per il resto non saprei”.
H.: “Bene. Ora rappresenteremo la tua famiglia d’origine. Ne
1. Questa rappresentazione è stata condotta da Bert Hellinger e non è mai sta-
ta pubblicata.
2. Alla donna è stato attribuito il nome di Brigitte. Bert Hellinger viene abbre-
viato con “H”.
eBook acquistato da rosalba faraci
fanno parte tuo padre, tua madre e - quanti fratelli?”.
Brigitte: “Un fratello”.
H.: “Tu sei la primogenita?”.
Brigitte: “Sì”.
H.: “Tuo padre o tua madre hanno avuto relazioni precedenti?”.
Brigitte: “Non che io sappia”.
H.: “Bene, allora rappresentiamo queste quattro persone. - Hai
già assistito alla rappresentazione di una costellazione familiare?”.
Brigitte: “No. In effetti no. (Dopo un po’ di esitazione) Ne ho vi-
sta una ieri pomeriggio”.
H.: “Scegli tra il pubblico dei rappresentanti per tuo padre, tua
madre, tuo fratello e te stessa. Essi verranno sul palco e sarai tu a po-
sizionarli. Coraggio, scegli!”.
H. (Quando Brigitte si ferma esitante di fronte al pubblico sen-
za riuscire a decidere): “Non ha importanza chi scegli”.
H. (Quando tutti i rappresentanti sono stati scelti e si trovano
sul palco): “Ora ti spiego come funziona. Prendi ognuno per le spalle
con entrambe le mani e conducilo al suo posto (Hellinger mostra co-
me fare) proprio dove pensi che debba stare. Va bene? Fallo con racco-
glimento”.
H. (ai rappresentanti): “Lasciatevi muovere e fate caso al senti-
mento che nasce in voi e a come si modifica. Poi vi chiederò cosa pro-
vate. Ora non c’è bisogno di dire nulla e anche tu (rivolto a Brigitte)
non dire nulla. Va bene? Comincia!”.
Figura 1.
Nella figura gli uomini vengono
indicati con un rettangolo e le donne
con un cerchio. La tacca nei simboli
indica la direzione dello sguardo.
V U = padre morto / M = madre / 1 = figlio
(fratello) / 2 = figlio (Brigitte) / MM = ma-
dre della madre / BM U = fratello della
madre, morto prematuramente
di difterite
H. (al pubblico): “Si tratta di una strana rappresentazione. Ri-
cordiamo che si tratta di una famiglia: secondo quale criterio sono di-
sposti? Questa è la prima domanda che andrò a porre. Prima però
chiedo a tutti i rappresentanti come si sentono”.
132 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
H. (si dirige verso il rappresentante del padre): “Come sta il pa-
dre?”.
V.: “Tutto regolare”. (Risate in sala)
H.: “Cosa significa?”.
V.: “Un po’ distante”.
H.: “E com’è la sensazione?”.
V.: (dopo una breve esitazione): “Bella”.
H. (alla madre): “Come si sente la madre?”.
M.: “Mi sento separata dai bambini, soprattutto dal maschio.
(Guarda da un’altra parte). Sento la presenza del marito, (dopo una
breve pausa) ma non è sufficientemente forte . Vedo la figlia solo con
la coda dell’occhio”.
H. (al fratello): “Come si sente il fratello?”.
(1): “Qui mi sento piuttosto solo. Non vedo la mia famiglia e pro-
vo solo la sensazione di avere qualcuno alle spalle”.
H. (alla figlia): “Come si sente la figlia?”.
(2): “Il primo sguardo che ho scambiato con mia madre mi ha
procurato una sensazione di disagio. Sentivo di dover distogliere lo
sguardo. Ho la sensazione di avere la possibilità di andarmene (indi-
cando nella direzione opposta). (Dopo una pausa) Mi sento anche in-
quieta”.
H. (prendendo il padre per un braccio): “Il padre è morto prema-
turamente. Ora lo posiziono in modo che possa essere visto”. (Hellin-
ger sistema il padre di fronte al figlio).
Figura 2.
H. (al padre): “Come ti senti in questa posizione?”.
V.: “Bene. Vedo tutto e ho tutto davanti a me. È appagante”.
H. (al figlio): “Come si sente ora il figlio?”.
(1): “Va meglio. Vedo il padre. Mi sento meglio di prima”.
APPENDICE II 133
eBook acquistato da rosalba faraci
H. (alla madre): “Cos’è cambiato nella madre?”.
M.: “Manca qualcosa. Mancano il sostegno e il calore provenien-
ti da dietro”.
H. (alla figlia): “E tu?”
(2): “Divento sempre più inquieta”.
H. (al pubblico): “Dalle reazioni osservate finora deduco che è
accaduto qualcosa di particolare nella famiglia d’origine della madre.
Ed è ciò che chiederò (Hellinger va verso Brigitte che finora è rima-
sta in disparte).
H. (a Brigitte): “Cos’è accaduto di particolare nella tua famiglia
d’origine?”.
Brigitte: “Mio fratello minore, che aveva tredici o quattordici an-
ni meno di me, è morto di difterite durante la guerra proprio mentre
mia madre era stata mandata a chiamare il medico. Subito dopo ci fu
un bombardamento. Il secondo fratello era minore di due anni. È
morto d’infarto a 49 anni; mia madre era convinta che la causa fosse-
ro i problemi con la moglie. Il loro matrimonio non era felice e si so-
no separati. La moglie non lo aveva lasciato andare”.
H.: “Cos’è accaduto ai tuoi genitori?”.
Brigitte: “Ai miei genitori?”
H. (indicando la madre): “Ai suoi genitori”.
Brigitte: “La madre di mia madre è sempre stata malata di cuore.
Quando mia madre era bambina, sua madre era sempre in procinto di
morire e lei doveva sempre correre a chiamare il dottore o il prete”.
H.: “Sì. Queste sono informazioni importanti. Ora scelgo una
rappresentante per la madre della madre e un rappresentante per il fra-
tello minore della madre (Hellinger si rivolge a Brigitte dopo avere di-
sposto i due nuovi rappresentanti sul palco) “Come li disporresti?”.
(Brigitte posiziona il fratello della madre e la nonna).
Figura 3.
134 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
H. (a Brigitte): “Di cos’è morto tuo marito?”.
Brigitte: “D’infarto”.
H. (alla madre): “Cos’è cambiato nella madre?”.
M. (guardando il fratello che le sta di fronte): “Vedo un raggio di
sole. Dietro di me sento poco. Mi piacerebbe voltarmi a guardare”.
H. (alla figlia): “Cos’è cambiato in te?”.
(2): “Mi sento più sicura”.
H. (al fratello della madre): “E tu come stai?”.
BM.: “Vedo un gruppo molto piccolo davanti a me. Va bene. Die-
tro di me (esita) non sento nulla”.
H. (alla madre della madre): “Come si sente la madre della ma-
dre?”
MM.: “Qui mi sento un po’ costretta. Desidero arretrare di un
passo. La visuale su mio nipote è buona. Il fratello mi infastidisce leg-
germente”.
H.: “È tuo figlio!”.
MM.: “Sì”.
H.: “Okay. Ora farò qualche cambiamento” (Hellinger mette in
fila la madre della madre, il fratello della madre e la madre. Hellin-
ger posiziona l’uomo vicino alla moglie).
H. (ai figli): “Vi posiziono di fronte ai vostri genitori, o meglio (li
avvicina al padre) nella sfera d’influenza di vostro padre”.
H. (alla madre): “Quanto ti si deve avvicinare tuo fratello?”.
M.: “Più vicino” (Hellinger le avvicina il fratello).
H.: (alla madre): “E quanto vicino deve stare la madre?”.
M.: “Un po’ più vicino” (Hellinger avvicina ancora un po’ la ma-
dre della madre).
Figura 4.
H. (alla madre): “Ora come ti senti?”.
APPENDICE II 135
eBook acquistato da rosalba faraci
M.: “La vicinanza fa bene. Mi sento protetta”.
H.: (al padre): “Come si sente il marito?”.
V.: “Mi sento un po’ troppo vicino a questa parte della famiglia”
(Intende i parenti della madre aggiunti alla rappresentazione. Hel-
linger prende l’uomo per le spalle e lo allontana leggermente dalla
moglie).
V.: “Così va bene”.
H. (al figlio): “Come si sente ora il figlio?”.
(1): “Ora mi sento bene. Percepisco la madre come un tutt’uno.
(Dopo una pausa) Più completo. Si sono aggiunte molte nuove com-
ponenti”.
(Hellinger si avvicina con il microfono alla figlia).
(2): “Mi sento troppo vicina al fratello. Mi appare irrigidito. Mi fa
male il braccio destro”.
(Hellinger avvicina sia il figlio che la figlia al padre).
H. (alla figlia): “Come va?”.
Figura 5.
(2) (guardando il fratello): “Non è più così rigido”.
H. (alla figlia): “Vai da tua madre.” (Hellinger indica il posto fra
il fratello della madre e la madre. Inserendo la figlia, padre e madre
tornano a essere più vicini).
Figura 6.
136 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
H. (alla madre): “Ora ti senti meglio o peggio?”.
M.: “Meglio”.
(2): “Ho la sensazione che la madre desideri che mi avvicini;
quando mi sono avvicinata ha compiuto un movimento con la mano”.
H.: (alla figlia): “Come ti senti ora? Meglio o peggio?”.
(2): “Sono un po’ agitata, dov’ero prima non mi sentivo così”.
H. (al padre): “Come sta ora il marito?”.
V.: “Non più tanto bene. Starei meglio se mi allontanassi”.
H. (prende il padre per un braccio): “Girati e allontanati di due
passi. (Quando il padre lo ha fatto) Ora come va?”.
Figura 7.
V.: “Peggio”.
H. (alla madre): “Come si sente la madre quando lui si allonta-
na? Meglio o peggio?”.
M.: “Peggio”.
H. (va a prendere il padre): “Ritorna al tuo posto”. (Hellinger di-
spone la madre della madre, il fratello della madre e la madre uno
dietro l’altro in modo che non guardino verso la famiglia. Questa po-
sizione indica allontanamento e morte).
Figura 8.
APPENDICE II 137
eBook acquistato da rosalba faraci
H. (alla madre): “Ora come ti senti?”.
M.: “Non bene. Mi sento molto distante e in qualche modo l’ul-
tima”.
H: (alla madre): “Mettiti vicino a tuo marito. (Rivolto alla figlia)
Tu mettiti lì”.
Figura 9.
H. (alla figlia, dopo che si è posizionata dietro al fratello): “Co-
me va?”.
(2): “Meglio”. (Annuisce).
H. (al pubblico): “Ho sperimentato diverse posizioni. Quando in
una famiglia la madre è continuamente in punto di morte, talvolta il
figlio dice: ‘Meglio io di te’. E quando è morto un figlio, come in que-
sto caso il fratello, un altro figlio lo vuole seguire nella morte. All’ini-
zio ho immaginato che la madre volesse morire. Ora la figlia prende il
posto della madre e segue l’altro nella morte. Lì si sente bene. È que-
sta la dinamica della malattia”.
H. (rivolto a Brigitte): “Cosa dici in proposito?”.
Brigitte: “Mi sento triste, ma lo sento”. (Piange e annuisce).
H. (al pubblico): “È questa la soluzione che le famiglie traggono
dall’amore primordiale. Esso rappresenta il profondo legame che uni-
sce genitori e figli. I bambini si sentono talmente legati ai genitori e
ai fratelli da volerne condividere il destino dicendo dentro di sé: ‘Ti se-
guo nella morte. Condivido il tuo destino’. Talvolta ciò si manifesta
con una grave malattia. È questa la dinamica che sta dietro alla pato-
logia. Oppure dicono: ‘Preferisco farlo io piuttosto che tu, cara mam-
ma. Muoio al posto tuo. Mi ammalo al posto tuo. Sparisco al posto
tuo’. Si è convinti di poter salvare o liberare la persona amata con il
proprio sacrificio. È questo l’amore primordiale.
Ciò di cui non si tiene conto è che anche l’altro ama. Colui che si
138 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
vuole seguire non desidera né ha bisogno di essere salvato. Se il bam-
bino se ne rendesse conto, abbandonerebbe la visione magica del mon-
do: amiamo l’altro a un livello superiore, non salvandolo, ma rispettan-
dolo. Ora cerco di trovare una soluzione per questo caso a un livello su-
periore, una soluzione che non richieda a nessuno di ammalarsi”.
H. (a Brigitte): “Sei d’accordo?”. (Brigitte annuisce e sorride).
H. (prende Brigitte per un braccio): “Ora ti inserisco subito al
tuo posto”. (La rappresentante di Brigitte se ne va e Brigitte prende il
suo posto dietro al fratello della madre. Hellinger dispone la madre
della madre e il fratello della madre di fronte a Brigitte e sposta Bri-
gitte di fianco al fratello).
Figura 10.
H. (alla madre): “Prendi per mano tua figlia e vai con lei verso
tua madre. (Quando sono giunte a destinazione) Ora inchinatevi en-
trambe davanti alla madre”. (Madre e figlia s’inchinano contempora-
neamente davanti alla madre della madre).
Figura 11.
H. (alla madre): Dì (Hellinger si rivolge a Brigitte con aria in-
terrogativa) come ti rivolgevi a tua madre?”.
APPENDICE II 139
eBook acquistato da rosalba faraci
Brigitte: “Non lo so”.
H.: “Okay. (Rivolto alla madre) Dì: ‘Mamma’!”.
M.: “Mamma”.
H.: (suggerisce alla madre): “È stato così terribile”.
M.: (alla propria madre): “È stato così terribile”.
H. (suggerisce): “Ti prego resta!”.
M.: (alla propria madre): “Ti prego resta!”.
(Brigitte ascolta attentamente. Il suo mento inizia a tremare. È
molto colpita).
H. (alla madre della madre): “Come si sente la nonna?”.
MM: (annuisce): “Credo che sia proprio la cosa giusta. Vengo va-
lorizzata”.
H. (suggerisce alla madre): “Ti prego sii benevola se resto, an-
che se tu te ne vai”.
M. (alla propria madre): “Ti prego sii benevola se resto, anche se
tu te ne vai”.
H. (a Brigitte): “Come ti senti?”.
Brigitte (con il mento tremante): “Bene”. (Annuisce).
(Hellinger divide delicatamente madre e figlia che si tengono
per mano).
H. (a Brigitte): “Dì: ‘Cara nonna!’”.
Brigitte: “Cara nonna!”. (Hellinger appoggia la mano sulla spal-
la di Brigitte).
H: (suggerisce a Brigitte): “Ti rispetto”.
Brigitte (alla madre della madre): “Ti rispetto”. (Brigitte è mol-
to commossa).
H. (a Brigitte): “Vai da lei e abbracciala”.
(Brigitte va verso la madre della madre e l’abbraccia. Hellinger
appoggia la mano sulla nuca di Brigitte) “Apri la bocca e respira pro-
fondamente!”.
H. (a Brigitte mentre è ancora abbracciata alla nonna): “Pren-
dila nel tuo cuore. Respira profondamente. Respirando profondamen-
te la prendi nel tuo cuore. (Brigitte continua ad abbracciare la non-
na e respira profondamente. Dopo un po’ sorride ed è raggiante. Hel-
linger se ne accorge e le tocca il braccio) Proprio così. Vedi, ti fa be-
ne”. (Brigitte annuisce).
H.: “Proprio così”.
(Brigitte piange di gioia).
H. (a Brigitte): “Rimettiti vicino a tua madre”.
140 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
(Brigitte sorride ancora alla nonna e ritorna vicino alla madre).
H. (alla madre): “Come sta la madre?”.
M.: “È bello, meraviglioso”.
(Brigitte sorride e piange).
H. (alla madre): “Dille: ‘Resta!’”.
M. (a Brigitte): “Resta!”.
H. (alla madre quando sente l’impulso di abbracciare Brigitte):
“Sì, segui il tuo istinto. Va bene”.
(La madre abbraccia Brigitte. Restano abbracciate a lungo).
H.: “Bene. Ora prendetevi di nuovo per mano e andate insieme
dal fratello della madre”.
(La madre e Brigitte vanno davanti al fratello della madre).
“Inchinatevi appena davanti a lui”.
(La madre e Brigitte si inchinano davanti al fratello della ma-
dre).
H. (a Brigitte): “Digli: ‘Caro zio!’”.
Figura 12.
Brigitte (al fratello della madre): “Caro zio”.
H. (le suggerisce): “Vivo ancora per un po’”. Brigitte (piange for-
te, singhiozza e guarda il pavimento. La madre le tocca il braccio).
H. (a Brigitte): “Guardalo in faccia mentre lo dici. Guardalo.
(Quando lei guarda di nuovo il pavimento e singhiozza). No, no. Sen-
za singhiozzare. Respira profondamente”. (Brigitte singhiozza forte).
H. (al pubblico): “Si tratta di un sentimento infantile”.
H. (a Brigitte): “Guardalo. Stai calma”. (Hellinger le tiene da-
vanti il microfono).
Brigitte (al fratello della madre): “Io resto ancora un po’”. (Con
voce debole e tremante).
H. (le suggerisce): “Poi vengo anch’io”.
APPENDICE II 141
eBook acquistato da rosalba faraci
Brigitte (al fratello della madre): “Poi vengo anch’io”.
H. (le suggerisce): “Ti prego sii benevolo se resto ancora un po’”.
Brigitte: “Ti prego sii benevolo se resto ancora un po’”.
H. (al fratello della madre): “Come si sente lo zio?”.
BM.: “È bello. Mi offre la possibilità di dare”.
H. (alla madre): “Come si sente la madre?”.
M.: “Bene anch’io”.
H. (alla madre): “Ora rimettiti vicino a tuo marito. (A Brigitte)
E tu vicino a tuo fratello”.
H. (ai fratelli): “Rivolgetevi verso i genitori”.
Figura 13.
H. (al padre): “Come ti senti adesso?”.
V.: “Bene”.
H.: “Come va con tua moglie?”.
V.: “Bene”.
V. (dopo che Hellinger ha avvicinato la donna al padre): “Un po’
troppo vicino”. (Risate in sala. La donna si sposta di un passo verso
destra).
H. (alla madre): “Come ti senti ora?”.
M.: “Mi piacerebbe avvicinarmi. Sono un’estranea per lui”.
H. (a Brigitte): “C’è ancora qualcosa nella famiglia d’origine di
tuo padre”.
Brigitte (scuotendo la testa): “No”.
H.: “Oppure era già stato sposato prima di incontrare tua ma-
dre?”.
(Brigitte scrolla le spalle)
H.: “Okay. (Al figlio) Come ti senti ora qui?”.
(1): “Bene. Molto bene”.
H. (a Brigitte): “E tu come ti senti qui?”.
142 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Brigitte: “Mi sembra buffo che le cose siano così strane”. (Indica
se stessa e i genitori che le stanno di fronte, leggermente spostati).
H. (prende Brigitte per un braccio e la sposta verso sinistra in-
sieme al fratello, in modo che si trovino direttamente di fronte ai ge-
nitori): “Prova così!”.
Figura 14.
H. (a Brigitte): “Meglio così?”.
Brigitte (annuisce): “Sì”.
H. (a Brigitte): “Bene. È tutto”.
(I rappresentanti abbandonano il palco. Hellinger e Brigitte si
siedono vicini).
H. (al pubblico): “Quando rappresento la costellazione di un ma-
lato, guardo innanzitutto la famiglia: c’è qualcosa di irrisolto o c’è
qualcosa da rimettere in ordine? È necessario ad esempio riportare
nel campo visivo i morti o coloro che hanno avuto un destino partico-
larmente difficile, così come abbiamo visto in questo caso? Questo
processo crea una forza positiva. Lo abbiamo potuto vedere con Bri-
gitte. Quando entra in gioco la forza positiva, sono convinto che agi-
sca positivamente sulla malattia - in qualunque modo. Pensare di po-
ter curare una malattia sarebbe presuntuoso. In questo modo non si
terrebbe conto dei diversi livelli della vita umana e del destino. Tutta-
via l’effetto rigenerante e calmante che ne deriva è visibile guardando
il volto di Brigitte”.
H. (a Brigitte): “La domanda è se riesci a sopportarlo”.
Brigitte (raggiante): “Sopportare cosa?”.
H.: “La felicità!”.
Brigitte (Ride. Scrolla le spalle e dice sorridendo): “Vedrò”.
H. (al pubblico): “È molto difficile, quando in una famiglia qual-
cuno abbandona il destino degli altri. Generalmente non ne ha il co-
APPENDICE II 143
eBook acquistato da rosalba faraci
raggio, perché si sente troppo legato. Osa solo se gli altri lo guardano
con benevolenza”.
H. (rivolto a Brigitte): “Lo hai visto non è vero?” (Brigitte annui-
sce).
H.: “Se diventa difficile, guarda i volti! Va bene?”.
(Brigitte è commossa e sorride).
H.: “Dì loro: ‘Siate benevoli se resto ancora un po’”.
(Brigitte annuisce).
H.: “Bene. È tutto”.
Brigitte: “Grazie!” (Brigitte lascia il palco).
H. (al pubblico): “Desidero dire qualcosa a proposito di questa
metodologia. Ciò che ha sorpreso molto anche me è stato scoprire che
qualcosa di nascosto viene alla luce. A condizione che il cliente riesca
a mantenere il raccoglimento. Nemmeno la persona interessata si
rende conto di ciò che è nascosto. Improvvisamente qualcosa si mani-
festa e ci si rende conto che mancava. Qualcosa disturba la famiglia. E
si può tentare di scoprire cosa manca o cosa disturba. Ciò che manca
viene portato all’interno della famiglia, proprio come qui ho portato il
fratello morto della madre e la madre a lungo malata. Bisogna imma-
ginare come si possa sentire un bambino quando pensa continuamen-
te che la madre stia per morire. Cosa oseranno prendere dalla vita
questi bambini? Cosa accade nel loro cuore? E come si sentiranno
quando potranno dire finalmente: “Cara mamma, ti prego resta, e se
te ne vai, sii benevola, se io resto ancora un po’”.
In questo caso la situazione è ulteriormente complicata dalla
morte prematura del padre. Credo che anche nella sua famiglia vi sia
stata una dinamica che lo ha spinto ad andarsene. Per la soluzione
non era importante saperlo con certezza. Quando le cose tornano fi-
nalmente in ordine, l’anima può rivolgersi nuovamente a qualcosa di
più grande e felice. Tuttavia l’attrazione verso questa vecchia forma
d’amore è molto forte. Se ad esempio la cliente continuasse a restare
malata, probabilmente si sentirebbe maggiormente legata alla fami-
glia che se guarisse o stesse meglio.
La soluzione è rappresentata dunque dalla rinuncia all’intimità
con la famiglia. Solo chi ha coraggio di muoversi su un livello supe-
riore e di abbandonare tale intimità sentendosi diviso dagli altri e se-
parato dai morti, è in grado di resistere. Per questo tale soluzione è
spesso paragonabile ad un’azione religiosa o spirituale. Non bisogna
credere che tali cambiamenti avvengano con facilità, perché l’anima
144 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
ha regole proprie che devono essere rispettate e trattate con grande
cautela”.
H. (a Brigitte, che siede fra il pubblico): “Lo farai?”.
(Brigitte sorride e annuisce).
H. (al pubblico): “Qualche domanda?”.
Domanda: “Perché ha suggerito la frase ‘Io resto ancora un po’,
poi muoio anch’io’?”.
H.: “Le parole sono state scelte in base all’effetto che hanno sul-
l’anima e non in base alla logica. L’effetto che ha su un morto una fra-
se tipo ‘Caro papà, tu sei morto, io resto ancora un po’, poi muoio an-
ch’io’ è completamente diverso da quello ottenuto dicendo: ‘Tu sei
morto, io resto!’ (rivolto a chi ha posto la domanda) Vedi la differen-
za? Quest’ultima frase ha un che di arrogante, mentre la prima è in ar-
monia con il morto. Comunque s’interpreti la parola un po’, la vita è
sempre solo un po’ se paragonata alla morte. Contiene una certa mo-
destia. Esprimendomi in questo modo, sono solidale con il morto.
Non mi sento superiore ai morti nel senso di ‘voi non ci siete più, io
ci sono ancora’. Sarebbe terribile. L’anima si ribellerebbe a queste pa-
role. Solidarizzando con i morti riceviamo una benedizione che raf-
forza la nostra vita”.
Domanda: “Ha detto che per un bambino è terribile vedere la
madre soffrire costantemente e saperla vicina alla morte. Cosa accade
se si tratta del padre?”.
H.: “Non ha importanza che si tratti del padre o della madre”.
Domanda: “Perché la paziente non ha stabilito da sola il proprio
posto, perché le è stato assegnato?”.
H.: “Si tratta di una domanda molto importante. Se lascio il pa-
ziente ai propri sentimenti, segue l’amore originario. Rappresenta ciò
che conferma il problema. Evita la soluzione. Il terapeuta deve pren-
dere l’iniziativa per fare la cosa giusta. Chiedendo al cliente come si
sente verifica ciò che fa. In questo modo il terapeuta non compie un
cambiamento arbitrario. È questo che differenzia questo tipo di rap-
presentazione delle costellazioni familiari da molte altre: il terapeuta
prende l’iniziativa; l’esperienza gli consente di crearsi un’immagine
dell’ordine. Deve correggere dei dettagli ma conserva un’immagine
del giusto ordine, che consente di sistemare le cose”.
APPENDICE II 145
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
B ib l i ogr af i a
Bly, Robert: Der Eisenhans - Ein Buch über Männer, München, 1993
(Bly, Robert: Per diventare uomini: come un bambino spaventato
si può trasformare in un uomo completo e maturo, Milano, 1992).
Franke, Ursula: Systemische Familienaufstellung - Eine Studie zu sy-
stemischer Verstrickung und unterbrochener Hinbewegung unter
besonderer Berücksichtigung von Angst-Patienten. Profil-Verlag,
Wien und München 1996.
Goldner, Guntram Colin: Zen in der Kunst der Gestalt-Therapie, Aug-
sburg, 1986.
Hellinger, Bert/ten Hövel, Gabriele: Anerkennen, was ist - Gespräche
über Verstrickung und Lösung, München, 1996 (Hellinger,
Bert/ten Hövel, Gabriele: Riconoscere ciò che è: la forza rivelatrice
delle costellazioni familiari, Milano, 2001).
Hellinger, Bert: Familienstellen mit Kranken - Dokumentation eines
Kurses für Kranke, begleitende Psychotherapeuten und Ärzte,
Heidelberg, 1995.
Hellinger, Bert: Finden was wirkt - Therapeutische Briefe, München,
1993.
Hellinger, Bert: Haltet mich, dass ich am Leben bleibe. Lösungen für
Adoptierte, Heidelberg, 1998.
Hellinger, Bert: Die Mitte fühlt sich leicht an - Vorträge und Geschi-
chten, München, 1996 (Hellinger, Bert: Costellazioni familiari:
aneddoti e brevi racconti, Milano, 2005).
Hellinger, Bert: Ordnungen der Liebe - Ein Kursbuch, Heidelberg,
1994 (Hellinger, Bert: Ordini dell’amore: manuale per la riuscita
eBook acquistato da rosalba faraci
delle relazioni, Milano, 2003).
Hellinger, Bert: Schicksalsbindungen bei Krebs - Ein Buch für Betrof-
fene, Angehörige und Therapeuten, Heidelberg, 1997.
Hellinger, Bert: Touching Love. Bert Hellinger at work with family
systems. Documentation of a three-day-course for psychothera-
pists and their clients, Heidelberg, 1997.
Hellinger Bert: Verdichtetes - Sinnsprüche, kleine Geschichten, Sät-
ze der Kraft, Heidelberg, 1996.
Jacobi, Jolande: Die Psychologie C.G. Jungs, Frankfurt, 1989 (Jacobi,
Jolande: La psicologia di C. G. Jung, Torino, 2000).
Jellouschek, Hans: Die Kunst, als Paar zu leben, Stuttgart, 1992 (Jel-
louschek, Hans: L’arte di vivere in coppia, Roma, 2003).
Jung, Carl Gustav: Archetypen, München, 1990 (Jung, Carl Gustav:
Gli archetipi dell’inconscio collettivo, Torino, 1980).
Jung, Carl Gustav: Erinnerungen, Träume, Gedanken, Olten, 1990
(Jung, Carl Gustav: Ricordi, sogni, riflessioni, Milano, 2003).
Krüll, Marianne: Unreflektiertes patriarchales Denken - ein Gespräch
mit der Familiesoziologin Marianne Krüll, In: Psychologie heute,
Nr. 6, 1995.
Lauster, Peter: Die Liebe, Reinbek, 1983 (Lauster, Peter: L’amore e il
senso della vita: miti e pregiudizi, affetti e gioie, gelosie e separa-
zioni, Padova, 1997).
Miller, Alice: Am Anfang war Erziehung, Frankfurt, 1979.
Miller, Alice: Das Drama des begabten Kindes, Frankfurt, 1979 (Mil-
ler, Alice: Il dramma del bambino dotato, Torino, 1982).
Nichols, Roy e Jane: Begräbnisse - eine Zeit der Trauer und Reife, In:
Elisabeth Kübler-Ross: Reif werden zum Tode, Stuttgart, 1989.
Nüse, Ralf et al.: Über die Erfindungen des Radikalen Konstruktivi-
smus - Kritische Gegenargumente aus psychologischer Sicht,
Weinheim, 1991.
Watts, Alan: The way of Zen, New York, 1957 (Watts, Alan: La via del-
lo zen, Milano, 2000).
Weber, Gunthard (a cura di): Zweierlei Glück - Die Systemische The-
rapie Bert Hellinger, Heidelberg, 1993 (Weber, Gunthard (a cura
di): I due volti dell’amore: come far funzionare l’amore nei rappor-
ti affettivi, Spigno Saturnia, 2002).
Wirl, Charlotte: Workshop mit Cloé Madanes: Sex, Love and Violen-
ce, In: Megaphon - Rivista della società Milton Erickson, Nr. 22,
1995.
148 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Zeig, Jeffrey: Die Weisheit des Unbewussten - Hypnotherapeutische
Lektionen bei Milton Erickson, Heidelberg, 1995 (Zeig, Jeffrey: Se-
minari di ipnosi: l’insegnamento ericksoniano, Napoli, 1987).
BIBLIOGRAFIA 149
eBook acquistato da rosalba faraci
eBook acquistato da rosalba faraci
Pu bb licazio ni
di e su
B er t H el l in ger
Baxa, Guni-Leila/Essen, Christine/Kreszmeiner, Astrid Habiba (a cura
di): Verkörperungen - Systemische Aufstellung, Körperarbeit und
Ritual, Heidelberg, 2002.
Brink, Otto: Spielregeln der Partnerschaft, Freiburg, 2001.
Döring-Meijer, Heribert: Familienaustellungen mit Suchtkranken,
Paderborn, 2000.
Dykstra, Ingrid: Wenn Kinder Schicksal tragen - Kindliches Verhal-
ten aus Systemischer Sicht verstehen, München, 2002.
Franke, Ursula: Systemische Familienaufstellung - Eine Studie zu sy-
stemischer Verstrickung und unterbrochener Hinbewegung unter
besonderer Berücksichtigung von Angst-Patienten. Profil-Verlag,
Wien und München, 1996.
Franke-Griksch, Marianne: Du gehörst zu uns! Systemische Einblic-
ke und Lösungen für Lehrer, Schüler und Eltern, Heidelberg, 2001
(Franke-Griksch, Marianne: Tu sei uno di noi: le costellazioni fami-
liari e la scuola: intuizioni e soluzioni sistemiche per insegnanti,
Spigno Saturnia, 2004).
Gómez, Pedra Sylvia (a cura di): Kindliche Not und kindliche Liebe,
Heidelberg, 2001.
Hellinger, Bert/Ten Hövel, Gabriele: Anerkennen, was ist - Gespräche
über Verstrickung und Lösung, München, 1996 (Hellinger,
Bert/ten Hövel, Gabriele: Riconoscere ciò che è: la forza rivelatri-
ce delle costellazioni familiari, Milano, 2001).
Hellinger Bert: Der Abschied - Nachkommen von Tätern und Opfer-
stellen ihre Familie, Heidelberg, 1998.
eBook acquistato da rosalba faraci
Hellinger, Bert: Die Quelle braucht nach dem Weg zu fragen - ein Na-
chlesebuch, Heidelberg, 2001.
Hellinger, Bert: Einsicht durch Verzicht - Der phänomenologische
Erkenntnisweg in der Psychotherapie, in: Praxis der Systemauf-
stellung, München.
Hellinger, Bert: Entlassen werden wir vollendet - Besinnliche Texte,
München, 2001.
Hellinger, Bert: Familienstellen mit Kranken - Dokumentation eines
Kurses für Kranke, begleitende Psychotherapeuten und Ärzte,
Heidelberg, 1995.
Hellinger, Bert: Haltet mich, dass ich am Leben bleibe. Lösungen für
Adoptierte, Heidelberg, 1998.
Hellinger, Bert: In der Seele an die Liebe rühren - Familien-Stellen
mit Eltern und Pflegeeltern von behinderten Kindern, 1998.
Hellinger, Bert/a cura di Michaela Kaden: Liebe am Abgrund - Ein
Kurs für Psychose-Patienten, Heidelberg, 2001.
Hellinger, Bert: Mitte und Maß - Kurztherapie, Heidelberg, 1999.
Hellinger, Bert: Ordnungen der Liebe - Ein Kursbuch, Heidelberg,
1994 (Hellinger, Bert: Ordini dell’amore: manuale per la riuscita
delle relazioni, Milano, 2003).
Hellinger, Bert: Religion, Psychotherapie, Seelsorge, München, 2000.
Hellinger, Bert: Schicksalsbindungen bei Krebs - Ein Kurs für Betrof-
fene, ihre Angehörigen und Therapeuten, Heidelberg, 1997.
Hellinger, Bert: Touching Love. Bert Hellinger at work with family
systems. Documentation of a three-day-course for psychothera-
pists and their clients, Heidelberg, 1997.
Hellinger Bert: Verdichtetes - Sinnsprüche, kleine Geschichten, Sät-
ze der Kraft, Heidelberg, 1996.
Hellinger Bert: Was in Familien krank macht und heilt - Ein Kurs für
Betroffene, Heidelberg, 2000.
Hellinger Bert: Wir gehen nach vorn - Ein Kurs für Paare in Krisen,
Heidelberg, 2001.
Hellinger Bert: Wo Ohnmacht Frieden stiftet - Familien-Stellen mit
Opfer von Trauma, Schicksal und Schuld, Heidelberg, 2000.
Hellinger Bert: Wo Schicksal wirkt und Demut heilt - Ein Kurs für
Kranke, Heidelberg, 1999.
Hellinger Bert/Kaden, Michaela: Die größere Kraft - Bewegungen der
Seele bei Krebs, Heidelberg, 2001.
Langlotz, Robert (a cura di): Familien-Stellen mit Psychose-Kranken.
152 GUARIRE LE MALATTIE DELL’ANIMA
eBook acquistato da rosalba faraci
Beiträge zu systemischen Lösungen nach Bert Hellinger, Heidel-
berg, 1998.
Nelles, Wilfried: Liebe, die löst - Einsichten aus dem Familien-Stel-
len, Heidelberg, 2002.
Nelles, Wilfried: Wo die Liebe hinfällt - Gespräche über Paarbezie-
hungen und Familienbande, Himberg, 2002.
Neuhauser, Johannes (a cura di): Wie Liebe gelingt - Die Paartherapie
Bert Hellingers, Heidelberg, 1999.
Prekop, Irina/Hellinger, Bert: Wenn ihr wüsstet, wie ich euch liebe.
Wie schwierige Kinder durch Familien-Stellen und Festhalten ge-
holfen werden kann, München, 1998.
Schäfer, Thomas: Der Mann, der tausend Jahre alt werden wollte -
Märchen über Leben und Tod aus Sicht der Systemischen Psycho-
therapie Bert Hellingers, München, 1999 e 2002.
Schäfer, Thomas: Wenn der Körper Signale gibt. Wege aus der Kran-
kheit durch Systemische Aufstellungen. Prefazione di Bert Hellin-
ger, München, 2004.
Schäfer, Thomas: Wenn Dornröschen nicht mehr aufwacht - Bekan-
nte Märchen aus Sicht von Bert Hellingers Familienaufstellungen,
München, 2001.
Schäfer, Thomas: Wenn die Liebe allein den Kindern nicht hilft - Hei-
lende Wege in Bert Hellingers Psychotherapie, München, 2002.
Schneider, Jakob/Gross, Brigitte: Ach wie gut, dass ich es weiß - Mär-
chen und andere Geschichten in der systemisch-phänomenologi-
schen Therapie, Heidelberg, 2000.
Ulsamer, Berthold: Ohne Wurzel keine Flügel - Die systemische The-
rapie von Bert Hellinger, München, 1999 (Ulsamer, Berthold: Sen-
za radici non si vola: la terapia sistemica di Bert Hellinger, Spigno
Saturnia, 2000).
van Kampenhout, Daan: Die Heilung kommt von außerhalb - Scha-
manismus und Familien-Stellen, Heidelberg, 2001.
Weber, Gunthard (a cura di): Derselbe Wind lässt viele Drachen stei-
gen - Systemische Lösungen im Einklang, Heidelberg, 2001.
Weber, Gunthard (a cura di): Praxis der Organisationsaufstellungen,
Heidelberg, 2000.
Weber, Gunthard (a cura di): Zweierlei Glück - Die Systemische The-
rapie Bert Hellinger, Heidelberg, 1993 (a cura di Weber, Gunthard:
I due volti dell’amore: come far funzionare l’amore nei rapporti af-
fettivi, Spigno Saturnia, 2002).
PUBBLICAZIONI DI E SU BERT HELLINGER 153
eBook acquistato da rosalba faraci
N U O V I E Q U I L I B R I
Nessun’altro psicoterapeuta ha avuto negli ultimi anni un’eco pari
a quella ottenuta da Bert Hellinger. Ciononostante non esisteva finora
un’opera che rendesse il suo pensiero accessibile a tutti. Con questo
libro il naturopata e psicoterapeuta Thomas Schäfer avvicina le teorie
ed i metodi terapeutici di Hellinger ad una cerchia più ampia di lettori.
Quali sono le cause familiari di gravi malattie?
Perché alcune relazioni fra uomo e donna, fra genitori e figli,
si sviluppano in modo armonico mentre altre falliscono?
Che ruolo svolge la religione nello sviluppo umano?
Come deve essere affrontata la morte?
Hellinger considera la famiglia il principale sistema sociale responsabile
di tante gioie e tanto dolore. Per questo l’autore si sofferma in particolare
sulla tecnica delle “Costellazioni Familiari” sviluppata da Hellinger.
Spiega com’è possibile eliminare le dinamiche che fanno ammalare
e permettere all’amore originario di continuare a fluire.
Thomas Schäfer ha studiato sociologia e si è laureato nel 1985 presso l’Università
di Heidelberg. Dal 1993 lavora a Heidelberg e Stockach come naturopata specializzato
in psicoterapia. Ha inoltre frequentato numerosi corsi di formazione e specializzazione
sui metodi psicoterapeutici, fra cui la terapia ipnotica di Milton Ericksons.
Ha pubblicato numerosi racconti e libri sulle Costellazioni Familiari di Bert Hellinger.
eBook acquistato da rosalba faraci
Potrebbero piacerti anche
- Metamorfosi Dell'immobilita'Documento56 pagineMetamorfosi Dell'immobilita'Veronica GabberoNessuna valutazione finora
- Tarocchi Egiziani, Il Significato Dei 78 ArcaniDocumento47 pagineTarocchi Egiziani, Il Significato Dei 78 ArcanirosalbaNessuna valutazione finora
- Tarocchi e Zodiaco. Archetipi Del Pensiero SimbolicoDocumento1 paginaTarocchi e Zodiaco. Archetipi Del Pensiero SimbolicorosalbaNessuna valutazione finora
- Mario Livio, La Sezione Aurea - Storia Di Un Numero e Di Un Mistero Che Dura Da Tremila Anni, Rizzoli, 2003Documento215 pagineMario Livio, La Sezione Aurea - Storia Di Un Numero e Di Un Mistero Che Dura Da Tremila Anni, Rizzoli, 2003rosalbaNessuna valutazione finora
- GUIDA ALL'ASTRAZIONE, CONCENTRAZIONE E MEDITAZIONE - 9° Quaderno - Tommaso PalamidessiDocumento41 pagineGUIDA ALL'ASTRAZIONE, CONCENTRAZIONE E MEDITAZIONE - 9° Quaderno - Tommaso PalamidessirosalbaNessuna valutazione finora
- La Via Dei Simboli e La Trasmutazione Spirituale (Quattordicesimo Quaderno) by Tommaso PalamidessiDocumento33 pagineLa Via Dei Simboli e La Trasmutazione Spirituale (Quattordicesimo Quaderno) by Tommaso PalamidessirosalbaNessuna valutazione finora
- (Bello - Leggere) - Igor Sibaldi - La Creazione Dell'UniversoDocumento312 pagine(Bello - Leggere) - Igor Sibaldi - La Creazione Dell'UniversorosalbaNessuna valutazione finora
- Esseni - Chi Sono Gli EsseniDocumento3 pagineEsseni - Chi Sono Gli EssenirosalbaNessuna valutazione finora
- Masaru Emoto - L'acqua È Viva, Ha Un Anima - Cristalli e AcquaDocumento4 pagineMasaru Emoto - L'acqua È Viva, Ha Un Anima - Cristalli e AcquarosalbaNessuna valutazione finora
- I Segreti Del Sufismo. Ibn 'Arabi e La Metafisica Nella Tradizione Esoterica Dell'islamDocumento1 paginaI Segreti Del Sufismo. Ibn 'Arabi e La Metafisica Nella Tradizione Esoterica Dell'islamrosalbaNessuna valutazione finora
- The Magic Magia Rhonda ByrneDocumento160 pagineThe Magic Magia Rhonda ByrnerosalbaNessuna valutazione finora
- La Scienza Dei Numeri - Numerologia - SottolineatoDocumento54 pagineLa Scienza Dei Numeri - Numerologia - SottolineatorosalbaNessuna valutazione finora
- Tarocchi e RuneDocumento29 pagineTarocchi e RunerosalbaNessuna valutazione finora
- Iniziazione Alle Rune Nuova Ed. - IntDocumento19 pagineIniziazione Alle Rune Nuova Ed. - IntrosalbaNessuna valutazione finora
- Hermes - Il Fiore Della VitaDocumento87 pagineHermes - Il Fiore Della VitarosalbaNessuna valutazione finora
- HoponoDocumento20 pagineHoponorosalba100% (1)
- Il Perdono e - Uno Stao MentaleDocumento27 pagineIl Perdono e - Uno Stao MentalerosalbaNessuna valutazione finora
- Tenca - 4 LibriDocumento2 pagineTenca - 4 LibrirosalbaNessuna valutazione finora
- Essere FeliciDocumento210 pagineEssere FelicirosalbaNessuna valutazione finora
- Appunti FermaniDocumento2 pagineAppunti FermaniGabriela-Diana CiorneiNessuna valutazione finora
- 02 - I Filosofi Della PhysisDocumento15 pagine02 - I Filosofi Della PhysisLeonardo SimoniNessuna valutazione finora
- SocrateDocumento2 pagineSocrateFrancesco AstorinoNessuna valutazione finora