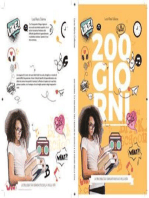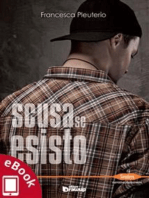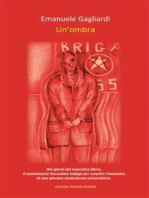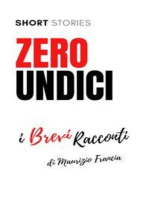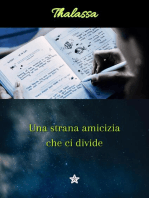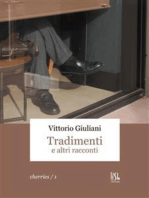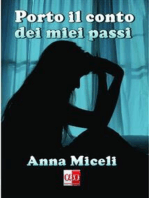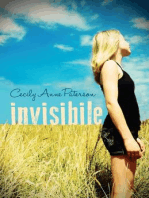Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Le Farfalle Nel Cuore
Caricato da
Irene Pedretti0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
75 visualizzazioni6 pagineracconto sull'Alzheimer
Titolo originale
Le farfalle nel cuore
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoracconto sull'Alzheimer
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
75 visualizzazioni6 pagineLe Farfalle Nel Cuore
Caricato da
Irene Pedrettiracconto sull'Alzheimer
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 6
Le
farfalle nel cuore
Questa mattina mi sono svegliata con un ritornello in testa, anzi con brandelli di una canzone.
Forse si tratta di una pubblicità. -All’ombra dell’ultimo sole, versò il vino e spezzo il pane per
chi diceva ho sete e fame-. No più probabilmente si tratta di musica da chiesa.
Comunque non ne vuole sapere di togliersi di torno, è come se fosse stata registrata in qualche
angolo della mia mente e ora si sia inceppata tra naso e orecchie.
Vorrei ricordare qualche parola in più ma già so che se mi sforzo dimenticherò anche le poche
parole del ritornello finché rimarrà solo la melodia e poi nemmeno più quella. Quindi non mi
sforzo.
Nel pomeriggio sono arrivate la Signora con la bambina, e dato che a loro posso chiedere delle
cose, ho provato a vedere se mi aiutavano con il ritornello che ancora non se n’era andato.
“Nonna, com’è che fa questa canzone?”.
Le ho ripetuto le parole che ricordavo ma a loro non dicevano niente così hanno provato a
cercarle sul telefono ma non c’era campo. Io stavo zitta mentre usavano il telefono per cercare
una canzone. Vedendole così concentrate in quella assurdità a un certo punto mi preoccupai
che avessero perso la testa e sbottai: “Va beh, va beh non è niente di importante”.
“Nonna non ti preoccupare appena usciamo c’è campo e te la cerco”. E io scoppio a ridere con
questa storia del campo, -ma che razza di campo è?-. Mi immagino un enorme campo di
girasoli dove ad ogni petalo di ogni fiore corrisponde una risposta solo che è difficilissimo
trovarla se non ci sai navigare dentro. Ecco l’altra parola che mi fa sbellicare: navigare. Stanno
tutti a navigare nel campo. Comunque ho imparato già da un po’ di tempo a non fare domande
che tanto le risposte che mi danno sono più assurde delle richieste che faccio. E poi che facce
fanno!, un misto tra stupore, pena e –ma che cazzo mi chiede questa?-.
Quindi zitta e muta con stampato in faccia il mio sorriso di circostanza. E son tutti più
tranquilli.
A proposito, qui dentro ce ne sono di tutti i colori. Ho imparato a riconoscere i tizi in bianco
sempre seri e con le cartelline. Con loro devo stare particolarmente attenta. Basta una parola
fuori posto e subito si mettono a consultarsi con le facce arrabbiate. Così ho affinato un mio
metodo. Loro fanno dieci domande, io ho dieci dita. Primo: “Buongiorno Aurora!”. Primo dito:
“Buongiorno dottore!”. Ecco non devo assolutamente dire cose tipo: “Ma Aurora chi?” o cose
leggermente più volgari che a volte mi scivolano fuori senza che me ne accorga. Cose tipo:
“Buongiorno forse per lei, sente che puzza orrenda in questa camera!” fino allo spinto
turpiloquio di quando mi sveglio con i dolori di Matusalemme.
Secondo: “Come andiamo oggi?”. Secondo dito: “Bene, finché mi sveglio con i dolori vuol dire
che sono viva quindi diciamo bene!”. Questa battuta insulsa ripetuta ogni giorno li fa sempre
sorridere e quindi la tengo fissa al secondo dito.
Terzo: “Hai fatto colazione?”. Terzo dito: “Si”. E qui devo subito stringere forte i pugni per non
dirgli che la frutta cotta fa vomitare, che il thè tiepido manco in ospedale e che le fette
biscottate senza poterci spalmare sopra niente sono più tristi di una telenovela latino
americana. Da qui partono una raffica di domande e devo stare attentissima a non perdermi
un dito dopo l’altro. Se ci riesco l’agonia finisce velocemente altrimenti si entra nel vortice
delle domande per le quali non ho risposte, delle parole sbagliate e dell’ansia che cresce.
“Aurora stai tranquilla, abbiamo finito!”. Ecco andatevene a rompere le scatole a qualcun altro.
Dopo che se ne vanno i bianchi rimango svuotata, devo aprire la finestra per cominciare a
respirare di nuovo. Ma per poter aprire la finestra devo aspettare le Signorine camice azzurro
perché c’è una sicurezza messa troppo in alto per me. Forse qualcuno pensa che se potessi
aprirmela da sola, la maledetta finestra, potrei buttarmi di sotto. Ammetto di aver accarezzato
l’idea, qualche volta ma il pensiero del mio corpo spiaccicato sul selciato di sotto, tra l’aiuola
delle azalee e la fontana, è abbastanza schifoso da farmi desistere.
Dunque dicevamo delle Signorine camice azzurro. Loro mi lavano, rifanno la camera e aprono
la finestra. La maggior parte sono frettolose, alcune sono gentili e una la eliminerei proprio. E
poi c’è il fisicoterapista. Nome azzeccatissimo visto il corpo da David di Michelangelo che si
ritrova. Quando mi fa fare gli esercizi appena posso sbircio il suo bel sedere. E’ così bello
tondo e sodo che a volte mi commuovo. E poi adoro quando mi fa appoggiare sul suo braccio.
Mi ci appendo proprio e a volte faccio finta di inciampare così mi deve accogliere in un grande
abbraccio. E’ forte, caldo e ha sempre un buon profumo. Non mi ricordo mai quali sono i giorni
degli esercizi così tutte le volte che lo vedo è una sorpresa.
Infine ci sono quelli di tutti i colori. Li chiamano “Le visite”. Ho capito che hanno degli orari
stabiliti e che ci sono giorni che non possono venire per via del lavoro, della scuola e di altri
impegni improrogabili. Credo vengano una volta a settimana anche se a volte mi sembrano
che passino anni. Non devo chiamarli per nome perché pare che mi sbagli sempre, alcuni ci
ridono ma la maggior parte ci rimane male. Riconosco solo la bambina, è mia figlia anche se
mi chiama nonna. E’ bellissima ma diventa più antipatica ogni volta che viene, credo sia
l’adolescenza. Sembra sempre avere fretta di andare via mentre la Signora che la accompagna
è così gentile e premurosa. Mi dà solo fastidio che si sia presa la libertà di chiamarmi mamma
ma non le dico niente perché vedo nei suoi occhi una profonda tristezza.
A volte mi prende la mano e mi massaggia le dita una ad una, chiedendomi se mi ricordo di
come io lo facessi a lei da piccola. La accarezzo e le dico di sì scavando nella mia memoria alla
ricerca di un ricordo che non è più mio.
Questa mattina mi sono svegliata e mi sono sentita osservata. Le orribili facce che hanno
appeso al muro davanti al mio letto mi guardavano, anzi, si stavano prendendo gioco di me.
Ho chiuso gli occhi e le ho sentite ridere. Gli ho tirato tutte le cose cha avevo a portata sul
comodino e loro continuavano a ridere.
Non so da quanto tempo stavo lottando ma quando ormai ero sfinita è entrato qualcuno. Era
una delle signorine gentili ma ero fuori di me e così il telecomando che avevo raccattato da
sotto al letto per tirarlo alla faccia grande le è finito addosso.
“Aurora che succede?”. La voce allarmata ha allarmato anche me e sono sbottata senza
ricordarmi del metodo delle dieci dita. “Ma Aurora chi? La volete smettere di chiamarmi così!
E’ un nome del cazzo e qui ci sono solo io. Aurora sarà nella prossima stanza.” E alzando la
voce in modo che potessero sentirmi anche quelli del piano di sotto ho urlato che dovevano
togliermi quelle facce da davanti, se no facevo un macello.
“Ma quali facce Aur… Signora?”.
Si è rincoglionita anche questa. “Quelle lì appese sul muro non le vedi?”.
“Ma non sono facce, è un quadro astratto, non si riconosce niente!”
Forse non le riconoscerai tu ma io ci ho litigato tutta la mattina. Sento la mia voce farsi
lamentosa: “Ti prego toglilo, ti chiedo solo di toglierlo!”.
“Ma non posso fa parte dell’arredo della clinica!”.
Sprofondo nell’angoscia, non posso pensare di svegliarmi anche domani con quei brutti musi
lì e comincio a piangere.
“Calmati, ti devi calmare se no devo chiamare qualcuno. Aurora è solo un quadro”.
Niente, non riesce a capire e comincio a tremare dalla rabbia bisbigliando: toglilo, toglilo,
toglilo.
E lei ha il colpo di genio. Alzandosi di scatto va a staccare il quadro, lo capovolge e lo
riappende alla parete. Poi timidamente: “Così va meglio?”
Benedetta ragazza!. Certo che va meglio, ora sembrano dei fessacchiotti a faccia in giù. Ora
rido io di loro e infatti mi viene un sacco da ridere e più rido più anche lei è contenta.
Sistema le cose della camera parlando un po’ con me un po’ con il quadro poi mi saluta
dicendo: “tanto non se ne accorgerà nessuno, brutto era e brutto è rimasto! Acqua in bocca
però!” E mi fa l’occhiolino andandosene saltellando.
Questa cosa dell’acqua in bocca però non l’ho capita. Mi tormentano tutto il giorno con l’assillo
di bere, bere e ancora bere. Il mi berrei una bella birretta e invece solo acqua che fa digerire
che ha quel lieve odore di uova marcie che tutto ti fa venire tranne voglia di bere. Forse
l’acqua in bocca la devo tenere per via delle gengive che mi fanno male. La prossima volta che
viene glielo chiedo, se me lo ricordo.
Questa mattina mi sono svegliata tutta sudata, con il sangue ancora caldo per la notte appena
trascorsa. Una notte di sogni erotici come non ne facevo da tempo o, più probabilmente, come
non ne ho mai fatti. Una meraviglia di baci, carezze e di indugi miei e suoi. Passo le mani tra le
lenzuola e poi me le appoggio sulla pancia. Sono caldissime. Leggero arriva il ricordo della sua
testa appoggiata lì e dei suoi capelli un po’ ispidi che tagliati corti mi sembravano uno zerbino.
Li accarezzo piano.
“Aurora!, ma non ti sei ancora alzata?”
Il tono non è dei più piacevoli e come sempre interrompe qualcosa di bello.
“No!, perché?. Mi dovrei alzare per fare cosa esattamente?” sento la mia voce sgradevolmente
alta ma il fastidio è troppo.
E così comincia la tiritera di ogni mattina. Questa signorina camice azzurro è tra le più
insopportabili, una specie di gatta morta con le unghie lunghe e affilate. Si lamenta sempre. Di
tutto e di tutti. Ogni giorno dice che vuole andarsene ma poi non se ne va mai. Ogni tanto
medito di darle un aiutino spingendola con un bel calcione giù dalla finestra.
Cerco di non ascoltare le sue recriminazioni e mi concentro sui sogni appena trascorsi, sulle
mani strette, i corpi frettolosi e pieni di vita. Chissà dov’è ora quel corpo, quell’uomo forte con
le labbra sottili e gli occhi profondi che sapeva farmi ridere quando nessuno aveva il coraggio
di farlo.
Questa mattina mi sono svegliata con un bel po’ di trambusto fuori dalla porta.
E’ venuta la Signora senza la bambina accompagnata da un Signore che non avevo mai visto
prima. E’ bello ed elegante ma freddo e distaccato. Lei è così pallida che potrebbe svenire da
un momento all’altro e quando le si appoggia alla spalla la scansa infastidito. -Che stronzo!-.
Parlano fitto fitto con i Signori in bianco che si sono presentati al gran completo. Ogni tanto
qualcuno lancia uno sguardo furtivo dentro la camera ma senza soffermarsi su di me. Forse
vogliono rifare la stanza e stanno decidendo i colori delle pareti. Parlano di sperimentazione.
Penso che per me possono sperimentare tutte le tinte che vogliono basta che mi tolgono
questo verdino caghetta che va d’accordo giusto con la frutta cotta.
“Lei è sempre più lontana, non credo abbia molti momenti di lucidità e poi sta diventando
anche violenta.”
Che tristezza sentire parlare così di una paziente. Forse si tratta della Signora Tartaruga. L’ho
soprannominata così perché ha una faccia con tante di quelle rughe che sembra uno di quei
giochi della Settimana enigmistica che parti da una parte e, dopo un’infinità di giri, devi uscire
dall’altra. Deve essere davvero super vecchia ed è messa così male che anche il mio bel
fisicoterapista ha perso le speranze.
“Vorremmo provare con questo nuovo farmaco, sembra che su qualche paziente abbia avuto
esiti straordinari ma dobbiamo tenere conto degli effetti collaterali soprattutto visto il diabete
di sua madre”.
Oh, non sapevo che la Signora Tartaruga avesse il diabete.
Continuano a parlare a voce sempre più bassa poi la Signora chiede: “Potrebbe riconoscermi
ancora?”
Che palle con questa ansia del riconoscimento. Sei bella, sei gentile che cosa ti interessa
dell’essere riconosciuta?.
Mi sono appisolata quando sento un tocco leggero sulla mano. Ho gli occhi ancora chiusi e
vorrei che mi accarezzasse ancora ma il bellimbusto la chiama: “Chiara ti muovi? Tanto sta
dormendo”.
Mi accarezza ancora un poco, poi se ne va chiudendosi dietro la porta e penso alla bellissima
coincidenza del nome della Signora gentile che è lo stesso di mia figlia.
Questa mattina mi sono svegliata e ricordo tutto. Come una doccia freddissima mi stanno
piombando addosso echi rimossi, memorie lontane e presenti inquietanti.
Riconosco la freddezza di una clinica e il quadro di Kandinskij alla parete chiedendomi chi sia
stato l’idiota che l’ha appeso al contrario.
Sento le voci in corridoio. Devono essere i medici. Una infermiera lancia gridolini appena uno
di loro le fa un complimento. Aspetto paziente che arrivi qualcuno per chiedergli cosa ci faccio
qui.
Più aspetto più mi rompo le scatole, così decido di alzarmi. Sollevo il lenzuolo e non riconosco
le mie gambe al posto delle quali vedo dei salamotti bluastri. –Che schifo!-
Ah forse è per questo che sono in ospedale.
Con non poca fatica mi alzo e finalmente riesco ad andare in bagno. C’è uno specchio piccolo
ma non così tanto da impedirmi di inquadrare il mio faccione. Grande, grosso e pieno di rughe.
-Ma dov’è la mia faccia?-
Poi tutto diventa nero e mi sento cadere sul pavimento freddo.
Mi sveglio di nuovo nel letto ma questa volta ci sono due dottori e un’infermiera.
“Aurora mi senti? Come stai?”.
“Dottore certo che la sento. Lei come starebbe dopo uno svenimento e una capocciata sul
pavimento?”.
“Sempre la solita Aurora!” e tutti a ridere. Va beh la cosa mi fa incazzare ancora di più e chiedo
che mi spieghino perché sono lì.
Mi fanno un sacco di domande, alcune davvero ridicole e mentre li vedo che scrivono,
scrivono e si lanciano occhiate compiaciute, butto lì l’unica domanda a cui dovevano dare una
risposta.
“Ma io quando torno a casa?”
E cominciano con un ritornello di non lo sappiamo, dobbiamo vedere se i miglioramenti sono
stabili e poi dobbiamo tenere sotto controllo le altre patologie e giù un sacco di scuse senza
trovare il coraggio di dirmi che a casa non sarei potuta tornare.
-Che grande rottura!-.
Questa mattina mi sono svegliata e ai piedi del mio letto c’è Chiara. Che bella donna è
diventata!. La guardo ancora un po’ soffermandomi sulla fossetta del mento uguale a quella
del papà, sulla curva della bocca appena imbronciata e sugli occhi attraverso i quali, quando
era piccola, le chiedevo di scoprire le meraviglie del mondo. E poi lei mi vede. Timidamente mi
chiama: “Mamma!”.
“Sono qui amore mio”. E mi abbraccia e piange e io non capisco perché.
Poi mi racconta di questi due anni in cui io non ci sono stata, di come a poco a poco non l’abbia
più riconosciuta fino a rinchiudermi in un mondo piccolo quanto questa stanza perché tutto
quello che accadeva oltre quella porta era troppo sconosciuto e imprevedibile per non farmi
venire attacchi d’ansia accompagnati da crisi violente.
Ascoltavo le sue parole come se non stesse parlando di me, non riuscivo a capire come il mio
cervello non fosse più riuscito a fare nemmeno i percorsi più semplici, come avesse potuto
dimenticare persino cose che credevo impresse a fuoco nei miei neuroni.
Poi con una sensazione di calore che dallo stomaco è dilagata fino alle estremità delle mani ho
preso consapevolezza del mio essere morta, morta per un mondo che non era più il mio
perché non lo potevo riconoscere. Che il mio corpo fosse ancora qui mi sembrò solo una beffa
feroce.
Chiara parlava, raccontava cose che non mi interessavano. Sembrava che volesse riempire
tutti i buchi di silenzio che in quei due anni erano diventati sempre più grandi. Io volevo
vivere, capire e soprattutto uscire di lì.
Però non potevo. I farmaci che mi avevano restituito la memoria avevano diversi effetti
collaterali e essendo in fase sperimentale alcuni avrebbero potuto scoprirli direttamente sulla
mia pelle.
Guardai la sponda in ferro del letto, il quadro, la sedia bassa vicino alla finestra e mi venne da
ridere al pensiero che ora che avrei potuto di nuovo ricordare non avrei avuto altro da vivere
se non quella stanza di ospedale.
Mi guardai la mano che mia figlia aveva intrecciato alla sua e mi chiesi cosa avrei fatto quando
se ne sarebbe andata.
Le chiesi soltanto di tornare il prima possibile.
Questa mattina mi sono svegliata e ai piedi del mio letto c’è Chiara. La notte è stata
lunghissima. Sono venuti a trovarmi fantasmi di persone, alcune delle quali non sono riuscita
a ricordare se vive o morte. Poi ho capito cosa dovevo fare e mi sono lasciata andare a un
sonno senza sogni.
“Mamma, come stai?”
Mentre cerco gli occhiali per mettere a fuoco il suo viso le rispondo non troppo convinta:
“Bene.” E lei non contenta della mia banale risposta, incalza: mi chiede se ho dolori alle gambe,
se ho sete, quante volte sono andata in bagno …
La guardo e mi sembra che questa volta sia lei a non riconoscermi. “Amore mio davvero ti
importa delle reazioni di questo vecchio corpo? Parla con me, raccontami di quello che hai
fatto in questi due anni.”
Mi dice che devono monitorarmi, capire le reazioni. A me non importa, non più. Sto pensando
al mare.
“Chiara ascoltami! Lascia perdere gli esperimenti, portami al mare!”. Devo essere stata troppo
diretta e lei spalanca gli occhi come quando mi chiedeva di salvare uno dei tanti animali in via
d’estinzione e io non sapevo da che parte iniziare.
Allora le spiego i particolari del mio piano. Deve venire a prendermi una di queste mattine e
portarmi via. Io qui dentro non ci voglio restare.
Alza le sopracciglia e prova a farmi ragionare come facevo io con lei quando ero piccola. Poi la
guardo e le faccio l’occhiolino, il nostro messaggio in codice per dirci “solo io e te ci capiamo!”
e lei scoppia a ridere e mi dice: “Mamma ti prego!” e già so che sta cominciando a cedere.
Parliamo tanto, come non ricordo di avere mai fatto, e poi capisco che lo faremo insieme. Per
l’ultima volta.
Questa mattina non mi sono svegliata. Durante la notte il mio muscolo cardiaco è impazzito
più volte, prima andando a un ritmo esagerato poi rallentando pericolosamente. Poi
sopraffatto da quelle montagne russe si è fermato, non prima di aver sfogliato tutti i ricordi
del mio cuore.
Sono andata al mare con Chiara. Ho scalato con lei gli scogli sedendomi a guardare le onde
mentre fischiava il maestrale. E come goccioline di sale che ti investono il viso sono arrivati
tutti i ricordi.
Ho camminato in montagna trotterellando dietro a Marco, il mio fratellino che seguiva
mamma fiducioso fino a quando persi sul sentierino dietro casa, ci siamo messi tutti a
chiamare disperati: “papà!”. E lui è arrivato e mi ha preso sulle spalle.
Ho giocato con Pluto che è riuscito a masticarmi le scarpe migliori mentre ha lasciato indietro
le ciabatte.
Ho attraversato Firenze in bicicletta con libri troppo pesanti nello zaino.
Ho camminato per Roma alle prime luci del mattino e l’ho trovata bellissima.
E quando le pagine del mio manoscritto segreto hanno cominciato a lasciarsi andare e ad
aprire le ali come farfalle è arrivato il dolore, il dolore più ancestrale e potente che ho potuto
sopportare. Avevo troppo caldo e non avevo fiato abbastanza. E stringevo la sua mano,
chiedendogli di non lasciarla per nessuna ragione al mondo.
Poi è successo tutto in fretta, mi ha lasciato la mano e il dolore è finito perché quel piccolo
corpicino che avevano appoggiato sulla mia pancia aveva avuto il coraggio di venire al mondo.
E nell’ultimo dolcissimo istante in cui tutto tornava soltanto perché potessi lasciarlo andare,
ho capito che stavo morendo per nascere un’altra volta.
Potrebbero piacerti anche
- 1 Maggiore 1263 Parte 5Documento5 pagine1 Maggiore 1263 Parte 5h a p p y n e s sNessuna valutazione finora
- 1 Maggiore 1263 Parte 4Documento5 pagine1 Maggiore 1263 Parte 4h a p p y n e s sNessuna valutazione finora
- Cuò Re. Sostantivo Maschile DRAMMATURGIA 2Documento28 pagineCuò Re. Sostantivo Maschile DRAMMATURGIA 2Daniela GiovanettiNessuna valutazione finora
- 1 Maggiore 1263 Parte 2Documento5 pagine1 Maggiore 1263 Parte 2h a p p y n e s sNessuna valutazione finora
- 200 giorni: La dislessia tra i banchi di scuola e nella vitaDa Everand200 giorni: La dislessia tra i banchi di scuola e nella vitaNessuna valutazione finora
- Il Ragazzo Di San PietroburgoDocumento3 pagineIl Ragazzo Di San PietroburgoVictoria BarniNessuna valutazione finora
- Zero Undici: I brevi racconti di Maurizio FranciaDa EverandZero Undici: I brevi racconti di Maurizio FranciaNessuna valutazione finora
- La strada è in salita ma la vista è grandiosa Vol IIDa EverandLa strada è in salita ma la vista è grandiosa Vol IINessuna valutazione finora
- Stringimi Le Mani Romanzo D AmoreDocumento44 pagineStringimi Le Mani Romanzo D Amoremarya86Nessuna valutazione finora
- Metaverso: Nulla è in pausa e nulla si riavvolgeDa EverandMetaverso: Nulla è in pausa e nulla si riavvolgeNessuna valutazione finora
- Le Funzioni Della Memoria Di Lavoro Visuo-SpazialeDocumento2 pagineLe Funzioni Della Memoria Di Lavoro Visuo-SpazialePsycHomer100% (1)
- L'Afasia Dopo L'evento StrokeDocumento42 pagineL'Afasia Dopo L'evento StrokeAlfraedNessuna valutazione finora
- 4 - Il Rituale Dell'InterazioneDocumento2 pagine4 - Il Rituale Dell'Interazioneemanuele_congedoNessuna valutazione finora
- La Semplificazione Dei Testi Alan PonaDocumento46 pagineLa Semplificazione Dei Testi Alan PonaMarco PappalardoNessuna valutazione finora
- Sara Porro L Alfabeto Delle Piccole FelicitaDocumento31 pagineSara Porro L Alfabeto Delle Piccole FelicitaFedericaNessuna valutazione finora