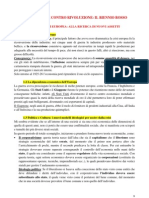Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Repressione e Dissenso Procacci
Caricato da
paolo vaccaroCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Repressione e Dissenso Procacci
Caricato da
paolo vaccaroCopyright:
Formati disponibili
Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
Author(s): Giovanna Procacci
Source: Studi Storici , Jan. - Mar., 1981, Anno 22, No. 1 (Jan. - Mar., 1981), pp. 119-150
Published by: Fondazione Istituto Gramsci
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/20564896
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Studi Storici
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
REPRESSIONE E DISSENSO
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Giovanna Procacci
Uno degli argomenti che la storiografia italiana ha spesso discusso, ma
non altrettanto approfondito, e quello del dissenso popolare durante la
prima guerra mondiale.
Come e noto, fin dalla fine degli anni Cinquanta gli studi di Spriano,
Monticone e Zucaro su Torino operaia durante iA conflitto e sui moti del
l'agosto 1917 permisero di fondare su basi documentarie le vicende della
classe operaia del principale centro piemontese 1; la pubblicazione da parte
di Renzo De Felice della relazione dell'Ufficio riservato di Pubblica sicu
rezza sulle agitazioni che si verificarono dalla seconda meta del 1916 alla
primavera del 1917 nelle varie regioni d'Italia, forni ulteriori fonti per
la conoscenza delle manifestazioni di protesta in tutto il paese 2. Ma la
carenza di successive analisi documentarie impedi che per lungo tempo il
dibattito si arricchisse di nuovi elementi '. Sulla base infatti dei documenti
pubblicati - in particolare di quelli editi da De Felice, i soli che riguar
dassero tutto il territorio nazionale, ma che, in quanto sintesi delle singole
1 P. Spriano, Torino operaia nella grande guerra (1914-1918), Torino, 1960; A. Mon
ticone, II socialismo torinese e i fatti dell'agosto 1917, in ? Rassegna storica del Ri
sorgimento ?, 1958, 1, pp. 51-96 (poi in Id, Gli italiani in uniforme 1915-1918,
Bari, 1972); D. Zucaro, La rivolta di Torino del 1917 nella sentenza del Tribunale
militare territoriale, in ? Rivista storica del socialismo ?, 1960, 10, pp. 437-469.
2 R. De Felice, Ordine pubblico e orientamenti delle masse popolari nella prima
meta del 1917, in ?Rivista storica del socialismo?, 1963, 20, pp. 467-504. Sulle
agitazioni al momento dell'intervento v. B. Vigezzi, Le ? radi?se giornate ? del
maggio 1915 nei rapporti dei prefetti, in ? Nuova rivista storica ?, 1959, 3, pp. 313-344;
1960, 1, pp. 54-111 (poi in Id, Da Giolitti a Salandra, Firenze, 1969).
3 Nei 1968 usci un saggio di R. Paci sulla struttura econ?mica, ma anche con im
portanti notazioni sulle condizioni di lavoro e le lotte (R. Paci, Le trasformazioni
ed innovazioni nella struttura econ?mica italiana, in Aa.Vv, II trauma dell'in
tervento: 1914-1919, Firenze, 1968, pp. 29-55); e nei fascicolo 32 della ?Rivista
storica del socialismo ?, uscito nei 1970, dedicato a II Psi e la grande guerra,
forn? notizie documentarle N. De Stefano, Moti popolari in Emilia-Romagna e To
scana 1915-1917, pp. 191-216; nello stesso numero della rivista vennero pubblicati,
a cura di P. Melograni, documenti sullo stato d'animo delle truppe nei 1918, con
tenenti per? anche riferimenti sulle condizioni dello spirito pubblico all'interno
(P. Melograni, Documenti sul ? morale delle truppe ? dopo Caporetto e conside
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
120 Giovanna Procacci
relazioni prefettizie, si soffermavano sulle condizioni generali dell'ordine
pubblico, senza entrare negli specifici particolari delle lotte nelle fabbriche
- parte della storiografia veniva indotta a esprimere giudizi fortemente
riduttivi sull'entita e i caratteri dell'opposizione al regime di guerra. Tale
opposizione veniva circoscritta essenzialmente alle manifestazioni, svoltesi
nelle campagne e nei piccoli centri, contro il carovita e la mancanza di
generi di prima necessita. II fatto che esse fossero nella maggior parte dei
casi promosse da donne, e che ad esse mancasse il supporto organizzativo
del Partito socialista, faceva giungere alla conclusione che, se una prote
sta contro la guerra c'era stata - De Felice sosteneva che in alcuni casi
le agitazioni erano state sul punto di assumere intonazioni di tipo rivolu
zionario - essa non era uscita tuttavia dall'ambito di una ribellione spon
tanea, ed era pertanto priva di effettiva portata politica 4.
Escluso ogni rapporto organico tra manifestazioni contadine e agitazioni
in fabbrica (che anzi veniva sottolineato l'accentuarsi dello storico dissi
dio tra mondo rurale e cittadino), il giudizio nei confronti del dissenso
operaio era ancora piu drastico. La forte diminuzione della conflittualita in
fabbrica, la grande prevalenza di scioperi per motivi economici e la loro
breve durata portavano infatti a supporre che, con la sola eccezione del
proletariato torinese, la classe operaia italiana fosse rimasta sostanzialmente
estranea al conflitto, e percio politicamente passiva, con punte anzi di espli
cito patriottismo dopo Caporetto.
Pur non condividendo tali conclusioni estreme, anche la storiografia piu
attenta alle vicende del movimento operaio concordava sostanzialmente sul
la dicotomia tra manifestazioni spontanee di protesta delle campagne e agi
tazioni economiche in fabbrica, attribuendo la relativa combattivita poli
tica del proletariato (eccettuato ovviamente quello torinese) soprattutto al
la tregua decisa dagli organi dirigenti del sindacato e del Partito socialista.
L'attenzione, piu che sul fermento della base, veniva cosi concentrata sul
le posizioni assunte nei confronti della guerra dalle varie correnti del
partito '.
In tempi recenti, tuttavia, un nuovo interesse si e risvegliato riguardo alla
razioni sulla propaganda socialista, pp. 217-263). In questa sede terremo conto
solo del dissenso della popolazione civile, rimandando per quello delle truppe,
oltre al citato articolo di Melograni, alla sua Storia politica della grande guerra,
Bari, 1969, e a E. Forcella, A. Monticone, Plotone d'esecuzione. I processi della
prima guerra mondiale, Bari, 1968.
4 Cfr. R. De Felice, Ordine pubblico..., cit., pp. 468-477; Id., Mussolini il rivo
luzionario, 1883-1920, Torino, 1965, pp. 315 sgg., 332, 412 sgg.; P. Melograni,
Documenti..., cit., pp. 222-224; Id., Storia politica..., cit., pp. 294, 329-342, 470-474,
535-537; N. De Stefano, op. cit., passim; M. Mazzetti, L'industria italiana nella
grande guerra, Roma, 1979, pp. 95-98, 106-119. Anche secondo R. Vivarelli, Rivo
luzione e reazione in Italia negli anni 1918-1922, in Rivoluzione e reazione in
Europa 1917-1924. Convegno storico internazionale. Perugia 1978, II, Roma, 1978,
pp. 205-206, 224-238, la guerra ebbe ? carattere popolare ?, e solo nelle campagne
si verifico una forte politicizzazione in senso massimalista.
5 V. a proposito quanto osserva G. Rochat, LTtalia nella prima guerra mondiale.
Problemi di interpretazione e prospettive di ricerca, Milano, 1976, pp. 74-82.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
121 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
condizione e agli atteggiamenti della classe operaia: ne sono nati studi,
ricchi di notazioni stimolanti e di preziosi elementi documentari, sulla si
tuazione del lavoro in fabbrica, sui mutamenti della composizione della
classe operaia durante la guerra (ingresso di mano d'opera nuova, non
specializzata e piu ribelle), sulle lotte e sui rapporti tra classe operaia e
sindacato 6,
Alla luce di questi nuovi contributi, si impone oggi un riesame dei ca
ratteri del dissenso durante la guerra, in base al quale riaffrontare i pro
blemi chiave del periodo. Ovvero: rappresento la guerra dal punto di vista
della lotta di classe una parentesi, sicche le agitazioni del bienno rosso fu
rono essenzialmente suscitate dal clima di eccezione del dopoguerra, oppu
re vi fu un processo senza soluzione di continuita, che anzi subi un'accele
razione determinante negli anni del conflitto? In che misura cioe riusci
il progetto di ricomposizione sociale della classe dirigente italiana? E, piu
specificatamente, quanto l'apparato repressivo e propagandistico ottenne
i suoi effetti? Si allargo effettivamente la frattura tra citta e campagna?
Infine, che rapporto vi fu tra le manifestazioni del dissenso e l'azione dei
sindacati e dei partiti?
Senza presumere di potere in queste brevi note dare una risposta esau
riente a tali interrogativi, nelle pagine che seguono cercheremo di contri
buire alla conoscenza del problema attraverso l'analisi dell'andamento e
dei caratteri degli scioperi nelle fabbriche e delle agitazioni nelle cam
Per le pubblicazioni sul Partito socialista e sul sindacato, si rimanda alia rassegna
critica di P. Alatri, La prima guerra mondiale nella storiografia italiana dell'ultimo
venticinquennio, in ? Belfagor ?, 1973, 1, pp. 57-62, e a quella curata da A. Agosti,
A. Andreasi, G. M. Bravo, D. Marucco, N. Negrotti, II movimento sindacale in
Italia in ? Annali della Fondazione Luigi Einaudi ?, III, Torino, 1970, pp. 37-62.
6 Cfr. in particolare: V. Foa, Sindacati e lotte sociali, in Storia d'ltalia, V, I docu
menti, 2, Torino, 1973, pp. 1787-1808; E. Ragionieri, La storia politica e sociale,
ivi, IV, 3, Torino, 1976, pp. 2009-2041; G. Berta, Dalla manifattura al sistema
di fabbrica: razionalizzazione e conflit ti di lavoro, ivi, Annali, 1, Torino, 1978,
pp. 1110-1111; B. Bezza, Il sindacato di massa tra riorganizzazione capitalistica e
fascismo (1915-1925), in La Fiom dalle origini al fascismo, a cura di M. Antonioli
e B. Bezza, Bari, 1978, pp. 81-113; A. Camarda, S. Peli, L'altro esercito. La classe
operaia durante la prima guerra mondiale, Milano, 1980. Tra gli studi di storia
locale, per la mole documentarla e le acute osservazioni critiche, si rimanda so
prattutto a P. Ferraris, Sviluppo industr?ale e lot ta di classe nei Bielle se, Torino,
1972; A. Morelli, L. Tomassini, Socialismo e classe operaia a Pistoia durante la
prima guerra mondiale, Milano, 1976; A. Kelikian, Industria e sindacalismo a Brescia:
dalla mobilitazione industr?ale alla legge sindacale, in ? Annali della Fondazione
L. Einaudi?, IX, Torino, 1976, pp. 161-195; A. De Benedetti, La classe operaia
a Napoli nei primo dopoguerra, Napoli, 1976; G. Consonni, G. Tonon, Casa e lavoro
nell'area milanese. Dalla fine dell'Ottocento all'avvento del fascismo, in ? Classe ?,
1977, 14, pp. 165-259; S. Musso, L'operaio dell'auto a Torino. Struttura e lotta
dal periodo giolittiano alla fine della prima guerra mondiale, ivi, pp. 87-143 (ri
fuso poi in Id, Gli op?rai di Torino 1900-1920, Milano, 1980, donde citeremo) ;
L. Tomassini, Classe operaia e organizzazione sindacale durante la prima guerra
mondiale: la Camera del Lavoro di Firenze, 1915-1918, in ? Ricerche storiche ?,
1979, 2-3, pp. 259-374. Documenti sulle agitazioni del 1917 e 1918 sono anche
in R. Monteleone, Let tere al re, Roma, 1973.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
122 Giovanna Procacci
pagne. Poiche 1'entit'a del dissenso non puo essere valutata senza tenere
conto dell'organizzazione repressiva messa in atto durante la guerra, fa
remo precedere all'esame delle agitazioni la descrizione delle leggi ecce
zionali di pubblica sicurezza, della legislazione piu specificamente atti
nente le fabbriche sottoposte alla Mobilitazione industriale, e dei criteri
e modi con cui tali norme furono applicate.
Le leggi speciali in materia di pubblica sicurezza
Al momento dell'entrata in guerra fu emanato un corpus di decreti che
limitavano la sfera dei diritti di liberta dei cittadini. Tra di essi il R.D.
23-5-1915, n. 674 , con l'art. 3 dava facolta ai prefetti di vietare le
riunioni pubbliche e gli assembramenti in luogo pubblico (ed erano rite
nute pubbliche << anche le riunioni indette per invito in forma privata,
quando per il numero delle persone invitate e per lo scopo della riunione
o il tema da svolgersi nella conferenza e da escludere il carattere privato
della riunione >>). In base a tale articolo non solo si lasciava la possi
bilita di definire contrarie alla legge le riunioni politiche, ma gia si
profilava un attacco al diritto di sciopero8. II successivo articolo dello
stesso decreto sanciva che << nei casi di perturbazione dell'ordine pub
blico o di grave pericolo per esso >> era ammessa la perquisizione e la
immediata chiusura delle associazioni << che lo abbiano determinato o
preparato, o in qualunque modo vi abbiano preso parte >>: appare evi
dente la larga sfera di discrezionalita lasciata alle autorita di pubblica
sicurezza. L'art. 9 prevedeva infine il rimpatrio con foglio di via ob
bligatorio per misure di ordine pubblico.
Veniva in tal modo preclusa quasi ogni attivita politica di base. Fu
in applicazione a tale norma che furono sciolti, come e noto, fin dai
primi anni di guerra la maggior parte dei circoli giovanili socialisti,
e internati gli esponenti politici e sindacali considerati phiu pericolosi.
Se tale decreto salvaguardava la << sicurezza dello Stato ? da fenomeni
a carattere collettivo, un altro gruppo di norme, emanate lungo tutto
il periodo della guerra, prevedeva e puniva reati di singoli, riguardanti
la << diffusione illecita di notizie >>. Rientravano in questo settore, oltre
al decreto sulla censura e al sequestro della stampa (R.D. 23-5-1915,
n. 675), quello sulla << propalazione di notizie concernenti la guerra o
fatti connessi >> (D.Lt. 20-6-1915, n. 885) e il D.Lt. 4-10-1917, n. 1561,
7 Per i decreti citati in questo par?grafo e nei successivi si rimanda a A. De Stefarii,
La legislazione econ?mica della guerra, Bari-New Haven, 1926; e a V. Manzini,
La legislazione p?nale di guerra. Raccolta completa sistem?tica e Appendice, To
rmo, 1918.
8 Come si ricava dalla giurisprudenza: cfr. G. Neppi Modona, Sciopero, potere
politico e magistratura, Bari, 1969, pp. 197-198: il capitolo dedicate? da questo
au tore alia legislazione di guerra ? fondamentale per l'approccio al problema.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
123 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
sulle << manifestazioni ostili alla guerra o lesive di interessi connessi (di
sfattismo) >>, noto come decreto Sacchi. Secondo l'art. 2 del decreto del
20-6-15, << chiunque [...] comunicando con piu persone riunite o anche
separate, da sull'ordine pubblico, sull'economia nazionale, o su altri
fatti di pubblico interesse, notizie non confacenti a verita, per le quali
possa essere turbata la tranquillita pubblica o altrimenti danneggiati pub
blici interessi, e punito con la detenzione sino a sei mesi, o con la multa
da lire 100 a lire 1.000 >> (con aggravanti se fosse stato individuato
il << fine di nuocere alla pubblica tranquillita o ai pubblici interessi >).
II decreto, quindi, non avrebbe dovuto riguardare i semplici commenti
o apprezzamenti, ma l'esposizione di notizie, e le notizie avrebbero dovuto
essere false, e infine avrebbe dovuto esistere il dolo: ma non sempre
nelle sentenze della Cassazione furono riconosciuti questi limiti9.
Tali garanzie scomparvero comunque con il decreto citato del 4 ottobre
1917, che all'art. 1 cosi suonava: << Chiunque con qualsiasi mezzo com
mette o istiga a commettere un fatto che puo deprimere lo spirito
pubblico o altrimenti diminuire la resistenza del paese o recar pre
giudizio agli interessi connessi con la guerra e con la situazione interna
od internazionale dello Stato, quando tal fatto non costituisca altro
reato previsto e represso dalla legge, sara punito con la reclusione sino
a cinque anni e con la multa sino a lire 5.000. Nei casi di maggiore
gravita, la reclusione potra estendersi fino a dieci anni e la multa sino
a lire 10.000 >>.
, ben nota la situazione che si venne a determinare nel paese in con
seguenza del decreto Sacchi. <<Con siffatti criteri - scrivera pochi
giorni dopo la fine della guerra V. Manzini nell'Appendice alla sua
Raccolta della legislazione penale di guerra -, degni del piu tirannico
Stato assoluto, qualunque sopraffazione, qualunque infamia rimane le
gittimata, purche sia ammantata col pretesto della guerra o del patriot
tismo >> 'O. Nonostante che la legislazione italiana non fosse stata parti
colarmente liberale negli anni precedenti, il decreto Sacchi opero una
svolta nel campo dei diritti dei cittadini, sancendo l'accettazione da parte
delle autoritia politiche dei desiderata delle forze militari e dell'interven
tismo piu fanatico, che premevano da tempo per una piu decisa azione
repressiva contro il ? disfattismo >> ". Del clima di caccia alle streghe
9 Cfr. V. Manzini, La legislazione... Raccolta..., cit., pp. 193-196.
10 Ivi, pp. 197-198; Ivi, Appendice, pp. VII-VIII, 62-65; v. anche A. Monticone,
11 regime p?nale nell'e ser cito italiano durante la prima guerra mondiale, in E. For
cella, A. Monticone, op. cit., pp. 467 sgg., 527 sgg. (poi in Id., Gli italiani in
uniforme, cit.).
11 Ci permettiamo di rimandare a proposito al nostro G. Procacci, Gli interventisti
di sinistra, la rivoluzione di febbraio e la politica interna italiana nei 1917, in
? Italia contempor?nea ?, 1980, 138. Anche la Commissione d'inchiesta su Ca
poretto condanno aspramente, mettendone in dubbio l'efficacia, gli ? insopportabili
sistemi polizieschi ? messi in atto durante la guerra: Dall'Isonzo al Piave. 24 ottobre
9 novembre 1917. Relazione della Commissione d'inchiesta, II, Le cause e le respon
sabilit? degli avvenimenti, Roma, 1919, p. 528.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
124 Giovanna Procacci
che si instauro in Italia sono testimonianza, come e noto, non solo gli
arresti dei capi politici socialisti, il sequestro dei giornali di opposizione,
e lo scioglimento di associazioni politiche e sindacali, ma anche e so
prattutto le centinaia di denunce, arresti, condanne di privati cittadini
per i piu futili motivi, dietro semplice segnalazione di chiunque volesse
erigersi a campione di patriottismo, ma assai spesso anche sulla base
di vendette politiche o personali.
La maggior parte dei processi indetti in applicazione del decreto Sacchi
non si svolsero davanti alla magistratura ordinaria. In base infatti al
D.Lt. 10-12-1917, n. 1964, la competenza per i reati previsti dall'art. 1
del decreto Sacchi fu demandata ai tribunali militari se l'accusato era
militare o borghese in concorso con militari (e militari erano buona parte
degli operai degli stabilimenti ausiliari). Di fronte alla magistratura mi
litare, inoltre, secondo lo stesso decreto, doveva essere giudicato chiunque
avesse compiuto << delitti contro la liberta di lavoro >>, previsti dagli articoli
165 e 166 del codice penale, a danno di stabilimenti militari e ausiliari.
Veniva cosi non solo affermata la illegittimit"a dello sciopero, ma ve
nivano puniti anche quanti, dall'esterno (ad esempio, manifestanti), im
pedissero lo svolgimento del lavoro; se poi fossero stati individuati << capi
o promotori >>, o se ci fosse stata << istigazione >> o << associazione a de
linquere >>, le pene previste erano molto piu severe (reclusione da tre a
dieci anni) 12
Si ha cosi, tra il 1915 e il 1918, anche per la legislazione vigente negli
stabilimenti sottoposti a Mobilitazione industriale, una quasi totale assenza
di giudicati della magistratura ordinaria in materia di sciopero 3.
La prevalenza assoluta del potere militare fu sancita infine per quelle zone
che furono dichiarate << in stato di guerra >>. La dichiarazione prevedeva
infatti che in tali zone i comandanti rnilitari potessero svolgere atti
vita legislativa mediante << bandi >>, e che ad essi facesse capo ogni
attivita politica e amministrativa; questa restava affidata agli organi
ordinari, ma in caso di << urgenza ?> l'autorita militare poteva prendere
disposizioni indifferibili di pubblica sicurezza 14.
Le zone dichiarate in << stato di guerra >>, oltre a quelle pi direttamente
12 La magistratura fu invitata ad applicare secondo criteri di estremo rigore le
norme descritte. Come scriveva al presidente del Consiglio il ministro di Grazia
e giustizia il 7-6-1918, il suo dicastero aveva sempre vigilato affinch?, in appli
cazione del decreto Sacchi, ? la repressione giungesse pronta e salutare ?, in modo
che ? tutte, nessuna eccettuata, le norme restrittive [...] trovassero adeguata sanzione
giudiziaria ? (Archivio centrale dello Stato, Ministero degli interni, Direzione gen?rale
di Pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, cat. A5G, Conflagrazione
Europea, 1914-18, 3, 70, 20: da ora ACS, A5G). V. anche G. Neppi Modona,
op. cit., pp. 202, 211 n. 36, 212 n. 41.
13 Cfr. G. Neppi Modona, op. cit., pp. 201, 209 n. 24; V. Manzini, La legislazione...
Raccolta..., cit., p. 97n.
14 V. Manzini, La legislazione... Raccolta..., cit., pp. 120 sgg.: Appendice, pp. 2
sgg., 27 sgg.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
125 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
interessate alla difesa militare (zone di confine, piazzaforti) furono, nel
corso del conflitto, quelle nelle quali si verificarono le maggiori tensioni
nelle fabbriche 15, In tali zone, dato il particolare regime di ordine pub
blico vigente, tutta la maestranza si trovava, dal punto di vista delle
libert"a individuali, in situazioni non dissimili da quelle degli operai degli
stabilimenti ausiliari, per i quali vigevano in tutto il territorio nazionale
particolari norme disciplinari e penali.
Le norme disciplinari e penali della Mobilitazione industriale
L'istituto della Mobilitazione industriale, seconda ripartizione del sotto
segretariato e poi Ministero per le armi e le munizioni, fu istituito con
R.D. 26-6-1915, n. 993, con la preoccupazione preliminare di assicurare una
mano d'opera stabile alle industrie che producevano per la guerra 16.
In base a tale decreto, e al regolamento di applicazione (D.Lt. 22 agosto
1915, n. 1277), tutto il personale degli stabilimenti dichiarati ausiliari
- non soltanto quello con obblighi di leva, ma anche il testo della mae
stranza, compresa quella femminile e minorile - veniva sottoposto alla
giurisdizione militare; successivamente tale principio fu esteso anche agli
operai degli stabilimenti militari (D.Lt. 26-9-1915, n. 1455) e al per
sonale << requisito ? di stabilimenti non ausiliari (D.Lt. 1-10-1916, n.
1576) 17 In ordine a tali disposizioni, gli operai, i cui contratti di lavoro
15 Vedile elencate in V. Manzini, La legislazione... Raccolta..., cit, pp. 2-4. Dopo
Caporetto quasi tutta l'ltalia settentrionale divenne zona di guerra.
16 La Mobilitazione industr?ale fu ? creata con lo scopo principale di disciplinare
la mano d'opera e di risolvere i problemi del lavoro evitando gli scioperi nelle
officine^?: cos? M. Guarnieri, La Mobilitazione industr?ale, Torino, 1918, p. 4 (poi in
La Fiom dalle origini..., cit.); v. anche V. Franchini, Di alcuni elementi relativi alla
maggiore utilizzazione delle maestranze durante il periodo bellico, Milano, 1928, p. 7n.
L'organismo della Mobilitazione industr?ale era costituito da un Comitato centrale con
sede a Roma e da 7 e poi (1917) 11 Comitati regionali. Corne ? noto, oltre aile funzioni
pi? propriamente attinenti alla produzione (dichiarazione di ausiliariet? e requisizione
degli stabilimenti, contratti per le forniture, decisione degli esoneri, reclutamento delle
maestranze, autorizzazione di dimissioni e licenziamenti, ecc), alla Mobilitazione indu
str?ale furono affidati compiti giurisdizionali in materia di controversie del la
voro negli stabilimenti da essa dipenden ti. Per i caratteri e l'evoluzione dell'istituto
durante la guerra si rimanda soprattutto alie opere di V. Franchini, che lavor?
presso il Comitato centrale: in particolare La mobilitazione industr?ale dell'Italia in
guerra, Roma, 1932; I Comitati regionali di Mobilitazione industr?ale 1915-1918, Roma,
1928; Di alcuni elementi..., cit.; si v. anche M. Guarnieri, op. cit.; E. Toniolo, La Mobi
litazione industr?ale in Italia, Milano, 1921; Relazione della Commissione parla
mentare per le spese di guerra, II, Roma, 1923, pp. 3-106; L. Einaudi, La condotta
econ?mica e gli effetti sociali della guerra italiana, Bari-New Haven, 1933; e, tra
le opere pi? recenti, A. Caracciolo, La grande industria nella prima guerra mondiale,
in Aa.Vv, La formazione dell'Italia industr?ale, Bari, 1969; M. Mazzetti, op. cit.
17 Secondo il decreto del 22 agosto potevano essere dichiarati ausiliari, oltre a
quelli che fornivano l'esercito, anche gli stabilimenti adibiti a produzione ? inte
ressante l'economia nazionale ?: ovvero la quasi totalit? delle imprese di certe
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
126 Giovanna Procacci
erano stati prorogati a tre mesi dopo la fine del conflitto (D.Lt. 22-8-1915,
n. 1277), non potevano ne scioperare, ne dimettersi (formalmente neppure
essere licenziati, ma nei fatti cio avvenne ugualmente, sotto veste di Ii
cenziamento per punizione), ne passare ad altro stabilimento senza I'auto
rizzazione del Comitato regionale: 1'abbandono del lavoro veniva infatti
equiparato alla diserzione.
Tali norme furono applicate ne primi anni di guerra con estremo vigore.
Ma la difformita delle sentenze per reati analoghi, e soprattutto l'impos
sibilita pratica di colpire alcuni soggetti donne e ragazzi - con le pene
massime previste dal codice militare, portarono all'emanazione di un
nuovo decreto (D.Lt. 5-11-1916, n. 1684) che attenuo certi principi, come
l'applicazione del reato di diserzione, ma aggiunse contemporaneamente
nuove figure di reato, sempre soggette alla giurisdizione militare, con le
quali diveniva possibile colpire comportamenti che precedentemente sfug
givano all'azione repressiva. Si previdero cosi pene durissime, anche piui
dure di quelle del codice penale militare, per I'assenza ingiustificata dal
luogo di lavoro (<< abbandono del posto >>), per il rifiuto di obbedienza
verso i superiori nella gerarchia tecnica dello stabilimento, per l'insubor
dinazione, per il cosiddetto << abuso di autorita >> 18. Un ulteriore inaspri
mento si ebbe con il gia citato decreto del 10 dicembre 1917 nei con
fronti dei reati << contro la liberta del lavoro >>, e la loro attribuzione
alla giurisdizione militare. Attraverso iA complesso di tali norme le fab
briche vennero praticamente equiparate alle caserme.
Tale equiparazione, del resto, si era voluta sottolineare anche con la sud
divisione rigida delle maestranze degli stabilimenti sottoposti alla Mobi
litazione industriale in specifiche categorie, a seconda del loro rapporto
con il vincolo militare, e con la subordinazione del personale a un uf
ficiale distaccato dal Ministero della guerra per provvedere alla sorve
glianza disciplinare in ogni stabilimento. Le maestranze erano infatti o
non soggette a obblighi militari (anziani, donne, ragazzi, libici, stranieri,
prigionieri, condannati, ecc.), oppure soggette a tali obblighi. Queste
dimensioni. Gli stabilimenti con maestranza requisita erano quelli ehe, per la loro
limitata importanza, non potevano aspirare all'ausiliariet?, ma che, come gli ausiliari,
erano assoggettati ai Comitati.
18 Per stabilire la gravita delle mancanze o dei reati, fu stabilito l'obbligo del
l'affissione nelle fabbriche di uno specchio con tutta la maestranza in ordine ge
rarchico, secondo le cat?gorie del personale amministrativo (proprietari, dirigenti,
amministratori delegad, ecc), del personale t?cnico (direttori, ingegneri, capitecnici,
ecc.) e del personale operaio (capi op?rai, capireparto, capisquadra, op?rai). Cfr.
Comitato per la mobilitazione civile [S. ?nterlandi], La sorveglianza disciplinare
sul personale degli stabilimenti produttori di materiale bellico durante la grande
guerra (1915-1918), Roma, 1930, pp. 47 sgg. Secondo il decreto del 5 novembre 1916,
l'operaio che avesse rifiutato obbedienza agli ordini di un superiore nella gerarchia
t?cnica era punito col carcere militare. In an?loga pena incorreva chi fosse passato
ad altro stabilimento senza autorizzazione, o si fosse assentato anche per sole 24 ore
se l'autorit? di sorveglianza avesse deciso trattarsi di ? abbandono del posto ?.
Sanzioni pi? rigide erano previste se i reati erano commessi da tre o pi? individui.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
127 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
ultime erano formate da a) esonerati, b) militari operai (comandati o a
disposizione), c) riformati o appartenenti a classi non ancora chiamate l9.
Tra le varie categorie esistevano notevoli differenze salariali e soprattutto
disciplinari '. Inoltre, affinche si sentisse << sensibilmente piu soggetto alla
disciplina militare ,, 21, tutto il personale degli stabilimenti ausiliari e sot
topo!sti a requisizione, quando non vestiva la divisa in quanto militare
operaio, doveva portare un distintivo, diverso secondo la categoria e le
funzioni, dentro -e fuori la fabbrica, che ne permettesse l'immediata iden
tificazione, e insieme ne influenzasse il comportamento, agendo come re
mora psicologica alla ribellione.
Stabilita cosi una rigida suddivisione delle maestranze, il controllo disci
plinare nelle fabbriche fu affidato, come abbiamo gia detto, a ufficiali
di sorveglianza distaccati dal Ministero della guerra, e in un primo periodo
direttamente dipendenti dai Comandi di divisione (nelle fabbriche di
minori dimensioni la sorveglianza fu attuata attraverso ispezioni perio
diche da parte dei carabinieri). Gli ufficiali, oltre a deferire i colpevoli
di reato ai tribunali militari, avevano il compito di infliggere sanzioni
per mancanze di minore entita, di ordine non penale. Nei limiti delle
norme generali emanate, agli ufficiali fu lasciata larga liberta nella decisione
dei reati da punire e delle pene da infliggere.
L'opera di sorveglianza degli ufficiali fu coadiuvata fin dal 1916 a Torino,
e dal settembre 1917 in tutto il paese, dalla presenza in fabbrica di
<< fiduciari >>, travestiti da operai, alcuni alle dipendenze dei Comitati
regionali, altri direttamente legati agli ufficiali. L'azione di spionaggio
- riferisce l'Interlandi -<< permise l'epurazione dell'ambiente dagli ele
menti anarchici e sovversivi >>, la prevenzione e il contenimento dei moti,
l'individuazione degli operai militari, vestiti in divisa, che si recavano
alle Camere del lavoro, in una parola << fu mezzo efficacissimo per una
piu intensa sorveglianza della massa operaia >>2-. Gli ufficiali avevano
il compito di individuare e punire i responsabili di mancanze o di reati
il piu sollecitamente possibile, sia dentro che fuori la fabbrica. Nel caso
19 Gli esonerati erano a disposizione delle autorit? militari ma non vestivano la
divisa; i militari op?rai comandati erano militari assegnati a lavorare in stabilimenti
ausiliari dopo una ? prova d'arte ?, cio? attitudinale, lavoravano vestiti in uniforme,
dormivano in caserma, e il loro salario veniva versato ai reparti, che ne d?traevano
il 15%; gli op?rai militari a disposizione erano invece op?rai specializzati che, prima
della chiamata aile armi della loro classe, lavoravano presso gli stabilimenti ausiliari;
non portavano divisa, ricevevano la paga dallo stabilimento e abitavano nelle loro
case: [S. Interlandi], op. cit., pp. 20-27.
? Cfr. ivi, pp. 53-65.
21 Ivi, p. 29.
22 Ivi, pp. 77-80; v. anche L. Tomassini, op. cit., pp. 269-270; G. Consonni,
G. Tonon, op. cit., p. 223. Anche l'Ansaldo aveva richiesto all'inizio di gennaio
1917 l'invio di carabinieri tra vestiti: il capo gabinetto di Orlando, C. Corradini,
aveva promesso di mandare agenti di pubblica sicurezza e carabinieri in pensione
(ACS, A5G, 108, 13, 13).
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
128 Giovanna Procacci
che il fermento rivestisse carattere di particolare gravita, i Comitati re
gionali dovevano darne avviso all'autorita politica locale e agire in accordo
con essa
Per meglio collegare l'azione disciplinare con quella attinente le ver
tenze sorte negli stabilimenti, con D.Lt. 5-7-1917, n. 1093, l'istituto
della vigilanza disciplinare passo alle dirette dipendenze della Mobilita
zione industriale. Di conseguenza gli ufficiali non erano piu responsabili
verso i Comandi di divisione, bensi verso i Comitati regionali.
Tale disposizione era sintomatica di un progressivo aumento di poteri
dei Comitati regionali, ai quali veniva in tal modo a far capo ogni pro
blema attinente il trattamento economico e disciplinare delle maestranze.
Ad essi fu lasciata dagli organi centrali la piu ampia liberta di azione, in
modo che ogni decisione potesse essere presa discrezionalmente a seconda
delle diverse situazioni locali e di ogni singola industria.
All'interno dei Comitati l'influenza degli industriali fu enorme. Come e
noto, tali organismi regionali erano costituiti, oltre che da due militari
con le funzioni di presidente e segretario, da 4-6 membri << civili >>, scelti
in base alle loro specifiche competenze (ovvero, quasi tutti industriali) 74
e da una rappresentanza paritetica, da 4 a 10, di industriali e operai,
con voto consultivo; ma, mentre gli industriali erano gli esponenti piu
qualificati della regione, gli operai erano al contrario scelti spesso tra i piu
legati alla direzione 25. Percio, piu che essere subordinati ai Comitati re
gionali, gli industriali li dominavano '.
Grazie al regime instaurato dalla Mobilitazione industriale, il potere del
padronato in fabbrica - che le lotte dell'anteguerra avevano contestato
e in alcuni casi incrinato - torno ad essere quasi assoluto. Cio avvenne
anche per le posizioni assunte, come e noto, dal sindacato: in cambio
di miglioramenti salariali e del riconoscimento e legittimazione del proprio
ruolo, esso rinuncio infatti al controllo sull'organizzazione del lavoro e
sulla disciplina. Divenuti gli industriali piu forti e aggressivi, ridotta al
minimo la possibilita di iniziativa e difesa da parte della classe operaia,
essa fu sottoposta durante la guetra a una repressione crescente e continua.
23 Gli ufficiali di sorveglianza avevano potest? di applicare la disciplina militare
solo all'interno dello stabilimento; ma la giurisprudenza dichiar? gli op?rai sog
getti alia giurisdizione militare per tutti i reati previsti dal c?dice militare anche
se non commessi in fabbrica (V. Manzini, La legislazione... Appendice..., cit, p. 22).
Tra le competenze degli ufficiali erano anche quelle di conceder? le licenze, con
trollare le assenze per malattia, con facolt? di gravi sanzioni (licenziamento e revoca
conseguente dell'esonero o del comando), se il medico militare, istituito presso
gli uffici di zona, non avesse ritenuto legittima la causa dell'assenza. Con D.Lt.
5-7-1917, n. 1093, fu loro affidato anche il controllo del lavoro: [S. Interlandi],
op. cit., pp. 86-87, 91 sgg.
24 V. Franchini, La Mobilitazione..., cit, p. 81; Id, I Comitati..., cit, pp. 148 sgg.
25 M. Guarnieri, op. cit., pp. 13 sgg.
26 Cfr. A. Caracciolo, La grande industria..., cit, pp. 185 sgg.; V. Castronovo,
Giovanni Agnelli, Torino, 1971, pp. 101-102, 143; M. Abrate, La lotta sindacale
nelVindustrializzazione italiana (1906-1926), Torino, 1967, p. 163.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
129 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
L'applicazione delle norme disciplinari e penali
Poiche erano soprattutto gli operai specializzati a godere, in virtu delle
loro capacita tecniche, dell'esonero o del comando, gli organi della Mo
bilitazione industriale cercarono di ricorrere alla punizione massima nei
loro confronti - il licenziamento con conseguente invio al fronte -
meno frequentemente possibile, e soprattutto in casi singoli. Lo stesso
Dallolio, preoccupato che la repressione potesse provocare moti di rivolta
e sortire perci6o effetti contrari a quelli desiderati, raccomando di com
minare le pene senza esitazioni, ma evitando se possibile di colpire col
lettivamente 27, II ritiro dell'esonero o del comando fu largamente attuato
nei confronti di esponenti politici e sindacali, dirigenti delle Camere del
lavoro, o anche membri operai dei Comitati regionali sospettati di svol
gere attivita organizzativa 2II provvedimento fu tuttavia applicato anche
su larga scala ogniqualvolta si verificarono agitazioni di una certa entita.
In genere, di fronte al profilarsi di un fermento, si cercava di isolare
gli operai militari, assegnando i comandati e quelli a disposizione nelle
caserme, e gli esonerati presso le loro abitazioni; ma se, per la repentinita
della dimostrazione, tale provvedimento non poteva essere eseguito, e i
dispensati partecipavano all'agitazione, la sanzione giungeva immediata.
Al licenziamento per punizione si ricorse invece con estrema frequenza
nel caso di maestranze non specializzate, e percio facilmente rimpiaz
zabili, soprattutto femminili 29. Anche l'uso della prigione, pur largamente
applicato, trovo dei limiti di esecuzione collettiva nella necessita di non
sottrarre mano d'opera alla produzione, e nella possibilita di disporre di
locali sufficienti 30.
27 Circolare del Comitato centrale di mobilitazione industr?ale del 19 luglio 1917.
Cfr. [S. Interlandi], op. cit., pp. 88 sgg.
28 ? Or quando si consideri ? scriveva l'ispettore gen?rale di Pubblica sicurezza
E. Saracino al Ministero degli interni 1'8 dicembre 1916 riguardo alia situazione
in Liguria ? che su un totale di 29 mila op?rai quasi la meta sono militari ed
esonerati e che tutti costoro dovrebbero necessariamente essere rinviati ai corpi,
si dovr? convenire che [...] la produzione, tanto indispensabile, sarebbe inevitabil
mente arrestata?; corne rimedio proponeva perci? il ? maggiore impulso alla eli
minazione grad?ale degli elementi pi? perniciosi ?, attraverso il rinvio ai corpi
dei ? pi? scalmanati ? (ACS, A5G, b. 54A). Secondo il giornale della Fiom, ? Il Me
tallurgico ? (25-1-1917), la Liguria era la regione dove la repressione verso op?rai
che si occupavano di organizzazione sindacale, o che semplicemente si recavano
alla Camera del lavoro, era pi? forte, mentre il Piemonte era Tunica regione dove
ci? non avveniva (ma nelTaprile 1918 le autorit? militari meditano di inviare
anche Buozzi e Guernieri al fronte: cfr. ACS, A5G, 52, 108, 27).
29 II licenziamento implicava per le maestranze borghesi l'esclusione da qualsiasi
altro stabilimento dipendente dai Comitati regionali, e per le maestranze militari la
revoca dell'esonero o comando. Cfr. [S. Interlandi], op. cit., pp. 58-59.
30 La reclusione veniva inflitta anche per mancanze lievissime: negli stabilimenti
Whitehead di Napoli quattro op?rai, individuati corne capi, subirono la prigione
di rigore per essersi rifiutati di compiere due ore di lavoro straordinario (ACS,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, Serie Sp?ciale, Prima Guerra
Mondiale, 19-6-5-24, Bollettino settimanale sulle agitazioni operaie, luglio 1917:
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
130 Giovanna Procacci
Purtroppo i dati disponibili a livello nazionale riguardano solo le in
dustrie ausiliarie ed esclusivamente iA 1918, anno nel quale, in seguito
all'inasprimento delle norme disciplinari e penali, e da supporre che
il livello delle mancanze gravi o dei reati fosse piu basso. Secondo
tali dati"3, dal gennaio all'ottobre 1918 furono inflitte 28.540 punizioni
con prigione, che colpirono circa lo 0,5% della maestranza totale nel
l'intero periodo (ovvero un operaio su 200), con ricorso assai piu fre
quente alla prigione di rigore, e con un'accentuazione nei mesi di luglio
e di agosto. Il rinvio al corpo per motivi disciplinari colpi in numero
maggiore gli operai comandati e a disposizione piuttosto degli esonerati,
che pure erano notevolmente piu numerosi. Tra rinviati ai corpi e de
feriti ai tribunali si ebbero, dal gennaio all'ottobre, 5.066 casi, ovvero
lo 0,08% del totale delle maestranze occupate in stabilimenti ausiliari 32;
ma, come e stato giustamente notato , l'entita delle pene cui poteva
essere soggetto solo il personale con obblighi militari deve essere rap
portata esclusivamente a questa parte dei lavoratori, che costituivano
circa un terzo della maestranza impiegata: risulta allora che le pene
piu gravi colpirono in modo non indifferente la classe operaia.
Certamente, comunque, la disciplina in fabbrica fu soprattutto mante
nuta facendo ricorso a quelle punizioni che non danneggiavano la pro
duzione, ovvero alle multe. Queste furono numerosissime ed estremamente
gravose, comminate dagli ufficiali di sorveglianza in termini molto piu
duri di quelli previsti dai regolamenti interni, e spesso per futili mo
tivi. In particolare, insieme al licenziamento, le multe furono il principale
strumento disciplinare nei confronti della mano d'opera femminile e mi
norile 34.
La repressione agiva di concerto dentro e fuori la fabbrica. Se le fun
zioni delle autorita di vigilanza si estendevano, come abbiamo detto,
anche fuori della fabbrica, viceversa erano spesso gli stessi prefetti a
sollecitare, di fronte a minacce di agitazioni di vasta portata, la dichia
razione di ausiliarieta o la requisizione degli stabilimenti, al fine di
da ora ACS, Presidenza, Bollettino) ; a Livorno il 20 marzo 1918 quattro op?rai
della Metallurgica italiana, che, lavorando a cottimo, non avevano compiuto il
lavoro ? a regola d'arte ?, vengono imprigionati e licenziati (ACS, A5G, 50, 108, 15) ;
sempre nello stesso stabilimento il 18-10-1917 a un operaio trovato senza ? distintivo
prescritto vengono inflitti tre giorni di prigione (ma si teme va una pena moho
pi? grave) (ivi).
31 [S. Interlandi], op. cit., p. 131.
32 II numero dei civili giudicati durante la guerra dai tribunali militari fu di 61.927,
di cui 37.839 condannati: cfr. A. Monticone, Il regime p?nale..., cit, p. 435, n. 8.
Per abbandono del lavoro furono condannati 2.796 op?rai, di cui 650 delle retrovie:
cfr. Relazione della Commissione parlamentare..., cit, p. 131.
33 L. Tomassini, op. cit., p. 298.
34 Secondo i dati forniti dallTnterlandi, nei soli stabilimenti ausiliari da gennaio a
ottobre 1918 le multe colpirono il 28,27% del totale della maestranza occupata,
ovvero quasi un operaio su tre. Le punte massime furono toccate nei gennaio e
nell'agosto.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
131 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
sottoporre le maestranze a giurisdizione militare. Era inoltre abituale
I'arresto o il rimpatrio coattivo, in base alle norme di pubblica sicurezza,
degli operai individuati come promotori di agitazioni, anche economiche,
possibilmente prima che la manifestazione avesse luogo. Vi furono tut
tavia casi in cui si verificarono contrasti tra i due poteri, per le pretese
da parte dell'autorita militare di provvedimenti di repressione alle quali
i prefetti non ritenevano di poter corrispondere sulla base delle norme
di pubblica sicurezza vigenti. Tali vicende furono spesso alla base delle
richieste da parte degli organi militari della Mobilitazione industriale di
trasformare la regione in zona di guerra 3
Si deve infine ricordare che, oltre alle norme penali e disciplinari della
Mobilitazione industriale e a quelle generali di pubblica sicurezza, esi
stevano altri modi per fiaccare l'opposizione operaia: ad esempio la chiusura
degli stabilimenti 36.
Le agitazioni nelle fabbriche: dati quantitativi
Sebbene la legislazione avesse privato la classe operaia del diritto di
sciopero, essa vi ricorse ugualmente, anche se in misura ridotta rispetto
all'anteguerra. Esamineremo prima l'andamento delle agitazioni in tutte
le fabbriche, secondo i dati sugli scioperi nell'industria forniti dal Mini
stero dell'economia nazionale 3, e successivamente le vertenze nei soli
stabilimenti ausiliari.
35 A proposito del contrasto tra i due poteri, ? significativo quanto afferma il prefetto
di Genova (18 dicembre 1916) : ? La locale Divisione militare ritenendo che si
possa dalTAutorit? di Pubblica Sicurezza, con la stessa facilita ch'? possibile da
parte dell'Autorit? militare in confronto degli op?rai militari od esonerati, adottare
misure di rigore a carico di op?rai borghesi, anche quando manchino gli elementi
od indizi che confermino in modo tangibile il sospetto della loro opera di sobillazione,
pretende che siano allontanati dal luogo gli op?rai borghesi agitatori, anche se
nati od aventi cola il domicilio di soccorso ? (ACS, A5G, 50, 108, 13, 19). Da
questo contrasto scatur? la proposta di dichiarare la Liguria zona di guerra, per
sottoporla direttamente sottq_ il potere militare (su pressione dell'Ansaldo); ma ad
essa e ad altri drastici provvedimenti si era dichiarato contrario l'ispettore di
Pubblica sicurezza (ACS, A5G, b. 54A) e lo stesso Orlando (ibidem, 48, 108, 13, 3).
La richiesta verra accolta, corne ? noto, dopo le agitazioni dell'estate del 1917.
Un altro contrasto tra autorit? militare e politica, con successiva proposta da parte
della prima di dichiarare lo stato di guerra, si verifico a Milano nei maggio del
1917 (ACS, Presidenza, 19-6-5-24), a Terni nell'estate (ACS, Ministero per le
Ar mi e le Munizioni, Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale, b. 67: da ora
ACS, CCMI).
36 La chiusura degli stabilimenti (non registrata nelle statistiche ufficiali sulle serrate
se era preceduta da sciopero) fu particularmente fr?quente a Napoli e in Liguria,
in genere dopo episodi di ostruzionismo o di scioperi di solidariet?.
37 Cfr. Ministero defl'economia nazionale, J conflitti del lavoro in Italia nei decennio
1914-1923, Roma, 1924. Tutti i dati da noi esposti sulla conflittualit? nell'industria
sono tratti da questa fonte.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
132 Giovanna Procacci
Come si trae dalla tabella ', il numero degli scioperi diminui costante
mente (ma aumento, come vedremo, quello delle vertenze concordate
o decise dagli organi arbitrali della Mobilitazione industriale). Crebbe
pero, dopo una flessione nel 1916, il numero degli scioperanti e la
partecipazione media agli scioperi (scioperanti per sciopero) 3. Inoltre
nel corso della guerra vi fu un aumento delle giornate perse per sciopero,
con variazioni pero non eccessive delle giornate perse da ciascun operaio.
In genere gli scioperi furono piu brevi che nell'anteguerra: quelli in
feriori a 10 giorni costituirono l'80-90% del totale, con netta prevalenza
degli scioperi da due a cinque giorni (50%); analogo l'andamento delle
percentuali degli scioperanti 4.
Il maggior numero di scioperi e di scioperanti si ebbe ovviamente nel
triangolo industriale, e in Toscana. La Lombardia fu sempre in testa
come numero di scioperi, di scioperanti e di giornate perdute. La se
guiva, a distanza il Piemonte, dove, come in Lombardia, il *numero
degli scioperanti e delle giornate perdute fu in ascesa a partire dal
1917; la percentuale media sul totale nazionale degli scioperi verifi
catisi dal 1915 al 1918 fu in Lombardia del 35,98% e in Piemonte del
13,7%; quella degli scioperanti rispettivamente del 45,33% e del 15,23%;
quella delle giornate perse del 37,7% e del 24,7%. La Lombardia
precedeva il Piemonte anche come numero medio di scioperanti per.
sciopero (media dei quattro anni 432); in Piemonte a ciascuno sciopero
38
Anni A B B/A C C/B C/A
(scioperi) (scioperanti) (scioper
giorni)
1913 810 384.725 474 3.839.240 9,9 4.739
1914 782 173.103 221 2.086.046 12,0 2.667
1915 539 132.136 245 673.015 5,0 1.248
1916 516 123.616 239 737.385 5,9 1.429
1917 443 168.626 380 831.227 4,9 1.876
1918_303 158.036 521_906.471_5,7 2.99
Fonte: I conflitti del lavoro, cit.
39 Si deve tenere presente che negli ultimi due mesi del 1918, cio? a guerra termi
il numero degli scioperanti e delle giornate perdute fu molto alto. Le serie statist
del Ministero dell'economia nazionale purtroppo forniscono dati disaggregati
mese solo riguardo ai settori industriali: quelli maggiormente impegnati in sci
nei novembre e dicembre 1918 furono sempre il tessile e il siderurgico-metalmecc
navale. Dal ? Bollettino dell'ufficio del lavoro ? (serie mensile), XXXIl, lu
dicembre 1919, si trae che in quel periodo la regione quasi esclusivamente coin
da scioperi nei settore siderurgico-metalmeccanico fu la Lombardia, mentre nei te
al primo posto fu il Piemonte, seguito a distanza dalla Lombardia.
40 Non mancarono tuttavia scioperi di una certa durata: nei 1916, 12 scioper
protrassero dai 31 ai 75 giorni (con complessive 2.634 maestranze impegnate)
1 fu superiore a 100 giorni (364 maestranze) ; nei 1917, 4 durarono da 31
giorni e 1 pi? di 75 (complessivamente 1.073 maestranze); nei 1918, 8 fur
tra 31 e 75 giorni (1.029 maestranze). .
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
133 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
parteciparono mediamente 358 operai, in Liguria 359 (con una punta
massima di 578 nel 1916), in Toscana 183. Quest'ultima regione fu al
terzo posto nella percentuale media degli scioperi (10,52%), e la Liguria
in quella degli scioperanti (7,82%) 41.
Riguardo ai settori piu impegnati negli scioperi, in testa era il tessile,
con una percentuale media sul totale dell'industria nei quattro anni del
30,37%, e di scioperanti del 43,64%; seguiva il siderurgico-metallurgico
meccanico-navale, con una percentuale media di !scioperi del 16,81% e di
scioperanti del 25,30%. Anche rispetto alle giornate perdute, al primo
posto era il tessile e al secondo il metalmeccanico-siderurgico-navale. Que
sto dal 1917 vide un aumento della partecipazione operaia (365 operai
per sciopero nel 1916 e 501 nel 1917) e dei giorni persi da ciascuno
scioperante (2,6 nel 1916 e 4,7 nel 1917). Anche nel tessile la par
tecipazione aumento (306 operai per sciopero nel 1916, 582 nel 1917),
ma diminui il numero dei giorni persi da ciascun operaio (6,4 nel
1916 e 4,2 nel 1917). Riguardo all'anteguerra le percentuali di scioperi
e di scioperanti dei due settori sul totale dell'industria crebbero forte
mente, mentre caddero quelle di settori nei quali in tempo di pace si
era manifestata una forte conflittualita, come i trasporti e soprattutto
le costruzioni, e basse si mantennero le percentuali di tutti gli altri 42.
Prendiamo o?a in considerazione i soli stabilimenti ausiliari. Mentre per
quanto concerne tutta l'industria non conosciamo ne il numero degli
41 Riguardo alla partecipazione agli scioperi, ? bene tenere pero presente che,
di fronte a un numero ridotto di essi (come si ebbe durante la guerra), poche
agitazioni di una certa entit? possono alterare molto la media. Cfr. le osservazioni
a proposito di A. Lay, D. Marucco, M. L. Pesante, Classe operaia e scioperi: ipotesi
per il periodo 1880-1923, in ?Quaderni storici?, 1973, 1, p. 112; A. Lay, L. Pesante,
Ciclo econ?mico e classe operaia in Europa 1880-1920, in ? Rivista di storia con
tempor?nea ?, 1974, 3, p. 390n.
42 Cfr. L. Bordogna, G. Provasi, J7 movimento degli scioperi in Italia (1900-1971), in
Il movimento degli scioperi nei XX sec?lo, a cura di G. P. Celia, Bologna, 1979,
p. 234. All'interno del settore siderurgico-metallurgico-meccanico-navale, quello che
presenta un maggior numero di scioperi e di scioperanti ? il meccanico (nei quale
il numero degli occupati ? pero maggiore) ; nei 1917 gli scioperanti e le giomate
perdute son? invece superiori nei metallurgico-siderurgico. Riguardo al rapporto tra
industrie tessili e siderurgiche-metalmeccaniche, nei 1918 la percentuale degli scio
peranti diviene pi? alta nelle seconde (43,98%; 32,9% nelle tessili). Se si consi
derano pero i soli mesi di guerra (escludendo cio? novembre e dicembre in cui si
ebbe una forte partecipazione agli scioperi dei metalmeccanici), la percentuale degli
scioperanti resta sempre superiore nei tessile. L'elevato livello di conflittualit? dei
due settori fu determinato ovviamente anche dall'alto numero degli occupati; questi
nei metalmeccanico crebbero enormemente, spesso per il trasferimento da altri settori
(costruzioni, artigianato, nei quali infatti la conflittualit? diminu? notevolmente).
Inoltre nei metalmeccanico entro durante la guerra un gran numero di mano d'opera
femminile (soprattutto nei meccanico), la quale d'altra parte costituiva la stragrande
maggioranza della maestranza tessile: e la percentuale delle donne sul totale
degli scioperanti aumento notevolmente durante la guerra (34,4% nei 1915, 43,9%
nei 1916, 64,2% nei 1917, 45,6% nei 1918). La mancata o tardiva dichiarazione
di ausiliariet? di molti stabilimenti tessili incise inoltre certamente sul loro maggior
livello di conflittualit?.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
134 Giovanna Procacci
stabilimenti ne quello degli occupati, esistono in questo caso i dati ri
guardanti sia gli uni che gli altri, anche se non per tutto il periodo
bellico. Gli stabilimenti ausiliari, dipendenti dai 7 e poi 11 Comitati re
gionali, passarono da 276 alla fine del 1915, a 998 alla fine del 1916,
a 1.857 alla fine del 1917 e a 1.976 alla fine del 1918, in maggioranza
concentrati nel triangolo industriale4'. Ad essi erano da aggiungere una
sessantina di stabilimenti militari veri e propri e un migliaio di imprese
non ausiliarie, ma sottoposte al controllo della Mobilitazione industriale4".
Al momento dell'armistizio le maestranze occupate negli stabilimenti di
guerra erano 903.250: di esse il 32,9% era costituito da operai bor
ghesi, il 21,9% da donne, il 6,6% da ragazzi, il 19% da operai militari
esonerati, il 16,7% da operai comandati o a disposizione, e il 2,6% da
prigionieri di guerra, profughi, operai libici e detenuti 45.
La maggior parte delle maestranze era occupata nel triangolo industriale
e in Toscana 46, e, come si vede dalle percentuali, alto era il numero
delle donne e dei ragazzi impiegati, di non molto inferiore a quello
degli operai maschi borghesi 47, mentre gli operai militari costituivano
solo poco piu di un terzo della maestranza totale. Infine, rispetto al
loro impiego per settore industriale, nel 1918 la grande maggioranza
43 II maggior numero di stabilimenti dipendeva dal Comitato regionale di Milano
alla fine del 1918 essi erano 545; seguiva Torino con 371, Genova con 200, Palermo
con 185, Firenze con 171; riguardo alia ripartizione per settori industriali, al 31 di
cembre 1918, 762 stabilimenti (38%) lavoravano e utilizzavano metalli: di essi
il 39,6% dipendeva dal Comitato regionale di Milano, il 25% da quello di Torino
e 1'11% da quello di Genova. Gli altri 1.214 stabilimenti riguardavano industrie
chimiche e elettrochimiche (358), concentrate, come quelle che elaboravano i pro
dotti dell'agricoltura, della caccia e della pesca (228), e quelli corrispondenti a bi
sogni collettivi (135), sempre nei triangulo industr?ale; gli stabilimenti di industrie
estrattive (292) e di industrie di lavorazione di minerali non metalliferi (126) si
trovavano soprattutto sotto i Comitati regional! di Milano, Palermo, Firenze, Genova;
gli stabilimenti di lavorazione delle fibre tessili (75) nei Comitati regionali di
Milano, Firenze, Torino. Cfr. ? Annuario statistico italiano ?, 1917-1918, pp. 334 sgg.
L'ausiliariet? riguardo nei primi due anni di guerra soprattutto la siderurgia, la
metallurgia e la meccanica: V. Franchini, La mobilitazione..., cit, pp. 98 sgg.; A. Ca
racciolo, La grande industria..., cit, p. 178.
44 Cfr. R. Bachi, Vitalia econ?mica nei 1916, Citt? di Castello, 1917, p. 264;
M. Mazzetti, op. cit., pp. 18, 26 n. 32.
45 ?Annuario statistico italiano?, cit, p. 335; Relazione della Commissione parla
mentare d'inchiesta..., cit, p. 122. Secondo V. Franchini (La mobilitazione..., cit,
p. 145), tali percentuali ebbero andamento costante a partir? dalla seconda meta
del 1916. V. anche Id, I Comitati regionali..., cit, pp. 124 sgg.
46 Al momento dell'armistizio delle 903.250 maestranze impiegate nella lavorazione
di guerra, il 30,7% era sotto il Comitato regionale di Milano, il 19,6% sotto quello
di Torino, il 16,1% sotto il Comitato regionale di Genova, 1'8,1% sotto quello
di Firenze (?Annuario statistico italiano?, cit, p. 335).
47 In seguito alia politica svolta dalla Mobilitazione industr?ale, che, con inviti prima
e con disposizioni obbligatorie poi (circ. del Sottosegretariato per armi e le mu
nizioni del 23-8-1916 e del 19-3-1917), infranse la resistenza industr?ale a occupare
mano d'opera non specializzata e meno soggetta a norme disciplinari e penali, la
forza lavoro femminile e minorile aument? moho nei corso della guerra sia nelle
industrie ausiliarie e militari che in quelle non ausiliarie, ma d?dite alla pro
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
135 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
della mano d'opera risultava occupata all'interno di stabilimenti metalmec
canici e siderurgidC .
L'aumento progressivo delle maestranze sottoposte ad ausiliarieta spiega
il forte incremento del numero delle vertenze composte o decise so
prattutto negli ultimi due anni di guerra 4. Tuttavia il crescente ri
corso ai Comitati regionali e al Comitato centrale sta anche a significare una
duzione di armi e munizioni. In tutte queste la mano d'opera femminile pass?
da 23.000 unit? alla fine del 1915 a 89.000 alia fine del 1916, a 175.000 alia
fine del 1917, a 198.000 al momento deH'armistizio, con maggiore incremento nelle
industrie ausiliarie. La mano d'opera minorile fu impiegata prevalentemente in sta
bilimenti di piccole e piccolissime dimensioni e perci?, a differenza di quella fem
minile, in maggior parte non ausiliari; essa pass? da 43.000 unit? alla fine del
1916 a circa 60.000 al momento dell'armistizio. Donne e minori furono inizial
mente usati soprattutto in lavori di meccanica leggera, ma a partir? dal marzo 1917
anche in lavori pi? pesanti. Vedi V. Franchini, II contributo delle maestranze
femminili all'opera di allestimento di materiali bellici 1915-1918, Milano-Roma, 1927;
Id., I Comitati regionali..., cit., pp. 123-135; Ministero per le armi e munizioni, Le
donne d'Italia nell'industria di guerra, Roma, 1918; Banca commerciale italiana, Cenni
statistici sul movimento econ?mico dell'Italia, Milano, 1919, p. 168; M. Mazzetti,
op. cit., pp. 207 sgg. (verbale della seduta del Comitato centrale di mobilitazione
del 26-11-1916).
48 II Bachi (Vitalia econ?mica nei 1918, Citt? di Castello, 1919, p. 183n.) d? le
seguenti percentuali, attinenti al primo trimestre del 1918: 48% occupati nell'in
dustria meccanica, 17% nella siderurgia, 7% nelle estrattive, 4% nelle fabbriche
di esplosivi, 5% nelle tessili, 3,8% nelle chimiche, 2,9% nelle elettriche, 1,3%
nelle calzature, 1% nelle alimentari.
49 Ricordiamo come avveniva il componimento delle vertenze negli stabilimenti
ausiliari: nei caso che l'accordo tra le parti non fosse raggiunto, era previsto
l'intervento di alcuni membri o delegati del Comitato regionale (vertenze composte).
Se falliva il tentativo di accordo, si ricorreva al Comitato regionale, che emetteva
un'ordinanza provvisoria esecutiva, contro la quale era previsto il ricorso al Co
mitato centrale, che decideva inappellabilmente (vertenze decise, dal Comitato re
gionale o centrale). Il Comitato centrale, attraverso il suo ? Bollettino ?, forn? alla fine
del 1917 i dati sulle vertenze conc?rdate e decise fino a quella data, proseguendo
fino a tutto il 1918 la pubblicazione delle notizie per mese. L'andamento delle
vertenze risulta il seguente:
Comitati Vertenze composte
regionali
1915 1916 1917 1918 Totale
Torino 16 25 20 61
Genova 12 53 51 116
Milano 36 171 210 417
Bologna 6 39 74
Venezia | 29 3 3
i?
Firenze 18 44 44
Roma 11 68
Cagliari 3 3
Napoli 19 7 31
Bari 1 1
Palermo 26 104 130
Totale 91 362 493 948
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
136 Giovanna Procacci
maggiore durezza della lotta e soprattutto una combattivita operaia in
forte aumento: la maggior parte delle vertenze fu infatti sollevata dal
personale 50.
Le maestranze occupate in stabilimenti ausiliari impegnate in vertenze com
poste o decise furono, nel 1918, 458.767 (e fino al mormento dell'ar
mistizio 397.964): circa iA 6% del totale delle maestranze occupate negli
stabilimenti ausiliari durante tutto l'anno, e quasi tre volte gli scioperanti
nell'industria 51.
L'intervento arbitrale dei Comitati non escluse tuttavia il ricorso allo
sciopero anche negli stabilimenti ausiliari. Spesso lo sciopero avveniva
dopo che erano fallite le trattative dirette e rientrava dopo l'intervento
del Comitato regionale; oppure si verificava nelle varie fasi della ver
tenza, gia affidata al Comitato regionale o al Comitato centrale, per
Comitati Vertenze decise con ordinanza
regionali del Comitato regionale del Comitato centrale
1915 1916 1917 1918 Totale 1915-17 1918 Totale
Torino ? 4 9 28 41 ? 8 8
Genova 5 7 22 37 71 21 19 40
Milano ? 8 66 104 176 29 38 67
Bologna
Venezia ? ?
_ ?
? 7
( 11
? ?( 4 3 7
( ? ?
Firenze ? i o l q 23 23 ( , 15 15
Roma - { 2 \ 8 12 22 ? 6 3 9
Cagliari ? ? ? ? ? ? ? ?
Napoli ? 3 5 7 15 4 3 7
Bari ________
Palermo ? ? 28 69 97 15 18 33
Totale 5 24 142 287 458 79 107 186
Fonte: ? Bollettino del Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale ?, aprile
n. 10, pp. 119-120; novembre-dicembre 1918, n. 17-18, p. 385.
50 Nei 1917 furono tutte sollevate dal personale (?Bollettino...?, cit, n. 10, p.
Rispetto al numero degli stabilimenti, nei 1918 le vertenze si verificarono n
circa 39% di essi: in ben 93,5% degli stabilimenti siciliani, nei 57,6% di q
lombardi, nei 44% dei liguri e solo nei 12,9% dei piemontesi. La percentuale
vertenze solo decise crebbe nei 1918 ovunque: ibidem e n. 17-18, p. 385.
51 Riguardo alla partecipazione operaia alle vertenze, sempre secondo i dati d
? Bollettino... ?, cit, nei 1918 i centri maggiormente interessati furono Milano
vertenze medie di varie centinaia di lavoratori, e alcune di varie migliaia, so
tutto tra quelle decise con ordinanza; Palermo, con vertenze numer?se, m
piccole dimensioni; Genova, che in maggio ha una vertenza decisa con ordina
di 40.260 op?rai, e in setiembre un'altra di 40.500; Firenze e Torino, quest'ul
con una vertenza di 25.000 op?rai decisa in maggio con ordinanza. Per qu
riguarda gli anni precedenti, purtroppo il ? Bollettino ? non fornisce dati,
tandosi a dichiarare che in tutte le regioni si ebbero vertenze grandi e piccole
prevalenza pero di quelle di vaste dimensioni, soprattutto in Liguria. Per ? rag
di riserbo ? non vennero indicate le cat?gorie di industrie in cui scoppiaron
vertenze: cfr. il n. 10 cit., pp. 121-122, e passim per tutti i numeri riguardanti il
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
137 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
il ritardo con cui questi emettevano l'ordinanza; o ancora perche la di
rezione eludeva il concordato; spesso infine lo sciopero si verificava,
come vedremo meglio in seguito, per protesta contro multe, arresti, ecc.
Non esistono, a nostra conoscenza, dati ufficiali sul numero degli scioperi
e degli scioperanti negli stabilimenti ausiliari. Possediamo pero quelli
delle giornate perdute per sciopero dal 10 gennaio al 31 ottobre 1918:
esse furono 358.855, ovvero piu della meta delle giornate perdute per
sciopero in tutti gli stabilimenti industriali, sottoposti o no alla Mobi
litazione industriale, nello stesso periodo (620.231) 52.
II dato e immediatamente significativo: nonostante la legislazione repres
siva e le pene durissime previste, anche la classe operaia degli stabi
limenti ausiliari ricorse allo sciopero in modo massiccio, come e del
resto dimostrato anche dalla partecipazione crescente e piu prolungata
agli scioperi delle maestranze, interamente soggette alla Mobilitazione
industriale, del settore siderurgico-metallurgico-meccanico-navale. Se si tie
ne conto sia dell'andamento degli scioperi sia di quello delle vertenze
risolte per arbitrato, si deduce che, dopo un periodo di minore com
battivita, che coincide circa con il primo anno di guerra - quando
il richiamo alle armi indeboli gli antichi quadri, mentre la nuova classe
operaia, appena entrata in fabbrica, era ancora disorientata (e bassa era
altresi la percentuale di mano d'opera femminile) le agitazioni ripresero
successivamente intense, piu vaste e prolungate.
Le agitazioni nelle fabbriche: i caratteri
I recenti studi sulla situazione della classe operaia, di cui abbiamo ac
cennato nelle prime pagine, hanno ampiamente documentato le condizioni
di sfruttamento a cui essa venne sottoposta durante il conflitto. E stata
cosi confutata la leggenda dei << favolosi >> salari operai, divulgata negli
ambienti interventisti negli stessi anni di guerra (ma gia al suo sorgere
smentita da osservatori piu imparziali). I salari infatti crebbero nella loro
media meno dell'aumento del costo della vita; se vi furono incrementi
salariali notevoli per una parte, della mano d'opera, quella specializzata,
i livelli retributivi si mantennero molto bassi per la maggior parte delle
maestranze impiegate. II meccanismo della Mobilitazione industriale im
pedi inoltre l'allargamento delle concessioni ottenute da un'azienda alle
52 Cfr. [S. Interlandi], op. cit., p. 131; I conflitti..., cit. Le giornate di assenza
furono pi? numer?se negli stessi Comitati regionali dove maggiore fu la partecipazione
operaia aile vertenze composte o decise; in particolare si ebbero moite giornate
perse in collegamento con le grandi vertenze di Genova, Torino, Firenze: ulteriore
prova che la procedura arbitrale non imped?, nelle zone di maggiore conflittualit?,
il ricorso alio sciopero. Le assenze per motivi individuali non giustificati furono nello
stesso periodo 932.627, soprattutto nei mesi estivi, perci? imputabili a contadini
oper?i che si allontanavano per i raccolti. I dati sono forniti sempre dall'Interlandi,
op. cit., pp. 121-131.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
138 Giovanna Procacci
altre del settore: cosicche, soprattutto nelle industrie pi' piccole, gli
operai vennero pagati in misura molto minore rispetto a quelli di uguale
qualifica di altri stabilimenti. Differenze notevolissime si verificarono
tra maestranze dei maggiori centri industriali del nord e delle altre
zone d'Italia, nonche tra quelli delle fabbriche metalmeccaniche e degli
altri settori. Infine, gli aumenti salariali, oltre che sull'indennita caro
viveri (che il Comitato centrale di mobilitazione industriale delibero dover
essere piu bassa dell'aumento del costo della vita), avvennero soprattutto
sul cottimo e non sulla paga base, con la conseguenza che ad essi cor
rispose un maggiore sfruttamento. Riguardo ai ritmi di lavo;ro, e stato
notato che in Italia l'aumento della produttivita si ottenne nella maggior
parte delle lavorazioni - salvo che nel munizionamento, dove il lavoro
in serie trovo maggiore applicazione - non attraverso una razionaliz
zazione del processo produttivo, ma mediante l'intensificazione dei ritmi,
grazie appunto all'estensione massiccia del cottimo. Contemporaneamente
i turni - sospese le disposizioni sul lavoro festivo e notturnoi anche
per le donne e i fanciulli - furono portati, tra orario ordinario e straor
dinario obbligatorio, fino a 16-18 ore giornaliere. Indici diretti, quali
Ilaumento degli infortuni e delle malattie professionali - il lavoro av
veniva spesso in locali improvvisati, senza alcuna precauzione igienica -,
o indiretti, quali la crescita della mortalita infantile - conseguenza
dell'orario di lavoro femminile e in genere delle peggiorate condizioni di
vita - sono testimonianza della spaventosa condizione del proletariato,
dentro e fuori la fabbrica ".
Particolarmente difficile fu la situazione della nuova classe operaia, di
quella maestranza cioe precedentemente non impiegata, o occupata in
attivita entrate in crisi con la guerra, spesso di tipo artigianale, o pro
veniente dalle campagne, che afflui numerosissima in fabbrica. Il ricorso
alla mano d'opera non specializzata non era certamente fatto nuovo
nella storia italiana, ma il fenomeno non si era manifestato mai con
l'intensit'a del periodo di guerra. Sicche in questi anni si verifico un
vero e proprio sconvolgimento nella composizione della classe operaia.
con una netta prevalenza di lavoratori di nuova formazione.
Per costoro le condizioni di vita e di lavoro furono specialmente insop
portabili: sia perche non adusi al regime di fabbrica; sia perche co
stretti, soprattutto nei grandi centri, a lunghi percorsi per recarsi sul
53 Per la documentazione e discussione sui livelli salariali, sui ritmi, e in genere
sulle condizioni di lavoro e di vita della classe operaia durante la guerra, si rimanda,
tra gli scritti pi? recenti, a A. Camarda, S. Peli, op. cit., pp. 22-23, 65-70, 85 e
115-176 passim; P. Frascani; Politica econ?mica e finanza pubblica in Italia nei
primo dopoguerra (1918-1922), Napoli, 1975, pp. 69-78; B. Bezza, op. cit., pp.
101-106; per le indagini su situazioni locali: P. Spriano, op. cit., pp.187-197; S. Musso,
op. cit., pp. 143 sgg., 155, 174-182; L. Tomassini, op. cit., pp. 279-302; G. Consonni,
G. Tonon, op. cit., pp. 179-193, 220-238; A. Kelikian, op. cit., pp. 166-167. Riprende
la tesi di Melograni (Storia politica, cit., pp. 359-369) sul miglioramento delle
condizioni di vita dei lavoratori M. Mazzetti, op. cit., pp. 130-149.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
139 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
luogo di lavoro senza l'ausilio di mezzi pubblici adeguati, o, inurbati,
a vivere in abitazioni sovraffollate e ad altissimo costo; sia, ancora,
perche pagati meno, in quanto non specializzati, e con salari maggior
mente decurtati da multe, piu frequenti data l'inesperienza, con la
conseguenza di dover ricercare nella massima incentivazione del cottimo
la possibilita di un salario di sopravvivenza. Soprattutto drammatiche
furono le condizioni del proletariato femminile, i cui salari furono so
vente piu bassi di quelli degli stessi minori maschi; e sul quale, fuori
di fabbrica, gravavano le estenuanti conseguenze della mancanza di ap
provvigionamenti dei generi di prima necessit'a. Non stupisce quindi se,
come vedremo nelle prossime pagine, fu proprio la classe operaia di
nuova formazione, e in particolare le donne e i ragazzi, a dimostrare la
maggiore combattivita `4.
Anche la classe operaia di piu vecchia data, formata in gran parte da
operai non. inviati al fronte per le loro capacita tecniche e percio mi
litarizzati, ebbe tuttavia a soffrire durante la guerra condizioni di lavoro
durissime. Dato il numero esiguo di mano d'opera specializzata, essa
fu sfruttata al ma'ssimo, senza limiti di orario; il salario, in conse
guenza alla massima intensificazione della produzione, venne commisurato
piu sul rendimento che sull'abilita': percio i privilegi della professio
nalita furono notevolmente ridotti. Gli operai militari, il cui salario
era piu basso di quello dei borghesi, furono inoltre spesso comandati
in stabilimenti lontani dal luogo di residenza, e il loro disagio economico
e morale fu cosi grave che molti di essi richiesero di essere richiamati ai
propri corpi
Le comuni sofferenze di fabbrica, alle quali in base ai decreti sopra
menzionati era impossibile sottrarsi neppure licenziandosi, il livellamento
salariale, i rigori punitivi della disciplina, che colpiva indiscriminatamente
la maestranza, provocarono tra nuova e vecchia classe operaia italiana
una solidarieta - incrinata solo in alcuni casi nei confronti della mano
d'opera femminile - ignota in altri paesi, come ad esempio la Gran
Bretagna, dove durante la guerra fu vistoso il fenomreno di rigetto da
parte delle vecchie << aristocrazie >> nei confronti della mano d'opera non
specializzata. Cosi in Italia il processo di modernizzazione sociale in
fabbrica che si attuo durante la guerra si realizzo senza fratture interne
e forti resistenze corporative, nonostante i tentativi padronali di esaspe
rare il frazionamento attraverso le differenziazioni salariali, le divisioni in
categorie negli stabilimenti ausiliari, ecc.
Salari insufficienti, ritmi di lavoro massacranti, controllo ferreo della
disciplina da parte degli organi dello Stato, prevalenza numerica di una
classe operaia nuova, maggiormente sfruttata e insofferente del regime
54 Sul mutamento della composizione della classe operaia durante la guerra, grazie
soprattutto all'ingresso di mano d'opera femminile, v. in particolare A. Camarda,
S. Peli, op. cit., pp. 17-97, 108-109, 112-114; L. Tomassini, op. cit., pp. 272-279.
55 Cfr. M. Guarnieri, op. cit., p. 24; Relazione della commissione..., cit, p. 126.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
140 Giovanna Procacci
di fabbrica, solidarieta tra le varie categorie operaie: sono questi gli
elementi che stanno alla base delle agitazioni del periodo di guerra, deter
minandone i caratteri.
II continuo rialzo del costo della vita, la relativa disponibilita degli
industriali, grazie agli immensi profitti, a concedere aumenti retributivi,
l'appoggio alle vertenze economiche dato dal sindacato, dettero il via
negli anni di guerra a un gran numero di agitazioni salariali. Gli stessi
organi della Mobilitazione industriale incitarono gli industriali a << con
cedere >> il massimo e il piu presto possibile, piuttosto che essere poi
costretti a << cedere >>5 : sollecitazione, tuttavia, che, se trovo concordi
le industrie piu moderne e di maggiori dimensioni, come quelle affiliate
alla Lega industriale torinese, spesso trovo resistenze in quelle di minori
dimensioni o anche in alcuni grandi complessi (come gli stabilimenti
siderurgici), assai meno disposti a sottostare alle pressioni della base,
e alla contrattazione con l'organismo sindacale che eventualmente con
ducesse la vertenza 5. Quasi sempre, inoltre, dopo aver stipulato un
accordo, le ditte lo applicavano solo parzialmente, o tardavano talmente
ad applicarlo che gli aumenti venivano erosi dal crescente costo della
vita. Le agitazioni erano percio continue, e assai spesso sfociavano in
scioperi.
Secondo i dati del Ministero dell'economia nazionale sugli scioperi in
tutta l'industria 58, quelli per il salario crebbero durante la guerra, ri
spetto all'ultimo anno di pace, di numero e di partecipanti, raggiun
gendo nel 1917 ben il 78,5% del totale degli scioperi e 1'83,4% del
totale degli scioperanti. Ma nell'ultimo anno di guerra essi subirono
una flessione (probabilmente in rapporto con il maggior numero di ver
tenze decise con arbitrato): gli scioperi per esclusivi motivi salariali di
minuirono di un terzo e gli scioperanti quasi della meta. Nel 1918 aumento
il numero dei partecipanti ad agitazioni miste, quelle cioe nelle quali
a fianco della causa salariale comparivano una o piu altre cause; in
particolare, durante tutti gli anni di guerra, ma in misura piu spiccata
nell'ultimo, furono numerosi gli scioperanti in vertenze che abbinavano al
salario richieste attinenti al monopolio del lavoro.
Queste ultime, da sole, sebbene in numero molto inferiore rispetto
56 Circolare del 19 luglio 1917 cit.
57 Cos? ad esempio nei cantieri Odero di Livorno, a Terni, a Napoli, e in Liguria:
cfr. ACS, Presidenza, Bollettino. Vedi anche M. Abrate, op. cit., p. 177 e il verbale
della riunione del 16-12-1916 del Comitato centrale di mobilitazione industr?ale, in
M. Mazzetti, op. cit., pp. 235 sgg.
58 I criteri usati nella classificazione degli scioperi da I con flit ti..., cit., sono i se
guenti: esclusi gli scioperi politici veri e propri, gli scioperi economici (cio? quelli
tendenti a ? ottenere miglioramenti delle condizioni di lavoro ?) furono suddivisi,
riguardo aile cause che li determinarono, in scioperi per questioni di salario e suoi
accessori (compresa la forma del salario), or ario, disciplina (applicazione del rego
lamento e sanzioni), regolamento (compilazione e interpretazione), sforzo e pericolo,
monopolio del lavoro (organizzazione sindacale, assunzioni e licenziamenti, soli
dariet?, ecc).
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
141 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
all'anteguerra, furono al secondo posto per entita di scioperi e di scio
peranti (con un notevole aumento di questi ultimi nel 1918). Seguivano,
in ordine di quantita, le vertenze per cause disciplinari e subito dopo
queUle per l'orario, ambedue con numero massimo di partecipanti nel
1917. Pochissimi infine gli scioperi e gli scioperanti per cause attinenti
allo sforzo e al pericolo, e al regolamento: indice, gli uni, della noncuranza
operaia verso la pericolosita e l'igiene del lavoro (determinata probabil
mente dalla grande quantita di mano d'opera nuova e percio ignara),
e gli altri della possibilita ridottissima da parte operaia di discutere l'in
terpretazione del regolamento (le cause riguardanti l'applicazione del re
golamento furono infatti inserite nella categoria delle disciplinari) 5.
L'altissima percentuale di scioperi per cause salariali e stato uno dei
motivi che hanno condotto parte della storiografia, come abbiamo gia
accennato nelle prime pagine, a supporre una sostanziale passivita po
litica della classe operaia durante la guerra, con 1'eccezione di quella
torinese. Una risposta esauriente richiederebbe una articolata analisi e
descrizione delle singole situazioni locali. In questa sede ci limiteremo
ad alcune osservazioni a carattere generale e ad alcuni riferimenti a spe
cifici episodi.
Una prima ovvia considerazione e che se, nonostante la legislazione
repressiva, le maestranze ricorsero ugualmente allo sciopero, il fenomeno
e gia di per se indicativo di un alto livello di combattivita. Data
la situazione eccezionale dentro e fuori la fabbrica, la portata politica
della conflittualita puo essere non tanto ricercata in manifestazioni pub
bliche di ostilita alla guerra o di solidarieta con la Russia, quanto valutata
tenendo presenti i contenuti delle rivendicazioni, comprese quelle eco
nomiche: le quali erano le sole che potevano essere sollevate senza eccessivo
rischio di rappresaglie.
Le agitazioni salariali presentarono durante la guerra caratteri che da una
parte le collegavano senza soluzione di continuita ai conflitti prebellici,
e dall'altra anticipavano le grandi lotte del dopoguerra. Le agitazioni
contro lo sfruttamento perpetuato attraverso il cottimo, cosi frequenti
negli anni bellici, proseguivano una battaglia combattuta dalla classe ope
raia fin dall'inizio dell'industrializzazione; e, per la connessione organica
che nel sistema di retribuzione a cottimo si creava tra aspetto salariale
59 Rispetto alla durata, gli scioperi salariali furono mediamente di 5-6 giorni, con
un leggero incremento nei 1918, mentre quelli per il monopolio del lavoro furono
pi? brevi, sui 3-4 giorni, con un aumento nei 1918 (5,6). Riguardo all'esito, la
percentuale di quelli m?nimamente favorevoli o sfavorevoli ? nettamente superiore,
in modo per? meno accentuato per quelli salariali. Nei 1918 la percentuale degli esiti
favorevoli aumenta. Purtroppo ? conflitti..., cit., non fomiscono dati sui motivi
degli scioperi per settore. Fino a tutto il 1916 il ? Bollettino dell'ufficio del
lavoro? mensile descrisse gli scioperi: rielaborando i dati forniti da questa fonte,
S. Muss? ha calcolato che nei 1915 e 1916 si ebbe nei settore metalmeccanico
una pi? alta percentuale, rispetto agli altri settori industriali, delle cause di
disciplina e regolamento. Queste diminuirono fortemente nei tessile, mentre si
mantennero alte quelle per l'organizzazione del lavoro (op. cit., pp. 155 sgg, 183).
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
142 Giovanna Procacci
e aspetto disciplinare, esse non ebbero mai carattere esclusivamente
economico 6. Furono inoltre frequenti le richieste di minimi di salario
garantiti, in modo da alzare i livelli delle categorie peggio retribuite:
rivendicazione che diverra uno dei punti cardine delle piattaforme pro
grammatiche del dopoguerra. Un altro aspetto fondamentale di molte
agitazioni fu la richiesta di aumenti della paga base e dell'indennita
caroviveri uguali per tutti, o addirittura in misura inversamente propor
zionale ai salari, affinche le categorie meno pagate ricevessero aumenti
maggiori. Tali rivendicazioni a carattere egualitario, che testimoniano la
pressione delle categorie non specializzate, e la solidarieta verso di esse
delle altre, furono in continuo aumento 61.
Si deve tenere poi presente che molte delle agitazioni per motivi eco
nomici si intrecciarono, soprattutto negli ultimi due anni, con la pro
testa contro i caroviveri e la mancanza di generi di prima necessita,
sfociando spesso, come diremo, in ribellioni contro la guerra. Inoltre,
In seguito alla punizione di scioperanti per motivi salariali, fu assai comune
che l'agitazione si allargasse a macchia d'olio, trovando solidali anche
operai non impegnati nella vertenza economica; lo sciopero di solidarieta,
nei confronti di compagni colpiti da multe, licenziamento, arresto o invio
al fronte, spesso per ragioni politiche, fu il piu frequente all'interno
della categoria degli scioperi per il monopolio del lavoro. Fu inoltre
crescente iA ricorso all'ostruzionismo, attuato dagli operai militari per
evitare le conseguenze punitive dello sciopero, e numerosi furono i casi di
sabotaggio62.
Se nel primo periodo della guerra gli scioperi furono generalmente molto
brevi e di ridotte dimensioni, anche se continui 3, a partire dalla pri
mavera del 1917 la protesta operaia si allargo a tutte le zone industriali
e assunse connotati inequivocabilmente politici 64.
60 Cfr. S. Ortaggi, Cottimo e organizzazione operaia nell'industria del primo No
vecento, in ? Rivista di storia contempor?nea ?, 1978, 2, pp. 168-169; sulle lotte
contro il cottimo nell'anteguerra v. anche Id., Cottimo e produttivit? nell'industria
italiana del primo Novecento, ibidem, 1978, 1.
61 Cfr. V. Foa, op. cit., pp. 1806-1808; S. Musso, op. cit., pp. 158, 167-168, 186,
188; A. Camarda, S. Peli, op. cit., pp. 161 sgg.
62 Sia l'ostruzionismo sia il sabotaggio si verificarono soprattutto negli stabilimenti
siderurgici e metallurgici della Liguria, di Napoli, Piombino, Livorno, ecc.
63 In Liguria fu segnalato fin dall'estate del 1915 un forte fermento, soprattutto
negli stabilimenti Ansaldo, di cui, in conseguenza di ci?, fu dichiarata in settembre
l'ausiliariet?. A partir? dalla primavera del 1916 in tutti gli stabilimenti metallurgici,
e in particolare in quelli di Sestri Ponente, Sampierdarena e Comigliano, inizi?
un'agitazione per miglioramenti salariali e normativi (nei marzo vi parteciparono
tutti gli op?rai Ansaldo, 20.000), ehe sfoci? nell'autunno nella presentazione di
un memoriale unico in cui venivano richiesti aumenti salariali inversamente propor
zionali, minimi garantiti, tariffe di cottimo uguali per uomini e donne, il riconosci
mento della rappresentanza operaia, ecc. Cfr. ACS, A5G, 48, 108, 13, 2; ? Lotta ope
raia?, 20-11-1916; C. Costantini, Gli anarchici durante la prima guerra mondiale,
in ? Il movimento operaio e socialista in Liguria ?, 1961, 2, pp. 116 sgg.
64 Sul.carattere politico delle agitazioni operaie, a partire dalla loro intensificazione nel
l'inverno 1916-17, sono esplicite le autorit? militari e politiche locali. ? probabile che
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
143 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
Lo sciopero generale, gia sfiorato a Torino in marzo e a Milano in mag
gio, fu proposto e attuato nei mesi successivi in molti centri operai:
fu prospettato a Terni in giugno, dopo un'agitazione prolungata di tutti
gli operai delle acciaierie, al fine di impedire il deferimento ai tribunali
e l'invio al corpo di 35 operai militari; venne effettuato a Sestri in
luglio per un'intera settimana, per il rilascio, alfine ottenuto, degli
operai arrestati in seguito a un'agitazione per un memoriale unico che
aveva impegnato la stragrande maggioranza dei metallurgici di tutti i centri
liguri; nel Biellese in luglio un'agitazione, sconfessata dalla Lega, si estese
alla maggior parte degli operai tessili, per solidarieta con otto socialisti
arrestati, e lo sciopero generale scoppio infine in ottobre; a Napoli in
luglio e agosto un movimento di << eccezionale violenza >>- secondo le
parole dell'autorita militare - uni gli operai di tutti gli stabilimenti
ausiliari, e agli inizi di settembre fu proposto lo sciopero generale, per
solidarieta con le vittime cadute a Napoli e a Torino 65. Le agitazioni
furono cosl intense e violente da far temere alle autorita, gia in luglio,
propositi insurrezionali e un collegamento tra i metallurgici dei vari
centri ". Sicche il moto di Torino dell'agosto, visto all'interno di questa
vasta sollevazione contro la fabbrica e la guerra, appare un fenomeno
assai meno isolato e unico nella storia della classe operaia durante il
conflitto, di quanto si sia ritenuto.
La decisa repressione attuata non solo nel capoluogo piemontese, ma
in tutti i centri dove si erano verificati episodi massicci di protesta - morti
e feriti a Napoli, revoche di esonero a Terni, dichiarazione della Liguria
zona di guerra -, l'applicazione rigida ovunque del decreto Sacchi e del
decreto del 10 dicembre, e infine, dopo Caporetto, l'estensione a quasi
tutta l'Italia settentrionale dello << stato di guerra >>, provocarono una
battuta d'arresto delle lotte. Ma esse ripresero nella primavera-estate, con
un'adesione crescente da parte degli operai militari (mentre, come ab
biamo gia notato, diminui la presenza femminile). Anche se non rag
giunsero i livelli preinsurrezionali di quelle dell'estate precedente, le agi
tazioni furono spesso di notevoli dimensioni; inoltre, in conseguenza al
l'intensificazione della produzione e quindi dello sfruttamento dopo Ca
su tali valutazioni influissero fattori surrettizi, tra cui quello di sollecitare provvedi
menti da parte dei vertid governativi: i quali pero condividevano tali opinioni; Orlando,
ministro degli Interni, il 12 aprile 1917 parlando con Malagodi delle agitazioni di
Torino e della Liguria, ne affermava 1'? evidente sostrato politico ? (O. Malagodi,
Conversazioni della guerra, a cura di B. Vigezzi, I, Napoli, 1960, p. 119); e Dallolio,
a proposito delle agitazioni nei Milanese, esortava a usare il massimo rigore verso gli
esonerati, poich? ? il movimento est politico contro guerra profittando disagio eco
n?mico ? (telegramma al ministro della Guerra del 5-5-1917, in ACS, Presidenza,
19.6.5.24).
65 Molti altri scioperi generali o quasi generali si svolsero in centri minori. Cfr, oltre
ai documenti pubblicati da De Felice e Monteleone, cit, ACS, Presidenza, Bollettino.
66 ACS, Presidenza, Bollettino; A5G, b. 53B (prefetto di Genova, 3-5-1917); A5G, 50,
108, 13, 19; v. anche R. Paci, op. cit., pp. 53-54.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
144 Giovanna Procacci
poretto, vi fu una maggiore partecipazione alle battaglie relative alle
condizioni interne alla fabbrica, ai metodi di lotta e alla rappresentativita
degli organismi operai. I conflitti piu duri furono, come nel 1917, quelli
che videro protagonisti i metallurgici e siderurgici della Liguria, di Napoli,
Piombino, Livorno, Terni.
Fu infatti la classe operaia impiegata nell'industria pesante che, all'in
terno del settore metalmeccanico, subi le maggiori conseguenze del regime
di guerra. Meno specializzati dei meccanici, e percio meno pagati e con
un salario basato essenzialmente sul cottimo, i siderurgici e metallurgici
furono sottoposti a una maggiore incentivazione dei ritmi e a una piu
rigida disciplina di fabbrica, dovendo contemporaneamente affrontare un
padronato piu resistente alle concessioni, e spesso senza l'appoggio del
sindacato confederale, tradizionalmente piu radicato nelle categorie mag
giormente specializzate. Si puo percio ipotizzare che, a differenza degli
anni precedenti, durante la guerra le lotte piu ardue, pi compatte e con
obiettivi piu avanzati fossero condotte dagli operai meno specializzati e
organizzati sindacalmente 67,
Le agitazioni annonarie e le manifestazioni nelle campagne
L'eccezionale gravita delle agitazioni dell'estate del 1917 fu determinata
dal fatto che alla protesta operaia contro il regime di fabbrica si sommo
quella di tutta la popolazione cittadina per la mancanza di generi ali
mentari. Sempre piu spesso, infatti, una dimostrazione di scioperanti
vide ingrossare le sue fila per la partecipazione di manifestanti estranei
alla fab'brica o, viceversa, una agitazione per la mancanza di generi di
prima necessita provoco l'uscita dagli stabilimenti degli operai. Tra la
primavera e l'estate del 1917 tali manifestazioni assunsero spesso ca
rattere di massa, il motivo immediato dello sciopero dilatandosi in una
protesta collettiva contro la guerra. Particolarmente gravi furono nell'estate
- oltre ovviamente all'episodio torinese - le manifestazioni operaie e
cittadine verificatesi a Napoli, Rivarolo Ligure, Sampierdarena, Genova,
Cornigliano, Savona, Ceriana, Valle Bisenzio-Prato (con formazione di bar
ricate e taglio dei fili telegrafici), Roma, Alessandria, Biella, Piombino 68.
Il connubio tra protesta dentro e fuori della fabbrica avvenne spesso
anche quando la folla dei dimostranti proveniva dalla campagna. Se infatti
da parte di questi ultimi vi furono talvolta atteggiamenti ostili verso
gli operai di fabbrica, e in particolare verso quelli addetti alla lavora
zione del materiale bellico - come, secondo i rapporti prefettizi e la
testimonianza di Turati, sembra essersi verificato nel Milanese nel maggio
67 A tali conclusioni giunge anche S. Musso, op. cit., pp. 168-182. Dove infatti il
sindacato era pi? forte e attivo, pi? di rado si giunse a situazioni di rottura.
68 Cfr. ACS, A5G, bb. 73A, 73B.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
145 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
del 1917 69 - piU sovente si ebbero, al contrario, episodi di solidarieta 'O.
In verita, soprattutto nei centri industriali minori, il rapporto tra pro
letariato cittadino e popolazione delle campagne rimase durante la guerra
molto stretto. La maggior parte della mano d'opera nuova non solo
proveniva dalle campagne, dove il piu delle volte proseguiva a vivere,
ma manteneva con la terra un rapporto organico, come dimostra l'aumento,
gia rilevato, delle assenze individuali ingiustificate dalla fabbrica nei mesi
delle lavorazioni agricole. Questo rapporto tra mano d'opera di recente
formazione e campagna determino un continuo scambio di motivi e stimoli
di lotta, unificati dalla comune protesta contro il carovita e i sacrifici
imposti, dentro e fuori la fabbrica, dalla guerra.
Furono soprattutto le donne che agirono come cinghia di trasmissione
tra il dissenso dentro e fuori la fabbrica. Come abbiamo accennato, alle
donne e ai minori - che lavoravano a peggiori condizioni, erano meno
abituati alla vita di fabbrica e soprattutto erano meno esposti alle mas
sime punizioni -si dovette infatti spesso l'iniziativa delle agitazioni in
fabbrica e delle manifestazioni contro il carovita. Talvolta erano gli stessi
operai maschi a incitare le donne a iniziare I'agitazione, unendosi even
tualmente ad esse nel corso della vertenza 7.
69 Cfr. R. De Felice, Ordine pubblico..., cit, p. 499. In verit?, corne ? stato giu
stamente notato (A. Camarda, S. Peli, op. cit., pp. 91-93), la protesta part? dai pi?
importan ti centri industriali a nord di Milano (Gallarate, Rho, Cornaredo, Sa
ronno, periferia di Milano, Busto Arsizio, Lecco) e ebbe come protagoniste donne
operaie (cfr. ACS, A5G, 103, 225, 2, 1; Carte Orlando, Misc., Manifestazioni 1?
maggio 1917, Milano; e gli stessi documenti riportati da De Felice); erano quelli
i comuni che si erano specialmente sviluppati da un punto di vista industr?ale
durante la guerra con l'immissione di un gran numero di mano d'opera nuova,
contadina e femminile: cfr. P. Bolchini, Milano 1915: il socialismo e la guerra, in
? Movimento operaio e socialista ?, 1970, 4, p. 263.
70 Cos? avvenne ad esempio a Bologna in aprile, dove le operaie degli stabilimenti
ausiliari tessili scioperarono per protesta contro la guerra, seguite da quelle della fon
deria Darracq-Parenti, e manifestarono insieme a donne venute dalla campagna (ACS,
CCMI, Comitato Regionale di Bologna, b. 67, 11). Episodi analoghi son? registrad
da prefetti e autorit? militari in moite altre province, a partir? daU'autunno 1916; a
Rivarolo Ligure, ad esempio, una manifestazione di notevole violenza unisce donne
della campagna e operaie; a Masone l'8 luglio 1917 una folla di con tadine manifesta
contro la guerra e per solidariet? con gli op?rai scioperanti di Sestri, molti dei quali
abitanti appunto a Masone (ACS, Presidenza, Bollettino; A5G, 49, 108, 13, 16). Si
noti che le donne della campagna non incitavano solo gli op?rai a scioperare, ma
anche gli stessi contadini a sospendere i lavori: cos? ad esempio nei Bolognese nei
1916, in provincia di Rovigo, di Ferrara e di Verona nei 1917 (A5G, 81, 162, 1).
71 Vi furono dei casi in cui fu la stessa commissione interna a decidere lo sciopero im
mediato delle donne e dei ragazzi e il ricorso degli uomini al Comitato regionale (ad
esempio alla Westinghouse di Vado: ACS, A5G, 108, 13, 2). Oltre che per incita
mento da parte socialista (secondo le testimonianze prefettizie) le donne venivano
talora indotte a scioperare da militari in licenza (ACS, Presidenza, Bollettino; N. De
Stefano, op. cit., p. 211). Tutto il problema della contrapposizione tra ? fanti conta
dini ? e ? op?rai imboscati ? ? su cui insistette la propaganda interventista e su cui,
come noto, sono tornati recentemente alcuni studiosi, in particolare il Melograni ?,
e in genere quello dell'antinomia tra citt? e campagna, dovrebbe essere riesaminato alla
luce dei mutamenti avvenuti nella composizione della classe operaia, e sulla base di una
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
146 Giovanna Procacci
Per quanto riguarda le campagne, fu soprattutto a tali manifestazioni,
imponenti a partire dall'autunno del 1916, che si affido durante la guerra
la protesta contadina. Gli scioperi infatti furono molto ridotti, rispetto
agli anni precedenti iA conflitto: 68 nel 1915 (ma solo 19 dopo l'entrata
in guerra) con 47.798 scioperanti, 61 nel 1916 - unico anno di discreta
combattivit'a - con 14.892 scioperanti, 27 nel 1917 con 6.191 scio
peranti e solo 10 nel 1918, con 675 scioperanti. Gli scioperi si verifi
carono soprattutto nelle tradizionali regioni bracciantili: in Lombardia,
e in particolare in provincia di Pavia, nella contigua regione risicola
piemfontese (soprattutto la provincia di Novara), nel basso Veneto (so
prattutto nelle province di Verona e Rovigo), in Emilia e in Lazio. Nelle
altre regioni, alcune delle quali avevano avuto una notevole percentuale
di scioperi nel 1915, come le Puglie e la Toscana, non si verifico nes
suno sciopero tra il 1916 e il 1918. La quasi totalita degli scioperi fu
attuata da avventizi (da soli o, in misura ridotta, con obbligati), e non
si verifico alcuno sciopero di coloni 72.
L'esiguita del numero degli scioperi agricoli durante la guerra, oltre che
dal richiamo alle armi, fu determinata dai decreti legge di proroga dei
patti agrari a un anno dopo la pace, che favorirono i salariati fissi, i piccoli
affittuari e i coloni parziali, e dalla regolamentazione preventiva di molte
vertenze, attuata dalle Commissioni provinciali di agricoltura e dalle Com
missioni compartimentali di arbitrato, create ambedue con decreto del
30-5-1916 (n. 645). Nei casi di conflitti collettivi, tali commissioni in
tervenivano per la conciliazione su richiesta di una delle due parti o
del prefetto. Altre commissioni arbitrali furono create nel 1918, insieme
all'istituto mastodontico, e mai entrato interamente in funzione, della
Mobilitazione agraria 73.
Si aggiunga inoltre che durante la guerra la Federterra rinuncio a pro
muovere grandi lotte, preferendo impegnare la propria azione in iniziative
extrasindacali, volte a premere sullo Stato soprattutto per la concessione
di sussidi e delle terre incolte 74. Non fu invece probabilmente elemento
di freno agli scioperi l'aumento dei salari, assai esiguo nei primi tre anni
di guerra, e sempre di gran lunga inferiore al costo della vita.
Le forze piu colpite dalle conseguenze della guerra furono le bracciantili,
che infatti, come abbiamo visto, ebbero quasi il monopolio degli scio
peri. Soprattutto drammatica era la situazione de2li avventizi: alla fa
analisi capillare dei fatti. Cfr. a proposito le osservazioni di A. Camarda, S. Peli, op.
cit., pp. 61 sgg.; G. Rochat, op. cit., pp. 76 sgg.
72 Cfr. I conflitti..., cit.; A. Serpieri, La guerra e le classi rurali italiane, Bari-New
Haven, 1930, pp. 266-267, 273, 284-285.
73 Su tali provvedimenti legislativi e in particolare sulla Mobilitazione agraria si veda
F. Piva, Mobilitazione agraria e tendenze dell'associazionismo padronale durante la
?grande guerra?, in ?Quaderni storici?, 1977, n. 35.
74 Cfr. A. Altobelli, Relazione morale e finanziaria 1911-1918. V Congresso nazionale
dei lavoratori della terra. Bologna, 13-15 giugno 1919, Bologna, s.d. (poi in Lotte
agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della terra 1901-1926, a cura
di R. Zangheri, Milano, I960).
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
147 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
miglia del richiamato restava infatti solo il sussidio, sempre insufficiente.
Migliori furono invece, come e noto, le condizioni dei piccoli proprietari,
dei mezzadri e degli affittuari, sia per il rinnovo dei contratti e la ri
duzione dei canoni in conseguenza dell'inflazione (ma solo quando questi
fossero da corrispondere in denaro), sia per la possibilita di supplire al
vuoto lasciato dai richiamati attraverso un'intensificazione del lavoro fa
miliare (quest'ultimo fenomeno non si verifico pero nel sud, dove non
c'era l'abitudine al lavoro femminile, e dove pertanto la mancanza di
braccia, gia grave per l'emigrazione, divenne spesso drammatica).
Tuttavia, l'imposizione di prezzi d'imperio non remunerativi su tutti i prin
cipali prodotti agricoli e sul bestiame, le requisizioni, i divieti di espor
tazione tra province di determinati generi alimentari, determinarono negli
anni di guerra in tutti i ceti agricoli una situazione di profondo disagio
economico e di diffuso malcontento.
Avvenne quindi che, a partire dal secondo inverno di guerra, e in parti
colare nel 1917 - anno pessimo per la produzione agricola, durante
il quale furono intensificate le requisizioni, e il richiamo alle armi si
estese a nuove classi, comprese quelle anziane nate nel 1874 - tutte
le regioni d'Italia fossero teatro di agitazioni contadine, che spesso assun
sero l'aspetto di rivolte contro la guerra e contro lo Stato. Dal Piemonte
alla Sicilia folle tumultuanti invasero i municipi e le prefetture, alzarono
barricate, presero a sassate le caserme dei carabinieri, le abitazioni dei
cittadini piu abbienti e le scuole (in avversione agli insegnanti che si
facevano promotori di sottoscrizioni e commemorazioni patriottiche). Se
in Lazio si verificarono alcune occupazioni di terre, l'odio verso < lor
signori >> accomuno tutte le popolazioni. Non di rado, insieme alle grida
contro la guerra e per la pace, si udi inneggiare anche alla rivoluzione 7.
Ancora all'inizio del 1918 la situazione dell'ordine pubblico era di una
eccezionale gravita 76; ma alla fine dell'inverno essa parve migliorare. Da
una parte fecero probabilmente effetto anche nelle campagne i decreti
restrittivi delle liberta; dall'altra, in seguito al perfezionamento del si
stema degli approvvigionamenti - mediante importazioni dall'estero -
l'incetta all'interno diminui. Altri provvedimenti governativi, tra cui so
prattutto b'aumento dei prezzi di alcuni prodotti sottoposti a calmiere,
la concessione di un maggior numero di licenze e di esoneri, il rialzo
dei sussidi e altre provvidenze a favore delle famiglie dei richiamati
(polizza, ecc.), e infine le promesse di una futura ripartizione della
75 ? Si parla di rivoluzione come di un fatto che possa verificarsi da un momento al
l'altro? (prefetto di Reggio Emilia, 11-9-1917: ACS, A5G, 81, 162, 1); an?loga
mente a Rovigo, Novara, Sondrio (ibidem), nei Milanese (? Delia rivoluzione si parla
come di una cosa che avverr? [?a ira], se non oggi, a guerra finita, se non a breve
scadenza?: il commissario di Pubblica sicurezza G. Pignatari a C. Corradini, in R.
De Felice, Or dine pubblico..., cit., p. 503).
76 In una riunione dei dicasteri interessati agli approwigionamenti il 10 gennaio 1918,
Crespi, commissario gen?rale, afferm? che era possibile una rivoluzione entro un
mese o due: cfr. A. Monticone, Nitti e la grande guerra, 1914-1918, Milano, 1961,
p. 174; v. anche P. Melograni, Storia politica..., cit., pp. 470-474.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
148 Giovanna Procacci
terra, determinarono una pausa nelle agitazioni contadine. Durante la
primavera e sul finire dell'estate ripresero le manifestazioni per la man
canza di generi alimentari e soprattutto contro l'applicazione della tessera
sul macinato, prima nel sud e poi nelle altre regioni. Ma, a differenza
dell'industria, dove, come abbiamo gia detto, il fermento nel 1918 prosegui
e sotto certi aspetti si accentuo, nelle campagne sia gli scioperi che le
manifestazioni popolari diminuirono notevolmente 7.
Spontaneita e direzione delle lotte
Sul problema dell'organizzazione delle agitazioni, o della loro iniziativa
spontanea, ci limitiamo in questa sede a formulare solo alcune ipotesi.
Sulla base soprattutto delle posizioni assunte dagli organi ufficiali e dai
principali esponenti, la storiografia e stata concorde nel negare al Partito
socialista, compresa la sua frazione intransigente, un'effettiva azione sti
molatrice delle lotte. Per quanto riguarda il sindacato, e stata giusta
mente messa in rilievo la sua << marcia nelle istituzioni >>- sancita dalla
prassi assistenziale e di collaborazione con gli organi dello Stato -, e
quindi il suo *obiettivo di mantenere la conflittualita nell'ambito esclu
sivamente economico, evitando il dilagare delle agitazioni (la maggior
parte degli scioperi fu infatti estranea alla direzione del sindacato con
federale) 78. Da cio si e generalmente dedotto che la protesta operaia e
contadina avesse origini spontanee.
L'insistenza tuttavia con cui le fonti prefettizie e militari attribuiscono
all'azione << sobillatrice >> dei socialisti (e talora dei preti) gran parte
delle agitazioni, non puo - pur con tutte le cautele e le riserve con
le quali, come abbiamo detto, e opportuno avvicinarsi a questo tipo di
documentazione - non' suscitare il dubbio che talvolta tali giudizi
corrispondessero a verit"a. Come e stato notato, non e forse del tutto ca
suale che il formarsi di una corrente rivoluzionaria all'interno del Partito
socialista e la divulgazione dei deliberati di Zimmerwald e di Kienthal
coincida con la ripresa delle agitazioni nelle fabbriche e nelle campagne79.
La diffusione di numerosi manifestini di propaganda antibellica, a volte
77 Cfr. ACS, b. 65B. Fondamentale fu nei marzo l'accordo per le zone risicole in
provincia di Pavia e Novara, tradotto in decreto il 14-3-1918, n. 350, con il quale i
sindacati ottenevano la regolamentazione org?nica del collocamento e la prevenzione
arbitrale dei conflitti: A. Serpieri, op. cit., p. 258. Per quanto riguarda il Lazio,
dove le lotte nei 1918 cessarono quasi del tutto,- si deve ricordare il D.Lt 1-10-1916,
n. 1257, con il quale le sentenze di sfratto pronunc?ate dopo l'entrata in guerra furono
sospese a sei mesi dopo la pace. Vedi, oltre a A. Caracciolo, Il movimento contadino
nei Lazio, Roma, 1952, pp. 149-154, A. Parisella, Le lotte dei contadini del Lazio
dalla guerra al fascismo (1914-1923), in ?Annali dell'Istituto Aleide Cervi?, I,
1979, pp. 201-214.
78 Cfr. 1 conflitti..., cit.; per quanto riguarda la percentuale degli scioperi diretti dalla
Fiom, v. B. Bezza, op. cit., pp. 85-86.
79 E. Ragionieri, op. cit., p. 1030; v. anche S. Caretti, La rivoluzione russa e il
socialismo italiano (1917-1921), Pisa, 1974, pp. 43-48.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
149 Repressione e dissenso nella prima guerra mondiale
incitanti le masse alla ribellione, l'azione svolta da esponenti della Fede
razione giovanile socialista e dalle organizzazioni femminili, testimoniata
dagli organi di polizia, fanno supporre che, in assenza di direttive da
parte dei vertici, si fosse comunque realizzata in alcune zone una ca
pillare attivita propagandistica e organizzativa da parte di militanti di
base, sia del sindacato che del partito, che non si riconoscevano nei deli
berati degli organismi nazionali.
P, probabile che l'azione di militanti di base sia stata determinante nello
sviluppo delle commissioni interne e, in generale, nell'allargamento della
coscienza sindacale che si verifico durante la guerra. In quegli anni infatti,
come e noto, il sindacato estese notevolmente la sfera della sua influenza 8.
Poiche laddove mancava l'organizzazione il padronato si permetteva ogni
sorta di sopruso, anche la classe operaia entrata piu recentemente in fab
brica e fino a quel momento estranea a ogni esperienza associativa, imparo
presto l'utilita degli organismi di difesa. Nuove fasce di operai divennero
cosi sensibili ai temi affrontati dalle leghe, parteciparono per la prima
volta a riunioni operaie alle Camere del lavoro. Queste assunsero du
rante la guerra un'importanza crescente, quale punto di riferimento es
senziale per i lavoratori, spesso intervenendo con propri rappresentanti
- in assenza o a fianco dell'organismo sindacale - anche nelle trattative
dentro la fabbrica. -Ma proprio i compiti assunti costrinsero molte Ca
mere del lavoro a modificare profondamente nel corso della guerra i propri
metodi e forme di intervento, per adeguarle alle richieste che provenivano
dai nuovi adrenti 81
Anche la Fiom, grazie probabilmente all'autonomia di cui godevano le
sezioni rispetto alla segreteria, e quindi alla loro maggiore flessibilita e
aderenza ai bisogni operai, nell'ultimo periodo della guerra riacquisto ener
gia e influenza 82, In alcuni casi essa pote usufruire dello spazio lasciato
libero dagli anarcosindacalisti dell'Unione sindacale italiana, i cui espo
nenti e organizzazioni furono colpiti nel 1918 da una massiccia repres
sione. L'attivita dei sindacalisti negli anni della guerra non deve essere
pur essa sottovalutata: soprattutto nei centri siderurgici e metallurgici, do
ve la mano d'opera era meno specializzata e dove avevano sviluppato
80 Gli iscritti alla Confederazione gen?rale del lavoro, dopo un iniziale calo nei 1916
riprendono a salire, e superano alia fine della guerra gli iscritti nei 1915 (1915:233.963;
1918:249.039) : cfr. La Confederazione gen?rale del lavoro negli atti, nei documenti,
nei congressi 1906-1926, a cura di L. Marchetti, Milano, 1962, p. 419; la Federterra
ebbe invece l'anno pi? basso nei 1917 e una forte ripresa nei 1918 (A. Altobelli, op.
cit.). La Fiom aumento costan temen te durante la guerra di sezioni e di soci, con un
notevole balzo nei 1918 (1915: 52 sezioni e 13.800 soci; 30 setiembre 1918:102 se
zioni e 47.192 soci, di cui quasi la meta in Lombardia e in Piemonte) : B. Buozzi,
L'op?ra della Federazione metallurgica dal 1910 al 1918, Torino, 1918, p. 24.
81 Per le trasformazioni verificatesi nella struttura e nei metodi delle Camere del
lavoro ? fondamentale lo studio di L. Tomassini, op. cit., pp. 337-374; v. anche A.
Morelli, L. Tomassini, op. cit., pp. 93, 99, 105-106, 121 sgg.
82 Nei 1918 (dati fino al 30 setiembre) diminu? fortemente rispetto al 1917 la per
centuale delle vertenze, guidate dalla Fiom, conc?rdate direttamente, e aumento quella
delle vertenze risolte con ordinanza: B. Buozzi, op. cit., p. 6.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
150 Giovanna Procacci
la loro azione gia prima della guerra, essi infatti svolsero una intensa
opera di stimolo e di organizzazione, traducendo l'insofferenza dei lavo
ratori in lotte vaste e prolungate, dense di contenuti politici. A Piombino,
a Terni, tra i minatori di San Giovanni Valdarno e di Castelnuovo de'
Sabbioni, tra i fonditori milanesi, e soprattutto nelle agitazioni dei si
derurgici e metallurgici liguri, la loro presenza fu spesso determinante.
Tuttavia, se studi sulle situazioni locali potranno permettere di impo
stare in termini piu' rigorosi il rapporto tra spontaneita e organizzazione
delle lotte, ci sembra che si possa comunque affermare che la spinta alla
loro radicalizzazione provenne dalle stesse masse operaie, cui la guerra
fece rapidamente maturare una coscienza non solo sindacale, ma anche
politica. Se le condizioni di eccezionale sfruttamento e di repressione
condussero la classe operaia al rigetto di posizioni moderate ed econo
micistiche (di cui fanno testo i numerosi casi di insubordinazione alla
linea concordata dal sindacato confederale), contemporaneamente la pre
senza in fabbrica di esponenti dell'esercito, dai quali dipendeva il con
trollo del lavoro e la commissione delle pene disciplinari, il ricorso in
caso di controversie ad organi di Stato, resero evidente il nesso che
legava il potere economico al potere politico, e fecero acquisire alla classe
operaia la consapevolezza della necessit"a di una battagolia non solo contro
il sistema di sfruttamento in fabbrica, ma anche contro il regime po
litico che se ne faceva garante.
Un processo analogo maturo tra le masse contadine. I richiami alle armi,
con le loro lugubri conseguenze, la vessazione governativa praticata attra
verso prezzi d'imperio e requisizioni, rinnovarono nelle campagne non mai
sopiti sentimenti antistatali, le cui piui evidenti manifestazioni furono
gli assalti ai simboli del potere, municipi e prefetture. Ma la ribellione
contadina non si configurava piu come rivolta anarchica di stampo otto
centesco, lo Stato apparendo ora il baluardo di difesa della proprieta dei
<< signori >>, quella proprieta di cui le vicende di guerra stavano facendo
ridiscutere la distribuzione.
Lo spirito di rivolta fu nutrito anche dalla coscienza del proprio ruolo,
che la guerra maturo negli operai e nei contadini. Nelle fabbriche la
mancanza di mano d'opera - fenomeno inedito nella storia del paese -
rese consapevole la classe operaia della propria funzione indispensabile
all'interno della produzione; e sentimenti simili ispirarono i contadini,
alimentate dalla fitta propaganda che sublimava il sacrificio del fante,
posto a perno dell'epica nazionalpatriottica, e dalle promesse di una ri
compensa materiale, la terra.
II progetto di ricomposizione sociale, cui il conflitto, secondo gli in
tendimenti della classe dirigente italiana, avrebbe dovuto dar vita, si
poteva dire fallito: le esperienze di quei tristi anni avevano maturato al
contrario una piu diffusa e radicata coscienza dei propri diritti e dell'anta
gonismo sociale e politico. Su di essa si innester'a nel dopoguerra il mito
della rivoluzione che proveniva dalla Russia bolscevica.
This content downloaded from
130.186.99.159 on Wed, 25 Nov 2020 16:34:10 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Potrebbero piacerti anche
- Il Mistero Di Belicena Villca - Prima Parte (Italiano) - EditadoDocumento404 pagineIl Mistero Di Belicena Villca - Prima Parte (Italiano) - EditadoPablo Adolfo Santa Cruz de la Vega100% (4)
- Corriere Cesenate 31-2014Documento25 pagineCorriere Cesenate 31-2014settimanale Corriere CesenateNessuna valutazione finora
- Operazione Greif - Wikipedia PDFDocumento3 pagineOperazione Greif - Wikipedia PDFStoriadossierNessuna valutazione finora
- Prima Guerra Mondiale, Di Andrea BasciuDocumento7 paginePrima Guerra Mondiale, Di Andrea BasciuGianfranco Marini100% (1)
- Storia Del Debito Pubblico Italiano PDFDocumento1 paginaStoria Del Debito Pubblico Italiano PDFdeligaNessuna valutazione finora
- I 36 Stratagemmi Della Crescita Personale ANTEPRIMA - Yamada Takumi PDFDocumento58 pagineI 36 Stratagemmi Della Crescita Personale ANTEPRIMA - Yamada Takumi PDFFede RicaNessuna valutazione finora
- Sangiusto ItDocumento2 pagineSangiusto ItNicolò Dalla CostaNessuna valutazione finora
- Biennio Rosso in EuropaDocumento2 pagineBiennio Rosso in EuropaGianfranco Marini0% (1)
- Guerra Di CrimeaDocumento1 paginaGuerra Di CrimeaZYO GIANNINessuna valutazione finora
- La Lettura 20140511Documento32 pagineLa Lettura 20140511apiglia51Nessuna valutazione finora
- Spazio e Tempo Per Il Popolo NuerDocumento9 pagineSpazio e Tempo Per Il Popolo NuerAnnastella FranzaNessuna valutazione finora
- The 10 Levels of Fingerstyle Guitar by Lucas BrarDocumento31 pagineThe 10 Levels of Fingerstyle Guitar by Lucas BrarDavo RockNessuna valutazione finora
- Stupri Di GuerraDocumento11 pagineStupri Di Guerraalessiomannucci100% (4)
- Veneto Serenissimo Governo - Storia e Documenti 1987-2005Documento396 pagineVeneto Serenissimo Governo - Storia e Documenti 1987-2005Demetrio SerragliaNessuna valutazione finora
- Oikeios Polemos. La Guerra Nella FamigliaDocumento32 pagineOikeios Polemos. La Guerra Nella FamigliaTiago da Costa GuterresNessuna valutazione finora
- La Cam P PDFDocumento83 pagineLa Cam P PDFgabuz inoNessuna valutazione finora
- La Politica e Gli Stati-RiassuntoDocumento39 pagineLa Politica e Gli Stati-RiassuntoSilvia IvaldiNessuna valutazione finora