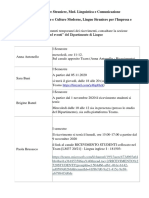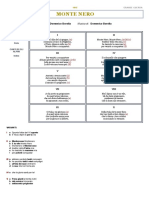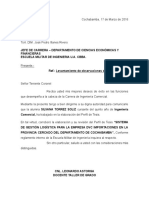Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Vivere Con La Guerriglia (1978)
Caricato da
Marco Rb0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
36 visualizzazioni8 pagineCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
ODT, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
36 visualizzazioni8 pagineVivere Con La Guerriglia (1978)
Caricato da
Marco RbCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 8
VIVERE CON LA GUERRIGLIA (1978)
L'anno scorso in Inghilterra è stato pubblicato uno studio
interessante: alcuni statistici hanno ordinato le differenti professioni
secondo la durata media della vita di chi le praticava. Ne è venuto
fuori che i minatori sono quelli che vivono di meno e - seguendo una
scala che va dal lavoro manuale a quello intellettuale - Perultimi
vengono i professori, gli avvocati e gli uomini politici. E
un'osservazione, in parte banale, che bisognerebbe però far
presente agli improvvisati elogiatori del lavoro manuale, e che a
torto è stata tenuta fuori dal dibattito in corso sulla democrazia, la
violenza e la morte, quindi sul corpo e i bisogni, il personale e la
vita quotidiana. Per essere acidi, si potrebbe metterla così: è
fondato il rischio che Colletti viva più a lungo della stragrande
maggioranza dei suoi studenti. C'è di che riflettere.
Ma è meglio riprendere il problema dagli inizi, dai termini in cni è
stato posto.
Il '77 ha visto l'emergere prepotente di una categoria centrale - la
fisicità, il corpo, i bisogni, i desideri: cioè l'individuo. Con l'individuo,
sono venute alla ribalta le differenze e le particolarità, che cercano
di definire il loro posto dentro un processo collettivo di liberazione.
La critica della politica - intesa come quel processo che eguaglia gli
uomini nella astrazione dello Stato, isolandoli nella concretezza
delle loro diversità, contrapponendosi a ognuno di essi come
«interesse generale» che li domina - è l'immagine sintetica di
questo passaggio.
Dietro ci stanno, ancora, la rivalutazione della concretezza della vita
quotidiana contro l'astrazione totalitaria dei «grandi ideali»; il rifiuto
della subordinazione del presente al futuro; la rivendicazione della
materialità della propria esistenza; l'odio per il sacrificio, l'eroismo,
la retorica. Non è importante tracciare qui la genealogia di questo
immediatismo: c'è l'impronta operaia, radicale ed egualltaria, del
«tutto e subito», e il ruolo cruciale del movimento di liberazione
della donna; è essenziale - in questo discorso - la rottura, non la
continuità, il fatto che per la prima volta questo blocco tematico
diviene il punto di aggregazione, il momento di identità di un
soggetto politico articolato e potente.
IL SOGGETTO GENERALE SFRUTTATO
Sono questi i termini della questione che innovano profondamente il
dibattito sullo Stato e la politica, la rivoluzione e la guerra, il
processo di liberazione e i bisogni. C'è un nodo, però, che bisogna
capire preliminarmente, per comprendere quante banalltà
tediosamente riesumate, quanto cattolicesimo protervo, abbiano
potuto venire fuori da una base così ricca, da premesse tanto
eversive: perché un percorso misterioso, nel giro di pochi mesi, ha
fatto di questo insieme di tematiche il terreno di fondazione di
un'medita cultura dell'emarginazione, di un linguaggio di piccolo
gruppo, ripetitivo, petulante e barocco, il linguaggio di chi
dell'«esclusione» ha fatto una professione di fede. C'è stata una
rimozione all'inizio, e di questa bisogna rendere conto: non è vero
che tra il movimento del '77 e le lettere a «Lotta Continua» ci sia un
filo semplice e diretto di continuità: c'è, viceversa, una selezione, un
filtro politico preciso e determinante. Il movimento del '77 non è
stato, socialmente, un movimento di emarginati e neanche - in
senso stretto - di «non garantiti»: ci stavano dentro fette rilevanti di
lavoratori dei servizi, di tecnici e impiegati, di giovani lavoratori
delle piccole fabbriche e studenti, di lavoratori a tempo parziale e
disoccupati, e aveva un rapporto stretto, tematico e politico, con il
movimento di lotta delle donne. Un soggetto sociale unito dal suo
essere in larga parte esterno ai meccanismi di cooptazione del
sistema dei partiti, ma ben addentro ai processi di produzione e
riproduzione della ricchezza sociale, fortemente interrelato con
l'insieme del tessuto sociale, non isolabile, socialmente potente
perché detentore di conoscenza e informazioni, perché inserito nel
cuore dei meccanismi riproduttivi. Non è stata la rivolta del ghetto,
ma l'emergenza di processi di modificazione profondi che hanno
percorso in questi anni l'insieme del tessuto sociale e di classe nel
nostro paese: l'esternità di questo soggetto politico al sistema dei
partiti non è interpretabile come sua emarginazione, ma come
debolezza profonda dell'assetto politico e istituzionale dell'«anello
Italia».
CONTRO LA FALSA COSCIENZA DI MARGINALI
La tematica dell'emarginazione non è stata un'identità naturale per
questo movimento; è stata il prodotto faticoso di una gestione
politica che ha smussato la radicalità dei problemi difficili che si
erano posti, che ha ricondotto l'emergenza delle nuove tematiche
dentro l'ossatura delle vecchie ideologie, che nella sostanza ha
spaccato il movimento isolandone una componente, sciogliendo il
problema della sua identità di soggetto politico in quello
dell'identità sociale di una parte di esso.
In tal modo, la critica della politica ha perso lo spessore che le
avrebbe permesso di essere anche critica pratica del potere e dello
Stato, per ridursi a una pratica di esclusione dall'uno e dall'altro; e
l'emergenza dell'individuale e del quotidiano dentro il processo
collettivo di liberazione è stata ricacciata nel ghetto garantista del
«lasciateci vivere», nella ricerca degli spazi marginali, mentre il
problema della «legittimazione» politica della radicalità dei
comportamenti e delle forme d'azione trovava la fondazione più
tradizionale e povera: l'esclusione, la disperazione, la rabbia. La
disperazione come identità collettiva, come segno di
riconoscimento, e con essa l'impotenza. E un'identità rassicurante,
per sé e per gli altri: «sono un emarginato arrabbiato, non ho
bisogno di correggere i miei errori, quando ho fame urlo>>; <<è un
povero emarginato, il male che può fare è poco, lo fa soprattutto a
sé». E a questo punto che le lettere a «Lotta Continua» diventano
un caso nazionale, un boom letterario, escono sulle pagine
dell'«Espresso». Emarginazione e disperazione esistono, certo, ma
non è questo il punto, qui si tratta di altro, di una cultura, di un
linguaggio, di una professione: è un grande filtro ideologico
attraverso il quale deve passare tutto quanto voglia stare «dentro il
movimento», una forma obbligata di espressione, un linguaggio che
dà legittimità e costringe al mimetismo. Questo linguaggio ha i suoi
cultori e amministratori: i sacri maestri inflessibili e autoritari nel
dettare le regole del gioco, i patiti dello «sballo» e gli ex cantori dei
servizi d'ordine, gli esperti in «rapporti umani» e le professioniste
del femminismo.
CRITICA DELLA DISTINZIONE TRA PACE E GUERRA
Il dibattito sulla violenza appare la prima grande vittima di questa
situazione infelice. Ha un punto di partenza importante: la
rivendicazione del diritto alla vita, il rifiuto del sacrificio e
dell'eroismo della retorica bellicista. La critica della politica e' anche
critica della guerra, rifiuto di immolarsi in nome dell'ideale futuro,
rifiuto della subordinazione di sé ai «superiori interessi di tutti»:
insomma, rifiuto di quel momento «eccezionale» in cui la donna si
comporta come l'uomo, e tutti come soldati, dove non c'è posto per
il gioco e lo scherzo, per la festa, dove non esistono i diritti della
vita quotidiana, e tutte le potenze distruttrici della società si
concentrano «per costruire un futuro migliore». Ma il discorso non
può finire qui, altrimenti diventa retorica natalizia. Bisogna
aggiungere: la critica della guerra è anche critica della pace che la
guerra produce e riproduce dal suo interno, ed è critica di quella
parte della società che è sempre in armi per garantire la pace. E -
non può non essere - critica della distinzione forzosa tra pace e
guerra, tra esercito e società tra soldato e civile.
Ed anche qui c'e' un problema, centrale, di rimozione del soggetto,
della nostra storia, collettiva come personale. Se lo guardiamo
infatti con l'occhio del militante e dell'ideologo, il movimento del '77
è stato il campo di battaglia di linee politiche ferocemente avverse -
militariste alcune, pacifiste altre. Organizzazioni di diversa natura -
alcune fatte per la guerra, altre fatte per la pace - si sono disputate
lo spazio politico al suo interno.
Se lo guardiamo, però, dall'esterno (per così dire: dalla faccia che
ha mostrato di Sé), o se guardiamo, oltre allo scontro, alla
convivenza di tendenze di diversa natura e alle stesse biografie dei
compagni, vediamo che, al di là dei veti e delle prescrizioni
categoriche, che slittano da un ruolo all'altro, che mescolano e
tengono insieme storie ed esperienze normalmente incompatibili,
allora ci accorgiamo che il movimento di questi anni, in Italia come
in Europa, ha intrecciato intimamente, in modo continuo e
sistematico, iniziativa legale e illegale, violenta e non violenta, di
massa e di piccoli gruppi, muovendosi ora secondo le leggi dello
stato di pace, ora dello stato di guerra: questo intreccio non è stato
prerogativa di una organizzazione, ma le ha attraversate tutte,
superandole e imponendo la convivenza di momenti organizzativi
diversi all'interno del medesimo soggetto sociale.
Questa caratteristica, questa capacità di mescolare insieme pace e
guerra, di sviluppare iniziativa offensiva senza produrre soldati, non
soltanto ha costruito la forza del movimento, ma, in generale, è
elemento centrale del suo essere comunista ed eversivo.
Erodere la distinzione tra pace e guerra vuol dire porsi sul terreno
della critica dello Stato, mettere in forse i principi della
legittimazione del potere politico, che afferma infatti una distinzione
fra «Stato» e «societa», «pubblico» e «privato», «generale» e
«particolare». L'interesse generale è armato, gli interessi particolari
si confrontano secondo le leggi che governano la pace.
L'armamento dello Stato garantisce il disarmo della società; il fatto
che una parte della società - l'apparato repressivo e militare - si
erga come corpo separato e funzioni secondo le leggi della
«guerra», garantisce che il resto della società viva nella «pace». E
«pace» vuol dire soltanto che la «guerra» è diventata un affare
particolare, di alcuni uomini che ne vivono (poliziotti emilitari), o di
quei particolari momenti in cui questi uomini particolari prendono il
comando su tutti gli altri, dimostrando nei fatti che -essendo loro i
garanti della pace di tutti - la governano anche, ne sono la parte
dirigente. La guerra garantisce la pace, la minaccia di essa la
conserva all'interno degli Stati o nei rapporti tra Stati; nella
distinzione tra pace e guerra appare fondarsi, nella cultura politica
occidentale, il concetto di Stato.
LA VlOLENZA DOMINA I RAPPORTI SOCIALI
La distinzione tra «guerra» e «pace» impone la definizione della
violenza in termini categoriali e, facendone affare particolare di un
gruppo di uomini particolari, ne tronca i nessi con le altre forme
dell'agire e della comunicazione sociale: la «violenza» si presenta
non per quello che è - un aspetto di ogni attività umana dentro il
rapporto di capitale, presente in ogni forma di espressione e
comunicazione, dove porta il segno del rapporto di potere - ma
appare un'attività accanto alle altre, specializzata e mostruosa, che
tutte ricatta.
Ogni rapporto di potere ha la sua faccia militare, e ogni rapporto
umano è, nella società capitalistica, rapporto di potere: per questo
la macchina da guerra affonda le sue radici nei rapporti di pace, e la
violenza che li domina si dà la sua rappresentazione generale
nell'«infinita potenza distruttrice» dello Stato moderno. L'apparato
repressivo, con i suoi specialisti della guerra, è sintesi della violenza
che domina i rapporti sociali, ed è la garanzia armata della loro
riproduzione: perché il lavoro salariato non si scopra come violenza,
la violenza si presenta come un lavoro accanto agli altri; perché il
lavoratore non scopra di essere immerso nella violenza quotidiana,
questa gli si presenta come professione di un altro «lavoratore», il
poliziotto. Rimettere sui piedi questo mondo capovolto vuol dire
andare a svelare la violenza nascosta nella vita quotidiana e
affrontarla per quello che è, senza cedere al ricatto del terrore,
attaccandone la macchina per sabotarla: vuol dire imparare a usare
la violenza, per non doverla delegare, per non esserne ricattati;
imparare a riconoscerla, o a viverci insìeme.
CHI SCIOGLIERA L'ARMATA ROSSA?
Il movimento di questi anni non è stato insurrezionalista o
militarista perché non è stato pacifista, perché non ha rispettato la
successione della pace che prepara la guerra o il suo apparato, il
suo esercito ordinato, e quella della guerra che prepara la nuova
pace; perché non ha visto la violenza concentrata nell'ora X della
resa dei conti - la cieca, disumana e astratta violenza degli eserciti
-, ma l'ha vista dispiegata e appresa lungo tutto l'arco della lotta
politica di liberazione.
Due e solo due sono le strade (e i «pacifisti» di turno lo dimostrano
sempre): a) la lotta politica esclude l'uso della violenza dal suo
orizzonte, e allora rispetta l'apparato militare esistente, oppure si
appresta a organizzarne uno alternativo ed equivalente per passare
poi a una fase di guerra, aperta o «legittima», esercito contro
esercito, Stato contro Stato (è una storia che già conosciamo, e
abbiamo imparato a porci le domande: chi scioglierà l'Armata
Rossa? chi lotterà contro lo Stato quando la classe operaia si sarà
fatta Stato?); b) il processo di liberazione non è prima «politico» e
poi «militare»; apprende l'uso delle armi lungo tutto il suo corso;
scioglie l'esercito nelle mille funzioni della lotta politica; mescola
nella vita di ognuno il civile e il combattente, impone a ognuno di
imparare l'arte della guerra e quella della pace.
Non si può pretendere di vivere il processo di liberazione comunista,
e avere lo stesso rapporto con la violenza, la stessa idea di bello, e
buono, e giusto, e desiderabile, la stessa idea di normalità, le stesse
abitudini, di un impiegato di banca torinese di mezz'età: vivere col
terremoto è sempre - anche - vivere col terrorismo, e per non avere
un'idea «eroica» della guerra bisogna innanzitutto evitare un'idea
pezzente della pace.
I pacifisti come Lama arruolano polizìotti, quelli «più a sinistra»
chiedono la legittimazione della «violenza di massa», del
«proletariato in armi». Il movimento reale è stato più realista e
meno bellicoso, più umano e meno eroico: è perché ha criticato la
guerra che ha messo in discussione la pace, ed è perché ha rifiutato
l'esercito che ha spezzato il criterio della delega e della
legittimazione; con errori e approssimazioni, e con deviazioni
terribili, e coltivando miti assurdi, e dentro una storia
contraddittoria, ma imparando, e migliorando in un processo che ha
modificato la realtà più di un'insurrezione.
CRITICA COMUNISTA DELLA DEMOCRAZIA
Critica della politica è dunque anche critica della dicotomia
guerra/pace. La pace di cui parliamo, è la pace della democrazia, e
la violenza che usa è «violenza legittima», che la maggioranza ha
delegato alle istituzioni dello Stato: criticare questa violenza vuol
dire criticare il principio più sviluppato della legittimazione politica,
la democrazia. Perché il problema della legittimità è il problema
della maggioranza, e il problema della maggioranza è quello degli
istituti in cui si esprime, cioè dello Stato: «maggioranza» e
«minoranza» appartengono all'universo del pensiero politico, si
spartiscono il comando sull'«interesse generale», vivono della
separazione di «pubblico» e «privato», di Stato e società,
affondando le radici dentro i rapporti di dominio che impongono agli
uomini di confrontarsi come quantità. La maggioranza si costituisce
per amministrare il potere: quanto più il potere è concentrato, tanto
più può la maggioranza, tanto meno può il singolo; quanto più ricco
è il «pubblico», l'«interesse di tutti», tanto più povero, espropriato,
è il «privato», tanto più spossessato, privo di espressione, è
l'interesse di ognuno. La democrazia è, insieme, il massimo sviluppo
del potere statale, il massimo momento di concentrazione del
potere politico, il luogo dell'incontrastato comando del principio di
maggioranza: il punto non è che nello Stato moderno vi sia poca
democrazia, che non siano tutelate le minoranze ma - al contrario -
che è condotta una lotta a morte contro tutto ciò che non si esprime
nei termini di maggioranza o minoranza, che non si esprime in
termini di potere e di gestione. E per questo che ovunque il
movimento di liberazione comunista è fuorilegge: perché si pone al
di fuori del codice democratico, e questo codice definisce in modo
esclusivo l'universo della politica. La radicale critica marxiana della
democrazia individua le categorie che fondano la lotta a morte fra
democrazia e comunismo, fra potere democratico e liberazione
comunista. il resto sono miserie, imbrogli ad usum delphini.
In democrazia è obbligatorio «lottare per la maggioranza» perché
senza maggioranza non si può fare nulla, neanche produrre uno
spillo, o suonare il clarino. Allo Stato si può chiedere tutto, ma senza
lo Stato non si può fare nulla, e il rapporto di potere si presenta
come il linguaggio universale in cui tutti i «dialetti» si condensano e
traducono. La lotta per la maggioranza è obbligatoria, di qualsiasi
maggioranza si tratti; e la maggioranza di un insieme piccolo
rimanda alla maggioranza di un insieme più vasto, come la
maggioranza del Pdup rimanda alla maggioranza di Dp, mentre le
istituzioni parlamentari si sviluppano su tutto il tessuto sociale, ed
eserciti crescenti di delegati apprendono il mistero della
conciliazione della massima divisibilità del potere con la sua
massima concentrazione.
Con la maggioranza si può tutto, senza la maggioranza non si può
nulla: la sola azione sociale riconosciuta è la lotta per la
maggioranza («è la dittatura degli avvocati sulla società
americana», scriveva anni fa un giornalista a proposito del
Congresso Usa); il solo rapporto sociale riconosciuto è quello
assembleare, di maggioranza e minoranza. Massima concentrazione
del potere, sua ottima amministrazione. Il capitale concentra i
mezzi di produzione, la ricchezza sociale, la democrazia li
amministra secondo un codice, quello del rapporto di maggioranza
e mìnoranza: è il codice migliore, ma è il mondo del capitale.
Non conosciamo un altro codice per «legittimare» il potere politico;
lo Stato socialista si muove all'interno di questo stesso orizzonte.
Questo vuole dire che stiamo lottando contro il potere politico,
contro la forma-Stato, contro la democrazia, contro l'universo dei
rapporti capitalistici di produzione, per il comunismo.
Lucio Castellano
(Pubblicato in «Preprint», n. 1, dicembre 1978)
Back
Potrebbero piacerti anche
- Ildeposito Canzoniere Alfabetico Completo Accordi PDFDocumento552 pagineIldeposito Canzoniere Alfabetico Completo Accordi PDFenricolimongelliNessuna valutazione finora
- 2018 Quaderno Sism Over There in Italy. L'Italia e L'intervento Americano Nella Grande GuerraDocumento442 pagine2018 Quaderno Sism Over There in Italy. L'Italia e L'intervento Americano Nella Grande GuerraVirgilio_IlariNessuna valutazione finora
- Politica e Cultura Nell'Età NapoleonicaDocumento5 paginePolitica e Cultura Nell'Età NapoleonicaMarco MattaNessuna valutazione finora
- Appunti Di Storia ConteporaneaDocumento2 pagineAppunti Di Storia Conteporaneamobydick76Nessuna valutazione finora
- LeSocietà10 2004Documento124 pagineLeSocietà10 2004Lawrence BoschettiNessuna valutazione finora
- Codev RossiDocumento54 pagineCodev Rossifrancea1Nessuna valutazione finora
- Massacro Di Sand CreekDocumento12 pagineMassacro Di Sand CreekDario Daddà TurresNessuna valutazione finora
- Gaio Giulio CesareDocumento49 pagineGaio Giulio CesareEttore MazzeiNessuna valutazione finora
- Date Avvenimenti 1900Documento2 pagineDate Avvenimenti 1900Doc KongNessuna valutazione finora
- Le Guerre Di Carlo VDocumento7 pagineLe Guerre Di Carlo VValentina ConaNessuna valutazione finora
- Tracce Dei Temi Concorso Allievi MarescialliDocumento2 pagineTracce Dei Temi Concorso Allievi MarescialliFlaminia House Bed and BreakfastNessuna valutazione finora
- Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. III: Dizionario Biografico D-LDocumento457 pagineAlessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. III: Dizionario Biografico D-LCorsaroGiallo100% (1)
- Ricevimento Lingue 1 1338Documento16 pagineRicevimento Lingue 1 1338ouapiti1977Nessuna valutazione finora
- Monte NeroDocumento1 paginaMonte Nerodavide812023Nessuna valutazione finora
- Cartas Emi 2Documento19 pagineCartas Emi 2Roma AguilarNessuna valutazione finora