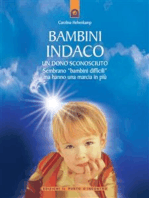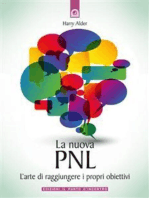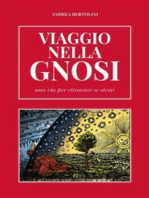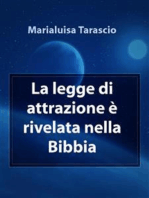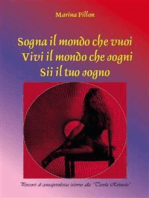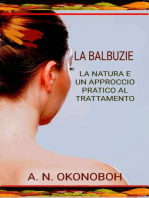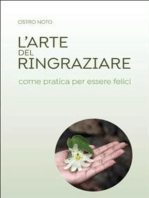Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Da Zero A Tre Anni PDF
Da Zero A Tre Anni PDF
Caricato da
7black20 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
20 visualizzazioni378 pagineTitolo originale
da-zero-a-tre-anni.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
20 visualizzazioni378 pagineDa Zero A Tre Anni PDF
Da Zero A Tre Anni PDF
Caricato da
7black2Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 378
PREFAZIONE II cervello del bambino è
come una scacchiera. All'inizio
qualunque partita è teoricamente
possibile, qualunque mossa brillante
è ipotizzabile. Poi, quando si
cominciano a muovere i pezzi, le
combinazioni iniziali via via
diminuiscono e il gioco comincia a «
strutturarsi » in un certo modo. Se
le mosse iniziali sono appropriate e
l'impianto del gioco è ben
sviluppato, la partita è ben avviata;
ma se le mosse iniziali sono
sbagliate sarà estremamente difficile
risollevare le sorti del gioco. Lo
svantaggio dovuto a una cattiva
impostazione sarà difficilmente
recuperabile. Nel cervello del
bambino avviene qualcosa di analogo.
Durante i primi anni, le « mosse »
sono quelle fatte dai genitori, dalla
madre in particolare, che è la prima
maestra vera. Solo al momento
dell'ingresso nella scuola il
cervello verrà consegnato
all'insegnante, il quale si troverà
di fronte a una partita già molto
avanzata, con una disposizione di
pezzi che finirà per determinare in
buona parte il futuro andamento del
gioco. Certo, nulla è mai perso e
nulla è mai vinto. Però in pratica
diventerà sempre più difficile
cambiare le sorti della partita e
recuperare il terreno perduto. Questo
esempio, sia pure in modo
approssimativo, permette di capire
l'importanza dei primi anni di vita,
durante i quali il bambino offre la
sua pasta cerebrale ancora intatta
alla manipolazione di chi gli è
accanto, affidandogli così la
costruzione della sua mente.
Alla nascita tutti i bambini sono
uguali, nel senso che il loro
cervello è vuoto di esperienze, di
idee : essi dispongono di un
patrimonio genetico diverso (frutto
di agganci casuali di molecole
selezionati in miliardi di anni) ma
la loro linea di partenza culturale è
la stessa. È l'unico momento della
vita, del resto, in cui si trovano su
un piede di uguaglianza. Non importa
se sono figli di un muratore o di un
avvocato, di un intellettuale o di un
analfabeta : dai loro genitori hanno
ereditato solo i cromosomi, cioè solo
un substrato biologico. Un uomo può
studiare tutta la vita filosofìa,
oppure mungere tutto il giorno
mucche, non per questo suo figlio
nascerà più o meno intelligente di
quanto gli consenta il suo patrimonio
genetico cioè le potenzialità mentali
derivanti dalla qualità delle sue
cellule nervose. La cultura non entra
nei cromosomi, così come non entra
alcun altro carattere acquisito.
Nessuno nasce con la cicatrice
dell'appendicite: allo stesso modo
nessun bambino, nascendo, conserva
traccia dei libri letti dal padre. Vi
è quindi alla nascita un'uguaglianza
che si basa proprio sul vuoto
pneumatico dell'intelletto, sulla
mancanza assoluta di costruzioni
mentali; queste verranno stimolate
solo attraverso i materiali che
l'ambiente metterà a disposizione del
bambino. All'inizio, dicevamo,
esistono solo dei pezzi bene
allineati sulla scacchiera. Le
diversità di gioco cominceranno però
a delinearsi ben presto, man mano che
le prime mosse verranno effettuate.
La partita è estremamente importante:
la posta in gioco è lo sviluppo
mentale del bambino. Ma chi insegna
alla madre a diventare una buona
giocatrice? Che cosa trova una madre
tornando a casa dalla maternità col
suo adorabile batuffolo umano avvolto
nelle coperte di lana? Forse qualcuno
che la consigli sul modo migliore di
sviluppare quei preziosissimi
duecentocinquanta grammi di cervello
che il neonato possiede all'interno
della minuscola scatola
cranica, e che rappresentano la
fantastica pasta vergine sulla quale
costruire giorno per giorno la sua
personalità, la sua intelligenza, il
suo avvenire d'uomo? In pratica, lo
sappiamo, questo ruolo così delicato
è lasciato in gran parte all'istinto
materno, alla capacità innata (e
culturale) che ha una madre di
educare il suo bambino. L'aiuto che
essa riceve per allevare il piccolo è
in generale limitato ai consìgli sul
come aver cura dei due buchi
principali (certo essenziali) di
ingresso e di uscita del neonato.
Intere industrie, con giri d'affari
di miliardi, lavorano a pieno ritmo
per riempirli da una parte e
accogliere gli scarti dall'altra:
pappe e pannolini, omogeneizzati e
talco profumato rappresentano il
mondo dorato della prima infanzia.
L'igiene e la nutrizione sono aspetti
molto importanti: ma lo sviluppo
cerebrale non lo è certo di meno.
Ora, una vera rivoluzione è in corso
per quanto riguarda la scoperta dei
meccanismi del cervello umano, e in
particolare per quanto riguarda la
nascita della mente nel bambino : si
cominciano ad intravedere chiaramente
le leggi biologiche che regolano lo
sviluppo mentale, e si può oggi
misurare la grande influenza
dell'ambiente nei primi anni di vita.
Le differenze nel quoziente di
intelligenza che si possono rilevare
al momento dell'ingresso nella
scuola, esistono già all'età di tre
anni e anche prima: ciò significa che
è nel primo periodo di vita (e quindi
soprattutto con la madre) che il
bambino costruisce la sua attitudine
a imparare, immaginare, esplorare,
capire. In questo periodo egli riceve
l'impronta di base che conterà non
solo per la sua capacità di amare il
prossimo e di avere uno sviluppo
psichico equilibrato, ma anche per
quella di interessarsi alle cose, di
memorizzare, di attivare i suoi
circuiti cerebrali, e di sviluppare,
in definitiva, la sua intelligenza e
la sua creatività. Esperimenti e
ricerche hanno mostrato che questa
graduale costruzione della mente
comincia fin dal primo giorno di
vita, e che il bambino alla nascita è
un miliardario del cervello, molto
più precoce e sensibile di quanto i
genitori non pensino, pronto a
modellarsi su tutto ciò che esiste
intorno a lui. Una vera rivoluzione è
in corso nel modo di vedere lo
sviluppo mentale: la famiglia e lo
Stato dovranno tenerne conto, e
rivedere molte vecchie idee. In
questo libro io ho cercato di
allargare il discorso iniziato con
una serie di inchieste televisive,
rìelaborando in un quadro più vasto
il materiale raccolto in tutto il
mondo nel corso di incontri e
conversazioni con alcuni dei più
famosi psicologi, biologi, neurologi,
fisiologi, biochimici che studiano lo
sviluppo del cervello nel primo
periodo di vita. E ho cercato di
raccontare in modo estremamente
chiaro che cosa accade nella mente
del bambino durante i primi tre anni
di vita, per aiutare ogni madre a
essere più consapevole del suo
importantissimo ruolo. Nell'ultima
parte del libro ho cercato di
mostrare come la stratificazione
sociale cominci già nel primo periodo
di vita (e come sia necessario agire
molto prima di quanto non si faccia
oggi per modificare le cose), e ho
infine affrontato il problema
dell'educazione in modo poco
convenzionale, partendo da una realtà
biologica che dobbiamo deciderci ad
accettare: il bambino (come l'uomo)
non è « libero », ma soggetto ai
condizionamenti dell'eredità e
dell'ambiente. Nessuno alla nascita
può scegliere i propri cromosomi o
l'ambiente che lo circonda. Credere
che un bambino possa crescere «
libero » significa abbandonarlo ad
altri condizionamenti, casuali.
L'unica sua difesa consiste nello
sviluppare la qualità più tipicamente
umana: l'immaginazione.
Un'immaginazione che possa salvarlo
anche dal collasso planetario
minacciato dal demenziale aumento
della popolazione e dai saccheggi
ambientali, di cui parleremo nella
conclusione del libro. Il futuro si
presenta infatti, per il neonato,
come una terribile sfida mentale, che
può essere affrontata soltanto con la
più urgente delle rivoluzioni :
quella del cervello.
Questo libro non è dedicato soltanto
alle madri, ma a tutti. Esso può
anche essere visto in un modo
completamente diverso : cioè come la
storia della nascita della mente, del
passaggio dalla molecola all'uomo
pensante. È un « taglio » che ho
tenuto sempre presente nella stesura
e riemerge di continuo tra le righe.
Credo infatti che osservare da vicino
i meccanismi dello sviluppo mentale
permetta di cogliere molti dei
problemi non solo del bambino ma
anche dell'adulto, e di capire meglio
il suo comportamento quotidiano nella
vita, nel rapporto con gli altri, e
anche in politica. Un'ultima
avvertenza: il primo capitolo (come
pure il quinto) è forse un po' «
tecnico », ma è una parte che ritengo
indispensabile alla comprensione dei
capitoli che seguono. Spero comunque
di aver mantenuto anche qui, come nel
resto del libro, un linguaggio molto
semplice e accessibile (vi saranno
anzi alcune apparenti ripetizioni:
per comodità di chi legge, infatti,
ho ritenuto utile ripetere, a volte,
certi concetti o meccanismi biologici
in modo da rendere il concetto ancora
più chiaro e agevolare al massimo la
lettura). Valeva la pena di compiere
questo sforzo di chiarezza, credo,
per condividere con gli altri le
meravigliose e sconcertanti scoperte
che ho cercato di capire guardando
sopra la spalla dei ricercatori.
Alla nascita un bambino ha già 3
miliardi di anni: l'origine delle sue
cellule risale infatti ai primordi
della vita sulla Terra, e il nucleo
di ogni cellula conserva la memoria
genetica di tutta l'evoluzione.
I • PRIMA DELLA NASCITA Vostro figlio
ha tre miliardi di anni Da dove viene
vostro figlio? Da molto lontano: alla
nascita infatti egli ha già tre
miliardi di anni. Solitamente si
pensa che la vita cominci con il
concepimento, cioè con la
congiunzione dello spermatozoo e
dell'ovulo: ma in realtà queste due
cellule « germinali » erano già vive
prima di unirsi insieme, avevano già
avuto una vita propria, una serie di
esperienze, una « famiglia »
cellulare. Ognuna era il risultato di
una cellula precedente, che a sua
volta era figlia di un'altra cellula
altrettanto viva, e così via
all'indietro, fino a risalire alle
origini della vita sulla terra,
origini che si calcola rimontino
appunto a oltre tre miliardi di anni
fa. In altre parole la vita non è
qualcosa che si accende come una
scintilla ogni qualvolta si
concepisce un figlio; è invece il
risultato di una lunga corsa a
staffetta : la fiamma viene trasmessa
come la fiaccola olimpica, da un
tedoforo all'altro, fino a
raggiungere il grande braciere nello
stadio. Sul monte Olimpo la fiamma
aveva preso origine dai raggi solari
: è proprio quanto è accaduto con la
vita, che è nata dall'energia solare,
all'inizio di questa corsa a
staffetta biologica. Il discorso su
vostro figlio deve iniziare
necessariamente qui, altrimenti si
rischia di non capire la vera natura
di molte cose. Purtroppo gran parte
della nostra educazione ci porta
di solito a leggere il libro della
vita aprendolo all'ultimo capitolo,
mentre bisogna cercare la prima
pagina per comprendere il senso di
tutto il discorso. È l'errore, del
resto, degli storici che cercano di
interpretare la storia dell'uomo
cominciando dalla sua nascita
(nascita che, peraltro, non è mai
avvenuta, perché vi è sempre stata,
in natura, una trasformazione
graduale). La vera storia dell'uomo
(e di vostro figlio) è cominciata con
l'apparizione delle prime molecole
capaci di replicarsi nel « brodo »
primordiale ed è continuata con i «
tedofori » rettili e mammiferi :
ignorare i meccanismi e le leggi
dell'evoluzione (che continuano ad
essere alla base del comportamento
umano) è come volere interpretare il
funzionamento di un'automobile senza
aver mai aperto il cofano del motore.
Diciamo subito, per sgombrare il
terreno da equivoci, che la « fiamma
» della vita non contiene alcuna «
forza vitale ». È semplicemente una
struttura. Una struttura molecolare
che si è modellata grazie al caso e
agli agenti che agivano su di essa,
in particolare l'energia solare. Per
capire dove prendono origine gli
istinti e l'intelligenza del bambino
sarà quindi bene rifare, molto
rapidamente, la storia di questa
corsa a staffetta, cominciando ancora
prima delle origini della vita sulla
terra, risalendo alle origini de)
cosmo: vi è infatti un filo
conduttore molto evidente che lega
tutti questi avvenimenti, e permette
di comprendere come si è passati
dalle esplosioni cosmiche iniziali al
neonato. Cercherò qui di ridurre
all'essenziale ciò che i lettori del
mio precedente libro già conoscono, e
condensare in poche pagine ricerche
estremamente complesse. Dalla nuvola
cosmica al neonato L'energia
iniziale, che continua a far muovere
tutto ciò che avviene intorno a noi
(e anche dentro di noi), sembra
risalire
a dodici-quindici miliardi di anni
fa. Oltre quella data le nostre
conoscenze attuali non ci consentono
di spingerci. A quell'epoca, si
ritiene, esisteva una massa d'energia
superdensa, con temperature
dell'ordine di miliardi di gradi, che
esplose, provocando la formazione di
una grande nube di idrogeno.
All'interno della nube cominciarono a
formarsi condensazioni di atomi che
si scontravano violentemente a
livello di elettroni e di protoni,
dando luogo alla formazione di atomi
di elio. Presero origine in questo
modo le prime condensazioni di tipo
stellare. In questi crogiuoli, per
successiva fusione, si formarono
tutti gli altri elementi chimici.
Dall'idrogeno (1 elettrone) all'elio
(2 elettroni) al carbonio (4
elettroni) e via via a tutti gli
altri elementi, vi fu un progressivo
« montaggio » a livello cosmico, con
la formazione di soli, pianeti,
galassie, corpi celesti di ogni tipo
che oggi ancora si trovano in fasi «
evolutive » diverse, e che continuano
a volar via nello spazio a velocità
vertiginosa dopo l'esplo-sione
iniziate, il cosiddetto «Big Bang».
L'energia che si trova oggi nel Sole,
e che ci scalda e ci illumina ogni
giorno, che fa crescere le piante con
le quali ci cibiamo (direttamente, o
indirettamente attraverso gli
animali), quest'energia risale sempre
all'esplosione iniziale di
dodiciquindici miliardi d'anni fa,
che come una gigantesca tempesta
elettromagnetica continua ancora ad
agire in tutto il cosmo e in ogni
atomo. Quando la Terra si formò,
circa 4 miliardi e mezzo di anni fa,
l'atmosfera primitiva terrestre fu
sottoposta a un bombardamento di
energia solare (calore, radiazioni,
parti-celle) che attraverso una serie
di reazioni chimiche (ripeti-bili in
laboratorio) diedero origine a
quantità sterminate di molecole
organiche di varia complessità. Nel
« brodo » iniziale (dì dimensioni
oceaniche) cominciarono a quel punto
a svilupparsi in maggior numero le
molecole capaci di « stampare » copie
di se stesse (appaiandosi
spontaneamente con materiali forniti
dall'ambiente circostante). E
qui apparve il meccanismo che doveva
costituire la chiave di tutta
l'evoluzione successiva: la
replicazione errata. Infatti la
replicazione di una molecola poteva
dar origine a errori, ad agganci
sbagliati, o a mutazioni dovute
all'azione di agenti esterni
(sostanze chimiche, radiazioni).
Questi « errori » creavano così
molecole sempre nuove e diverse : se
per caso uno di questi « difetti » di
fabbricazione risultava più efficace
per sfruttare l'ambiente circostante
e replicarsi più facilmente, la
molecola « difettosa » veniva allora
a trovarsi in una situazione di
vantaggio. Cominciava così la
selezione (intuita da Darwin nel
secolo scorso) che attraverso una
interminabile serie di « errori »,
premiati o puniti dall'ambiente,
faceva sì che le strutture più adatte
si affermassero e si replicassero,
trasformandosi poi pian piano in ciò
che noi intendiamo di solito con
vita, cioè strutture estremamente
efficaci, in grado di rispondere alle
richieste e agli stimoli ambientali,
e in grado anche di immagazzinare
energia come un accumulatore. Questa
progressiva lotterìa biologica ha
portato dalle prime molecole alle
forme precellulari, ai
microorganismi, agli esseri
pluricellulari e infine all'uomo.
L'evoluzione: un montaggio sempre più
efficiente Tutto ciò significa, in
definitiva, che gli atomi che
compongono la materia vivente e la
materia non-vivente sono gli stessi.
La differenza consiste nella loro «
disposizione », nel modo in cui si
uniscono insieme a costituire le
molecole, e nel modo in cui le
molecole si legano tra loro. Di atomi
ne esistono in tutto un centinaio di
tipi diversi : in pratica i tipi più
diffusi in natura sono soltanto
qualche decina (ossigeno, idrogeno,
carbonio, azoto, fosforo, ferro,
calcio ecc). Partendo da questi «
elementi » semplici si può
teoricamente « montare » qualunque
cosa : bulloni, viti, o
DALL'ESPLOSIONE COSMICA...
L'ssplosionG cosmica di dodici
rni-liardi di anni fa diede origine,
per successive fusioni, ad atomi
sempre più complessi (1 elettrone =
idrogeno [H], 2 elettroni — elio [E],
4 elettroni - carbonio [C] ecc...)-
Questi diversi atomi, in continua
formazione nello spazio, si ritro-
vano oggi sparsi in tutto l'universo
e costituiscono gli elementi di base
della •• materia ». Galassie e
stelle, risultanti da condensazioni e
fusioni di questi atomi, continuano a
volare via nello spazio,
allontanandosi le une dalle altre
come schegge di una bomba.
Nel nostro Sole (che è una stella
di media età originatasi circa 6-7
miliardi di anni fa) le fusioni
atomiche avvengono oggi ancora,
sprigionando energia e calore
altissi-
La Terra, frammento spento (pianeta)
riceve energia dal Sole (luce,
calore, radiazioni); è questa ener-
cato ribolli- gia che ha - crescente
di molecole, le per agganci
successivi hanno dato origine
spontaneamente a ciò che noi
chiamiamo vita. Senza l'energia
solare la vita si fermerebbe, come
una giostra senza corrente.
...AL DNA...
• • ••*
y
• >-.•••A...
À \ 4
La grande quantità e diversità di
molecole organiche createsi nei
primardi della Terra (oceani interi)
permise « agganci » e forme sempre
più complesse.
La struttura molecolare più «
efficace », n£ha storia della vita,
si è dimostrata quella del DNA (a
doppia elica) che è alla base di ogni
forma vivente. La replicazione è
permessa dal fatto che ogni •• nastro
•> è complemenlare di quello con cui
è intrecciato.
Le strutture a doppia elica (DNA)
si trovano raggomitolate dentro ogni
cellula dj ogni organismo e
costituiscono i cromosomi (cioè il
patrimonio genetico). Segmenti dei
cromosomi, di lunghejza variabile,
vengono chiamati « geni ».
8
I cromosomi racchiusi nei nucleo di
ogni cellula "rispondono» alle
meccanismi biochimici estremamen-!e
complessi. A seconda della lunghezza
del filamento e della sequenza dei «
pezzi » queste struttura può dare
origine a una mosca, a una fragoia, a
un cammello oppure a un uomo.
...AL NEONATO | Per agganci e
mutazioni successivi selezionali
dall'ambiente si è cosi passati dalle
macromolecole agli esseri
unicellulari, da quelli
pluricellulari all'uomo. Gli «errori
di copia» continuano anche negli
esseri umani: si calcola che nella
popolazione mondiale avvengano da una
generazione all'altra da cento a
mille miliardi di « mutazioni ».
L'evoluzione, sebbene molto lenta,
non è finita.
un'automobile che funzioni.
Analogamente si possono montare
aminoacidi, proteine, o un uomo che
funzioni. Sono in corso prove
sperimentali per dimostrare come
questo « montaggio » che ha portato
alla vita sia avvenuto spontaneamente
sulla Terra, sotto l'azione
dell'energia solare. In laboratorio
si è a buon punto nel replicare
questa scala della vita partendo da
simulazioni di atmosfere primitive
(metano, vapore acqueo, idrogeno e
ammoniaca). Con un « ac-cendisigari »
biologico si pensa tra breve dì
ottenere il montaggio spontaneo di un
virus, che è già « vita » nella sua
definizione più semplice : cioè una
grande molecola (composta di proteina
e acido nucleico) in grado di
replicarsi. Naturalmente tutto il
cammino della vita, nella storia del
nostro pianeta, si è svolto per
gradi, lentamente. Però man mano che
si saliva la scala della complessità
molecolare vi è stata
un'accelerazione crescente : infatti
se i primi passi erano
statisticamente i più difficili da
compiere, in seguito il gioco delle
mutazioni avveniva su una trama molto
più ricca, e quindi capace di più
grandi e rapide diversificazioni. È
come quando si gioca a canasta: è
difficile « aprire », ma quando si ha
un gran mazzo di carte in mano le
combinazioni possibili diventano
sempre più ricche. L'evoluzione della
vita sulla Terra è stata in pratica
un continuo aumento della complessità
delle strutture, della loro
sensibilità agli stimoli e
dell'efficienza nell'utilizzare
energia. Tutto ciò consentiva di
sopravvivere meglio e di replicarsi
meglio. La struttura più efficace,
che sin dall'inizio si è affermata, è
quella degli acidi nucleici (RNA,
DNA), capaci di realizzare in modo
assai semplice la duplicazione
(replicando la struttura, lineare per
I'RNA, a doppia elica per il DNA). Il
DNA è l'elemento costitutivo dei
cromosomi, e si trova nel nucleo di
ognuna delle cellule: è in pratica
una lunghissima molecola filamentosa
che nella cellula umana comprende
circa un milione di segmenti (geni)
o, se preferite, un miliardo di
segmentini (nu-
cleotidi). Lungo questo filamento si
è accumulata, attraverso agganci,
errori o mutazioni, una struttura
molecolare sempre più complessa. Le
mutazioni favorevoli all'ambiente
sono state conservate, quelle
sfavorevoli eliminate. Ecco quindi
che ogni bambino (come ogni organismo
vivente) possiede alla nascita un suo
« albero genealogico » biochimico che
è stato costruito pezzo per pezzo nel
corso di miliardi di anni, e
rappresenta il risultato della
graduale trasformazione delle forme
più adatte a sopravvivere. Il «
migliore », in natura, è infatti
colui che sa riprodursi meglio e sa
assicurare meglio la sopravvivenza
della propria discendenza. (E ciò
mostra, sia detto per inciso, dove
affonda le sue radici la sessualità.)
Questo passaggio dalla nuvola cosmica
al neonato, pur senza entrare nei
dettagli, ci consente, in definitiva,
di trarre un certo numero di
conclusioni. La struttura « vitale »
di ogni individuo è in realtà una
catena di molecole, disposte in un
certo modo, capaci di rea
gire chimicamente con l'ambiente,
sotto l'azione dell'energia
solare; Questa catena conserva le
tracce di tutti i passaggi pre
cedenti, raccolti nel corso
dell'evoluzione, che oggi ancora
sono presenti e necessari al
mantenimento e alla replicazione
della struttura : sono quelli che noi
chiamiamo istinti; Ogni individuo ha
un suo diverso « numero di matri
cola », quindi una diversa
personalità biologica. È insomma
differente da tutti gli altri.
Reagisce in modo personale al
l'ambiente (così come una sostanza
chimica reagisce in modo
diverso a seconda della sua formula)
anche se, in pratica, i
membri di una stessa specie «
reagiscono » in modo assai si
mile ad uno stesso stimolo, poiché le
loro « formule » sono
analoghe. La ricerca scientifica,
insomma, ci mostra oggi chiaramente
che l'essere umano (come qualsiasi
altro organismo « vivente ») non
contiene alcuna « forza vitale », ma
soltan-
to un filamento di molecole (diverso
in ogni individuo) che reagisce ai
cambiamenti ambientali, così come una
rotaia può reagire al calore
allungandosi. La sterminata
complessità delle strutture «
agganciate » nel corso
dell'evoluzione, ha pian piano creato
(e tramandato per sdoppiamento)
macchine chi-miche sempre più
perfezionate, capaci di muoversi
grazie al « carburante solare », e
capaci anche di accumulare energia
autonoma (immagazzinata nelle
cellule). La « forza » che fa muovere
gli organismi, però, è sempre
d'origine esterna : senza questa
energia (che trae indirettamente
origine dall'esplo-sione cosmica
iniziale) tutto il ribollire di
molecole si spegnerebbe. Questo
schema, sia pure assai semplificato,
mostra chiaramente quale sia il ruolo
rispettivo dell'ereditarietà e
dell'ambiente, e quale importanza
abbiano le variazioni ambientali, che
« suonano » sulla tastiera genetica,
modulando le risposte. La nascita del
cervello Naturalmente possiamo
chiederci come si concretizzano, come
si « rivestono » queste strutture
molecolari, perché infatti ciò che
noi vediamo in un neonato sono degli
occhi, una testa, delle braccia, e
non una struttura molecolare. Come
avviene questo passaggio? E poi, come
mai la specie umana possiede un
cervello così sviluppato, capace di
prestazioni così complesse? E cosa vi
è di innato, alla nascita? Per capire
meglio certi meccanismi (complessi)
dell'essere umano è bene prima
osservare i meccanismi (più semplici,
ma basati sulle stesse leggi) degli
organismi unicellulari. Per esempio,
se osserviamo una cellula che si
sdoppia per dar origine a due
cellule, è facile intuire che queste
due cellule disporranno di tutte le
capacità della prima: sapranno
contrarsi allo stesso modo, saranno
in grado di assorbire certe sostanze
dall'ambiente (cioè di nutrirsi),
sapranno trasfor-
mare queste sostanze in « carburante
» e potranno venire « uccise » con lo
stesso prodotto chimico. Per un
neonato le cose vanno allo stesso
modo. Però nell'essere umano (ciò
vale del resto per tutti gli animali,
anche i più elementari), le cellule,
moltiplicandosi, non si sparpagliano,
ma restano unite insieme, come se
fossero trattenute in un involucro;
questo fa si che ogni cellula
(attraverso un complesso meccanismo
di « induzioni ») si « specializzi »
in un lavoro: a seconda del punto in
cui si trova, diventerà cellula delle
ossa, della pelle, del cervello e
della vescica. Avviene, nelle colonie
cellulari, ciò che accade in una
popolazione: a seconda del punto in
cui si trova, un individuo finisce
per diventare agricoltore, avvocato,
pescatore, o montanaro. Il nascituro,
nel corso dei nove mesi di
gravidanza, procede dunque a questa
moltiplicazione e specializzazione
delle sue cellule. Egli attraversa
varie fasi, che qualcuno considera
anche come una specie di «
ricapitolazione » della vita sulla
terra. L'ovulo fecondato, infatti,
inizialmente non ha bisogno di
ossigeno (le prime forme di vita
nacquero appunto in una atmosfera
priva di ossigeno); poi affondando le
sue radici nella placenta, diventa un
organismo pluricellulare con uno
schema elementare di circolazione
sanguigna; poi attraversa la fase del
pesce (con l'abbozzo persino delle
branchie...) e infine quella del
mammifero. Quando nasce, l'uomo è un
mammifero dal cervello
sproporzionatamente sviluppato. Ma
perché un numero così alto di cellule
(dieci miliardi) si specializzano in
funzioni cerebrali? La risposta,
ancora una volta, è da cercare nella
storia della vita. Come certi animali
hanno sviluppato nel corso
dell'evoluzione taluni organi o
caratteristiche idonee alla
sopravvivenza (il leone la forza,
l'antilope la velocità, il camaleonte
il mimetismo, l'uccello le ali),
analogamente nell'uomo, per
selezione, si sono rafforzate le
strutture cerebrali, che costi-
a reagire (e quindi un certo
modo. tuivano un valido strumento di
sopravvivenza. Il cervello, infatti,
è un organo che non serve per
azzannare, per correre, per volare,
ma ha il grande vantaggio di
accumulare memorie : la funzione
essenziale del cervello (nell'uomo
come nell'animale) è proprio quella
di memorizzare le esperienze, e
tenerne poi conto per il
comportamento successivo. Nell'uomo
la parte « memorizzante » del
cervello (la corteccia) si è
enormemente sviluppata nel corso
dell'evoluzione grazie alle lotterie
ereditarie che premiavano ad ogni
generazione i più « furbi » (cioè
facevano sopravvivere e moltiplicare
coloro che avevano un migliore
cervello). Quello che però occorre
tenere ben presente (ed è la chiave
per capire tutto lo sviluppo mentale
nel bambino) è che questa macchina
cerebrale nasce vuota di esperienze.
Essa possiede all'inizio una tastiera
istintiva, ereditata dalle gè-
Ciò da origine alla diversità dei
tessuti e degli organi, che sono forr
geneticamente uguali, ma variamente -
specializzate». nerazioni precedenti
(capace di fornire risposte
automatiche, simili a quelle che si
ottengono battendo con un martelletto
sul ginocchio : fame, sete, sesso,
sonno ecc), ma le sue esperienze di
vita sono inesistenti. Ciò significa
che il neonato possiede una parte
istintiva (che si trova nella zona
cosiddetta antica del cervello) e una
parte destinata a riempirsi di
memorie nel corso dell'esistenza: il
cervello è quindi uno strumento per
conoscere, accumulare esperienze,
elaborare dati, costruire
comportamenti, in una parola
sviluppare un'attività mentale. Ma è
evidente che questo strumento potrà
memorizzare unicamente le cose che
l'ambiente gli offrirà. Non solo, ma
a seconda del modo in cui le
conoscerà, le stesse esperienze
potranno lasciare una traccia
profonda oppure leggera, gradevole
oppure sgradevole, ed avere
significati diversi. Parleremo
lungamente in un prossimo capitolo di
questo meccanismo dell'apprendimento.
Per ora limitiamoci a osservare che
il neonato possiede alla nascita una
macchina biochimica capace di inter-
agire
con l'ambiente circostante; che
questa macchina contiene tutta una
serie di risposte automatiche; e che
la capacità innata del cervello di
memorizzare ha bisogno di essere
alimentata dalle esperienze, così
come il computer ha bisogno di esser
alimentato dalle schede, altrimenti,
malgrado tutta la sua capacità
potenziale, non potrebbe calcolare
neppure il conto della spesa. Le due
intelligenze Vorrei, a questo punto,
aprire una breve parentesi e chiarire
meglio un punto essenziale, che
potremmo quasi definire « la stella
polare » per orientarsi in biologia :
vale a dire la differenza tra ciò che
è innato e ciò che è acquisito. Se
non si afferra bene questo concetto è
poi diffìcile capire molti dei
meccanismi cerebrali. Vediamo perciò
di fare qualche esempio pratico.
Quando un uomo e una donna si
uniscono per dar nascita a un figlio,
essi congiungono due delle loro
cellule « germinali » : uno
spermatozoo e un ovulo. Com'è noto
gli spermatozoi compiono una lunga
corsa a ostacoli per raggiungere
l'ovulo, lo stringono d'assedio e uno
solo penetra all'interno,
fecondandolo. Come è parimenti noto,
queste due cellule iniziali (ovulo e
spermatozoo) sono diverse da tutte le
altre del corpo per una
caratteristica unica: posseggono solo
ventitré cromosomi, anziché
quarantasei. Unendosi insieme,
ricostituiscono una cellula con
quarantasei cromosomi, che si
raddoppierà in due, quattro, otto,
sedici, trentadue cellule, e così via
per dare origine a un organismo
completo. Quello che si sa meno è che
gli spermatozoi non sono tutti
uguali; infatti, come un individuo
che estrae 23 libri da uno scaffale
che ne contiene 46 può prendere il 1
", il 3", il 4", oppure il 2", il 6",
l'8" eco., allo stesso modo i 23
cromosomi contenuti in uno
spermatozoo non sono uguali a
quelli di un altro spermatozoo: si
calcola che gli spermato-zoi di un
individuo possono essere diversi in
otto milioni di modi. Lo stesso
discorso vale per l'ovulo femminile.
A conti fatti, si pensa che, tenuto
conto delle varie combinazioni, un
figlio che nasce da due genitori è
estratto a sorte tra miliardi di
miliardi di figli possibili, tutti
diversi uno dall'altro. Senza entrare
nel complicato meccanismo dei
cosiddetti caratteri dominanti e
recessivi, bastano queste cifre per
mostrare la sterminata gamma di
possibilità, e capire perché due
fratelli possono essere assai diversi
tra loro. Detto questo, è però
evidente che molte caratteristiche
riappaiono chiaramente da una
generazione all'altra, proprio perché
il ceppo genetico è comune. Per
esempio una coppia alta, magra,
bionda, occhi celesti, pelle chiara,
trasmetterà buona parte di questi
caratteri ai figli. Ora, supponiamo
che due ragazzi, nati in due famiglie
diverse, abbiano ereditato certe
caratteristiche: immaginiamo, per
esempio, che uno sia mingherlino,
senza grandi qualità fisiche e che
l'altro invece sia dotato di grandi
polmoni, corporatura atletica, cuore
fortissimo. Se il mingherlino dispone
di una piscina e può allenarsi nelle
gare di nuoto, batterà l'atleta che,
non avendo avuto la possibilità di
allenarsi, si reggerà a malapena a
galla. Il problema dell'intelligenza
è tutto qui. Intelligenti si nasce
(così come si nasce con grandi
polmoni) : ma intelligenti si diventa
(così come il mingherlino può battere
l'atleta). Che cosa vuoi dire questo,
in pratica? Vuoi dire che
l'intelligenza di un individuo
dipende sempre da due fattori : i
cromosomi (che determinano per
esempio la buona qualità delle
cellule nervose, l'efficienza
elettrica nella trasmissione degli
impulsi, un buon sistema chimico per
il fissaggio delle memorie, una buona
irrorazione sanguigna del cervello o
di certe sue parti); e l'ambiente
(che offre « piscine culturali »,
cioè la possibilità di sviluppare le
capacità innate, di esercitarsi, di
imparare, di arricchirsi di
esperienze).
Lo spermatozoo che riesce a penetrare
nell'ovulo forma nuovamente una
cellula con 46 cromosomi, che per
sdoppiamenti successivi darà origine
a un nuo- per metà paterno e per metà
materno.
si tra loro, cosi come la metà di
un mazzo di carte può contenere
giochi sempre diversi. Si è calcolato
che, tenendo conto di tutte le
combinazioni possibili, due genitori
potrebbero generare, teoricamente,
migliaia di miliardi di figli, tutti
diversi uno dall'altro.
Tra le varie combinazioni, vi è
quella de! sesso. Come è ben noto se
nell'ovulo penetra uno spermatozoo
con il cosiddetto cromosoma Y nascerà
un maschio, in caso contrario (cioè
X) una femmina (XX = femmina, XY -
maschio), É dunque l'uomo a
determinare il sesso del nascituro?
Sarebbe una risposta troppo semplice:
si potrebbe anche dire che è l'ovulo
a « scegliere" fra i tanti
pretendenti quello che più gli
aggrada.. Vi sono quindi due tipi di
intelligenza che coabitano e si
fondono in uno stesso individuo, con
tutta una gamma di possibilità che
dipendono dal seme trasmesso dai
genitori e dalle opportunità offerte
dall'ambiente. Questa continua azione
combinata di eredità e ambiente è
alla base di tutto lo sviluppo umano,
e anche di tutta l'attività mentale
(lo vedremo diffusamente in seguito).
Per ora è bene avere ben chiaro
questa distinzione tra due tipi di
intelligenza, che permette di capire,
per esempio, perché il figlio di un
analfabeta può essere un genio (che a
causa dell'ambiente non potrà
sviluppare la sua intelligenza),
mentre il figlio di un laureato può
essere poco intelligente ma riuscire
comunque a prendere una laurea ed
apparire (e in pratica anche essere)
più intelligente del genio
analfabeta. A partire da questo
esempio si possono combinare a
piacere tutte le possibilità, e
divertirsi magari a situare, in
questa scala dell'intelligenza, i
propri amici (e soprattutto i propri
nemici).
// gene della pìgrizia Attualmente
sono in corso studi affascinanti per
cercar di identificare, nei
cromosomi, quei piccoli segmenti
(geni) che presiedono a certe qualità
mentali innate. Scendendo nell'in-
finitamente piccolo si cerca, cioè,
di trovare i « tasti » che regolano i
comportamenti eredìtari. Recentemente
negli Stati Uniti, con un colpo di
fortuna, si è riusciti a identificare
un gene che predispone a una forma di
depressione nervosa, trasmesso per
via femminile. E si è visto che tutti
gli individui che possiedono quel
certo gene sono esposti a crisi di
depressione nervosa. Si sa da tempo
che molti di questi piccoli segmenti
dei cromosomi possono essere uguali
negli animali e negli uomini : per
esempio il gene che presiede
all'albinismo è sempre lo stesso in
un gatto, in un topo o nell'uomo,
così pure quello che produce la
proteina contrattile, che permette ai
muscoli di ritrarsi (e quindi
muoversi). Si pensa che identificando
singoli geni di animali, si possa
lavorare su un « materiale biologico
» molto diffuso nelle forme viventi,
in grado di presiedere a funzioni
analoghe nelle varie specie, e quindi
anche nell'uomo. Di notevole
interesse sono gli studi condotti a
Roma al Consiglio Nazionale delle
Ricerche dal professor Alberto Oli-
verio, che in collaborazione con
ricercatori americani, ha potuto
localizzare nei topi due nuovi geni
che presiedono a certi comportamenti
ben precisi, come la « pigrizia »
oppure la tendenza a evitare una
punizione. Senza entrare nei dettagli
delle tecniche impiegate (diciamo,
per chi se ne intende, che è una
tecnica analoga a quella adottata da
Mendel coi piselli : sono state
esaminate varie generazioni di ceppi
puri, e attraverso incroci ramificati
si è potuta localizzare la posizione
del gene) vediamo che cosa si è
potuto osservare:
« I topi che possiedono il gene che
abbiamo chiamato AAL, Active
Avoidance Learning, » mi dice
Oliverio, « presentano tutti un
comportamento tipico : cioè imparano
a evitare le punizioni più
rapidamente degli altri. Se, per
esempio, vengono messi in una gabbia
in cui per sfuggire a una leggera
scossa elettrica debbono imparare un
certo esercizio, dopo poche prove
riescono già a evitare la punizione
mentre gli altri topi impiegano più
tempo. » « Si potrebbe dire che è già
una forma di intelligenza? » « In un
certo senso, sì. » « L'altro gene da
voi localizzato, e chiamato EXA
(Explo-ratory Activity) è stato
definito il gene della pìgrizia. Che
effetto produce sull'animale? » «
L'animale tende a essere meno attivo,
meno desideroso di muoversi e di
esplorare. Abbiamo potuto osservare,
per esempio, che se gli si mette a
disposizione una giostra a cilindro,
la fa girare con le zampette molto
meno degli altri topi. Così pure, se
è posto in una gabbia che comunica
con un'altra attraverso un tunnel,
non si sposta di frequente da una
gabbia all'altra. » « È già, questa,
una forma di conservatorismo! » « Si
potrebbe anche definire così, se
proprio si volesse estrapolare.
Aggiungo che questo comportamento non
sembra legato all'intelligenza
dell'animale. È però possibile che,
esplorando meno, egli abbia meno
occasioni di arricchirsi di nuove
informazioni ed esperienze. (Ma per
un topo ciò può anche costituire un
vantaggio, poiché essere meno curiosi
significa anche esporsi meno ai
pericoli e ai predatori.) » Questi
studi sono di particolare interesse
perché indicano che un solo gene può
già predisporre a certi comportamenti
chiaramente osservabili :
naturalmente, non bisogna dimenticare
che i geni operano in modo congiunto,
come i tasti di una tastiera per
formare la musica, o i colori di una
tavolozza per comporre un quadro, o
le bottiglie di un bar per comporre
un cocktail. È quindi evidente che le
combinazioni possibili
sono sterminate, soprattutto se si
tiene conto che la « tastiera » dei
geni è molto estesa : nell'uomo si
calcola che il corredo genetico sia
formato da circa un milione di geni,
cioè l'equivalente di un pianoforte
con una tastiera lunga sedici
chilometri (e diversa in ogni
individuo)... Anche l'intelligenza,
naturalmente, è una qualità che non
dipende dall'attività di un solo
gene, ma di parecchi : è una qualità
cosiddetta « poligenica », così come
lo è, ad esempio, la memoria (che è
una componente dell'intelligenza).
Era importante, mi pare, chiarire
questo aspetto genetico della nostra
personalità per mettere bene in
evidenza tre punti: Esiste un
substrato biologico dell'attività
mentale, che
è ereditario (nonostante si
ridistribuisca in modo sempre di
verso da una generazione all'altra);
questo substrato fornisce
la « potenzialità » e le «
predisposizioni » a comportarsi in
un certo modo piuttosto che in un
altro; Ciò mostra la grande diversità
tra gli individui, che è
una delle forze della natura, poiché
permette all'ambiente di
« selezionare » i più adatti
premiandoli con la sopravvivenza
(e quindi la riproduzione) e punendo
gli altri con la morte; Di tutto ciò
occorre tenere ben conto nell'educare
un
bambino: ogni bambino è un essere
unico, diverso da tutti gli
altri. Non è possibile, quindi,
definire regole uguali per tutti,
perché ognuno reagisce in modo
diverso. Il topo che porta il gene
AAL O quello che porta il gene EXA
non possono biologicamente essere
educati nello stesso modo perché sono
diversi; per compiere certi esercizi
hanno bisogno di un addestramento
differente. Che dire allora
dell'immensa diversità che esiste nel
comportamento umano? Occorre rendersi
conto che gli uomini (e i bambini)
non sono tutti uguali ma tutti
diversi, e che ogni educazione,
quindi, deve essere personalizzata.
Non si possono adottare le stesse
regole per tutti. In conclusione,
possiamo dire che le qualità mentali
di un indivìduo dipendono da due
fattori: l'eredità e l'ambiente.
LE DUE INTELLIGENZE
INTELLIGENZA INNATA INTELLIGENZA
ACQUISITA L'intelligenza innata,
come ogni altro carattere genetico,
si trova iscritta nei cromosomi. Fin
quando non sarà possibile modificare
il filamento di DNA (cioè i
cromosomi) ognuno dovrà tenersi la
macchina cerebrale che ha alla
nascita.
É possibile invece migliorare lo
«sviluppo » dell'intelligenza,
attraverso migliori stimoli
ambientali, cioè modificando il
cervello grazie alle memorie.
Solo modificando uno di questi due
fattori si può ottenere un diverso
risultato. Noi non possiamo (almeno
per ora) modificare i cromosomi,
dobbiamo tenerci quelli che abbiamo
(o che i nostri figli hanno), e
dobbiamo cercare di suonare della
buona musica con le tastiere che
madre natura ci ha dato. Il fattore
che invece può essere modificato è
l'ambiente: nell'uomo, infatti,
l'educazione ha un ruolo
preponderante, grazie alla grande
quantità di cellule cerebrali che «
elaborano » le informazioni (mentre
nell'animale le modeste capacità di
« elaborazione » fanno sì che
l'eredità genetica svolga un ruolo
prevalente, e rappresenti la
componente più forte nella « spinta »
del comportamento. Questa importanza
dell 'ambiente nello sviluppo mentale
dell'uomo (e il fatto che le
condizioni ambientali possono es-
sere modificate a volontà), inducono
a rivolgere tutta la nostra
attenzione a questo aspetto del
problema. In quasi tutto il libro,
perciò, metteremo l'accento
sull'ambiente, proprio perché è il
solo modo in cui noi possiamo agire
per migliorare il comportamento,
l'intelligenza, la creatività del
bambino. Nelle grandi linee il
discorso che faremo può essere valido
per tutti, poiché i meccanismi di
base sono gli stessi, malgrado le
diversità individuali. Occorrerà però
sempre tenere presente che ogni
individuo è geneticamente differente,
e che questa diversità va cercata,
capita e aiutata attraverso
un'educazione personalizzata che
cerchi di mettere in valore le
qualità che un bambino ha, e non
quelle che si vorrebbe che avesse.
L'intelligenza nel feto Dopo questo
rapido, ma necessario, giro
d'orizzonte sui meccanismi che hanno
portato all'origine della vita e
dell'intelligenza, vediamo ora di
esaminare più attentamente il
cervello del neonato. Intanto, come
prende forma questo cervello durante
la gravidanza? Inizialmente sulla
superficie dell'embrione viene a
organizzarsi una piccola placca, che
a mano a mano si arrotola fino a
formare una specie di tubo che poi si
immerge nel corpo primitivo
dell'embrione. Da questo tubo e dalle
cellule che gli si sono associate si
sviluppano propaggini che si diramano
alla periferia (analogamente a quanto
avviene per il sistema circolatorio,
o per le radici di una pianta). Altre
propaggini si collegano tra loro
costituendo una rete nervosa sempre
più fitta. Sembra che nel costruire
questa rete, i neuroni (cellule
nervose) mostrino delle vere e
proprie « simpatie » o « antipatie »
verso certi gruppi di cellule o
tessuti periferici. Un sistema, non
ancora completamente chiarito, di «
induzione » fa sì
Siene che lo particolare, I ) -
con l'ambiente. Il suo cervello è
sensibile alle con-idano. e che
possono influenzarne la graduale
costru-lutrizione può compromettere
l'intelligenza del bambino.
che, sviluppandosi, le propaggini
trovino esattamente la loro strada e,
poste di fronte a scelte diverse,
sappiano sempre trovare la via
giusta, cioè la corretta struttura da
raggiungere. La madre non si accorge
di questa straordinaria fioritura
nervosa che avviene spontaneamente
nel suo grembo; tutto si svolge a sua
insaputa e senza il suo intervento.
Il cervello si sviluppa in base a un
programma automatico, come un fiore,
stimolato dall'ambiente nutritivo che
lo circonda, e alla nascita il
bambino presenterà un certo tipo di
rete nervosa che sarà il risultato
del programma contenuto nell'eredità
paterna e materna.
È evidente che tutto quanto può
interferire, durante la gravidanza,
in questa delicatissima costruzione
del cervello, finirà per lasciare una
traccia indelebile nel suo sviluppo.
L'« ambiente », non bisogna
dimenticarlo, comincia già nel grembo
materno. Vi sono in proposito
osservazioni molto significative per
quanto riguarda la nutrizione. Una
cattiva alimentazione della madre
(grave insufficienza di proteine,
come latte, uova, carne) provoca
infatti nel feto un minore sviluppo
delle cellule cerebrali. Il professor
Za-menhof, dell'Università di
California, Los Angeles, mi ha
mostrato i suoi studi sui topi che
confermano appunto come una dieta
carente provochi la nascita di topini
con meno neuroni. Ciò sembra accadere
anche con bambini sotto-alimentati :
tra essi si riscontra un'alta
percentuale di ritardati mentali.
Questi studi mostrano che il feto non
è, come spesso si pensa, un «
parassita », capace di procurarsi
tutto quanto gli occorre a spese
della madre, ma anch'egli può
soffrire della malnutrizione materna:
vive cioè « in parallelo » con
l'ambiente. 11 feto, insomma,
comincia già a « conoscere »
l'ambiente in cui vive attraverso il
sangue della madre. Diversi studi
sono in corso, e si è notato per
esempio, che i figli di fumatrici
pesano meno (secondo un ricercatore
inglese hanno anche più difficoltà
nella lettura a scuola). Un'altra
ricerca interessante che si muove
sulla stessa linea è quella
dell'ossigenazione del feto,
applicata già su larga scala nella
clinica dell'Università di
Witswaterand, in Sud Africa : nel
caso che la madre soffra di disturbi
circolatori, sembra possibile fornire
al nascituro tutto l'ossigeno
necessario attraverso la
decompressione del ventre e il
richiamo di sangue verso la placenta.
Su queste ricerche mancano ancora
dati statistici sicuri, ed è
difficile valutare in quale misura il
successivo sviluppo mentale possa
essere favorito dall'ossigeno oppure
danneggiato dal fumo, così come lo è
dalla carenza di proteine. È certo,
però, che un gran numero di sostanze
possono in-
fluenzare, in modo determinante, lo
sviluppo cerebrale del feto,
modificando non soltanto la sua
intelligenza, ma anche il suo
comportamento da adulto. I polli del
professor Eiduson, di cui ora
parleremo, ne sono un esempio. //
pollo svogliato Per illustrare le
ricerche che sta compiendo il
professor Eiduson al Brain Institute
dell'Università di California, Los
Angeles, ricorriamo a un esempio
semplice. Supponiamo di versare un
bidone d'acqua in un secchio
attraverso un grande imbuto.
L'operazione richiederà, per esempio,
un minuto. Poi ripetiamo l'operazione
ostruendo in parte l'imbuto con le
dita. Nel secchio, all'inizio,
l'acqua arriverà più lentamente, ma
se dopo pochi secondi toglieremo le
dita lasciando di nuovo libero il
passaggio, l'acqua comincerà a
scendere con più forza, smaltendo
anche quella che si era accumulata
nel cono dell'imbuto, e l'intera
operazione potrà ugualmente essere
compiuta in un minuto. Il professor
Eiduson ha compiuto qualcosa di
analogo coi cervelli di pollo. Egli
ha dapprima misurato come aumentano,
in condizioni normali, certe sostanze
biochimiche presenti nel loro
cervello, dalla fase embrionale
all'età adulta. Poi, su altri
embrioni di pollo, ha provato a
ritardare la formazione di queste
sostanze, iniettando certi prodotti
inibitori. Comparando i « livelli »
di crescita, egli ha osservato che,
come nei secchi, all'inizio i livelli
aumentavano in modo diverso, ma poi,
cessato l'effetto inibitore, il punto
d'arrivo finale era lo stesso. In
altre parole il cervello « recuperava
» nella seconda fase ciò che non
aveva sviluppato nella prima. I
polli, però, messi in condizione di
apprendimento, si comportavano in
modo molto differente.
rarrte la fase embrionale) i
richiesti. el loro sviluppo
biochimico o. Il pollo B (« trattato
>• du- meno volentieri gli esercizi
(Eiduson)
« Nei polli sottoposti a trattamento,
» mi ha detto il pro-fessor Eiduson,
« il livello di intelligenza appare
simile a quello degli altri, però
essi non riescono a compiere un
esercizio, se richiede troppo
impegno. » « Cioè, quello che è
accaduto nella prima fase della vita,
lascia un'impronta permanente da
adulti? » « Sì, la differenza nel
loro comportamento va appunto
ricercata nella storia dello sviluppo
cerebrale. Solo apparentemente essi
sono uguali agli altri polli; in
realtà quell'esperienza precoce ha
provocato modificazioni a livello
molecolare con effetti permanenti
anche nella loro vita adulta. » Altri
esperimenti, condotti su topi dal
professor G. Tom-kins alla School of
Medicine dell'Università di San
Francisco, mostrano che anche un
comportamento fondamentale, com'è
quello sessuale, può essere invertito
se si interviene all'età fetale. «
Abbiamo iniettato in feti di topi
maschi ormoni femminili, » mi ha
detto Tomkins, « provocando
l'inversione del loro comportamento
sessuale in modo permanente per il
resto
della vita. Se lo stesso trattamento
con ormoni viene fatto su un topo che
ha già raggiunto l'età adulta, ciò
non accade : più precoce è
l'intervento, più evidente è il
risultato. » Per rendere ancor più
chiaro questo concetto si potrebbe
fare un esempio che tutti conoscono,
quello drammatico del thalidomide: il
thalidomide era un farmaco che non
aveva conseguenze nocive sugli
adulti, però impediva lo sviluppo
normale dei nascituri, che
diventavano focomelici. Vedremo in
seguito che anche esperienze
culturali negative nella prima
infanzia possono avere, in un certo
senso, un effetto analogo sul bambino
: possono impedire lo sviluppo delle
sue capacità mentali, e farne così un
focomelico dell'intelligenza. /
iviliardai'i poveri Prima di chiudere
questo capitolo (necessariamente un
po' tecnico, ma spero abbastanza
chiaro) possiamo ancora chiederci
qual è il vero e proprio meccanismo
biologico in base al quale, nelle
prime fasi della vita, certi
avvenimenti possono modificare
profondamente le strutture fisiche o
mentali. Per capire tale meccanismo
(fondamentale) vediamo brevemente
come avviene lo sviluppo umano, a
partire dall'ovulo fecondato.
Facciamo ancora un esempio semplice.
Supponiamo che un cuoco abbia a
disposizione una cucina ben
attrezzata con frigoriferi, fornelli,
forni, girarrosti ecc. Egli sarà in
grado, grazie a un vasto ricettario,
di preparare arrosti, gelati, pizze,
e un'infinità di altre cose. Questa
cucina potrebbe essere paragonata
alla cellula fecondata iniziale, che
grazie alle sue ricette (codificate
nel DNA, cioè i geni) è in grado di
fabbricare qualsiasi « piatto »
(proteine) richiesto dall'ambiente.
In quella fase si dice che la cellula
è « totipotente » cioè può, in
teoria, sviluppare tutte le sue
capacità.
Supponiamo ora che il nostro cuoco
cominci a aprire delle filiali, e che
queste a loro volta aprano altre
succursali un po' ovunque nel paese.
A seconda delle richieste ambientali,
queste «cucine» iniziali si
diversificheranno: alcune
cominceranno a specializzarsi in
pizze, e diverranno pizzerie, alire
in dolci e diventeranno pasticcerie,
altre ancora finiranno per diventare
gelaterie, o ristoranti tipici o café
chantant. Tutte conserveranno il «
ricettario » iniziale della casa
madre, ma non saranno più in grado di
rispondere alle varie richieste : la
gelateria non potrà più fornire
arrosti, né la pasticceria pizze. In
termini biologici questo si chiama «
inattivazione genetica ». Ogni
cellula, cioè, conserva sempre il
patrimonio genetico iniziale, ma
attraverso le « filiazioni » solo
alcuni geni vengono utilizzati, a
seconda delle richieste
dell'ambiente, e questa
specializzazione finisce per dare
certe caratteristiche a ogni tipo di
cellula, rendendo « inattivi » molti
geni. 11 professor Tomkins studia
questo fondamentale meccanismo della
vita. « Effettivamente si può dire
che nella cellula vi è, all'inizio,
una capacità completa di esprimersi,
ma via via che si specializza, questa
capacità diminuisce e l'espressione
diviene limitata. » « Si potrebbe
dire che la specializzazione che
avviene tra le cellule dell'embrione
in sviluppo è già una forma di <
apprendimento > (cioè ogni cellula
nel corso dello sviluppo impara a
comportarsi e a reagire di fronte
alla richiesta dell'ambiente), e che
questa capacità di adattarsi (e
quindi di < imparare >) diminuisce
praticamente già a partire dalla
fecondazione? » « Sì, è un modo
interessante di interpretare il
fenomeno. Naturalmente bisogna tener
presente che nel ciclo vitale vi sono
periodi più aperti di altri; una
cellula potrebbe essere in grado di
imparare in momenti successivi. Ma è
vero, in linea di massima, che vi è
una diminuzione di questa capacità di
risposta. Certi programmi sono
disponibili solo per determinati
•i L'ovulo fecondato, sdoppiandosi
in 2, 4, 8. 16 cellule ecc, da inizio
a un prò- ' cesso di specializzazione
che porterà alla nascita di un essere
completo. Ogni cellula, pur
mantenendo nel suo nucleo lo stesso
patrimonio genetico iniziale.
riconvertirsi.
le cellule contengono nel lorc nucleo
gli stessi geni: ma ognu1 un certo
lavoro, diventando cel del istallir
della palpebra o delle ciglia.
Nessuna sarebbe capace di
riconvertirsi per svolgere un altro
lavoro. La « totipotenza » iniziale
va perduta con la specializzazione.
logo per quanto riguarda lo sviluppo
mentale: la totipotenza che esiste
alla •• specializzare >• in
intelligenza o in ritardo mentale: e
sarà sempre più difficile
riconvertirsi.
periodi. In altre parole, ciò che
accade nella prima fase della vita
può lasciare una impronta permanente
e persino modificare un tipo di
comportamento innato. » Ciò che
accade nelle cellule, insomma, è
molto simile a ciò che accade agli
individui: ogni individuo si sviluppa
in modo diverso a seconda
dell'ambiente che lo circonda. Le
condizioni ambientali lo « inducono »
a specializzarsi in un certo lavoro,
a sviluppare certe qualità (fisiche o
mentali), lasciandone atrofizzare
altre. In questo senso sì può dire
che l'evoluzione cellulare
dell'embrione prefigura quella del
neonato che diventa uomo: vi è una
specializzazione progressiva (e
praticamente irreversibile) che per
ritocchi successivi plasma un
individuo. Un individuo, come una
cellula, tende ad adattarsi alle
richieste ambientali, e ogni « scelta
» che compie lo porta a diventare
sempre più diverso e sempre meno «
recuperabile ». La sua « totipotenza
» iniziale lascia il posto a una
progressiva specializzazione. Ci si
può « specializzare » in
intelligenza, o in ritardo mentale.
Dipende dalle strade che si
imboccano. Miliardario dei cervello
alla nascita, un bambino si può
ritrovare povero intellettualmente al
momento dell'ingresso nella scuola,
perché l'ambiente non ha saputo
amministrare e stimolare l'immenso
patrimonio che era in lui. Tutti gli
studi in corso mostrano che nei primi
anni di vita vi è una vera e propria
base biologica che rende l'infanzia
un periodo estremamente importante
per l'uomo. Non è quindi più
possibile relegare questi argomenti
nel compartimento « Scienze Naturali
», e continuare a ignorarne le
conseguenze nel campo
dell'educazione, dell'organizzazione
sociale e anche delle stesse scelte
politiche. La differenza tra
l'animale e l'uomo è data proprio
dalle differenze che esistono nelle
loro strutture cerebrali, e nella
capacità di accumulare e organizzare
le informazioni : sarebbe davvero
assurdo spendere tante energie e
risorse in altri
settori e trascurare l'investimento
più importante e redditizio, quello
sul cervello. In agricoltura si
cercano in continuazione nuovi metodi
per coltivare, irrigare,
fertilizzare, al fine di ottenere
messi più abbondanti e di migliore
qualità: anche per sviluppare le
qualità mentali ora disponiamo di un
« inaffiatoio » capace di fornire al
seme dell'intelligenza tutto il
nutrimento ambientale di cui ha
bisogno. Non usarlo significa
rinunciare a far crescere la pianta
più preziosa del nostro giardino, I
primi anni, ormai vi sono le prove
scientifiche, sono quelli che contano
per stimolare la costruzione della
macchina cerebrale e darle
un'impronta che potrà valere per il
resto della vita. Vediamo ora, in
pratica, come ciò avviene.
Alla nascita il bambino possiede
solo riflessi istintivi: il suo
cervello è vuoto di idee, Sarà
l'ambiente a fare di lui un
intellettuale o un cosiddetto ••
bambino-lupo ».
Il • I PRIMI PASSI DEL CERVELLO Un
computer senza schede II bebé, ora, è
nato (speriamo nel migliore dei
modi). Alla nascita egli si trova,
mentalmente, all'età della pietra.
Migliaia di anni di storia, di
battaglie, di invenzioni, d'arte, di
cultura non hanno lasciato traccia
alcuna nel suo cervello. Ogni volta
tutta l'avventura umana ricomincia da
capo; ogni volta nasce l'uomo delle
caverne. Anzi, molto meno. Il neonato
è un adorabile aggregato molecolare,
capace soltanto di riflessi istintivi
che scattano in serie, come quello di
respirare, tossire, gridare,
succhiare, afferrare (automatismi
analoghi a quelli che regolano il
battito cardiaco, la secrezione
gastrica, le funzioni intestinali
ecc). Per il resto zero. Egli ha
indubbiamente una « personalità »
genetica data dall'unicità dei suoi
cromosomi, diversi da quelli di
qualsiasi altro individuo. Non vi
sono due uomini uguali (così come non
vi sono due mucche o due polli o due
asparagi uguali), tranne nel caso dei
veri gemelli. Questo patrimonio
genetico contiene quindi (lo abbiamo
visto nel capitolo precedente) tutte
le « potenzialità » mentali di un
individuo, le sue predisposizioni
personali ad avere un certo
temperamento, una certa intelligenza,
o certe qualità e talenti, allo
stesso modo in cui una calcolatrice
di cassa potenzialmente ha la
capacità di calcolare il costo di tre
panini e due birre, oppure un
computer ha la capacità di calcolare
la velocità di fuga di una galassia.
Ma perché ciò avvenga occorre che la
cassiera batta le cifre, o che
l'astronomo inserisca i programmi di
calcolo: altrimenti si ha un bello
scuotere le due macchine, non ne
uscirà niente. Senza informazioni
dall'ambiente esse sono vuote, non
contengono in alcuno dei loro
meccanismi il conto dei panini né la
velocità di fuga delle galassie. Ecco
perché la cultura (che è fatta di
memorie) non può trasmettersi di
padre in figlio a livello di
cromosomi. Ogni bambino che nasce è
vergine (così come uscendo dalla
fabbrica un rullino fotografico è
vergine, e non contiene ancora alcuna
immagine) : se venisse lasciato in
un'incubatrice, al buio e senza
suoni, sarebbe meno di un animale,
non potrebbe esprimere nulla. Può
essere interessante riassumere qui in
poche righe, che cosa pensa del
neonato il professor J. Delgado.
dell'Università di Yale, noto per i
suoi studi sulla stimolazione
elettrica del cervello (cfr. « Toward
a Psychocivilized Society »):
L'intelletto non esiste al momento
della nascita; L'intelletto non può
nascere in assenza di percezioni
sensorie; Il carattere e il
comportamento di ogni uomo non sono
proprietà che si sviluppano da sole,
ma sono funzioni che deb
bono essere apprese, e che quindi
dipendono in gran parte
dalla ricezione di impulsi sensori;
Il fine dell'educazione non è la
rivelazione di funzioni
mentali, bensì la loro creazione, la
loro genesi; I simboli che provengono
dall'ambiente vengono fìsica-
mente integrati nel cervello, sotto
forma di modifiche moleco
lari della struttura dei neuroni;
L'uomo non nasce libero, ma è
condizionato dai geni e
dall'educazione. Non c'è male, come
demolizione di tanti miti. Anche se
detto un po' crudamente è proprio in
questo modo che il neonato si
presenta alla vita.
Egli ha in sé grandi potenzialità
mentali, ma senza l'ambiente sarebbe
come una macchina IBM appena uscita
dal cellofane dell'imballaggio, piena
di circuiti raffinatissimi ma
incapace di dare una qualunque
risposta a un quesito poiché ancora
vuota di « memorie ». L'urte dì
adattarsi L'esempio del calcolatore,
utilizzato spesso per meglio
comprendere per analogia certi
concetti, non deve naturalmente
spingersi troppo in là: vi è infatti
una differenza fondamentale tra il
computer e il cervello (a parte il
fatto che sarebbe più giusto
attribuire un ruolo di computer a
ognuno dei dieci miliardi di neuroni
che lo compongono). La vera
differenza è che il cervello è una
macchina biologica, che si « adatta »
ogni volta alle circostanze. È una
macchina che si modella
sull'ambiente, continua cioè a
comportarsi nella vita come ha fatto
durante lo sviluppo embrionale. In
questo senso il cervello è molto più
simile a una pianta, o a una radice
che pian piano si sviluppa là dove il
terreno è fertile e si atrofizza dove
mancano i sali e l'acqua. È appunto
un sistema premio-punizione, che
induce il nostro cervello a
trasformarsi in continuazione
codificando in certi tracciati le
memorie delle sue esperienze, «
mettendo in forma » le informazioni
(come dice il biologo francese H.
Laborit). È evidente l'importanza che
riveste, in questa costruzione
graduale, il primo periodo della
vita, poiché è proprio all'inizio che
si definiscono certi tracciati di
base, che si « attivano »
geneticamente le potenzialità del
cervello. Non bisogna, tra l'altro,
dimenticare che nei primi anni di
vita il cervello, come tutti gli
altri organi, cresce enormemente in
volume. Il grafico di p. 48 mostra
che dalla nascita ai dieci anni il
peso del cervello aumenta di sei o
sette
ime sviluppo gr. 120 Aumento del
volume cerebrale durante l'infami
volte : durante le varie fasi tutto
può influenzare e orientare lo
sviluppo di questa sensibilissima
macchina cerebrale. Infatti dal punto
di vista dello sviluppo nervoso il
neonato è ancora, parzialmente, un
feto: la sua costruzione cerebrale,
cioè, non è stata interamente
completata nel grembo materno. Alla
nascita sono pronti i sistemi che
controllano la vita vegetativa, i
battiti cardiaci, il respiro, le
funzioni intestinali, ma per molte
altre cose il cervello non è ancora
pronto, deve completare la sua
costruzione biochimica. Questo fa
dire allo psicologo americano J.
Kagan (ma non tutti sono d'accordo su
questo punto) che certi processi
cognitivi nel bambino sono in parte
legati alla crescita nervosa, nel
senso che non possono avvenire quando
la macchina nervosa non è ancora
pronta; e anche certe funzioni sono
controllate dalla graduale
maturazione del cervello. È certo,
comunque, che questo periodo
dell'infanzia è il più aperto, il più
disponibile a tutti gli stimoli.
Secondo molti ricercatori una lunga
infanzia, com'è quella dell'uomo,
sarebbe un vantaggio genetico che
consentirebbe alla costruzione
cerebrale di essere influenzata e
arricchita per un tempo assai lungo.
Insomma l'apparente debolezza del
periodo infantile sarebbe in realtà
un ulteriore vantaggio della specie
umana, poiché favorisce
l'accumulazione delle esperienze
precoci e la trasmissione della
cultura, grazie alla prolungata vita
coi genitori.
/ topini massaggiati Sulla
straordinaria capacità che ha un
organismo giovane di adattarsi
all'ambiente esistono numerosi studi.
« Noi abbiamo fatto alcuni
esperimenti abbastanza sorprendenti,
» mi ha detto il professor
Dennenberg, dell'Università del
Connecticut, dipartimento delle
Scienze del comportamento. « Se, per
esempio, prendiamo dei topini appena
nati, li togliamo dalla gabbia, li <
massaggiamo > per alcuni minuti e
infine li rimettiamo in gabbia,
questo avvenimento apparentemente
trascurabile può avere conseguenze
notevoli : i topini < massaggiati >
diventeranno, da adulti, più curiosi,
meno emotivi, più adattabili. » « Una
cosa del genere, può valere anche per
gli esseri umani? » « Penso proprio
di sì. Sono stati fatti studi su
gemelli prematuri messi in
incubatrici, sottoponendo uno dei
neonati a stimoli supplementari e
lasciando invece l'altro in
condizioni < normali >. Si è potuto
constatare che all'età di quattro
mesi il gemello sottoposto a stimoli
presentava una grande diversità nella
capacità di imparare. Penso che si
tratti di esperimenti assai probanti.
» Questi esperimenti, condotti dal
dottor Lipsitt, alla Brown University
(New York), consistevano
nell'estrarre il prematuro dalla
incubatrice per soli dieci minuti al
giorno (per dieci giorni
consecutivi), toccandolo,
parlandogli, coccolandolo,
offrendogli cioè quegli stimoli
materni che solitamente un neonato
riceve, e di cui sono privati invece
i bimbi prematuri, « isolati »
appunto nelle loro « isolettes ». «
Questa piccola quantità di stimoli, »
dice Lipsitt, « fa sentire i suoi
effetti anche a mesi di distanza, e
si può supporre che si tratti di
un'impronta permanente. « Vi è poi un
altro aspetto importante in questi
esperimenti, » egli afferma. «
Infatti, i neonati prematuri sono
solitamente più esposti degli altri a
danni cerebrali : oggi si pensa
che la causa possa anche essere
ricondotta a circostanze ambientali.
Si può formulare quindi l'ipotesi che
certi danni derivino proprio
dall'isolamento sensoriale in cui
essi sono tenuti nel primo periodo
della vita. » II microbiologo Rene
Dubos, dell'Istituto Rockefeller a
New York, ha compiuto dal canto suo
studi sull'influenza che possono
avere sul futuro dell'individuo le
malattie nella prima infanzia. Egli è
giunto alla conclusione che esiste
una specie di « freudismo biologico
»; cioè certe caratteristiche
biologi-che vengono orientate sin dal
primo periodo di vita a seconda delle
esperienze ambientali. Dubos afferma
che si tratta di un'orma
incancellabile. Sperimentalmente lo
si può dimostrare contagiando dei
topini con certi batteri : pur
guarendo completamente essi non
potranno più raggiungere il peso
degli altri topini, in età adulta, e
saranno meno resistenti.
Inversamente, alcuni ricercatori si
chiedono se non sia possibile
migliorare le difese immunitarie
attraverso leggeri stimoli precoci.
« Vi sono ricerche in questa
direzione, » mi ha detto Den-nenberg.
« Naturalmente non sappiamo fino a
che punto questi piccoli choc possano
giovare all'organismo. Si è scoperto,
per esempio, che in certe tribù
primitive moderati stress in età
precoce possono provocare un aumento
nell'altezza: analogamente, quando
noi < massaggiamo > i topi,
osserviamo un aumento del loro peso
nell'età adulta. Si è anche osservato
che questi animali manipolati
diventano da adulti più resistenti
alle malattie, e persino al virus del
cancro. » In questo primo periodo dì
vita l'organismo sì adatta dunque
rapidamente a ogni situazione,
sviluppando le qualità sollecitate
dall'ambiente. In pratica è la
risposta flessibile a un problema di
sopravvivenza. Le conseguenze, buone
o cattive, si faranno sentire poi per
tutta la vita, dal momento che è
stata presa una certa direzione
piuttosto che un'altra. In proposito
sono estremamente interessanti le
osservazio-
ni fatte sulla malnutrizione nel
primo periodo di vita. La
malnutrizione è un esempio di come
l'organismo si adatti rapidamente a
ogni situazione, e le regole che
valgono per lo stomaco, in tema di
adattamento, valgono anche per il
cervello, nel senso che la
denutrizione fisica mette in moto
meccanismi analoghi a quelli della
denutrizione culturale. Il
sottosviluppo fisico, di cui ora
parleremo, permette di capire molti
problemi dello sviluppo (e anche del
sottosviluppo) mentale. L'effetto
frenante della malnutrizione La
malnutrizione è un campo in cui,
putroppo, non mancano le occasioni di
compiere osservazioni direttamente
sugli esseri umani. Non c'è bisogno
di ricorrere ai soliti topini di
laboratorio, basta andare in una
parte qualsiasi del mondo (e in
particolare del terzo mondo) per
trovare materia prima in abbondanza.
Nell'America centrale esistono centri
di ricerca tra i più aggiornati, in
particolare in Messico e in
Guatemala. È qui che mi sono recato,
per incontrare alcuni tra i più
autorevoli esperti del settore,
cominciando dal professor J.
Cravioto, dell'Ospedale Infantile di
Città del Messico. Il professor
Cravioto sta compiendo
un'interessante ricerca in una
cittadina di diverse migliaia di
abitanti, a tre ore d'auto dalla
capitale : è una cittadina che sono
stato pregato di non nominare per non
interferire con gli studi in corso.
Da molti anni vengono qui eseguiti
misurazioni e tests su tutti i
bambini, dalla nascita in poi,
annotando le differenze
riscontrabili, soprattutto per quanto
riguarda il diverso ambiente
d'origine familiare e sociale. Le
madri portano periodicamente i loro
figli in un ambulatorio, e un'equipe
di medici e psicologi annota
minuziosamente tutto quello che può
essere rilevato. Senza entrare troppo
nei dettagli di questi studi, basterà
una
EFFETTI DELLA MALNUTRIZIONE Queste
due bambine, nate con lo stesso peso,
all'età di tre anni presentano
notevoli differenze nello sviluppo:
la bambina di destra, che ha sofferto
di malnutrizione, é più piccola di
circa dieci centimetri. Una volta
adulta il suo organismo sarà più
vulnerabile, (Da una foto del
professor Cravioto.) fotografia
(ridisegnata qui sopra), a dare una
chiara idea di quali possono essere
gli effetti della malnutrizione. «
Questi due bambini, » dice il
professor Cravioto, « avevano alla
nascita lo stesso peso e dimensioni,
ma all'età di tre anni la loro
differenza in statura è enorme.
Abbiamo re-
gistrato molti casi analoghi, e la
differenza va di solito da 7 a 10
centimetri. Noti bene che il più
piccolo non è un bambino che ha fame,
però il tipo di alimentazione ha
influito sul suo sviluppo fisico :
egli si è < adattato > sviluppandosi
meno. Non è un bambino macilento,
dall'aria denutrita : apparentemente
è sano, ma i danni sono più subdoli,
ne è la prova il fatto che è meno
resistente alle malattie, e quindi
più vulnerabile. « Nelle bambine la
malnutrizione provoca anche un altro
effetto collaterale: non
sviluppandosi sufficientemente esse
avranno una gravidanza e un parto
assai più diffìcili, con alti indici
di mortalità. » « Che cosa si intende
per malnutrizione, dal punto di vista
medico? » « Questo è un punto
interessante, perché noi distinguiamo
tra vari tipi di malnutrizione, assai
diversi tra loro. « II tipo più
diffuso, naturalmente, di cui soffre
gran parte degli individui sulla
terra, in varia misura, è quello
dovuto alla limitata disponibilità di
cibo, in particolare proteine: si
tratta cioè di un problema sociale,
non medico, e la sua soluzione non
può essere che politica. « In altri
casi, invece, la malnutrizione si
verifica anche quando c'è
disponibilità di cibo, ma vi è un
rapporto sbagliato tra madre e
figlio. Nelle nostre indagini
condotte in varie classi sociali
abbiamo potuto osservare che questo
tipo di malnutrizione non risulta
automaticamente dal reddito
familiare, o dalle condizioni in cui
vive il bambino, e neanche
dall'istruzione dei genitori : vi è
piuttosto, alla base, un'incapacità
della madre di interpretare le
esigenze del bambino. È una
privazione di significati, dovuti a
un rapporto sbagliato. » II professor
Chavez, a Città del Messico, studia
questo rapporto sbagliato, che si
stabilisce tra madre e figlio già nel
periodo dell'allattamento. « II
meccanismo solitamente è questo, »
spiega Chavez, « la madre non produce
abbastanza latte, il bambino piange,
la madre gli offre nuovamente il
seno, e così di seguito. Ben
presto il neonato si accorge di non
poter ottenere di più, e così dorme,
riduce l'attività, perde l'appetito e
tutto il suo sviluppo ne risente. «
Ne seguirà un rallentamento fisico,
che diventerà poi mentale e in
seguito anche sociale. È una spirale
tragica che tende a perpetuarsi
attraverso una serie di
concatenazioni ambientali : infatti,
quando una bambina che si trova in
queste condizioni diventerà a sua
volta madre, disporrà di meno latte
per nutrire il suo piccolo
(soprattutto tra il terzo e il sesto
mese, che è l'età critica) e disporrà
anche di minori capacità culturali
per interpretare le necessità del
bambino. » Naturalmente i vostri
figli non corrono questo pericolo,
anche se Chavez mi diceva che casi di
malnutrizione inconsapevole si sono
verificati in ogni classe sociale, e
persino nelle famiglie di alcuni re.
Ma questi studi, oltre a modificare
radicalmente certe idee sulla fame e
sul sottosviluppo, ci permettono
anche di vedere chiaramente come il
bambino, sin dal primissimo periodo
di vita, imposti in modo permanente
il suo rapporto biologico con
l'ambiente. Un'ulteriore prova ce la
fornisce un esperimento « rovesciato
» realizzato in Guatemala; un
esperimento che ai nostri occhi può
apparire un po' crudele, ma che è
considerato di eccezionale interesse
dagli esperti. La zuppa che fa
crescere In Guatemala, come in altre
parti del mondo, la malnutrizione è
un fatto quasi endemico, e i
ricercatori dell'lNCAP (l'Istituto
per la Nutrizione dell'America
centrale e Panama) non hanno dovuto
faticare troppo per trovare una serie
di villaggi indios sui quali
effettuare i loro studi. Sono stati
scelti quattro villaggi : in due di
essi sono stati distribuiti
quotidianamente ai bambini (sin dalla
nascita) cibi
più nutrienti, negli altri due invece
si è lasciata immutata
l'alimentazione tradizionale.
Osservazioni periodiche sono in corso
da quasi sei anni, per misurare le
differenze che questa diversa dieta
può provocare nello sviluppo. « I
bambini che beneficiano di questa
dieta migliorata sono circa seicento,
» mi ha spiegato il professor R.
Klein che dirige la ricerca. « II
cibo supplementare che noi
distribuiamo è molto semplice e poco
costoso, consiste in una zuppa fatta
con cereali locali di alto contenuto
proteico. La razione è di due tazze
al giorno, in aggiunta
all'alimentazione tradizionale. «
Ebbene, questo modesto cambiamento
provoca conseguenze sorprendenti: i
bambini, che generalmente sono di
piccola statura, diventano alti come
gli europei o gli americani. Ciò
mostra, tra l'altro, che la bassa
statura degli indios non è soltanto
un fattore genetico, ereditario, ma è
dovuto in gran parte alla cattiva
nutrizione nei primi anni di vita. »
Anche in questo caso, quindi, l'«
adattamento » iniziale dell'organismo
è determinante : sviluppo e
sottosviluppo fisico vengono « messi
in moto » da una esperienza precoce.
Ciò che vale per le cellule del corpo
vale anche per quelle del cervello:
nella prima parte della vita
qualsiasi avvenimento può far sì che
le cellule si adattino, si plasmino e
siano pronte a prendere una certa
direzione piuttosto che un'altra, a
ricevere un'impronta che varrà poi
per il resto della vita. Il cervello,
cioè, è pronto in teoria a incamerare
una massa enorme di informazioni e di
esperienze, ma se l'ambiente non
glieli offre accadrà come per la
denutrizione: il cervello si adatterà
a questa situazione di carenza,
perderà l'appetito di imparare (cioè
la curiosità), la capacità di
prestare attenzione, e ne conseguirà
un rallentamento mentale.
Teoricamente uno stesso neonato,
insomma, allevato in due ambienti
estremamente diversi, può diventare
un intellettuale o può diventare (con
scarse possibilità di recupero) un
cosiddetto « bambino-lupo ».
/ bambini-lupo Esiste una numerosa
casistica di bambini cresciuti in
condizione di isolamento spinto: il
caso più celebre è quello del ragazzo
trovato nel secolo scorso nei boschi
dell'Aveyron, in Francia. 11 bambino,
cresciuto allo stato selvaggio,
correva a quattro zampe e viveva in
tane scavate nella terra. Sul suo
caso esiste un rapporto dettagliato
di un istitutore che cercò
inutilmente di rieducarlo : la «
direzione » presa dal suo sviluppo
mentale lo aveva portato a un «
adattamento » ormai irreversibile.
Altri casi di bambini cresciuti in
condizioni analoghe (bambini-orso,
bambini-gazzella) sono stati
segnalati in passato: le osservazioni
fatte sul loro comportamento indicano
che, tornati alla vita « normale »,
questi ragazzi sono incapaci di
recuperare la distanza cerebrale che
li divide dal nostro mondo. Malgrado
i progressi che possono compiere, una
lacuna insormontabile sembra impedire
il loro recupero (più che di «
recupero » occorrerebbe però parlare
di salto mentale). Da molti anni non
si registrano casi di bambini
ritrovati nei boschi, ma di tanto in
tanto si ha notizia di bambini
cresciuti in isolamento molto spinto:
è il caso di due gemelli negri, che
vivevano abbandonati dalla madre in
una stanzetta alla periferia di
Boston. Il professor Peter Wolff,
dell'Università di Harvard, me ne ha
raccontato la storia. « Questi due
gemelli praticamente erano cresciuti
da soli, quasi senza cure materne :
la madre (separata dal marito) era
quasi sempre fuori casa, si occupava
pochissimo di loro. A volte sì
assentava per due o tre giorni,
lasciando ai bambini solo il cibo per
nutrirsi. Quando intervenne la
magistratura, essi vennero ricoverati
nel nostro istituto. Al momento del
ricovero avevano due anni e mezzo, ma
non sapevano ancora camminare, si
spostavano a quattro zampe. Se
qualcuno
Due gemelli ritrovati a Boston
all'età di due anni e mezzo,
praticamente vissuti senza madre,
erano incapaci d a sca più grave:
malgrado cin sforzi gli educatori
hano potuto rimediare solo in parte
alla enza materna iniziale (Da un
tilm del protessor Wolff ) si
avvicinava, strillavano e mordevano,
sembravano proprio degli animaletti.
« È bene precisare che questi bambini
non erano dei minorati; tuttavia,
quando li abbiamo esaminati il loro
elettroencefalogramma assomigliava a
quello di un bebé di sei mesi. « È
cominciata così l'opera di
rieducazione, affidata a personale
specializzato. Tutti i loro progressi
sono stati seguiti e annotati. «
Abbiamo potuto constatare che molto
rapidamente essi hanno recuperato
certe capacità, anche se imparare a
camminare ha richiesto qualche tempo.
« Le attività mentali, invece sono
state assai più lente; solo dopo
quattro anni e mezzo sono entrati in
possesso di un linguaggio utile.
Ancora oggi, a sette anni, hanno un
vocabolario limitato, e non riescono
a scrivere o a leggere bene. » « Non
presentano, dal punto di vista
medico, lesioni neurologiche? » « No,
oggi il loro elettroencefalogramma è
normale. Il recupero del ritardo,
sotto questo punto di vista è
completo, almeno in apparenza, ma
sono bambini molto arretrati,
rispetto agli altri, anche nella
socializzazione : penso che non
potranno mai essere normali. « La <
deprivazione > di cui hanno sofferto
nei primi due anni e mezzo di vita
avrà effetti permanenti', e avrebbe
potuto essere ancor peggio se,
anziché di gemelli, si fosse trattato
di un bambino cresciuto solo. » Tutte
queste osservazioni fatte sui bambini
cresciuti in isolamento (che è poi,
in definitiva, un isolamento
culturale) dimostrano che certe idee
sullo sviluppo « naturale » del
bambino, dal quale sboccerebbe il «
se stesso » innato, sono molto
lontane dalla realtà. Anche Robinson
Crusoè, se fosse naufragato
sull'isola in tenera età, sarebbe
diventato poco più di un animale a
quattro zampe. Alla nascita ogni
bambino, in un certo senso, è un «
bambino-lupo », che viene
gradualmente stimolato a salire nella
scala della conoscenza dalle persone
che ha intorno. Una carenza culturale
(come pure una carenza alimentare)
nella prima fase della vita crea un
adattamento sempre più difficile da
modificare, perché le ramificazioni
all'inizio si divaricano rapidamente,
e il bambino che a scuola viene a
trovarsi a diretto confronto con gli
altri non ha più un margine
sufficiente di « accelerazione
biologica » per recuperare il
ritardo. Il suo « adattamento »
iniziale lo porta ad essere un «
disadattato » al mondo della scuola.
Questo meccanismo (visto qui nel caso
estremo dei barn-
bini-lupo) vale naturalmente a tutti
i livelli. Viene perciò da chiedersi
: chi di noi riesce davvero a
sfruttare pienamente il potenziale
mentale che possiede, in teoria, fin
dalla nascita? La risposta è,
naturalmente, che siamo tutti un po'
deprivati, nel senso che non abbiamo
sviluppato tutto il patrimonio, tutte
le ricchezze mentali che possedevamo
quando siamo venuti al mondo. Il
livello medio culturale, nelle
società, è salito gradualmente
dall'età della pietra a oggi e
continuerà a salire. La «normalità »,
quindi, non è altro che una normale
deprivazione. O, se preferite, la
media delle occasioni perdute. Un
pacchetto che accumula memorie Ma
fino a che punto l'ambiente può
modificare le capacità cerebrali?
Diversi ricercatori lavorano in
questo campo, che si presenta assai
difficile proprio perché mancano
punti di riferimento: troppo poco si
sa ancora delle vere potenzialità del
cervello. Naturalmente non è
possibile effettuare esperimenti di
laboratorio sull'uomo, ma
sull'animale varie ricerche sono in
corso: esse permettono di confermare
(e anche di misurare) la relazione
diretta che esiste tra stimoli
ambientali e arricchimento del
cervello. In questo campo vi sono
studi ormai classici come quelli
effettuati dal professor Rosenzweig,
all'Università di Berke-ley in
California. Confrontando al
microscopio cervelli di topi allevati
in diverse condizioni ambientali egli
ha infatti scoperto evidenti
differenze nella biochimica cerebrale
e nello sviluppo delle ramificazioni
delle cellule nervose. Ciò significa
che il cervello si trasforma ogni
volta che noi apprendiamo qualcosa.
La memoria, cioè, non è una specie di
nuvoletta che aleggia nel cervello,
ma il risultato di modifica-
zioni materiali delle cellule
nervose, che si trasformano in
seguito al passaggio ripetuto di
stimoli, così come si trasformano le
fibre muscolari in un atleta. Queste
tracce (che sono già « memorie » allo
stadio più semplice) funzionano in
pratica come « scambi » o « semafori
» per i circuiti nervosi, e
costruiscono via via tracciati
cerebrali sempre più ricchi.
Riprenderemo il discorso su questo
punto nel capitolo dedicato
all'apprendimento: per ora
limitiamoci a prender nota che il
cervello è un organo in continua
trasformazione, in continuo
adattamento. Questa parte «
memorizzante » (la corteccia,
estremamente sviluppata nell'uomo)
non agisce autonomamente, ma agisce
in simbiosi con la parte « antica »
del cervello, dove trovano sede gli
istinti elementari di sopravvivenza.
Dall'azione combinata di queste
diverse zone del cervello nasce il
comportamento; gli istinti primitivi
e le emozioni premono sulla parte «
memorizzante » (dando luogo
all'apprendimento) e ne rimangono poi
influenzate a loro volta (attraverso
l'educazione). Il cervello si
presenta insomma come un pacchetto
sensibilissimo a tutti gli stimoli,
capace di reagire accumulando memorie
e restituendo comportamenti. È una
straordinaria macchina che più è
attivata più risponde, attraverso «
adattamenti » agli stimoli
ambientali. Sono questi stimoli che
finiscono per condizionare tutto il
suo sviluppo. Vergine mentalmente
alla nascita, il bambino offre la sua
pagina bianca all'azione culturale,
affettiva, psicologica della madre.
Vorrei qui precisare (e del resto è
un concetto che apparirà subito
chiaro nel prossimo capitolo) che la
parola « madre », naturalmente, va
intesa in senso lato: nel nostro
discorso (che riguarda il neonato)
essa indica la persona, o le persone,
che allevano il bambino, cioè
eventualmente la madre adottiva, la
zia, i nonni (o il padre,
naturalmente). In pratica, però, sì
sa che questo ruolo è quasi sempre
svolto dalla madre, che nei primi tre
anni di vita rappresenta la vera
figura centrale (e presente)
nell'educazione quotidiana. È lei che
fa emergere il bambino dal profondo
buio mentale in cui si trova : è lei
che, dopo la nascita fìsica, lo fa
nascere una seconda volta,
psichicamente. Ed è quindi a questa
figura materna che noi ci riferiremo
costantemente.
Specchiandosi nella madre il
bambino inizia, piai tale, grazie a
un continuo scambio nei due sensi.
Ili • MADRE E FIGLIO Una partita a
tennis Dopo tutto quanto abbiamo
visto nei primi due capitoli, appare
ora con evidenza lampante che il
rapporto tra madre e figlio va molto
al di là di ciò che noi chiamiamo
affetto o educazione. La madre è
chiamata a svolgere un ruolo
estremamente più vasto nello sviluppo
mentale del bambino: è come una
lampada solare che permette la
crescita molecolare della sua
intelligenza. Così come una pianta
nasce con un certo programma di
sviluppo innato, ed è l'ambiente,
l'umidità, la temperatura a
condizionarne la crescita, allo
stesso modo un neonato, che ha un suo
programma di sviluppo congenito, ha
bisogno di trovare un ambiente capace
di stimolare le sue qualità mentali,
che si ramificano in tutta la
meravigliosa diversità permessa dal
sistema nervoso: percezione,
apprendimento, linguaggio, socialità,
affettività. Questo sviluppo richiede
un continuo scambio nei due sensi : è
una costruzione che cresce grazie al
concatenarsi progressivo di stimoli e
reazioni, di domande e di risposte.
Fin dal primo giorno di vita, quindi,
madre e figlio giocano una partita a
due. La madre è, per così dire, una
tennista : ogni volta risponde ai
lanci, rimanda la palla, e permette
alle « potenzialità » del piccolo di
esprimersi. Una madre che manchi a
questo ruolo di partner finirà per
atrofizzare lo sviluppo del bambino;
il bambino, cioè, si scoraggerà se
nessuno risponderà alle sue aperture
e si adatterà rapidamente a questa
situazione. Abbiamo visto che un
rapporto sbagliato con la madre può
portare alla denutrizione da
adattamento e a un mancato sviluppo
della statura; può portare
addirittura all'incapacità di
camminare e di parlare, come nel caso
dei due gemelli cresciuti in
isolamento. Un meccanismo analogo è
alla base di tutto lo sviluppo del
sistema nervoso, cioè delle capacità
mentali, degli affetti, della
socialità, e in definitiva del
comportamento. Sono rami diversi di
uno stesso sviluppo progressivo che
comincia dal primo contatto, dalla
prima carezza della madre che
trasmette sensazioni di tatto, dì
movimento, di temperatura. Proprio
attraverso questo contatto sensoriale
si stabilisce il primo rapporto
fondamentale tra la madre e il
bambino. Le madri artificiali
Esperimenti ormai celebri sono stati
condotti dal professor Harlow,
dell'Università del Wisconsin, su
animali privati della presenza della
madre fin dalla nascita: essi hanno
rapidamente identificato la madre in
un fantoccio capace di soddisfare,
sia pure in parte, la loro necessità
di un contatto fisico rassicurante.
Questo contatto fisico è risultato
persino più determinante, dal punto
di vista affettivo, dello stesso
allattamento. Il professor Harlow ha
potuto constatarlo facendo entrare
una scimmietta nata da pochi giorni
(e subito privata della madre) in una
gabbia in cui si trovavano due
fantocci, uno dì stoffa e l'altro di
fil di ferro ma fornito di biberon.
La scimmietta succhiava il biberon,
poi correva ad abbracciare la « madre
» di stoffa, con la quale passava
tutta la giornata.
Privata della madre, una scim-
mietta identifica la propria « madre
>• in un fantoccio il contatto fisico
è risultato essere più importante
dello stesso allattamento.
Altre scimmiette, private anche del
fantoccio, hanno identificato la
madre con uno straccio morbido; la
sottrazione di questo straccio
rappresentava una vera separazione
affettiva, causa di grande dolore. È
dunque un vero e proprio legame
d'affetto che si stabilisce sin
dall'inizio tra un essere vivente e
una « cosa » capace di fornire certe
risposte fisiche (analoghe a quelle
che la madre sa dare nel modo più
completo). L'attaccamento della
scimmietta a una madre di stoffa non
viene indebolito da una lunga
separazione: una scimmietta che da
sei mesi non la vede corre subito
verso di lei, la abbraccia, e la
bacia. « Questo non è amore? » chiede
il professor Harlow. Questi
esperimenti con « sostituti materni »
mostrano in effetti che alla base di
un legame affettivo vi sono
inizialmente sensazioni fisiche; in
mancanza della madre queste possono
essere fornite da altre cose o
oggetti. All'Università di Davis, in
California, il professor W. Ma-son
sta appunto cercando di stabilire una
« scala » di sostituti materni,
partendo dai fantocci più semplici
per salire via
via a quelli più perfezionati, fino a
giungere a un « fantoccio » vivente:
quando sono andato a trovarlo,
infatti, egli aveva iniziato ad
allevare una scimmia neonata con una
cagnetta, che fungeva da « madre
artificiale ». Dallo straccio morbido
alla madre vera sembra esistere un
progressivo aumento dell'efficienza
del rapporto. Se non rischiassimo di
essere fraintesi, diremmo che la
madre vera è la più perfezionata
delle madri artificiali. Questo
spiega, del resto, perché una madre
adottiva può essere un'eccellente
mamma (anche migliore della vera). La
« voce del sangue » non esiste, sotto
questo punto di vista : il bambino
considera sua vera madre la persona
che gli è vicina nell'infanzia, che
alimenta ora per ora la sua
costruzione fisica e mentale. La
prima impressione Anche le ricerche
condotte sul rapporto tra madre e
figlio hanno mostrato che proprio in
questo primo periodo si costruisce un
legame affettivo stabile, poiché esso
viene a concatenarsi con certe «
risposte istintive » che ogni essere
vìvente possiede alla nascita. Se,
infatti, si pone una scimmietta in
totale isolamento affettivo, e solo
dopo tre mesi le si fornisce un
fantoccio di stoffa, essa non reagirà
più. Rimarrà in un angolo, tutta
tremante; è ormai tardi per lei, si è
« adattata » alla carenza materna
(come una pianta che ha ricevuto poca
acqua e poca luce) portandone però le
conseguenze nel suo sviluppo
affettivo. Questi studi si
riallacciano, del resto, alle
osservazioni fatte da molti etologi,
che confermano l'importanza delle
esperienze vissute nel primo periodo
di vita, durante il quale un essere
vìvente riceve un'impronta
fondamentale, o «imprinting», come si
dice in linguaggio tecnico. Negli
uccelli questa impronta è
particolarmente evidente :
in pochi minuti, dopo l'uscita
dall'uovo, essi imparano a
riconoscere la madre, e a non più
staccarsene : è il primo oggetto
mobile che vedono venendo al mondo.
In proposito è famosa la storia
dell'ochetta Manine, che considerò
come madre il professor Konrad
Lorenz, cioè il primo essere vivente
che si era occupato di lei alla
nascita. Esistono altri esempi, come
quello del pulcino che adottò come
madre un giocattolo a molla, o del
pavone che, cresciuto con delle
tartarughe, si innamorò di una di
esse e più tardi cercò anche di
accoppiarsi con lei. Tutti questi
esempi, e molti altri che riempiono
capitoli interi di etologia, mostrano
chiaramente che la madre non è tale
perché ha dato alla luce il figlio,
ma solo perché gli è vicina e lo
alleva. La vera maternità, dal punto
di vista affettivo, non è quella
biologica, ma quella psicologica. Il
piccolo non può provare un'attrazione
particolare per la madre biologica
(come del resto non prova
un'attrazione istintiva per il padre,
che pure gli ha fornito l'altra metà
dei cromosomi): il concepimento, la
gravidanza, il parto sono state le
varie tappe di una replicazione di
cui egli non conserva alcuna traccia
mentale (anche se hanno creato
affinità biologiche particolari).
L'affetto, l'attaccamento, l'amore
per una persona sono invece il
risultato di una costruzione mentale
progressiva, dovuta agli stimoli
delle esperienze ambientali. Questo
ruolo di « madre psicologica » può
svolgerlo chiunque, in maggiore o
minor misura, dal giocattolo a molla
al professor Lorenz, ad altri
sostituti viventi, capaci di
provocare un « parto affettivo »
precoce. 11 professor Harlow, per
esempio, ha provato ad allevare
scimmiette senza madre, soltanto in
compagnia di coetanei. Sembra che la
socializzazione, l'amicizia, possa in
parte compensare nella scimmia
l'assenza materna permettendole di
crescere senza quei sintomi che sono
tipici degli animali « deprivati ».
L'importante, per la costruzione
affettiva, è che gli stimo-
li giusti siano dati per tempo. Più
si tarda, più l'impronta iniziale
rimane difficile da cancellare. «
Alla base dello sviluppo sociale
dell'animale come dell'uomo, » mi
dice W. Mason, dell'Università di
Davis in Ca-lifornia, « c'è uno
scambio, un processo di dare e avere
: se ciò non avviene in tempo utile
l'animale si sviluppa in modo
incompleto e il suo comportamento ne
risente. Gli effetti possono essere
molteplici : per esempio da adulte le
scimmiette < deprivate > appaiono più
aggressive nei rapporti sociali,
hanno difficoltà nell'accoppiarsi, e
il loro comportamento materno è molto
scarso. » Sugli effetti della
privazione materna negli esseri
umani, osservazioni penose sono state
effettuate nei brefotrofi, dove a
volte i bambini vengono a trovarsi in
situazioni analoghe a quelle degli
esperimenti di laboratorio. //
cervello a dondolo In passato
numerosi studi sono stati condotti in
brefotrofi dove i bambini venivano «
assistiti » solo per quanto
riguardava l'alimentazione e il
ricambio dei pannolini, perché il
personale non aveva tempo di
occuparsi d'altro. Si è visto che i
piccoli, privati di una « maternità
psicologica » perdevano interesse per
l'ambiente circostante, cominciavano
a non giocare più, persino a non
piangere più. Da altre osservazioni,
effettuate una quindicina di anni fa
in un brefotrofio dell'Iran, risultò
che i bambini diventavano così
ritardati e apatici che più della
metà imparava a star seduta soltanto
all'età di due anni. La mancanza di
un contatto fisico « materno »
finisce per far sviluppare un
movimento sostitutivo, quello del
dondolio (cioè un reclinare avanti e
indietro del busto). « II dondolio, »
mi dice ancora il professor Mason, «
è un atteggiamento tipico del bambino
cui è mancata profonda-
mente la presenza della madre: è
infatti un comportamento che si
ritrova spesso tra i bambini piccoli
nei brefotrofi. Noi osserviamo la
stessa cosa tra le scimmie, e abbiamo
potuto constatare che alla base vi è
una mancanza di contatto materno, in
grado di rispondere alle esigenze di
movimento del piccolo. » Nel centro
dei primati, all'Università di Davis,
uno dei più grandi del mondo, il
professor Mason mi ha mostrato come
questa mancanza di movimento possa
far insorgere il dondolio. Egli ha
isolato in due diverse gabbie due
scimmiette fornendo loro lo stesso «
sostituto di madre », cioè un rozzo
simulacro di stoffa, piazzato su una
specie di altalena. In una gabbia
l'altalena era però inchiodata senza
possibilità di movimenti, nell'altra
era libera di muoversi. « Ebbene,
abbiamo potuto osservare che questa
piccola differenza provoca enormi
conseguenze : la prima scimmietta ha
sviluppato il tipico dondolio che
hanno anche i bimbi < deprivati), ed
è completamente rinchiusa in sé. Se
si tenta un
approccio si ritira, si rifugia
presso il simulacro della madre.
Invece l'altra scimmietta. che ha
potuto utilizzare l'altalena, non
presenta alcun dondolio del corpo, si
lascia avvicinare con più facilità, è
più curiosa. Anche per lei il
simulacro di stoffa è il punto di
riferimento, ma sembra che, grazie al
movimento, questo rapporto si sia
sviluppato meglio e le dia maggior
sicurezza nell'esplorare intorno. »
Senza voler estrapolare troppo,
esperimenti come questi mostrano
chiaramente che è partendo
inizialmente da esperienze sensoriali
come il movimento (o come il tatto,
la temperatura) che si stabilisce il
primo rapporto con la madre, un
rapporto che condizionerà, poi, anche
quello con l'ambiente. In altre
parole, occuparsi di un neonato,
parlargli, tenerlo in braccio, sono
gesti semplici e istintivi, ma molto
importanti per il piccolo. 1 danni
che si osservano in certi bambini
negli istituti di assistenza sembrano
dovuti non tanto alla mancanza della
mamma quanto alla carenza di
stimolazione. Essendo lo sviluppo una
catena di avvenimenti, un « montaggio
» di esperienze successive, la
mancanza di certi « pezzi » di base,
finisce per compromettere la crescita
armoniosa della costruzione. In
particolare, l'assenza di incentivi e
di risultati stimolanti fa sì che lo
sviluppo si atrofizzi, cosi come
avviene per l'organismo, per un
muscolo, per una cellula. // contagio
psicologico Ma in quale misura questa
« impronta » iniziale può modificare
una qualità tipicamente innata come
il carattere, il temperamento? La
risposta è qui assai sfumata, poiché
tocca una antica disputa sul
prevalere dell'ambiente o delle
qualità innate. Ma si tratta di una
contraddizione solo apparente, poiché
in realtà un comportamento è sempre
il frutto di queste due componenti:
l'eredità genetica e il
condizionamento ambientale.
C'è da notare, però, che una delle
due componenti (l'eredità genetica) è
fissa, mentre l'altra (l'ambiente) è
variabile. In altre parole, a un
individuo non si possono cambiare i
cromosomi (almeno per ora), mentre
gli si possono cambiare le condizioni
ambientali. Ciò significa che in
organismi superiori capaci di
accumulare memorie delle esperienze
ambientali (e quindi in misura
elevatissima nell'uomo) la parte
dovuta all'ambiente può essere
aumentata notevolmente, fino ad
amplificare certe risposte genetiche
a detrimento di altre. Detto in
parole più semplici, il carattere
della madre può influenzare
profondamente quello del suo piccolo,
anche se tendenzialmente è diverso
dal suo. Vi è cioè una specie di «
contagio psicologico » che può
stabilirsi sin dall'inizio.
Esperimenti su animali sono stati
effettuati al Dipartimento delle
Scienze del comportamento
dell'Università del Con-necticut, dal
professor Dennenberg. « Noi lavoriamo
qui con animali, » mi ha detto
Dennenberg, mostrandomi le gabbie, «
per vedere se, sostituendo sin dalla
nascita una madre aggressiva con una
calma, il carattere del piccolo si
modifica di conseguenza. Per questo
prendiamo topini dello stesso ceppo
genetico e li dividiamo ponendoli in
situazioni diverse; alcuni vengono
allevati dalla madre vera, di
temperamento molto aggressivo, altri
da una madre ratto, di temperamento
assai calmo. « In tutti gli
esperimenti effettuati abbiamo
scoperto che i piccoli prendono il
carattere di chi li alleva; cioè, il
carattere della madre influenza
l'aggressività dei figli una volta
adulti. Altre ricerche, effettuate in
altri laboratori, concordano con i
nostri dati : è possibile aumentare o
diminuire l'aggressività di un
soggetto a seconda del temperamento
della madre. » « Questo < contagio
psicologico > esiste anche per altri
caratteri? » « Sì, è possibile
modificare anche altri caratteri; per
esempio gli animali possono perdere
in parte la capacità di imparare un
certo tipo di risposta a uno stimolo.
»
La sequenza delle molecole nel DNA
(cioè nei cromosomi) determina tutte
le qualità « innate », anche quelle
relative al temperamento. Una
risposta biochimica più (o meno)
intensa a uno stimolo, determina un
comportamento diverso. « E queste
osservazioni fatte su animali,
possono essere estese anche all'uomo?
» « Sembra probabile, poiché gli
effetti che abbiamo osservato
agiscono in profondità e si
verificano vere e proprie
modificazioni, anche fisiologiche. »
Anche in questo caso si direbbe,
cioè, che intervengane « adattamenti
» biologici, nel senso che un diverso
ambiente sollecita una diversa
risposta genetica. Quello che noi
chiamiamo temperamento innato,
infatti, non è che il risultato di
una certa disposizione di molecole
nel filamento di DNA. Avere un
temperamento piuttosto che un altro,
significa avere una struttura
genetica (casuale) che risponde in un
modo piuttosto che in un altro a una
certa sollecitazione biochimica, così
come avviene per ogni altra
caratteristica dell'individuo, fisica
o mentale. Infatti la sequenza di
molecole nel DNA è all'origine del
tipo
di secrezione degli ormoni, della
qualità delle sostanze messe in
circolo nel sangue, del tipo di
collegamenti che si sono stabiliti
tra la corteccia e le zone profonde
del cervello, determinando così una
reazione personale, più o meno
intensa, di fronte a uno stimolo
ambientale (basti pensare
all'adrenalina prodotta dalle
ghiandole surrenali). Il «
temperamento » si basa su tutti
questi fattori, ed è evidente che
queste caratteristiche genetiche non
possono venire cancellate
dall'ambiente (così come nessun'altra
caratteristica genetica può essere
modificata); l'ambiente però può
influenzarle, stimolando certe «
risposte » piuttosto che certe altre
(è interessante citare in proposito
recenti osservazioni effettuate al
Centro di ricerca sui primati di
Yerkes, Atlanta, dal professor Irwin
Bernstein : si è notato che quando
una scimmia viene posta in una
situazione in cui può diventare un «
leader », nel suo sangue aumenta la
presenza di ormoni sessuali maschili,
e che inversamente la produzione di
questi ormoni diminuisce se una
scimmia-leader viene posta in
condizioni di sudditanza. Un
cambiamento ambientale psicologico,
cioè, modifica la biochimica degli
ormoni con conseguenze dirette sul
comportamento, il quale a sua volta
influenza la produzione di nuovi
ormoni ecc). Naturalmente il gioco
delle retro-azioni è molto complesso
ed è difficile stabilire in quale
misura le due componenti (quella
genetica e quella ambientale) non
soltanto agiscono nell'individuo, ma
inter-agiscono a vicenda. Per
esempio, un neonato che ha tendenza a
strillare in continuazione, o un
bambino che è più « musone » (che ha,
diciamolo in modo grossolano, più
difficoltà a « riassorbire » gli
ormoni messi in circolo da una
reazione aggressiva), ebbene questi
bambini non predispongono
favorevolmente la madre nei loro
confronti: tanto più se esiste un
paragone con altri fratelli. Ne segue
una concatenazione di avvenimenti,
che provocano una serie di
conseguenze psicologiche. Il rapporto
madre-figlio, insomma, è assai
complesso, per-
che, partendo da leggi di base
sostanzialmente semplici, si ramifica
in un intreccio sterminato di
combinazioni sempre diverse.
Tuttavia, pur con queste riserve,
appare chiaro che nel gioco a due la
madre, in pratica, contagia
fortemente il bambino dal punto di
vista psicologico, imprimendogli uno
stile di gioco che finisce per
amplificare o reprimere certe
tendenze innate. Ciò vale anche nel
rapporto con gli altri. // bambino e
gli altri Chi sono gli « altri »? Il
neonato non è in grado di distinguere
tra una madre vera e una madre
adottiva, tra la balia e la nonna,
tra un consanguineo e un non
consanguineo. Per lui è importante la
persona che è al centro del suo
sviluppo affettivo (e che,
naturalmente, si identifica quasi
sempre con la madre). La qualità del
« tennis » che pratica ogni giorno
con lei, prefigura la sua futura
capacità di giocare con gli altri. Il
suo volume di gioco e il suo stile
saranno influenzati dal tipo di
allenamento che avrà avuto con la
madre. Ciò è vero anche per la
capacità di amare. « Si impara ad
amare il prossimo, » mi ha detto il
professor Harlow all'Università del
Wisconsin, « amando la prima persona
che si incontra nella vita, cioè la
madre. Personalmente penso che questa
fase sia molto importante per lo
sviluppo del futuro comportamento
sociale di un individuo, e quindi dei
suoi rapporti con gli altri. E
ritengo molto difficile riparare i
guasti che colpiscono l'affettività
in questo primo periodo di vita. »
Già all'età di tre anni, infatti, le
differenze nei rapporti tra madri e
figli si riflettono visibilmente
anche nel comportamento dei bambini
verso gli estranei. Alla John Hopkins
University (Stati Uniti) una équipe
di
ricercatori ha studiato queste
differenze filmando di nascosto le
reazioni di vari tipi di bambini di
tre anni, posti di fronte a certe
situazioni. Per esempio, un bambino
entrava con la madre in una sala
d'attesa in cui vi erano dei
giocattoli. Subito egli si
interessava ai giochi, esplorava la
stanza. Veniva fatta allora entrare
una persona estranea : il bambino
istintivamente si avvicinava alla
madre, ma poco dopo accettava
l'invito dell'estranea a giocare
insieme. La madre, senza esser vista,
si allontanava, lasciando la borsa,
per segnalare una sua assenza
momentanea. Al suo rientro il bambino
mostrava un forte desiderio di
riunirsi a lei. Filmando vari tipi di
bambini nelle stesse circostanze, si
è osservato che quelli male
sviluppati affettivamente si
comportavano invece in modo diverso:
si interessavano meno
all'esplorazione della stanza,
avevano meno tendenza a giocare con
estranei, si mostravano più
indifferenti all'uscita della madre e
al suo rientro. I ricercatori della
John Hopkins University, analizzando
tutte queste differenze di
comportamento, ritengono che un buon
rapporto con la madre costituisca una
base affettiva solida che consente al
bambino di esplorare con sicurezza il
mondo circostante, e gli consente
quindi di sviluppare meglio la sua
capacità di imparare. Questo
atteggiamento gli permette anche di
avere un migliore rapporto col
prossimo, e costituisce già la base
del suo futuro comportamento nella
società. L'eccesso dì amore Si
innesta qui un discorso assai
delicato, che tocca un equilibrio
essenziale nello sviluppo del
bambino, cioè l'eccesso di amore
materno. L'amore materno, infatti,
non deve diventare possessivo,
sconfinando in quello che si chiama,
con una parola efficace, « mammismo
».
Le scimmie, istintivamente, evitano
il « mammismo ». Dopo un periodo di
amore totale, la madre » rifiuta »
dolcemente il figlio e lo spinge ad
allontanarsi da lei. Per poter
esplorare intorno a sé, il bambino
deve essere incoraggiato ad
allontanarsi gradualmente, ad
abbandonare la nicchia materna. Negli
animali questa spinta ad allontanare
il piccolo al momento giusto avviene
istintivamente, spesso addirittura in
modo brusco. Nella specie umana le
cose vanno a volte diversamente. Il
professor Harlow studia attualmente
in profondità questa evoluzione nel
rapporto tra madre e figlio, partendo
da osservazioni sul comportamento
degli animali. Egli ritiene che
esistano due fasi, in questo
rapporto. « Noi qui compiamo
osservazioni sulle scìmmie, » mi ha
detto, « ma pensiamo che siano valide
anche per la specie umana. Nella
prima fase la madre è tutta amore, si
tratta di un rapporto totale che
permette al piccolo di sviluppare
l'affettività basata sulla sicurezza
del contatto materno. Però, a un
certo punto, questo rapporto si
modifica e apparentemente quasi si
rovescia: cioè l'animale spinge il
piccolo ad allontanarsi, ad uscire
dal mondo materno. Questo avviene
perché un essere deve a un certo
momento spezzare il legame con la
madre, allontanarsi da lei ed entrare
nel mondo. « Noi pensiamo che a
questo punto sia estremamente
importante il rapporto con i
coetanei; il gioco è uno strumento
essenziale per lo sviluppo psichico,
così come lo è più tardi
l'accoppiamento sessuale. Nelle
scimmie abbiamo osservato che senza
giochi e accoppiamenti all'età giusta
lo sviluppo sociale e sessuale è
carente. » « A quale età avviene
questo passaggio? » « Nelle scimmie
verso i sei mesi, nella specie umana
verso i tre-quattro anni. È un
momento delicato, e non tutte le
donne sono capaci di adattarsi a
questo rifiuto. Certe madri non
riescono ad < allontanare > il figlio
per troppo amore; possono essere
buone madri nella prima fase e non
nella seconda. Per altre si verifica
l'inverso. « È una transizione che
comunque deve avvenire e che
rappresenta l'ingresso del piccolo
nel mondo. Egli continuerà a
costruire la sua personalità con i
materiali che l'ambiente gli offrirà:
è infatti solo entrando nel mondo,
che potrà continuare ad arricchirsi
di esperienze e svilupparsi in modo
più completo. » In altre parole si
potrebbe dire che a un certo punto la
madre diventa a sua volta
insufficiente per soddisfare le
esigenze del piccolo (così come lo è
un « sostituto » parziale), e deve
essere completata con una sorgente di
stimoli più allargata, quella fornita
appunto dai coetanei, dal mondo
esterno. La crescita mentale del
piccolo, permessa dal primo periodo
di vita, crea nuovi bisogni alla sua
macchina cerebrale; la madre deve
saper comprendere che questo graduale
allargamento degli interessi è una
esigenza naturale, necessaria allo
sviluppo della personalità del
bambino, e deve evitare di «
deprivarlo », per troppo amore.
Il doppio misto E il padre? Nel corso
del libro, per la verità, egli verrà
citato poco : faremo quasi sempre
riferimento alla figura materna. Ma
si tratta di un'assenza solo
apparente, poiché in realtà tutto il
discorso che faremo per la madre sarà
da considerare perfettamente valido
anche per il padre. Infatti, per
quanto riguarda i meccanismi
dell'affetto, dell'apprendimento,
della socializzazione, del
linguaggio, dello sviluppo
dell'intelligenza ecc. le regole sono
esattamente le stesse: il ruolo del
padre è analogo in ogni punto a
quello della madre. Anche lui è un «
tennista », che interviene (sia pure
molto meno spesso) nel gioco, e deve
quindi svolgere la sua parte
rispettando le stesse norme, mettendo
in moto gli stessi sistemi di
risposta e di « adattamento ». Questo
libro è quindi dedicato anche a lui.
La differenza, in questo « doppio
misto » familiare è costituita dalla
cosiddetta « figura paterna » : la
distribuzione delle parti, cioè, deve
tener conto di certe esigenze
psicologiche e fare in modo che il
padre sia chiaramente identificato
nel ruolo che gli compete, che è
generalmente quello del leader. Si
ritiene infatti che il bambino verso
l'ottavo mese, quando cioè comincia a
scoprire se stesso, scopra anche la
« figura paterna », una figura che in
seguito, nel corso dello sviluppo
psicologico, diventerà sempre più
importante sia come modello maschile
che come punto d'appoggio nei
confronti del mondo esterno. È bene
quindi che questo triangolo familiare
si disegni nettamente sin
dall'inizio, e che il bambino
consideri anche il padre, e non solo
la madre, una figura « presente ».
Solitamente il padre è poco coinvolto
nella prima fase dell'educazione :
persiste anzi la concezione errata
che egli debba entrare sul terreno di
gioco soprattutto a partire dal
momento in cui il bambino comincerà a
ragionare. La realtà è molto diversa,
ed è importante che egli partecipi
sin dal-
l'inizio a questa costruzione
cerebrale del figlio, per inserire
nel suo cervello quella parte di sé
che può già trasmettervi. Esistono,
evidentemente, problemi pratici: gli
orari del lavoro e quelli del bambino
il più delle volte non coincidono, e
il padre si trova praticamente ad
essere « assente » specialmente nella
prima fase dell'educazione. La madre,
però, può sopperire, almeno in parte,
a questa assenza creando intorno alla
figura paterna interesse e attesa. Un
« trucco » che suggeriscono gli
psicologi è quello racchiuso nella
formula « Lo chiederemo a papa questa
sera ». Questo spostare nel tempo una
risposta, oltre a essere per la madre
un comodo stratagemma per non dover
dire sempre « no » al bambino (tanto
più che il bambino scorderà poi la
maggior parte delle cose richieste),
permetterà di rendere presente e
conferire autorevolezza a una figura
che in pratica è lontana. Tuttavia è
bene che al padre non venga delegato
il ruolo di punitore e di vendicatore
delle malefatte quotidiane, ma
soprattutto quello dì dispensatore di
elogi e di premi: altrimenti la
figura paterna, agli occhi del
bambino, non costituirà più un'attesa
ma una minaccia. Detto ciò, poiché è
in pratica la madre ad essere
continuamente in contatto col bambino
nei primi anni di vita, sarà
soprattutto alla figura materna che
faremo costante riferimento nel corso
del libro, senza dimenticare che le
stesse regole valgono anche per il
padre. Concludendo questo capitolo si
può dire che tutti i fili dello
sviluppo appaiono legati da uno
stesso principio, che vale per la
crescita fisica, intellettuale,
affettiva. Esso si basa su uno
scambio estremamente raffinato e
sensibile, che permette di impostare,
sin dall'inizio, la costruzione
cerebrale del bambino, attivando o
atrofizzando certe capacità innate. È
anche attraverso questo primo
rapporto che può emergere
gradualmente la qualità forse più
tipicamente umana : la capacità di
comunicare.
Prima ancora di cominciare a
parlare il bambino dispone già di un
codice istintivo che è la base del
futuro linguaggio parlato.
IV • LA COMUNICAZIONE Un linguaggio
in codice La comunicazione esiste in
natura non solo tra gli uomini, ma
tra tutti gli animali. Scendendo via
via nella scala zoologica, diventa
sempre più difficile scorgerne i «
segnali », ma è fuori dubbio che ogni
essere vivente comunichi con i suoi
consimili attraverso messaggi che noi
non siamo ancora in grado di
interpretare. La prima cosa cui si
pensa, naturalmente, è il linguaggio
delle api, o i sistemi di
comunicazione delle formiche, i vari
ruggiti, cinguettii, ululati degli
animali. In realtà i « segnali »
possono essere molto meno evidenti ma
altrettanto efficaci : gli animali in
amore hanno atteggiamenti che sono
capiti immediatamente dagli altri,
oppure producono odori che sono vere
e proprie « fumate » a distanza.
Anche l'aggressività viene comunicata
attraverso atteggiamenti, gesti,
colorazioni, suoni che sono
chiaramente percepiti dai possibili
avversari; in caso di combattimento,
poi, il perdente di solito segnala la
sua resa con l'esposizione simbolica
delle parti vulnerabili, o con gesti
rituali di sottomissione. Esistono
altri codici visivi ancora più
segreti che permettono, per esempio,
a una scimmia di capire d'istinto che
un serpente è un suo nemico, pur
senza averlo mai visto prima. Anche
negli esseri umani esiste una «
segnaletica » istin-
tiva, che portiamo dentro di noi per
via ereditaria, e che consiste in una
serie di atteggiamenti, espressioni,
gesti che non hanno bisogno di essere
imparati perché fanno parte di un
repertorio « automatico ». Un esempio
semplice, rende bene l'idea : il
neonato è già in grado di «
comunicare » le sue sensazioni
attraverso gli strilli o il pianto,
senza che nessuno gli abbia insegnato
a strillare o piangere. Non solo, ma
il pianto è diverso a seconda della
sensazione da « comunicare » :
dolore, fame, malattia, paura. Un
altro esempio, ancora più evidente :
i bambini nati ciechi, sordi e muti
(quindi isolati quasi completamente
dal mondo) sviluppano ugualmente il
riso, senza averlo mai visto o
ascoltato in qualcuno, oppure battono
il piede in terra in segno di stizza,
o corrugano la fronte. Esiste,
insomma, un repertorio di « segnali »
che sono innati in ogni individuo, e
che permettono una comunicazione con
l'ambiente circostante. La madre è il
« ricevitore » ideale, capace di
captare nel modo più efficace questi
segnali, e di trasmetterne altri che
il bambino riesce a percepire. Ci sì
può chiedere, naturalmente, fino a
che punto un neonato possa
interpretare i significati di ciò che
la madre gli comunica, e a sua volta
trasmettere le sue sensazioni, le sue
gioie, i suoi desideri. Studi assai
interessanti sono in corso per
cercare di capire questo linguaggio
segreto che si stabilisce molto
presto tra madre e figlio, e che
costituisce la prima base della
comunicazione umana. All'Università
di Harvard il professor Peter Wolff
dirige il laboratorio in cui queste
ricerche vengono effettuate : « Sono
ricerche assai diffìcili, perché gli
istinti e le esperienze si mescolano
rapidamente e non è semplice separare
gli uni dalle altre. Siamo solo agli
inizi, però abbiamo potuto renderci
conto che il bambino possiede segnali
innati molto più complessi di quelli
esistenti negli animali. » « Lei
pensa che il neonato riesca a
percepire l'ambiente
emozionale che lo circonda attraverso
i gesti, i sorrisi, gli sguardi della
madre? » « Sì, certamente. 11
linguaggio parlato non esiste ancora,
però questa fase è quella che lo
prepara : il bambino è in grado di
ricevere i messaggi della madre
attraverso tutti i suoi sensi, come
ad esempio il tatto o la vista o il
tipo di voce, e anche attraverso i
gesti e le espressioni. » Queste
ricerche sul linguaggio istintivo
vengono condotte in uno speciale
laboratorio dell'Università di
Harvard. Una madre, col suo bebé,
viene fatta entrare in una pìccola
stanza: dietro un tramezzo il
professor Papusek e la sua équipe
osservano come madre e figlio «
dialogano », filmando di nascosto
questo scambio di messaggi istintivo,
fatto di espressioni, intonazioni,
sguardi, mugolii ecc. In un secondo
tempo si cerca di turbare questo
dialogo: la madre viene invitata a
muovere solo le labbra senza parlare,
come in un film muto, oppure a
dirigere lo sguardo leggermente a
lato del bambino, evitando di
guardarlo negli occhi. Le riprese
filmate vengono poi analizzate
fotogramma per fotogramma, per capire
come possono nascere o interrompersi
certe sequenze. « Con questo
accorgimento » mi ha detto Papusek «
abbiamo potuto rilevare l'importanza
che ha per il bambino il contatto
visivo, oppure le intonazioni, il
timbro della voce. Infatti, molto più
importanti delle parole, in questo
periodo, sono le intonazioni, le
modulazioni. È così che il bambino
comincia ad apprendere, comincia a
sviluppare i meccanismi cognitivi. »
« Ritiene che alcune madri riescano
meglio di altre a stabilire questo
rapporto istintivo col neonato? » «
Sì, alcune sanno compiere
istintivamente molto bene questo
ruolo, altre no. E non si tratta
sempre delle donne più colte, anzi
direi che una donna intellettuale, a
volte, ritiene noioso e primitivo
questo tipo di comunicazione, e usa
un linguaggio più sofisticato che il
bambino non capisce: ciò
crea una situazione meno stimolante.
Penso che non tutte le madri si
rendano conto dell'importanza di
questa fase. » // controllare
controllato In questo scambio
continuo tra madre e figlio, gli
psicologi ritengono che abbia molta
importanza non solo il ruolo della
madre, ma anche quello del bambino :
egli infatti non è un elemento
passivo, ma attivo, che stimola a sua
volta la madre. È interessante
ricordare, in proposito, le
osservazioni fatte da certi
ricercatori sul comportamento degli
animali appena nati. Si è notato, per
esempio, che tra gli uccelli l'amore
materno viene messo in moto dai
piccoli aprendo il becco; se un
uccellino non lo fa rischia di morire
di fame, perché la madre non è
stimolata a nutrirlo. In certi
uccelli, i genitori nutrono i figli
solo se questi pigolano; se non
riescono a farsi sentire sono
destinati a morte certa. Anche negli
esseri umani sembra che il ruolo del
bambino come stimolatore sia molto
importante, e naturalmente investe un
campo assai più vasto. Il bambino,
ritengono molti psicologi, pilota a
sua volta il rapporto, proprio perché
la partita si gioca a due, e ognuno
ha il suo ruolo di protagonista. «
Si, è un duetto che deve rispettare
certe sequenze, » mi ha detto WolfF.
« 11 neonato ha certe aspettative,
cioè attende dalla madre certe
risposte, e anche la madre ha certe
aspettative nei confronti del
bambino; ognuno dei due interroga e
risponde al tempo stesso. « Se la
sequenza si rompe, può risultarne
disturbato lo sviluppo armonico del
rapporto. Anche la madre, infatti, ha
bisogno di essere stimolata dal
bambino per essere a sua volta
stimolante. « Certi bambini affetti
da disturbi neurologici non sono
sempre in grado di sollecitarla nel
modo giusto, non sanno
morte. Tra due esse diventi, il
comporta-
sostenere bene questo duetto, e ciò
provoca una reazione a catena nello
sviluppo. » II « contagio psicologico
», insomma, avviene nei due sensi. Un
bambino può, con il suo atteggiamento
istintivo, provocare nella madre una
reazione positiva, oppure negativa
come nel caso del bambino di
temperamento « difficile ». Per dirla
in gergo psicologico, c'è una
relazione reciproca tra controllore e
controllato: il comportamento di un
genitore è rafforzato positivamente o
negativamente dalla risposta del
bambino. La claque psicologica Ciò è
vero, del resto, in tutti i rapporti
umani. Vi è una dipendenza reciproca
dovuta proprio a una continua spirale
azione-reazione, che influenza i
comportamenti di ognuno nei confronti
dell'altro.
Per esempio, un attore comico ha «
bisogno » di un pubblico che rida, un
conferenziere ha bisogno di una sala
che lo ascolti, noi stessi ci
scoraggiamo se parliamo con qualcuno
che guarda da un'altra parte. Il
comico francese Fernand Reynaud
raccontava che la cosa peggiore,
quando usciva sulla scena per i suoi
monologhi, era sentire qualcuno tra
il pubblico zittire quelli che
ridevano troppo forte, per poter
ascoltare meglio. La risata,
l'applauso « caricano » il comico, il
conferenziere e l'attore, e spiegano
l'importanza della « cla-que », che
favorisce l'insorgere di questa
spirale psicologica. Noi pure
diventiamo molto più brillanti quando
il nostro interlocutore annuisce,
ride, approva, si interessa al nostro
racconto. Anche se non parla lo
troviamo « simpatico », e lo è
certamente nel senso etimologico,
cioè sviluppa emozioni sincrone alle
nostre. Per il bambino, che ha tutto
da imparare (a cominciare dal-
l'imparare ad esprimersi), questo
clima emotivo favorevole costituisce
uno stimolo essenziale per
l'apprendimento: infatti, in questo
scambio continuo egli si specchia sul
volto della madre, e cerca
costantemente di imitarla. Imitando
la madre, egli .sente che i suoi
gesti provocano un'onda di ritorno
che lo mantengono in un circuito
d'amore, e l'imitazione diventa il
suo principale modo di apprendere.
Gli psicologi però mettono in guardia
contro un abuso di questo rapporto
privilegiato; poiché il bambino, per
non uscire dal circuito d'amore, è
disposto a rispondere anche a stimoli
che possono richiedere un impegno
imitativo superiore alle sue capacità
del momento, e ciò può andare a
scapito del suo sviluppo armonioso.
Questo accade soprattutto più tardi,
quando i genitori gli chiedono di
compiere qualcosa che non rientra nei
suoi interessi ma nei loro. La
relazione tra affettività e
apprendimento è infatti molto
stretta, in questa prima fase della
vita. Vedremo in seguito quali sono i
meccanismi biochimici a livello
cerebrale che collegano affettività e
apprendimento, cioè che collegano so-
stanzialmente la parte antica del
cervello con la corteccia «
memorizzante ». Ora vediamo come si
sviluppa, pian piano, nell'essere
umano quello straordinario strumento
che è alla base del suo progresso
intellettuale: il linguaggio parlato.
La nascita del linguaggio La nascita
del linguaggio, questa fioritura
prodigiosa della parola che, partendo
da zero, consente a un bambino di
imparare in poco tempo qualsiasi
lingua, di parlare correntemente il
turco, il cinese, o i dialetti della
Lapponia e dell'Hi-malaya, ebbene
questa nascita della parola non
avviene spontaneamente, da sola, ma è
il frutto degli stimoli ambientali, e
l'ambiente fin dal primo giorno di
vita può favorirne o sfavorirne lo
sviluppo. « Direi che vi è una
continuità tra il linguaggio
istintivo e quello parlato, nel senso
che la comunicazione comincia già col
primo vagito, » mi ha detto la
psicoioga Paula Menuck, che conduce
ricerche sul linguaggio al
Massachusetts Institute of Technology
(Boston). « Verso i nove-dieci mesi
appaiono certe intonazioni che non
sono più soltanto istintive, ma sono
tipiche della lingua parlata dalla
madre: per esempio le intonazioni
svedesi hanno un carattere, quelle
inglesi ne hanno un altro e così via.
Prima ancora di apparire con le
parole, insomma, il linguaggio
comincia a essere modellato
dall'ambiente, attraverso una
costruzione graduale che passa
attraverso varie fasi, ognuna delle
quali è molto importante, anche se
spesso un genitore non se ne rende
conto. » Questa « escalation » è resa
possibile dalla eccezionale capacità
di imitazione che esiste nell'essere
umano. È un processo che comincia con
le intonazioni e prosegue poi pian
piano con la vocalizzazione, col
gusto di provare varie combinazioni
di suoni imitando quelli della madre.
In certi laboratori di psicologia,
degli scimpanzè sono stati addestrati
a « parlare •> attraverso simboli e
gesti. Alcuni animali sono riusciti a
imparare diverse decine di parole,
tra cui il concetto
Naturalmente gli stimoli ambientali
non sono sufficienti : come sempre
avviene per lo sviluppo di qualsiasi
qualità fisica o mentale, è
necessaria un'azione combinata tra
eredità e ambiente. Occorre cioè che
la macchina sia adatta a questo
processo riproduttivo della parola.
Certi uccelli sanno imitare alcune
parole umane (pappagalli, gazze,
merli); anche scimpanzè e gorilla
hanno organi vocali perfettamente
adeguati a emettere parole, ma i
centri cerebrali del linguaggio (e
naturalmente la stessa struttura
cerebrale) non sono in grado di
organizzare mentalmente un processo
così raffinato come è quello della
parola. Le grandi scimmie posseggono
qualità imitative notevoli (basta
andare a un circo per rendersene
conto) e hanno anche alcune
primordiali capacità di astrazione:
se si paragona per esempio un bambino
a uno scimpanzè, ci si accorge che
all'età di due anni non c'è molta
differenza nella capacità di compiere
certi esercizi (come estrarre una
caramella da un tubo con l'aiuto di
un bastone, o aprire una porta chiusa
a chiave), ma vi è un abisso nella
capacità di imitare i suoni. Alcuni
ricercatori (come i coniugi Gardner a
Reno, Ne-
vada, o il dottor D. Premack,
all'Università di California) hanno
tentato di insegnare ad alcuni
scimpanzè'un linguaggio da sordomuti,
o fatto di simboli plastici, con
risultati ragguardevoli. Tuttavia la
distanza mentale che divide le
scimmie dall'uomo non permette di
andare oltre un certo limite. Esiste
infatti nell'uomo una macchina
cerebrale estremamente più complessa,
che consente non soltanto di imitare
ì suoni ma di elaborarli: le parole
diventano come etichette per astrarre
dei concetti, il linguaggio diventa
uno strumento per pensare, un
attaccapanni per appendervi le idee.
Del resto, il linguaggio, sostengono
alcuni psicologi, non è soltanto un
modo per comunicare con gli altri ma
anche per dialogare con se stessi, e
quindi per essere « consapevoli »,
trasferendo al proprio interno il
processo di conoscenza che viene
utilizzato nel capire il mondo
esterno. Dice B.F. Skinner: domande
come «che cosa hai fatto ieri? Che
cosa fai ora? e domani? Vuoi farlo?
Perché? Che cosa provi dinnanzi a
ciò? » mostrano che occorre una
comunicazione interna per sapere, e
per essere consapevoli. È un campo,
questo, in cui ci si muove ancora con
cautela, poiché i meccanismi mentali
che presiedono ai processi cognitivi
sono ancora troppo poco conosciuti.
Tuttavia è generalmente accettato che
il linguaggio sviluppi la capacità di
astrarre, condizionando quindi il
formarsi dell'attività mentale. Un
montaggio di parole Anche il
linguaggio (come gli atomi, le
molecole, i nucleo-tidi sul filamento
di DNA, O l'evoluzione) può
paragonarsi a un gioco dì LEGO:
partendo da pezzi di base
relativamente semplici si « montano »
costruzioni sempre più complesse e
diverse. È uno sviluppo che, in un
certo senso, segue regole analo-
ghe a quello delle strutture viventi
: è estremamente « flessibile », si
adatta, si arricchisce (oppure si
atrofizza) a seconda degli stimoli
ambientali. In realtà non ha molta
importanza usare una parola piuttosto
che un'altra (cioè una lingua
piuttosto che un'altra); l'importante
è il tipo di costruzione che si
riesce a organizzare. E ciò dipende,
naturalmente, da due fattori: dalla
macchina cerebrale di cui si dispone,
che è sostanzialmente simile in tutti
gli uomini (per questo l'americano
Chomsky ritiene che tutti i linguaggi
si riconducano agli stessi circuiti
cerebrali innati); e dai « pezzi »,
cioè le parole messe a disposizione
dell'ambiente. Vedendo le cose in
questo modo ci si rende meglio conto
del processo mentale del bambino,
quando impara a parlare. Egli
utilizza alcuni « pezzi » come
parole-perno, per agganciarvi
successivamente le altre parole, e
procedere via via a una costruzione
sempre più complessa. La giornalista
americana Maya Pines, nel suo libro
« Rivoluzione nell'Apprendimento »
(Armando Editore) cita alcuni esempi
classici di questi agganci, come «
Ecco mamma! Ecco pappa! Ecco bimbo! »
e riporta l'opinione del professor
Bruner, che ha condotto molte
ricerche all'Università di Har-vard.
« È a questo punto che il bambino
entra a far parte della specie umana
come essere parlante. È possibile
infatti trovare qualche espressione
< olofrastica > (cioè di una parola)
nei primati superiori, ma non si
troverà mai in essi una grammatica
combinatoria. Il ritmo con cui il
bambino opera su queste parole-perno
è veramente impressionante. La prima
settimana si potranno ascoltare
cinque o dieci esempi di forma
combinatoria, la seconda settanta, la
terza anche settecento, in seguito
addirittura un'esplosione. » Maya
Pines racconta che anche lei si mise
a osservare la nascita del linguaggio
in suo figlio, e si accorse di questo
« montaggio » progressivo, una
scoperta eccitante che le permetteva
di capire i progressi del bambino, e
anche di indovi-
nare ogni volta quale nuova direzione
potessero prendere. Capitava che alle
sei del mattino il piccolo la
svegliasse chiedendole : non vuoi del
sale? non vuoi del pepe? non vuoi
dello zucchero? non vuoi del latte?
Giunto in questa fase il linguaggio
prende decisamente il via e continua
ad arricchirsi di nuove parole e di
nuovi «montaggi », con un aumento
esponenziale delle combinazioni
possibili. L'allargarsi del
vocabolario permette una definizione
sempre migliore delle proprie
costruzioni mentali, e l'abitudine a
effettuare montaggi di frasi e di
idee consente di organizzare sempre
più efficacemente il pensiero.
L'imitazione dei suoni diventa man
mano perfetta : un individuo che
parla con accento Veneto o
napoletano, in pratica, è un perfetto
imitatore dell'accento che ha
ascoltato attorno a sé. Egli lo
mescola inoltre con espressioni,
gesti, atteggiamenti in parte innati
e in parte acquisiti per imitazione.
Questo processo imitativo, del resto,
vale non soltanto per il linguaggio,
ma per ogni altra cosa : un bambino,
si può dire, è un imitatore del suo
ambiente anche per quanto riguarda il
comportamento culturale o mentale.
Imita la raffinatezza o la volgarità,
l'interesse per la lettura o per le
canzonette, la tendenza al
ragionamento o alla reazione
istintiva. La nascita del sorriso
Questo meccanismo della nascita del
linguaggio mostra bene quanto
l'ambiente familiare possa influire
sullo sviluppo del bambino. In certe
famiglie il piccolo sente parlare
poco intorno a sé, o vede utilizzare
gesti e intonazioni di voce più che
parole. Egli « imita » tutto ciò, si
« adatta », e riceve un'impronta che
col passare del tempo si radicherà.
È, infatti, talmente
sensibile all'ambiente che lo
circonda da rimanerne influenzato
prima ancora di compiere un anno di
età. L'Università di Gerusalemme ha
compiuto una serie di ricerche
dirette appunto a stabilire quale
conseguenza possa avere sul bambino
un diverso ambiente culturale e
sociale, che si esprime soprattutto
attraverso la comunicazione di gesti
e di parole. « Abbiamo studiato
bambini al di sotto di un anno, in
cinque diversi ambienti : nelle
classi medie, nelle classi a basso
reddito, nei brefotrofi, nei
kibbutzim e tra i beduini, » dice il
professor Greenmaum. « Stiamo ancora
elaborando i dati raccolti, ma già
emergono notevoli differenze e appare
chiaro che l'ambiente in cui il
bambino nasce e cresce ha
un'influenza su di lui fin dai primi
mesi di vita, o addirittura dai primi
giorni. « Le osservazioni fatte
mostrano quanto sia importante la
gente che sta intorno al bambino, il
modo in cui gli parla o sorride. I
nostri dati sembrano indicare che la
qualità degli stimoli, più ancora che
la quantità, è determinante. Sono
cioè determinanti quei momenti in cui
la madre parla col bambino, quando lo
lava, lo veste, o lo nutre. » II
professor Greenmaum, per effettuare
queste ricerche, si è recato per
molte settimane con una équipe di
collaboratrici in ognuna delle
abitazioni, cronometrando la durata
del rapporto tra il bambino e la
madre (o coloro che gli erano
intorno), e soprattutto il tipo di
stimoli che il bambino riceveva e le
sue reazioni. Una delle cose che più
colpisce, in queste osservazioni,
riguarda la nascita del sorriso. « II
sorriso, » mi ha detto la dottoressa
R. Landau che ha condotto
personalmente questa ricerca, «
appare in tempi diversi a seconda
dell'ambiente che circonda il
bambino. Nei brefotrofi ad esempio,
il sorriso appare assai più tardi.
Nelle classi medie appare più
precocemente che nelle classi
socialmente svantaggiate.
« È interessante notare che questa
differenza non esiste invece per
quanto riguarda il ridere (cosa
diversa dal sorridere). 11 bimbo
comincia a ridere, in ogni ambiente,
più o meno alla stessa età.
L'ambiente non sembra dunque
influenzare il riso, ma il sorriso. »
« E quali possono essere le
conseguenze? » « Si può pensare, per
esempio, che un bambino più
sorridente possa influenzare a suo
vantaggio l'ambiente, nel senso che
stimolerà maggiormente le persone a
giocare con lui o a occuparsi di lui.
È uno scambio che può avere un
effetto a spirale. Un bambino che col
suo sorriso genera simpatia riceverà
più attenzione, parole, racconti.
Crescendo, questo può determinare in
lui un atteggiamento più sorridente
anche verso gli altri. » Un «
rafforzamento » positivo o negativo
può quindi prendere il suo avvio già
nella primissima età. e creare una
catena di avvenimenti che, se non
viene precocemente corretta, tende a
diventare sempre meno « reversibile
», perché una certa direzione è stata
ormai presa. Questi studi, e molti
altri che vedremo in seguito,
mostrano chiaramente come l'ambiente
culturale si faccia sentire sin
dall'inizio, nei primi anni di vita
del bambino. In questo quadro
d'insieme la questione del linguaggio
sembra assumere un'importanza del
tutto particolare. La madre e il
linguaggio Sempre in Israele la
dottoressa G. Ortar, dell'Università
di Gerusalemme, sta conducendo
un'interessante ricerca sul ruolo
della madre nello sviluppo
linguistico, e quindi mentale, del
bambino. Ecco che cosa mi ha detto
sui suoi studi : « Come lei sa,
Israele è un paese in cui sono
affluiti ebrei da ogni parte del
mondo. « Noi abbiamo notato che,
malgrado la parità scolastica, i
figli di immigrati europei erano più
dotati intellettualmente di quelli
immigrati da paesi medio-orientali.
Abbiamo provato a colmare la
differenza con scuole speciali, ma
senza risultato. « Attraverso prove
mentali abbiamo scoperto che queste
differenze tra i diversi bambini
esistono già all'età di tre anni : a
tre anni non vi è gran diversità nel
comportamento, ma vi è un abisso nel
linguaggio. Un bambino ebreo
immigrato dal Medio Oriente, a tre
anni parla come un bambino ebreo
immigrato dall'Europa di un anno e
mezzo. « Abbiamo cercato di risalire
alle cause di questo enorme salto, e
abbiamo potuto notare che le madri
medio-orientali parlano poco con i
loro figli: esse pensano che sia
inutile parlare, dal momento che il
piccolo non le capisce. Le altre
madri invece parlano molto, e cercano
di stabilire il contatto col bambino
ripetendo le parole, spiegando. I
figli di queste madri non solo
sviluppano più precocemente il
linguaggio, ma nelle prove di
intelligenza riescono meglio. » « Non
ha molta importanza il tipo di
discorso che viene fatto col bambino
piccolo? » « No. Un filosofo ha detto
che per fortuna non sono gli
scienziati a educare i bambini,
perché gli scienziati dicono soltanto
cose difficili e non le ripetono;
invece le madri parlano di cose
semplici e le ripetono. « In realtà
tutte le madri, con un bambino
piccolo, parlano sempre delle stesse
cose : della pappa, del bagnetto, dei
pan-nolini. A questo livello direi
che non vi è differenza nei discorsi.
La differenza è ne] <modo> di dire la
stessa cosa. » « Lei afferma che vi
sono tre cose importanti : parlare
molto, ripetere e spiegare. » « Sì,
questo è essenziale. Abbiamo notato
che certe madri si limitano spesso a
dire al bambino < non fare questo > o
< quello senza spiegargli però il
perché. Altre madri, invece, cercano
di spiegargli i motivi. « Per
esempio, un bambino vuoi uscire sul
balcone : la madre può vietarglielo
con un ordine, oppure con un ordine
ac-
nonusere
nonusere -• erché fa f ed do
nonusere erche fa f redrjo-* e
se se >. rriag oneL
nonusere erche fa reddo-*
e se nzamaglion -.ti prend, t
raffreddore
La concatenazione verbale degli
avvenimenti abitua il bambino ad
associare le idee, a estrapolarne le
conseguenze e quindi a immaginare il
futuro. compagnato da una spiegazione
: < Non uscire >, < Non uscire perché
fa freddo, <Non uscire perché fa
freddo e sei senza maglione >, oppure
<Non uscire perché fa freddo e senza
maglione ti prendi il raffreddore >.
« Vede, io credo che sia importante
far capire al bambino, appena ne è in
grado, la concatenazione degli
avvenimenti: ciò vale per ogni
piccolo fatto della vita quotidiana.
» « Non bisogna, cioè, abituare il
bambino ad accettare senza motivo una
cosa piuttosto che un'altra? » « È
così. Se il bambino capisce che ogni
cosa ha una causa comincerà a
interrogarsi, a mettere in relazione
certi fatti tra loro, e ad associare
le idee. » La dottoressa G. Ortar sta
realizzando in un piccolo villaggio
di Israele un esperimento pilota:
riunisce periodica-mente alcune madri
per insegnar loro come comportarsi
col bambino, e in quale modo
parlargli. Vengono proiettate delle
diapositive che rappresentano
situazioni tipiche della giornata
familiare : il pasto, il bagno, il
gioco. Le madri intervenute alla
riunione debbono spiegare come, a
loro avviso, bisognerebbe parlare al
bambino nelle varie circostanze. Ogni
fatto può fornire lo spunto per
un'osservazione, una spiegazione da
proporre al bambino. L'iniziativa,
che sta ottenendo molto successo, va
nel senso ormai condiviso dalla
maggior parte degli psicologi, cioè
la mente del bambino nasce dalla
capacità della madre di essere non
solo nutrice e dispensatrice di
affetto, ma anche maestra.
Vecchio a sei anni Le ricerche in
corso dimostrano che la scuola
comincia praticamente già in questa
prima fase della vita; è in questo
momento che si possono stimolare o
addormentare le grandi risorse
intellettuali del bambino. Ed è anche
in questo momento che si possono, in
certa misura, correggere le
differenze che altrimenti emergeranno
inevitabilmente, al momento
dell'ingresso nella scuola, tra
bambini di diversa estrazione
culturale e sociale. « Nelle classi
povere, » dice il professor J. Kagan
dell'Università di Harvard, Stati
Uniti, « i bambini appaiono di solito
meno motivati, più passivi, meno
capaci di esprimersi col linguaggio.
Non è la povertà di per sé a creare
questo handicap, ma la relazione tra
madre e figlio. Noi abbiamo
constatato che negli ambienti
culturalmente arretrati la gente
ritiene inutile educare un bambino
prima che cominci a parlare. E a un
anno si nota già nel bambino questa
differenza di ambiente. » Se già nel
primo anno di vita è possibile
rilevare questa diversità, è evidente
che col passare del tempo le
differenze tendono a consolidarsi.
Nei sei anni che il bambino trascorre
con la famiglia (ed essenzialmente
con la madre) avviene un «
adattamento » psico-biologico che ha
il tempo di radicarsi prima ancora
dell'ingresso nella scuola. Ogni
bambino si presenterà quindi alla
linea di partenza con un curriculum
personale molto diverso. Avrà, in un
certo senso, un grande avvenire alle
spalle. 1 prossimi capitoli saranno
dedicati proprio a questo aspetto
fondamentale del rapporto tra madre e
figlio, che è alla base dello
sviluppo dell'apprendimento e quindi
dell'intelligenza nel bambino. Prima
di parlarne ricapitoliamo ora
brevemente. Gli scienziati, lo
abbiamo visto a più riprese, ci hanno
mostrato che il rapporto tra madre e
figlio comincia già dal
primo giorno con il tatto, con il
movimento, con la percezione
sensoriale, per continuare poi con un
linguaggio segreto e sfociare nel
linguaggio parlato vero e proprio.
Abbiamo anche visto come la madre può
trasmettere al figlio per contagio
psicologico il suo stesso
temperamento, la sua preparazione
culturale, persino il suo sorriso. 11
bambino, dal canto suo, stimola la
madre, stabilendo una corrente nei
due sensi, attraverso la quale
costruisce pian piano, la sua
personalità, che deve poi arricchire
e completare con l'ambiente
circostante, una volta uscito
dall'incubazione psicologica materna.
Lo smontaggio di questi meccanismi
permette anche di capire come, in una
società che voglia eliminare le
disuguaglianze, certe disparità
possono essere corrette soltanto
dalla scuola. Esperimenti molto
significativi di cui parleremo più
avanti mostreranno come
l'intelligenza possa venire repressa
o stimolata nel primo periodo di vita
dall'ambiente. Il bambino, a sei
anni, quando entra in classe ha già
una lunga storia dietro di sé. In un
certo senso è già un vecchio.
Il cervello del bambino è una
spugna che assorbe tutti i succhi
intellettuali ambiente. Ma per
imparare (cioè per memorizzare) è
necessario che anchi emozioni siano
coinvolte.
V • LA MACCHINA PER MEMORIZZARE La
mucca di Arcadia Buendia Affrontiamo
ora più in profondità il grande tema
dell'infanzia (e non solo
dell'infanzia): l'apprendimento.
Questo capitolo sarà un po' tecnico,
ma aiuterà a capire molto meglio
tutto il discorso che seguirà dopo.
Apprendere significa immagazzinare
esperienze, e perciò riempire
l'archivio cerebrale di quegli
elementi senza i quali nessuna forma
di pensiero è possibile, così come
non è possibile far funzionare un
computer senza schede. La memoria
(che è alla base del processo di
apprendimento), è oggi uno dei
fenomeni più studiati in biologia
perché essa presiede a tutta
l'attività mentale, ed è la chiave
per capire il comportamento,
l'intelligenza, il pensiero. Senza
memoria la specie umana non potrebbe
sopravvivere, sarebbe come
decerebrata. incapace di ogni azione.
Ne) suo fortunato romanzo « Cent'anni
di solitudine » G.G. Marquez parla di
un immaginario villaggio in cui una
strana malattia provoca la perdita
progressiva della memoria; questa
situazione paradossale può mostrarci,
come una moviola che va all'indietro,
l'inevitabile ritorno del cervello
verso l'infanzia mentale e poi verso
il nulla. 11 protagonista, Arcadio
Buendia, di fronte a questa
preoccupante epidemia, tenta di
correre ai ripari segnando a
inchiostro ogni cosa col suo nome:
tavolo, sedia, orologio, porta, muro,
letto, casseruola.
Poi fa altrettanto con piante e
animali : vacca, capra, porco,
gallina, manioca, malanga, banano.
Poi si rende conto che non basta
ricordare il nome di un oggetto o di
un animale, perché l'amnesia
progressiva porterebbe prima o poi a
dimenticarne anche l'utilità. Allora
appende al collo della vacca un
cartello: « Questa è la vacca,
bisogna mungerla tutte le mattine in
modo che produca latte, e il latte
bisogna farlo bollire per aggiungerlo
al caffè e fare il caffellatte. » Ma
il suo è un tentativo inutile, perché
per ogni parola contenuta in questa
frase occorrerebbe un cartello
esplicativo a parte, senza contare
che lo stesso significato delle
singole parole finirebbe prima o poi
per svanire. Naturalmente tale
amnesia si estenderebbe non solo alle
parole scritte, ma anche a quelle
parlate, provocando un'incapacità di
parlare, di capire, e anche di
pensare, portando in definitiva alla
paralisi della mente. Il pensiero è
infatti un « montaggio » di memorie
così come il linguaggio è un
montaggio di parole, e senza elementi
di base non è possibile alcuna
costruzione mentale. Si torna al buio
più profondo, al nulla. Questo
capitolo sarà dedicato ai meccanismi
biologici della memoria e
dell'apprendimento, cioè, in pratica,
al funzionamento « pensante » del
cervello, e tenterà di schematizzare
al massimo processi molto complessi e
raffinati; con l'avvertenza che si
tratta di un campo in cui molte
ricerche sono in corso e non sempre
gli studiosi concordano tra loro su
certi punti. Fatte queste riserve,
aggiungo inoltre che devo qui
concentrare in poche pagine
(altrimenti uscirei di tema) ricerche
molto estese. Rimando quindi le
lettrici e i lettori che volessero
approfondire maggiormente questi ed
altri meccanismi cerebrali, a un mio
precedente libro,* mentre rinvio
direttamente al capitolo seguente
coloro che si annoiassero a leggere
le pros-
Una cellula nervosa è com e in
partenza. I .. bottoni » all'altra.
Poiché esistono possibili sono
praticament
centralino telefonico, con centinaia
di linee in arrivo ntatto (sinapsi)
trasmettono gli impulsi da una
cellula di di cellule nervose nel
cervello umano, i tracciati itati.
sime dieci pagine. Ritengo tuttavia
che quanto seguirà sarà
sufficientemente chiaro per
inquadrare il problema nel suo
insieme. La corsa a staffetta tra i
neuroni 11 cervello, come qualsiasi
altro organo, è composto di parti
diverse, che hanno funzioni diverse.
È una rete compli-catissima,
costituita da circa dieci miliardi di
cellule nervose, o « neuroni ».
Queste cellule hanno due
caratteristiche principali : 1) dal
loro corpo centrale si diramano
propaggini, ramificazioni simili a
quelle di una radice, che raggiungono
e si collegano con le ramificazioni
di altre cellule nervose : i punti di
contatto (« sinapsi ») possono essere
addirittura mille o millecinquecento,
trasformando così ogni cellula in una
specie di centralino telefonico
capace di inviare, ricevere o
smistare
segnali attraverso una rete
sterminata di tracciati possibili: 2)
la trasmissione dei segnali avviene
attraverso una leggera corrente
elettrica (in termini tecnici, si
tratta di una corrente originata
dalla polarizzazione e
ripolarizzazione della membrana); la
corrente provoca a sua volta, nei
punti di collegamento tra le cellule
nervose (le « sinapsi »), uno spruzzo
di particolari sostanze chimiche
(serotonina, dopamina, nora-
drenalina, acetilcolina ecc).
Attraverso questi sistemi di
trasmissione a staffetta da un
neurone all'altro, un segnale,
partendo da un neurone periferico
stimolato da una sensazione di tatto
(per esempio una puntura di spillo),
si trasforma a ogni passaggio in
impulso elettrico (dovuto alla
polarizzazione), poi in spruzzo
chimico sulla cellula nervosa vicina
(nel punto di collegamento o «
sinapsi »); ne segue un nuovo impulso
elettrico, poi chimico, e così via.
Lungo questa staffetta elettrochimica
(che viaggia a velocità variabile a
seconda delle linee, ma che può
raggiungere
allegria, si evocano ricordi di
suoni e immagini, si provocano praìic
lutti i movimenti del corpo,
manovrando l'animale lo l'uomo) come
una marionetta. Impiantando dsglj
elettrodi e possibile stimolars a
vosi. Nell'antico cervello
(paleoencefalo) si trovan nella
corteccia i centri delle memorie
acustiche, ecc. Stimolando queste
zone si •• accendono » a c
maticamente dei circuiti ner i
centri degli istinti primari, ive,
dei movimenti del corpo ansie,
piaceri, desideri.
quella di un'auto da corsa) si
trasmette un'enorme quantità di
segnali che circolano in
continuazione nel nostro sistema
nervoso : segnali che prendono
origine dai « tentacoli » periferici
del cervello (cioè le cellule nervose
sensibili alla variazione di luce, di
pressione, o di temperatura, o di
suoni, vale a dire, in pratica, i
segnali della vista, del tatto,
dell'udito ecc). Altri segnali
viaggiano nell'interno
dell'organismo, e sono quelli della
rete nervosa collegata alle funzioni
del corpo (battito cardiaco,
intestino, secrezione gastrica ecc);
altri segnali infine circolano
all'interno stesso del cervello.
Nell'interno del cervello esiste una
quantità enorme di cellule
specializzate in funzioni diverse,
localizzate in zone diverse;
semplificando molto le cose, le
raggrupperemo in due zone principali
che sono quelle che interessano al
nostro discorso. Le chiameremo la
zona antica e quella recente, cioè il
paleo-cervello e la corteccia.
Nel cervello antico, situato nella
parte più interna, si trovano riuniti
i centri « specializzati » nelle
reazioni nervose istintive: fame,
sete, sonno, aggressività, sesso.
Sono centri automatici che si possono
far scattare a comando, come quando
il medico, battendo col martelletto
sul ginocchio, provoca un riflesso
nella gamba. Sono celebri in
proposito gli esperimenti del
professor Delgado all'Università di
Yale (Stati Uniti); mediante
sottilissimi elettrodi impiantati nel
cervello di scimmie (elettrodi che
provocano una « polarizzazione »
delle cellule interessate) Delgado è
riuscito a stimolare, anche via
radio, tutta una serie di riflessi
istintivi: fame, nausea, desiderio
sessuale, apatia, aggressività,
sonno, euforia. Questo nostro paleo-
cervello, che è la parte più
propriamente animale (o meglio la
parte che conserva tutti gli istinti
di sopravvivenza che hanno reso
possibile l'evoluzione) è avviluppato
dalla corteccia, la parte « pensante
». La corteccia esiste anche negli
animali, dove però il suo spessore è
molto più modesto. L'uomo, attraverso
la selezione ambientale, ha finito
per aumentare enormemente,
soprattutto nella zona frontale, lo
strato di queste cellule nervose
specializzate nel memorizzare e
nell'« elaborare » e si trova oggi a
possedere una macchina pensante dalle
straordinarie capacità. I neuroni
della corteccia infatti (e questo è
il punto-chiave) sono quelli che
presiedono alla memorizzazione delle
informazioni, e funzionano da super-
centralino di controllo. Detto in
modo molto semplice si può
raffigurare la parte « nuova » e «
antica » del cervello rispettivamente
con la parte colta e quella
passionale dell'uomo, l'educazione e
gli istinti, o se volete, l'ambiente
e l'ereditarietà. Nell'animale, che
ha poca corteccia, prevale la parte
istintiva: nell'uomo, invece, può
prevalere la corteccia (a condizione
però che sia stata educata a questo
scopo : infatti nel bambino-lupo, in
mancanza di memorie culturali,
prevale il lato animale).
La segnaletica cerebrale Queste due
parti del cervello non sono
indipendenti ma funzionano in modo
combinato, agiscono continuamente una
sull'altra; sono in contatto con
l'esterno e con l'interno, ricevono
stimoli dall'ambiente e dal corpo, e
in base alla loro natura e struttura
« scaricano » segnali (depolarizzano)
provocando questa o quella reazione.
L'estrema complessità di questa rete
fa sì che ogni piccola scarica e
contro-scarica contribuisca a
orientare i tracciati in un certo
modo, così come un automobilista può
viaggiare su un percorso cosparso di
sensi unici, direzioni vietate, sensi
rotatori, e così via. L'educazione e
gli istinti premono, ognuno dal canto
loro, per correggere la direzione e
il volume di queste « scariche » : il
risultato di un tale « negoziato » è
il comportamento. Per fare un esempio
molto semplice, che però rende bene
l'idea, si pensi a un cane lupo
addestrato a non ricevere cibo dagli
estranei : quando qualcuno gli
offrirà un bel boccone di carne i
suoi istinti lo stimoleranno a
mangiare, ma la sua « educazione » lo
tratterrà (è già « un caso di
coscienza » nella sua espressione più
semplice). Nell'uomo, il « Parlamento
» degli istinti e dell'educazione
(che è estremamente più ricco e
raffinato) entra in gioco in ogni
decisione, con un dosaggio di spinte
e controspinte che rappresentano il
peso specifico delle varie « schede »
mentali. È evidente, in questo schema
di funzionamento, l'importanza che
assumono le memorie immagazzinate
attraverso le esperienze : con la
loro presenza esse possono orientare
in un modo piuttosto che in un altro
i « tracciati » cerebrali,
modificando di conseguenza il
comportamento. Queste memorie
praticamente non esistono alla
nascita (anche se il feto possiede
già memorie tattili e acustiche che
sono probabilmente anche alla base
dei suoi sogni) : esse si formano man
mano, grazie al flusso delle
sensazioni che at-
Il » Parlamento » degli istinti e
dell'educazione è chiamato in causa
per ogni decisione, anche piccola, e
tiene conto di tutti i vari •• gruppi
di pressione •• (ereditati o
acquisiti). Il trutto di questo
negoziato è il comportamento.
traversano continuamente il cervello
e che lasciano una traccia materiale
nella rete cerebrale. Oggi si cerca
di capire in cosa consista
esattamente questa traccia che è alla
base della memoria. Osservazioni su
animali, effettuate in particolare
dal professor Rosenzweig
all'Università di Berkeley in
California (e confermate da altri
studi) hanno mostrato che topini
posti in condizioni di apprendimento
stimolante presentavano, nei
confronti di altri topini tenuti
isolati in gabbia, vere modificazioni
misurabili: un aumento della
corteccia, un arricchimento
biochimico nel cervello, e un
ispessimento delle sinapsi. Cioè il
cervello, come un muscolo, si
modifica sotto l'azione degli stimoli
esterni: questi cambiamenti
costituiscono una traccia capace di
influenzare il passaggio dei
successivi stimoli nervosi. Infatti,
come uno scambio ferroviario può
modificare il percorso di un treno, o
un semaforo regola il traffico delle
auto, queste « tracce » correggono il
percorso di un impulso elettrochimico
che viaggia lungo il sistema nervoso.
L'organizzazione delle memorie Molti
ricercatori stanno cercando di capire
più a fondo come si organizzano
queste tracce. Al Massachusetts
Institute of Technology, il professor
Chorover studia il comportamento
elettrico del cervello durante
l'apprendimento, cioè mentre sta
memorizzando; grazie a finissimi
elettrodi impiantati nel cervello di
animali egli è in grado di osservare
ciò che accade nelle singole cellule
cerebrali. « Noi riteniamo, » dice
Chorover, « che l'apprendimento
provochi dei cambiamenti materiali
nelle cellule nervose. I cambiamenti
possono avvenire in due modi: gli
impulsi nervosi modificano o le
cellule stesse oppure i collegamenti
tra una cellula nervosa e l'altra.
Ciò determina il formarsi di certi
tracciati nel sistema nervoso. «
Questa costruzione dei tracciati
prende inizio sin dalle primissime
esperienze, e riguarda naturalmente
tutte le percezioni sensoriali:
olfatto, udito, vista ecc. Esse
vengono, man mano, ad arricchire la
rete nervosa e a costituire
l'archivio delle esperienze. » « Lei
ritiene, insomma, che il cervello sia
come una scacchiera, in cui
all'inizio della partita tutte le
mosse sono possibili, poi a mano a
mano le combinazioni si riducono? »
« Sì, penso che avvenga proprio
qualcosa di analogo; alla nascita il
sistema nervoso può, in teoria,
sviluppare innumerevoli connessioni,
tutte ugualmente probabili. Poi, con
le successive esperienze, i tracciati
diventano sempre più fitti e le
probabilità iniziali via via
diminuiscono, poiché vengono ad
inserirsi in una trama già disegnata
in modo sempre più dettagliato. » Per
fare un esempio ancora più semplice,
potremmo pensare a un grande terreno
vergine sul quale deve sorgere una
città: su questo terreno si potrebbe
disegnare in teoria qual-siasi tipo
di tracciato stradale. Ma via via che
cominciano
a sorgere viali e palazzi, piazzette
e vicoli, la città prende forma,
diventa sempre più densa di edifici e
di strade, e sarà sempre più
difficile (e improbabile) modificare
la sua pianta d'insieme. 11 cervello
del bambino si sviluppa in modo
analogo: ogni cosa che impara lo
arricchisce, ma al tempo stesso crea
in lui delle memorie, dei tracciati
che orientano in modo sempre più «
dettagliato » il suo comportamento.
Ogni esperienza, piacevole o
spiacevole, contribuisce alla
costruzione di una rete di « sì » e
di « no » lungo la quale vengono
automaticamente smistate e
canalizzate le sue sensazioni (e le
sue risposte). Tutto ciò permette di
capire come nascono i condizionamenti
in un individuo e mostra come
l'educazione sì imprima «
biologicamente » nelle cellule
cerebrali. Accade un po' come in una
vaccinazione, che a modo suo è già
una forma di memoria: una
vaccinazione lascia infatti
nell'organismo una traccia capace di
farlo reagire più attivamente quando
si presentano gli stessi germi.
Analogamente (anche se con un
meccanismo diverso), ogni traccia
mnemonica sì-no « sensibilizza »
cellule e circuiti che rispondono più
attivamente quando uno stesso stimolo
si ripresenta. Già si intravvede
chiaramente come questi meccanismi
cerebrali inducano a considerare
sotto una luce nuova il problema
della « libertà di scelta », di cui
parleremo alla fine del libro.
Emozioni e apprendimento Un punto
estremamente importante, torniamo a
ripeterlo, è l'azione combinata che
hanno le due parti del cervello,
quella « memorizzante » e quella «
primitiva » : per poter memorizzare è
infatti necessario che la parte
primitiva sia coinvolta (direttamente
o indirettamente) attraverso uno
stimolo spia-
Partendo dalla zona degli istinti
un'emozione si dirama verso le
viscere e verso la corteccia, dove
crea delle situazioni biochimiche più
attive per il fissaggio delle
memorie. cevole o gradevole, cioè un
sistema premio-punizione. In altre
parole, per imparare, un individuo
deve essere toccato nelle sue
emozioni, nella sua affettività : un
avvenimento neutro, o un ambiente
neutro, non è in grado di stimolare
il cervello dal punto di vista
biochimico, e quindi non è in grado
di provocare il fissaggio della
memoria. Studi assai rivelatori
vengono condotti in questo campo dal
professor Seymour Kety, del
Massachusetts General Ho-spital. « Lo
stato d'animo di un individuo è un
elemento essenziale al momento
dell'apprendimento, » dice Kety, «
poiché è questo stato d'animo, che
possiamo chiamare paura, curiosità,
attenzione, e così via, a determinare
le condizioni chi-miche nel cervello
per il formarsi della memoria. Dalla
zona <primitiva) del cervello (dove
hanno sede le emozioni primarie, gli
istinti come fame, sete, aggressività
ecc.) vi sono cellule che attraverso
un'estesissima rete raggiungono la
corteccia cerebrale; ebbene, io
ritengo che siano certe sostanze
chimiche stimolate dalla zona degli
istinti a provocare il fissaggio
delle memorie nella corteccia. In
altre parole succe-
derebbe nel cervello quello che
succede anche nel corpo : per
esempio, quando si dice <è
meraviglioso >, questa emozione si
propaga alle funzioni viscerali;
analogamente si propaga alla
corteccia, e crea una situazione
biochimica che facilita il fissarsi
dei ricordi, per esempio sotto forma
di leggere modificazioni delle
connessioni cerebrali. » « Quindi,
per provocare il formarsi della
memoria occorre stimolare le
emozioni? » « Sì, ciò è importante ai
fini dell'apprendimento. Se il
livello emotivo non è abbastanza alto
l'apprendimento è ostacolato : una
cosa neutra non emoziona, e non
provoca le condizioni adatte per
fissare i ricordi. Proprio per
questo, affinchè l'insieme funzioni,
è necessario un sistema di valori
(che possono definirsi in senso molto
generale <bene> e <male>), in grado
di indicare le cose da evitare e
quelle da desiderare. Il bambino già
sin dalla nascita ha un suo sistema
di valori istintivo che gli permette
di distinguere ciò che è < bene > e
ciò che è <male>; per esempio bene è
mangiare, sentire il calore materno,
male è bruciarsi, avere sete, e così
via. Egli impara in base a questo
codice primario. « Successivamente,
con l'esperienza, il sistema viene
allargato, e il bambino comincia a
imparare che certe cose sviluppano
intorno a lui un'atmosfera di
benessere, altre invece portano al
dolore. Pian piano queste emozioni
verranno indirettamente identificate
in certi valori che simboleggiano ciò
che può portare al < bene > e al <
male > ; l'elaborazione potrà
diventare molto raffinata, ma alla
base vi sarà sempre l'emozione,
alimentata dalla parte antica del
cervello e dal suo sistema
biochimico. » La sopravvivenza come
valore dì base Questa idea di base
trova la sua conferma, a voler
guardare bene, nel comportamento
quotidiano dell'uomo. Qualsiasi
« valore » può essere smontato e
ricondotto alle sue motivazioni
originarie, fino a ritrovare quelle
più primitive e incon-sce :
sostanzialmente si può dire che il «
valore » di base è sempre la
sopravvivenza propria e della specie.
È una spinta biologica a conservarsi
che esiste ovunque in natura : è la
cosiddetta « lotta per la
sopravvivenza » che ha accompagnato
tutta la storia della vita, dalle
molecole primitive agli organismi
unicellulari, dai molluschi ai
rettili, dal mammifero all'uomo. La
selezione naturale (e quindi
l'evoluzione) si è sviluppata su
questa regola fondamentale, che oggi
ancora permane nel nostro
comportamento quotidiano. La clava è
stata sostituita dal cervello (che è
una clava molto più efficiente). Oggi
si vince con l'intelligenza, con la
preparazione culturale, con
l'astuzia, o con certi simboli di
potere, come le banconote, il potere
politico, il prestigio. Studio,
lavoro, accumulazione delle
conoscenze diventano così « strumenti
» di sopravvivenza, come pure le
invenzioni, la tecnica, la scienza.
Sin dai tempi antichi, inoltre, si è
imparato che il gruppo assicura in
modo più efficiente la sopravvivenza
del singolo : nascono così certe
regole sociali che ognuno deve
rispettare per il bene comune e che
diventano « valori » che portano al
« bene » o al « male ». All'interno
del gruppo, poi, ognuno tende a
ottenere il maggior numero di
vantaggi, attraverso una lotta di
sotto-gruppi che diventa « politica »
: anche i sistemi politici, dal canto
loro, si modificano per sopravvivere
meglio. L'uomo, predestinato alla
morte, tende poi a sopravvivere anche
attraverso la discendenza, e quindi
attraverso l'accoppiamento sessuale,
per il quale occorre il
corteggiamento e quindi l'eleganza,
la bellezza, i segni esterni di
prestigio. I figli, eredi del proprio
seme genetico, vanno protetti,
allevati, posti nelle condizioni
migliori per sopravvivere, e quindi
educati a rispettare le « regole »
considerate più adatte. Infine il
desiderio di sopravvivere anche dopo
la morte, può trovare
soddisfazione nella fede religiosa,
con la prospettiva di una vita
ultraterrena. Se si osserva dunque il
comportamento quotidiano deli'uo-mo
da questa particolare angolazione è
possibile, per ramificazioni
successive, ricondurre alla
fondamentale « spinta » di
sopravvivenza tutte le attività umane
(anche quelle che appaiono molto
lontane dagli « istinti », come
l'arte, la scienza, la cultura). Si
possono così, per trasparenza,
interpretare meglio quei « valori »
che simboleggiano il « bene » o il «
male », e che coinvolgono, in
pratica, la conservazione o la
distruzione di una struttura, cioè la
sua vita e la sua morte. Lo studio
dei meccanismi biologici ci mostra
che l'uomo è mosso, in tutte le sue
manifestazioni, da una caldaia
primitiva (indirettamente alimentata
dall'esplosione cosmica iniziale), la
quale si serve di ogni mezzo
possibile (la forza, l'adattamento,
la lotta, la fuga, l'intelligenza)
per mantenersi in vita, cioè per
autoconservarsi. Il collegamento tra
intelligenza e istinti diventa molto
evidente se si pensa che alle unghie
e ai denti si è sostituita la pietra,
poi il coltello e infine, attraverso
il linguaggio, l'astrazione. Alle
prove di forza fisiche (che
sopravvivono nello sport) sono
succedute quelle mentali. J.F.
Kennedy e R. Nixon, per abbattersi a
vicenda, si sono scontrati con le
parole, in un famoso duello
televisivo. Noi stessi possiamo
ferire qualcuno con un insulto (la
parola è l'equivalente di un'arma,
come dice giustamente una celebre
aria, « Pari siam : a te la lingua, a
me il pugnai! »). Anzi, più le parole
e le idee sono intelligenti ed
efficaci, più la lotta può essere
condotta con apparente cortesia,
provocando non sofferenze fisiche, ma
sofferenze morali e psichiche, anche
molto gravi. D'altronde questa forza
cerebrale di autoconservazione,
trasferendosi dall'individuo al
gruppo e infine alla collettività, ha
dato origine a « parole » scritte (le
leggi) che colpiscono, o anche
uccidono, coloro che si pongono
contro l'in-
1) teresse collettivo, cioè contro i
principi (e le morali) che regolano
la sopravvivenza della struttura
sociale. Su tutti questi problemi
varrebbe la pena di soffermarsi molto
più a lungo, perché capire i
meccanismi umani a questo livello
vuoi dire anche capire i
comportamenti quotidiani dell'uomo in
ogni aspetto della vita, a cominciare
dal comportamento politico. Non vi è
qui lo spazio sufficiente per
parlarne : ma mi riprometto di
tornare più diffusamente su questo
argomento in un prossimo libro. Premi
e punizioni Per concludere questo
capitolo sul cervello sarà dunque
bene sottolineare alcuni punti
essenziali, che permettono di
chiarire meglio i meccanismi
dell'apprendimento. Ogni struttura
vivente vegetale, animale o umana
tende
a sopravvivere, e per questo dispone
di una serie di riflessi
istintivi, codificati nei cromosomi.
Nel corso dell'evoluzione sono
apparsi « strumenti »
(cioè organi) di vario tipo per
migliorare questa sopravvi
venza, il più raffinato dei quali è
il sistema nervoso, centraliz
zato nel cervello. II ruolo
principale della « corteccia », molto
svilup
pata nell'uomo, è quello di
conservare traccia delle esperien
ze (cioè memorizzare) e confrontare
continuamente le situa
zioni nuove che si presentano con i
ricordi precedenti, in
modo da riconoscere il « buono » dal
« cattivo » e migliorare
le possibilità di sopravvivenza. Per
questa ragione, di fronte a un «
premio » o una
« punizione », la parte istintiva
reagisce creando nella cor
teccia cerebrale le condizioni
chimiche per il fissaggio di una
nuova memoria (i nostri ricordi più
lucidi sono fatti di epi
sodi che più ci hanno colpito
emotivamente1, amori, pericoli,
risate, dolori, gioie, paure).
Questa rete di memorie si costruisce
sin dal primo gior
no di vita, attraverso percezioni
sensoriali tattili, auditive, vi
sive, di temperatura, che formano
tracciati sì-no associati tra
loro in modo sempre più complesso. II
« bene » e il « maie » vengono
identificati in situa
zioni che richiamano direttamente o
indirettamente una pre
cedente esperienza di « premio » o di
« punizione ». Tutti questi
meccanismi sono simili per gli uomini
e per
gli animali. Più si sale nella scala
dell'evoluzione, più aumen
ta il numero dei neuroni che «
elaborano ». Nell'uomo, il pre
mio e la punizione vengono
simboleggiati da « valori » o
principi morali, che presiedono
direttamente o indiretta
mente alla sopravvivenza. Questo
sembra essere, grosso modo, il
meccanismo di base che presiede
all'apprendimento. Esso mostra
chiaramente che la parte « istintiva
» e quella « razionale » sono
strettamente legate tra loro:
funzionano in simbiosi,
influenzandosi continuamente a
vicenda. I concetti, le parole, i
simboli entrano in « risonanza » con
le tracce mnemoniche del cervello
provocando emozioni; le emozioni a
loro volta provocano cambiamenti che
si ramificano in tutto l'organismo e
anche nella corteccia cerebrale. « Se
la faccio andare in collera, » mi
diceva il professor Eiduson
dell'Università di Los Angeles, «
posso osservare i cambiamenti che
avvengono nel suo organismo: per
esempio misurare l'aumento di certe
sostanze nel suo sangue. Attraverso
le parole, cioè, si possono provocare
cambiamenti biochimici, analogamente
a quanto avviene con un'iniezione. »
Imparare qualcosa significa
coinvolgere tutto questo sistema
vitale : attraverso l'astrazione del
linguaggio e della cultura il nostro
fisico reagisce a situazioni che
simboleggiano il « bene » o il « male
» (il premio o la punizione),
situazioni che accompagnano tutta la
nostra vita. Vogliamo provare a
vedere attraverso quale labirinto di
premi e punizioni passa un individuo
nel corso della sua esi-
stenza? Eccone un piccolo elenco:
ognuno può sbizzarrirsi ad aggiungere
altre situazioni, ma soprattutto può
sbizzarrirsi a pensare quante cose un
poveretto deve fare per cercar di
ottenere certe cose e per evitarne
altre. La caramella e lo
scappellotto; i voti alti e i voti
bassi; l'applauso e i fischi; il
piacere e il dolore; la promozione e
la bocciatura; l'onore e il disonore;
l'aumento di stipendio e il
licenziamento; il cavallo a dondolo e
il sacco di carbone; l'ammirazione e
il disprezzo; il guadagno e le
perdite; la vittoria e la sconfitta;
gli elogi e le critiche; i baci e gli
schiaffi; la croce di cavaliere e la
prigione; il paradiso e l'inferno.
C'è di che riempire una vita.
L'apprendimento da gradualmente
origine a scita del pensiero può
essere « auscultata
un'attività mentale organizzata. La
na anche attraverso ì battiti del
cuore.
vi • L'APPRENDIMENTO // cervello fa
le aste Torniamo ora al bambino nella
culla. La sua mente è ancora una
pagina bianca, anche se, come abbiamo
visto, sin dal momento della
fecondazione egli ha cominciato (come
del resto ogni organismo vivente) a
« imparare », nel senso che ha
conservato traccia nel suo corpo, e
anche nel cervello, degli «
adattamenti » sollecitati
dall'ambiente. Ma dal punto di vista
delle esperienze il bambino si
trovava, nel ventre materno, in
condizioni di « deprivazione »
estrema, più spinta che in qualsiasi
esperimento di laboratorio: cioè era
tenuto sempre al buio, a bagnomaria,
senza possibilità di vedere o toccare
oggetti, di muoversi, di annusare, di
avere esperienze. Spesso, guardando
un neonato, ci chiediamo : chissà a
che cosa pensa, come vede il mondo,
che senso ha per lui ciò che gli sta
intorno? (in fondo domande di questo
tipo ce le poniamo anche a proposito
di un gatto, di un cavallo o di una
gallina). La risposta è che un
bambino appena nato è ancora un feto,
dal punto di vista mentale, cioè
praticamente zero. Pian piano (ma con
enorme rapidità, se calcoliamo la
strada che percorre) incasella tutti
i dati di base per poter dar vita a
un'attività mentale organizzata. In
questo periodo il suo cervello « fa
le aste » o se vo-
gliamo ricorrere a un esempio
pianistico, saggia le note : un
pensierino organizzato è già
l'equivalente di una frase musicale,
che richiede una certa padronanza
della tastiera. « Le petit montagnard
» cerebrale è addirittura un picco
che esige un lungo apprendimento.
Durante tutto questo periodo il
pensiero è estremamente elementare,
molto simile nell'uomo e nell'animale
: le prestazioni mentali di un
bambino nel primo periodo di vita
(taluni affermano fino a un anno,
altri anche dopo) non sono molto
superiori a quelle di uno scimpanzè.
Probabilmente proprio per questa
ragione non conserviamo traccia dei
ricordi della prima infanzia : la
mente, in quel periodo, non è ancora
in grado di recepire e « incasellare
» ricordi organizzati, dando loro un
significato. Un neonato guarda gli
invitati al suo battesimo o un film
alla televisione come un analfabeta
può guardare i titoli di un giornale
: egli non sarà in grado di ricordare
questi titoli, anche se più tardi
imparerà a leggere. Proprio per
questo certi avvenimenti, che per noi
sono motivo di ilarità o di sdegno o
di paura, per il neonato non hanno
alcun significato. Se mancano gli
elementi per interpretarlo,
l'avvenimento perde il suo senso, e
viene così a mancare la « spinta »
emotiva (anche biochimica) per
ricordarlo. Egli può catturare
qualche frammento, che servirà poi
alla sua costruzione mentale, ma non
capirlo. I frammenti catturati sono
pezzi di un caleidoscopio non ancora
collegati fra loro per formare le
immagini di una vetrata. Prima
dell'alba La nascita della mente
avviene dunque gradualmente, così
come si passa lentamente dalla notte
al giorno. A che punto « fa chiaro »
per il bambino? Si dice spesso che
l'uomo si differenzia dall'animale
perché
l'animale sa, mentre l'uomo sa di
sapere. Ma a parte il fatto che tra
l'uomo e l'animale è esistita tutta
una gamma di esseri intermedi oggi
scomparsi e che rappresentano tutte
le varie tappe della « consapevolezza
» (australopiteci, pitecantropi,
zinjantropi ecc, che oggi non
sapremmo se collocare in uno zoo o in
un centro per ritardati mentali...)
questa consapevolezza così
tipicamente umana quando nasce nel
bambino? In quale momento il bambino
si differenzia mentalmente da un
animale e diventa un individuo che sa
di sapere! A tre mesi? A sei mesi? A
un anno? È evidente che si tratta di
un processo graduale, che è difficile
situare e datare: ciò che risalta con
più chiarezza sono i punti di
partenza e di arrivo. E appare
altrettanto evidente che all'inizio
il neonato si trova, come abbiamo già
visto, in un profondo buio mentale,
poiché la sua macchina cerebrale è
ancora priva di informazioni. Questa
particolare sua condizione mentale
tra l'altro potrà forse spingere
qualcuno a chiedere, in avvenire,
l'estensione al bambino, appena
uscito dal grembo materno, dello
stesso regime legale che esiste oggi
in certi paesi per il feto o per il
decerebrato : varie legislazioni
infatti considerano lecito sopprimere
un essere che non è ancora nato o un
essere che non ha più un'attività
mentale, vale a dire consentono
l'aborto e l'eutanasia legale dei
decerebrati in vista di trapianti.
Queste leggi in altre parole
permettono la soppressione di un
essere che non è ancora considerato
un uomo, o che non è più considerato
un uomo, proprio perché è privo di
quelle qualità mentali che lo
distinguono dal mondo animale o
vegetale. Il bimbo appena uscito dal
grembo materno, ancora legato dal
cordone ombelicale, è in pratica
nelle stesse condizioni di un feto :
molte voci si sono già levate perché,
in caso di gravissime deformità o
tare, i genitori, d'accordo con il
medico, possano porre termine, con la
eutanasia, a quella che sarebbe una
triste e dolorosa esistenza;
eutanasia che del resto veniva un
tempo esercitata dalla stessa natura
attraverso un'altissima morta-
lità infantile. È stata posta a molte
future madri la domanda: « Se vostro
figlio dovesse nascere con una
gravissima mostruosità, vorreste
comunque tenerlo oppure preferireste
che il medico, secondo precedenti
accordi, lo addormentasse per sempre
con un sonnifero, prima ancora che
voi abbiate potuto vederlo, dicendovi
che non aveva potuto sopravvivere per
via di una malformazione cardiaca? »
In gran parte le donne interrogate su
questo tragico dilemma sembrano
preferire, sia pure con dolore, la
seconda soluzione, in attesa di
riversare tutto il loro amore su un
prossimo figlio, che aspetta lui pure
il suo turno alla vita, il suo
diritto di nascere. * Al di là di un
problema straziante come questo, è
dunque evidente che alla nascita il
bambino è ancora avvolto nella sua
notte mentale, quella che precede
l'alba. Venendo al mondo egli entra
di colpo in un'oceano di sensazioni,
e tutti i suoi « canali » sensoriali
sono in grado di percepire e captare
i segnali provenienti dal mondo
circostante : luci, suoni,
temperature, contatti, odori, tutti
frammenti che costruiranno il mosaico
della sua mente. L'amore materno,
l'intelligenza degli esseri che gli
stanno intorno e la struttura sociale
del suo gruppo potranno permettergli
di organizzare le sue memorie e
diventare pian piano un individuo che
sa di sapere. Questa nascita della
mente oggi comincia ad essere «
auscultata » in un modo che può
apparire sorprendente : attraverso i
battiti cardiaci. / battiti del
pensiero « Auscultare » il cervello
attraverso il cuore non deve esser
considerata in realtà una cosa molto
sorprendente, poiché
come abbiamo visto nel capitolo
precedente, l'apprendimento coinvolge
uno stato emotivo, e le emozioni si
trasmettono alle funzioni cardiache e
viscerali. L'uomo è un insieme
solidale che non funziona per
compartimenti stagni; tutto
l'organismo partecipa, direttamente o
indirettamente, a ogni funzione.
Anche l'attività del cervello, in una
certa misura, può quindi essere
osservata ascoltando il cuore. «
Abbiamo effettuato parecchie ricerche
proprio in questa direzione, » mi ha
detto il professor J. Kagan,
dell'Università di Harvard. « Siamo
partiti da una constatazione. Se si
mostra a un adulto una fotografia che
rappresenta un paesaggio, o gli si fa
ascoltare una musica gradevole, il
suo battito cardiaco rallenta. Se
invece gli si presenta un problema
mentale da risolvere il battito
accelera. « Abbiamo provato ad
applicare lo stesso metodo ai bambini
di pochi mesi. Abbiamo così potuto
constatare che, se si presenta a un
bambino di sei mesi una maschera in
cui gli occhi sono al posto del naso
e la bocca è di traverso, il suo
battito cardiaco rallenta: il bambino
cioè non si pone problemi, lo
contempla così come si contempla un
paesaggio. Se invece gli si mostra la
stessa maschera quando ha dieci mesi,
si può notare un'accelerazione del
battito cardiaco. Cioè cerca di
capire, cerca di correlare. « II
bambino, in quel momento, sta
pensando. » Molti studi sono stati
effettuati utilizzando
l'elettrocardiogramma; è stato così
possibile misurare le variazioni del
battito dei neonati posti di fronte a
certe situazioni, e ci si è resi
conto che i ritmi cambiano a seconda
di ciò che essi vedono o sentono. In
generale, le cose che li spaventano
provocano un'accelerazione del
battito, quelle che li interessano lo
rallentano. Si è provato, per
esempio, a far ascoltare al bambino
un segnale sonoro : se esso raggiunge
l'intensità di 70 decibel quasi
istantaneamente, in pochi
millisecondi, il neonato chiude gli
occhi e il suo ritmo cardiaco
aumenta, segni evidenti di una
risposta di difesa. Se invece, lo
stesso suono raggiunge
ELETTROCARDIOGRAMMA
ELETTROCARDIOGRAMMA A sei mesi il
battito cardiaco di un barn- A dieci
mesi la stessa maschera provo- bino
posto dinanzi a una maschera come ca
un'accelerazione cardiaca. Il bambino
questa rallenta. Essa non rappresenta
percerca di capire, di •< rimettere a
posto » lui un problema, non vi è
nulla da capire. naso, bocca e
occhi Egli sta * pensando».
l'intensità massima nell'arco di due
secondi, il neonato apre gli occhi,
guarda intorno e il suo battito tende
a diminuire: questi sono segni di
interesse. È ancora troppo presto per
trarre qualsiasi conclusione da
queste prime ricerche; si sarebbe
però tentati di dire che quando la «
sopravvivenza » (nel senso lato che
le abbiamo dato nel capitolo
precedente) è messa in causa, si
verifica un'accelerazione; quando
invece una cosa è gradevole o non
presenta pericoli si verifica una
decelerazione cardiaca. È forse la
stessa differenza che può esistere
tra giocare a scacchi e pescare, tra
una attività eccitante e una
rilassante. Cioè se si cerca di
risolvere un problema mentalmente si
mettono in moto meccanismi di difesa,
che sono tanto più intensi quanto più
l'avvenimento richiede una
mobilitazione di energie. Anche uno
stesso fatto naturalmente può essere
« percepito » in modo diverso, a
seconda dell'intensità della
lampadina rossa di pericolo che si
accende nel cervello : questa
intensità è in pratica condizionata
dalle « schede » mentali che già vi
si
trovano. Per tornare all'esempio di
prima, se noi incontrassimo veramente
un individuo con gli occhi al posto
del naso, ci spaventeremmo, perché
siamo abituati a vederli in un'altra
posizione. Per qualcuno che non ha
mai incontrato un essere umano la
cosa non sarebbe invece così
sorprendente. Un esperimento curioso
è stato realizzato con dei polli :
cresciuti in isolamento, tenuti
lontano da qualsiasi oggetto mobile,
non si spaventavano alla vista di un
oggetto che si muoveva, per esempio
un cilindro di cartone. Polli
allevati in condizioni normali si
spaventavano. Alcuni ritengono che i
polli cresciuti normalmente vedessero
nel movimento un contrasto con le
precedenti esperienze di oggetti
mobili; non potendo quindi «
incasellare » questo movimento in uno
schema mentale precedente esprimevano
una reazione di paura. Una
discrepanza, un problema, un
contrasto sono dunque in grado di
stimolare biologicamente il cervello,
creando uno stato di attenzione o di
tensione che pone la corteccia
cerebrale in una condizione
biochimica più attiva, tale da
stimolare l'apprendimento. Il battito
cardiaco, dal canto suo, accelera per
pompare più sangue ossigenato, e far
fronte alle aumentate richieste di
energia. Una « novità » può essere
interpretata in vari modi, a seconda
delle « schede » già esistenti nel
cervello. All'origine vi è però
sempre una variazione ambientale. In
fondo tutto il nostro sistema nervoso
reagisce e si costruisce a partire
dagli stimoli che le cellule nervose
sono in grado di percepire (cioè le
variazioni rispetto a una situazione
precedente). Parliamo quindi ora di
questo concetto fondamentale, di «
variazione », citando un celebre
aneddoto. Variazioni su un tema Un
avvocato stava pronunciando un giorno
la sua arringa in tribunale, di
fronte a una giuria ormai stanca e
sonnec-
chiante. L'avvocato, visto il poco
interesse che le sue parole
suscitavano, si girò allora verso il
fondo della sala, interrompendo
l'arringa ed esclamando: « Chi ha
fatto entrare quel cavallo qui in
tribunale? » Non era vero, ma tutti
di colpo si svegliarono, cercando con
gli occhi il cavallo. La loro
attenzione era stata ridestata da un
fatto nuovo e inatteso, cioè da una
« variazione ». Qualcosa del genere
accade continuamente nella vita : noi
ci abituiamo presto a una luce, a un
rumore, a un odore, a una presenza,
ma se sopraggiunge una « variazione »
automaticamente scatta un meccanismo
di attenzione (che è poi un
meccanismo collegato alla
sopravvivenza): un leggero
scricchiolio nel silenzio è più
percettibile di un forte rumore
continuo come quello di un bull-
dozer; possiamo ignorare cento
persone che stanno parlando in una
sala, ma se di colpo tacciono, subito
ci guardiamo intorno; una voce
inattesa ci fa trasalire; entrando in
una stanza percepiamo odori che chi
vi si trova non sente più. Al di là
dell'interpretazione che il cervello
può dare a tutti questi fatti, in
base alle sue precedenti esperienze,
ampliando o riducendo lo stato di
tensione (per esempio a seconda che
l'odore nella stanza sia dovuto alle
sigarette o a una fuga di gas) resta
il fatto meccanico, sensoriale, che
il cambiamento intervenuto mette in
azione nuovi circuiti cerebrali e ciò
genera un richiamo d'attenzione.
Questi contrasti vengono spesso usati
di proposito nella vita per attirare
la nostra attenzione, variando o
alternando luci e suoni : basti
pensare ai segnalatori di svolta
nelle auto, ai lampeggiatori della
polizia, alle sirene « variabili »
dell'ambulanza, alle strisce colorate
nelle curve pericolose,
all'accendersi e spegnersi delle
insegne luminose, senza parlare di
tutte le tecniche pubblicitarie che
in quest'arte sono maestre. Per-sino
nel parlare ricorriamo a certe
variazioni di intonazione per rendere
il discorso più « vivace » e rialzare
l'interesse in chi ci ascolta.
Il neonato, forse ancora più di noi,
è stimolato da queste « variazioni »
: esse provocano in lui un riflesso
emotivo, creano attenzione,
interesse, e facilitano il fissaggio
di esperienze. Sono cioè alla base
dell'apprendimento. Per esempio, il
dottar Lipsitt, della Brown
University (N.Y.) che da molti anni
studia il comportamento nella prima
infanzia, ha osservato che in un
neonato aumenta l'eccitazione
respiratoria e cardiaca se gli si da
da annusare un nuovo odore; ripetendo
più volte la prova, però, egli si
abitua e la sua eccitazione
diminuisce. Riprende nuovamente se
gli viene presentato un altro odore.
Analogamente se gli si tocca un piede
in certe condizioni, il neonato lo
ritira per riflesso di difesa, ma
dopo un certo numero di ripetizioni
egli si rende conto che quell'azione
non costituisce una minaccia e non lo
ritrae più. Questa capacità di
adattarsi, di abituarsi, è già un
apprendimento, cioè un'esperienza che
viene immagazzinata, « incasellata ».
Del resto, nei bambini che soffrono
di danni cerebrali, questa capacità
di adattarsi (cioè di imparare)
risulta minore. Tutto ciò concorda
con le osservazioni fatte dal
professor Kagan, dell'Università di
Harvard. « II bambino alla nascita
possiede una tendenza innata (cioè
biologica) a prestar attenzione ad
avvenimenti che sono ricchi di
elevati contrasti. Per esempio, un
suono intermittente provoca
un'attenzione più marcata di un suono
continuo; accostamenti di colori,
come il bianco e il nero, creano un
< salto > che cattura la sua
attenzione. Ritengo che proprio per
questo il bambino sia interessato,
sin dalle prime settimane, agli occhi
della mamma, che costituiscono per
lui un punto d'attrazione. » In
questa chiave si può meglio capire
anche l'importanza della intonazione
di voce, di cui parlava Papusek a
proposito del linguaggio (« molto più
importanti delle parole, in questo
periodo, sono le intonazioni, le
modulazioni »). Il bambino, come
l'adulto, ha bisogno di « novità »,
nel
senso più esteso della parola: egli
si abitua presto a un certo stimolo.
Riprende interesse se questo viene
variato, anche di poco. L'attesa di
novità Questa azione di stimolo che
svolgono i contrasti, le variazioni,
le modulazioni, viene certamente a «
ingranare » in un meccanismo
cerebrale congenito, che non si
conosce ancora bene. Si ha
l'impressione, infatti, osservando il
comportamento degli animali e
soprattutto dell'uomo, che esista una
specie di bisogno biologico di
novità. Questo bisogno di stimoli
sembrerebbe analogo alla necessità di
movimento, di calore o di contatto di
cui parlavamo in un precedente
capitolo: si direbbe parte della vita
stessa, e potrebbe spiegarsi con la
necessità che hanno le membrane
cellulari di « polarizzare ». e
quindi di « scaricare » grazie al
passaggio di stimoli, proprio perché
ciò rientra nella loro attività
vitale. Il bisogno di « variazioni »
(e quindi di novità, di informazioni)
è stato osservato ovunque in natura.
Si potrebbe ricordare, a titolo di
esempio, il celebre esperimento in
cui una scimmia, chiusa in un cassone
di legno, effettuava certi esercizi
per ottenere come ricompensa
l'apertura di una finestrella che le
consentiva di guardar fuori, anche se
fuori non succedeva nulla. La novità
(o meglio l'attesa di novità)
funzionava come nocciolina, come
premio. Noi stessi viviamo di «
attese » : attendiamo sempre che
qualcosa succeda. Quando mi capita di
scrivere in ufficio con la porta
aperta e sento dei passi in
corridoio, alzo automaticamente la
testa per vedere chi passa, anche se
so benissimo che è sempre la solita
gente che a sua volta guarda
automaticamente nel mio ufficio.
Queste « attese » esistono
naturalmente quando comperiamo un
giornale o accendiamo la radio per
ascoltare le notizie.
quando leggiamo un libro o
assistiamo a un film. Ci annoieremmo
se dovessimo rileggere lo stesso
giornale, le stesse notizie, o
rivedere lo stesso film (tanto più se
era a « suspen-ce », cioè con una
forte « attesa »). Il neonato è in
una situazione analoga. Egli « cerca
» le variazioni, e quando lo si mette
in condizione di regolare a
piacimento lo stimolo, non solo si
diverte a « esplorare » queste novità
ma si trova nelle condizioni migliori
per imparare, poiché è compensato
nelle sue attese ed è in grado di
modificare il volume d'ingresso degli
stimoli, regolandolo da solo.
Interessanti esperimenti hanno
mostrato che il neonato, posto in
queste condizioni, da prova di
capacità finora insospettate di
imparare (e anche di annoiarsi). Il
dottar Lipsitt, ad esempio, ha
inventato un curioso congegno che
consiste, grosso modo, in un
succhiotto collegato
con un potenziometro: più il bambino
succhia più un'immagine proiettata su
uno schermo si illumina. Il bambino,
a soli tre mesi, impara rapidamente
ad associare i due fatti e si diverte
a « teleguidare » la luminosità
dell'immagine, succhiando più o meno
forte. Egli impara rapidamente anche
l'esercizio opposto, cioè a succhiare
meno per ottenere l'immagine più
vivida. Ma la ripetizione
dell'esercizio lo annoia : il suo
interesse riprende se nel meccanismo
viene cambiato qualcosa che provochi
una variazione, anche piccola.
Analoghe prove sono state fatte
collegando il succhiotto con un
registratore, permettendo così al
bambino di teleguidare l'intensità
del suono. La precocità dei neonati,
in questo genere di prove, è
veramente sorprendente.
All'Università di Edimburgo il
professor Brower ha realizzato
quest'altro esperimento. Un bebé di
cinque settimane è stato messo in una
specie di tettino, che aveva al posto
del cuscino uno speciale dispositivo:
ai lati della testa aderivano due
tavolette imbottite che fungevano da
pulsante, in modo che appoggiando la
testa a sinistra o a destra il
bambino faceva scattare un sistema
elettronico. Questo sistema
elettronico provocava l'accensione di
una piccola luce davanti al viso del
bambino e il contemporaneo squillare
di un campanello. Brower aveva
regolato il dispositivo in modo che
solo girando la testa a destra si
potessero provocare luce e suono. In
breve tempo il bambino imparò il
movimento giusto, compiendolo poi di
proposito, per divertirsi a far
scattare il suono e l'apparire della
luce. Gli sperimentatori provarono
allora a rendere l'esercizio sempre
più difficile, e si resero conto che
un bebé di appena cinque settimane
era in grado di imparare da solo una
manovra assai complessa, come quella
di dover spostare la testa due volte
a destra e una a sinistra per
ottenere come « premio » la luce e il
suono ! Già in esperimenti come
questi si può intravedere in em-
brione quello che sembra il
meccanismo principe di un
insegnamento efficace : porre il
bambino in condizione di essere egli
stesso il protagonista del suo
apprendimento. Vale a dire
procurargli tutti gli elementi
necessari (ambiente, stimoli,
strumenti, premi) affinchè sia in
grado di « cavalcare » e guidare
queste spinte sincronizzando i tempi,
le distanze, i ritmi
dell'apprendimento con le sue
capacità. Egli si trova così nelle
migliori condizioni per imparare,
perché entra allora in azione la
tendenza innata a esplorare, il
desiderio di ottenere una ricompensa,
e la possibilità di autoregolarsi.
Tutto ciò si può riassumere in un
concetto di cui torneremo a parlare
più avanti : occorre che il bambino
possa esercitare la sua curiosità, la
sua iniziativa, e che quindi venga
messo nelle situazioni adatte per
sviluppare queste qualità, senza che
gli vengano inseriti dei modelli e
delle formule già bell'e pronte, tali
da scoraggiare l'immaginazione (che è
lo strumento essenziale per pensare e
quindi per arricchirsi mentalmente).
Come dice un detto ormai celebre
della moderna psicologia : ogni volta
che si insegna qualcosa a un bambino
gli si impedisce di scoprirla da
solo. Da spettatore a protagonista II
desiderio del neonato di condurre da
sé le sue esperienze è già evidente
anche nel gioco. Sempre alla Brown
University (N.Y.) il dottar Lipsitt
ha effettuato, assieme al dottar
Siqueland, esperimenti assai
significativi. Sopra la culla di un
bambino di tre mesi ha appeso una
serie di pupazzetti, legati insieme
da fili e bilancieri (del genere
mobiles). Poi li ha collegati al
polso del neonato con una cordicella,
in modo che il bambino, ogni volta
che muoveva il braccio, provocava
spostamenti del mobile, facendo «
danzare » i pupazzetti. Il piccolo si
rendeva subito conto di essere il re-
L'interesse è più vivo {e
l'apprendimento più attivo) quando è
il bambino che « con
trolla » la propria stimolazione,
quando cioè partecipa da protagonista
e non da
spettatore. (Lipsitt) sponsabile di
questa danza, e agitava il braccio
per provocarla, sorridendo. A questo
punto la cordicella veniva slacciata
: il bambino continuava ad agitare il
braccio, ma non accadeva più nulla.
Egli allora cominciava a piangere.
Riallacciando il cordino, tornava ad
agitare il braccio e a sorridere
vedendo riapparire la danza provocata
dai suoi movimenti. Un gioco
infantile? Certo, dicono i dottori
Lipsitt e Sique-land, però esso mette
in evidenza anche un principio
importante, lo stesso mostrato
dall'esperimento succhiotto-scher-mo
visivo: i piccoli sono più
interessati, mantengono un'attenzione
più prolungata e imparano le cose più
facilmente, quando sono essi stessi a
controllare la propria stimolazione.
Queste osservazioni, e molte altre
ancora, indicano chiaramente che la
scelta dei giocattoli, sin dalla
primissima età, è assai importante :
il giocattolo è, in un certo senso,
il primo strumento culturale con cui
il bambino si trova in contatto. È un
po' come la madre: deve permettere un
« dialogo », of-
frirgli il modo di « variare » le
situazioni, deve stimolarlo a
pilotare il rapporto, e offrirgli
esperienze che siano alla sua
portata, permettendogli di progredire
nella scala delle conoscenze. Abbiamo
visto dettagliatamente quanto il
neonato si « adatti » biologicamente
alle situazioni ambientali sin dal
primo periodo di vita: anche i
giocattoli, nel loro ambito,
contribuiscono a questo adattamento.
Vi sono giochi in cui il bambino è
semplicemente spettatore, altri in
cui il bambino è protagonista, che lo
abituano, cioè, a prendere
iniziative, a scegliere, e quindi a
pensare. Ancora oggi la scelta dei
giocattoli non tiene sufficientemente
conto di tutte le più recenti
scoperte nei meccanismi del cervello.
Esistono giocattoli apparentemente
belli ma sostanzialmente idioti, che
non offrono nulla al bambino, altri
da pochi soldi che lo possono invece
stimolare nel modo giusto. Tutto è
lasciato al caso: da un lato alle
capacità e alle conoscenze dei
costruttori di giocattoli, dall'altro
alle scelte dei genitori, delle zie,
delle nonne. È un campo in cui molto
rimane ancora da fare. Per questa
ragione il professor B. White,
dell'Università di Harvard, non ha
esitato a farsi lui stesso
progettista di nuove girandole,
palloncini e pupazzi (costruiti ora
in serie), ritenendo che anche i
giocattoli che si mettono nella culla
debbono essere studiati su misura, e
adatti ai vari stadi dello sviluppo
mentale. A Boston sono andato col
professor White in casa di madri che
avevano applicato questi giocattoli
nella culla, e ho potuto vedere
quanto interesse portavano i bimbi a
questi nuovi giochi : piccoli
trapezi, eliche che giravano a
pressione, specchi per vedere la
propria immagine riflessa. Tutti i
giocattoli erano fissati sopra la
culla, in modo da essere sempre nel
campo visuale del bambino e a portata
della sua mano (mentre di solito il
neonato « perde » il suo giocattolo
tra le coperte). « Le nostre
osservazioni, » dice White, «
confermano i la-
vori del celebre psicologo svizzero
Jean Piaget : più cose il bambino
esperimenta nel primo periodo di
vita, più sarà motivato a farne delle
nuove, e più l'intelligenza crescerà.
» Sono assai lontani i tempi in cui
un bambino veniva fasciato come un
salame, con le braccine dentro, e
veniva lasciato « riposare » in
silenzio, in modo che si sviluppasse
senza esser disturbato : questo modo
di vedere il neonato sì riallaccia
all'idea, radicata ancor oggi per
quanto riguarda la vita adulta, che
l'uomo possieda sin dalla nascita un
« se stesso » autonomo che si
sviluppa, come per incanto; un « se
stesso » che sarà poi anche alla base
delle future « libere scelte » della
sua vita. Riprenderemo ampiamente
questo discorso nell'ultima parte del
libro. Per ora notiamo che questa «
deprivazione » nella prima infanzia
viene oggi contestata anche nei suoi
aspetti più innocenti, come il
tradizionale velo bianco che avvolge
la culla. « II fatto è, » dice sempre
White, « che un bambino di tre
mesi si annoia nella culla. Se lei
riflette un attimo, e immagina di
mettersi nelle stesse condizioni di
un neonato, cosa vedrebbe? Solo
drappi bianchi tutt'intorno, veli e
soffitto bianco. Un ambiente per
nulla interessante. « Noi abbiamo
provato, invece, a togliere tutte
queste bardature, e abbiamo visto che
i bambini alzavano la testa e
guardavano incuriositi tutfintorno.
Io penso che in questi primi mesi di
vita un neonato può interessarsi a
tutte le cose che lo circondano. Non
deve imparare cose specifiche, ma
nutrire sin dall'inizio la sua
curiosità. » // gioco La curiosità
del bambino deve potersi nutrire, del
resto, a ogni età, come anche il suo
innato desiderio di esplorare, di
avere nuove esperienze, di
immaginare. In questo senso il gioco
svolge un ruolo di primissimo piano.
È infatti « giocando » che un bambino
comincia a conoscere gli oggetti (nel
primo periodo anche con la bocca che
è per lui un efficace mezzo di
conoscenza); è « giocando » che egli
simula situazioni immaginarie,
inventando situazioni e personaggi,
ed è sempre « giocando » che comincia
a socializzare con i coetanei. Noi
adulti non ci rendiamo abbastanza
conto dell'utilità del gioco nello
sviluppo del bambino: lo consideriamo
soprattutto un divertimento, mentre
in realtà è una vera e propria scuola
che permette al piccolo di entrare in
contatto con oggetti, situazioni,
persone, problemi, regole. È un suo
modo di apprendere, di entrare nella
realtà. Se fossimo capaci di
sfruttare meglio le immense risorse
del gioco riusciremmo ad ottenere
risultati insospettati. Oggi siamo
ancora molto primitivi in quest'arte
e penso che siamo dinanzi a un mondo
ancora tutto da scoprire. Molti
psicologi da tempo studiano i
meccanismi del gioco
e il loro ruolo nella crescita
mentale del bambino, ma a livello di
genitori ancora molto poco si sa su
questo argomento. In un prossimo
capitolo parleremo della « scuola per
genitori », che potrebbe essere
realizzata sia attraverso corsi sia,
soprattutto, attraverso la
televisione: in questa prospettiva
credo che insegnare a un genitore a
giocare col proprio figlio sarebbe
uno dei compiti educativi più utili.
Intanto sarebbe bene cominciare a
osservare il gioco con uno sguardo
nuovo, non considerandolo soltanto un
divertimento, o peggio ancora uno
stratagemma per fare star buono il
bambino. Dobbiamo abituarci invece, a
considerarlo un vero « lavoro » per
il piccolo, un lavoro che egli compie
volentieri perché tocca tutte le sue
corde più sensibili (autoregolazione,
attese, novità, premi, successi).
Pensate in quanti modi potremmo
utilizzare questo torrente emotivo,
inserendo degli insegnamenti
mimetizzati, che verrebbero portati
avanti senza sforzo dalla corrente.
Già oggi esistono molti giocattoli «
educativi » ma dovrebbero essere
diffusi in maggior numero (e sarebbe
del resto, augurabile che
pedagogisti, inventori, artisti,
scienziati, si dedicassero con vero
impegno creativo a questo
delicatissimo compito). Ma non
bastano i giocattoli: occorre che i
genitori, la scuola, la televisione
scoprano meglio questo nuovo mondo e
offrano maggiori materiali e
opportunità al bambino di arricchirsi
attraverso giochi intelligenti e
anche attraverso un modo di
apprendere più facile e divertente.
Non si tratta naturalmente di «
burocratizzare » l'immaginazione, che
è un fatto personale e creativo, e
neppure di assillare inutilmente il
piccolo, quanto piuttosto di
migliorare i rapporti educativi (e
scolastici) grazie a uno sforzo di
fantasia, cercando di comunicare
grazie a « canali » che possono
essere meglio captati dal bambino. È
una tecnica che vale non solo per il
mondo dell'infanzia, ma anche per
quello degli adulti. E torna qui alla
mente l'aurea regola latina tanto
citata e così poco applicata Lu-
dendo docere: una massima che
dovrebbe essere scritta a grandi
lettere all'ingresso delle scuole e
degli studi televisivi. Insegnare
divertendo dovrebbe diventare un
dovere, alla luce di tutte le più
recenti scoperte scientifiche, che
mostrano come funzionano certi
meccanismi mentali. Invece esiste,
solitamente, una tendenza sciocca a
separare le cose « serie » dalle cose
« divertenti », considerando le prime
di serie A, le seconde di serie B. A
parte il fatto che un tale
atteggiamento non aiuta l'insorgere
del senso dell'umorismo (qualità
indispensabile a ogni uomo civile) si
tende, in pratica, a rendere noiose
cose che potrebbero essere
estremamente interessanti. «
Divertire » significa infatti, in
termini più generali, destare
interesse; significa toccare le leve
profonde (anche biologiche)
dell'apprendimento e facilitare
l'incontro tra un cervello e un
avvenimento. È di questo « incontro »
che vorremmo ora parlare un po' più
diffusamente, esaminando quelli che
sono i meccanismi dell'apprendimento
sia nel bambino sia nell'adulto. Alla
base di tutto sembra esservi l'«
interesse » per un avvenimento:
interesse inteso in senso lato
(divertimento, emozione, attenzione
ecc.) che permetta di realizzare il
collegamento tra informazione e
memoria, grazie a una corretta
lunghezza d'onda.
Una sfida mentale accettabile
stimola l'interesse e l'attenzione
del bambino questo modo egli « impara
ad imparare ».
VII • L INCONTRO Incomprensione per
eccesso Se ci trovassimo di colpo in
una città della Finlandia, dove si
parla solo il finlandese, e
assistessimo al comizio di un uomo
politico, non potremmo conservare
alcun ricordo di ciò che l'oratore ha
detto. Potremmo capire che si è
arrabbiato o che si è commosso (a
seconda delle sue intonazioni),
potremmo cominciare a familiarizzarci
con i suoni della lingua, ma saremmo
incapaci di dare un significato
qualsiasi al suo discorso. Dopo un
po' ci annoieremmo e perderemmo
interesse anche a questi suoni.
Rimanendo però molti anni sul posto,
cominceremmo a capire le prime parole
semplici, poi le frasi, poi i
concetti, e infine anche gli oratori.
Il bambino, venendo al mondo, si
trova in una situazione simile, anzi,
ancora più difficile, perché non ha
punti di riferimento per interpretare
ciò che accade intorno a lui: deve
imparare tutto. L'esempio
dell'oratore (che permette anche di
capire meglio perché non siamo in
grado di conservare ricordi di
avvenimenti di cui siamo stati
testimoni sensoriali nella prima
infanzia) spiega quale dev'essere la
chiave per insegnare qualcosa a un
bambino : occorre essere il più
vicino possibile al suo mondo
mentale, alle sue capacità del
momento. Occorre spiegargli il senso
di una parola, la funzione di un
oggetto, ripetere, interessarlo.
L'importante è la « distinzione »
degli
stimoli, non la loro quantità : per
imparare il finlandese non serve
qualcuno che faccia un discorso, ma
qualcuno che insegni una parola alla
volta. È più utile capire poche cose
che non capirne molte. Al limite
sarebbe possibile « deprivare » un
bambino proprio per eccesso,
collocandosi al di sopra delle sue
possibilità, e creando un mondo per
lui incomprensibile. Questo accade
spesso, del resto, nella vita: nella
scuola, nelle manifestazioni
culturali, nell'informazione si è
spesso « al di sopra » di coloro che
dovrebbero capire. Se il messaggio
non arriva (e la gente si orienta
verso altre scelte culturali) la
colpa non è di chi non può ricevere,
ma di chi non sa trasmettere.
Torneremo a parlare di questo
argomento importantissimo, che a mio
avviso è alla base di molti problemi
del nostro tempo. Infatti nella vita
sociale, politica, ma soprattutto
culturale, la « comunicazione »
troppo spesso non avviene, per
incapacità, negligenza, snobismo o
calcolo di chi dovrebbe compierla. I
messaggi passano alti sulla testa di
chi dovrebbe riceverli: ciò (è bene
saperlo) equivale a una forma
deliberata di « deprivazione »,
equivale cioè a un furto neurologico
nei confronti di chi dovrebbe
arricchirsi mentalmente e non è
invece in grado di capire, perché chi
ha il compito di comunicare non ha la
capacità (o l'umiltà) di spiegare. Il
meccanismo mentale del bambino è
uguale a quello dell'adulto, anche se
a un livello molto più elementare.
Vediamo dunque in quale modo egli «
aggancia » le informazioni dal mondo
esterno. Una sfida accettabile Ancora
una volta ricorriamo al gioco di
LEGO. Come per i « montaggi » delle
molecole primitive, o del DNA, O del
linguaggio o delle idee, così per la
costruzione della mente esiste
una gradualità. Si comincia con i
pezzi più semplici, poi via via si
uniscono insieme nuovi elementi, fino
a montare strutture sempre più
complesse. Quello che è importante,
oltre a questa gradualità, è che i
nuovi pezzi possano attaccarsi a
quelli che già esistono, che trovino
i punti di aggancio adatti. Se questa
regola viene rispettata, il bambino
troverà sempre qualcosa che lo
interessi, perché la « novità » sarà
rappresentata da un pezzo nuovo che
egli sarà in grado di capire e che
potrà agganciare alla sua costruzione
mentale (« premiando » così la sua
attesa). Le osservazioni degli
psicologi mostrano infatti che sin
dall'inizio il bambino comincia a
interessarsi a cose « legger-mente
diverse da quelle familiari » : esse
diventeranno a loro volta familiari e
forniranno la base ad altre cose «
legger-mente diverse ». Se questo
meccanismo non viene rispettato
l'apprendimento è reso più difficile,
o addirittura non avviene. Molti
ricercatori tentano oggi di definire
meglio questa scala di sviluppo, e di
osservare, in pratica, in quale modo,
con quale concatenazione di eventi il
bambino salga i gradini della
conoscenza. Uno degli psicologi che
hanno maggiormente studiato questa
gradualità nello sviluppo è il
professor Hunt, dell'Università
delFIllinois. Egli ha cominciato col
mostrarmi un esempio semplice,
verificabile in ogni bambino. « II
bambino può risolvere certi problemi
solo procedendo in un certo ordine, »
dice Hunt. « Prendiamo ad esempio una
scatola come questa, che noi usiamo
nelle nostre prove mentali. Lei vede
che qui vi sono buchi di varie forme:
il bambino deve cercare di infilare i
vari pezzi, in modo che ognuno trovi
il buco adatto, cominciando dai pezzi
più semplici. Naturalmente procederà
per tentativi, sbagliando, ma
riuscirà a vincere le difficoltà
procedendo per gradi. Se però si
comincia a dargli subito quest'ultimo
pezzo, il più difficile, egli non
soltanto non riuscirà, ma si
stancherà presto e finirà col
disinteressarsi. Gli mancherà quello
che io chiamo il
rispondere bene a queste esigenze,
permettendo al bambino d cesso con un
giusto sforzo. Occorre però che
questa » sfida » delle sue
possibilità (e dei suoi interessi).
fungere il suc-:ri nella gamma
< match>, cioè la possibilità di
incontrarsi con un problema che sia
alla sua portata e che provochi una
sfida mentale accettabile. Questo
match esiste sempre in ogni forma di
apprendimento, anche da adulti :
quando il problema è fuori portata
subentra il disinteresse. » « Lei
ritiene che quando vi è questo
incontro, il bambino si interessi,
non si stanchi e l'apprendimento
quindi diventi per lui un piacere? »
« Esattamente. Spesso i genitori
pensano che il bambino non debba
essere sforzato, ed è giusto : però,
in realtà, quando viene sforzato un
bambino? Quando si cerca di
insegnargli qualcosa che non è in
grado di capire. Il problema, invece,
sta nel saper svegliare il suo
interesse: è questo, io credo, uno
dei segreti dell'educazione. In altre
parole l'abilità della madre sta nel
rendere interessanti al bambino le
cose che
deve imparare, nel metterle alla sua
portata, senza imporgli certe cose a
viva forza. « Capisco, naturalmente,
che per una madre non è sempre un
compito facile; però è questo il
modello a cui si deve cercare di
tendere, a mio parere, perché è
proprio così che il bambino ritrova
il piacere di imparare, e si
arricchisce mentalmente. Spesso noi
osserviamo differenze enormi tra
bambini educati diversamente: in
certi casi una stessa fase dello
sviluppo mentale può essere raggiunta
a un anno oppure a tre anni, a
seconda dell'ambiente. » Imparare a
imparare Chiariamo subito, anche se
avremo occasione di riparlarne in
seguito, che non si tratta di
utilizzare questa tecnica
d'apprendimento come una pompa da
bicicletta per gonfiare il cervello
del bambino di cose che sono estranee
ai suoi interessi reali. Non avrebbe
senso, per esempio, ammaestrare un
bambino a leggere le quotazioni di
Borsa a tre anni. Eppure molti
genitori (come certi maestri), spesso
tendono a confondere educazione con
erudizione. Ne risultano dei poveri
bambini che scimmiottano
atteggiamenti o nozioni che non
appartengono ai loro interessi, ma a
quelli dei loro genitori. Per non
uscire dal circuito d'amore dei
genitori, a volte il bambino riesce a
compiere certe cose spinto più dalla
paura di sbagliare che da un vero
interesse. Questo è un danno grave.
Se le recenti scoperte mostrano che
il bambino è assai più precoce di
quanto si crede (il professor Bruner
di Harvard afferma addirittura, con
un ottimismo non da tutti condiviso,
che qualsiasi materia può essere
insegnata, in ogni fase dello
sviluppo in modo adeguato), ciò non
significa che sia possibile, o
opportuno, accelerare le varie fasi
oltre un certo limite. In primo luogo
perché esistono dei processi di
maturazione
nervosa del cervello (ne abbiamo
parlato nel 2° capitolo) che si
prolungano nel tempo dopo la nascita,
fin quasi all'età di dieci anni, e
che probabilmente limitano certe
capacità, ma soprattutto perché
accelerando queste fasi non ci
sarebbe molto da guadagnare. È come
se si volesse far crescere in altezza
un bambino per farlo diventare alto
un metro e ottanta all'età di sei
anni : a parte un'impossibilità
fisiologica sarebbe un obiettivo
completamente sbagliato. Un bambino
per diventare un « atleta della mente
» deve, come un futuro campione,
accumulare « materiali atletici »
nelle sue strutture cerebrali : i
risultati si faranno già sentire
nelle varie fasi, ma soprattutto a
distanza. In pratica ciò significa
che il bambino, più che imparare
delle cose, deve « imparare a
imparare ». È una regola
fondamentale, che ricorda la famosa
massima di un filosofo cinese: « Se
un uomo ha fame non regalategli un
pesce, poiché mangerà solo un giorno:
insegnategli a pescare, e mangerà per
il resto della vita. » Ebbene,
bisogna insegnare a « pescare », al
bambino, cioè a pensare, immaginare,
capire. Non ha molto importanza se
non sa compiere certi esercizi da «
enfant prodige », o se non sarà il
primo della classe (ciò potrebbe
costituire piuttosto un segnale
d'allarme, visto il nozionismo
tuttora imperante nella scuola,
malgrado la retorica anti-
nozionistica); è importante, invece,
che impari a ragionare, a rielaborare
le sue « schede », ad associare le
memorie montandole in modi sempre
diversi e adattandole alle nuove
situazioni. È questa una « abitudine
» che si prende sin da bambini, ed è
un'eccellente abitudine, perché
permetterà a un individuo di disporre
di una maggiore ricchezza inferiore e
di affrontare meglio la vita. Spesso,
guardando al futuro di un bambino, i
genitori si orientano verso un
obiettivo concreto: medico, avvocato,
ingegnere. È comprensibile questa
preoccupazione di « siste-
mare » il figlio in una certa
casella: personalmente, però, penso
che si deve stare attenti a non
puntare a un successo tattico
commettendo un errore strategico. Nel
mondo di domani, dove tutto cambierà
a una velocità altissima, sarà
soprattutto necessario disporre di
grandi capacità mentali di
adattamento : occorrerà saper
comprendere molto più in fretta,
immaginare soluzioni nuove,
aggiornare le idee. Per un genitore è
importante capire che suo figlio più
ancora che un ingegnere o un medico,
deve saper diventare un uomo. Questa
costruzione comincia sin dall'inizio,
stimolando nei piccoli la curiosità,
l'interesse, il ragionamento,
l'immaginazione. Non bisogna quindi
confondere il bersaglio : non si
tratta di insegnare al bambino delle
cose, ma insegnare a imparare
attraverso le cose. Le domande e le
risposte Torniamo ora al concetto di
« incontro », che è essenziale per
capire meglio il meccanismo
dell'apprendimento, non solo nel
bambino, ma anche nell'adulto. Se
prendiamo un foglio di carta
dattiloscritto e lo mettiamo a un
centimetro dall'occhio, oppure a
venti metri, non riusciamo a leggere
neppure una parola. Per il cervello
accade qualcosa di molto simile:
esistono zone « buone » in cui
l'avvenimento può esser messo a fuoco
mentalmente, e diventare percepibile
: al di qua e al di là di questi
limiti non solo è fatica sprecata
insegnare, ma si « depriva » un
individuo di informazioni con cui
esercitare la propria intelligenza e
creatività. Se si afferra bene questo
concetto, insegnare a un bambino può
diventare un'avventura appassionante,
perché egli è già in grado sin da
piccolo di « rispondere » e imparare
cose
insospettate. Il segreto sta nel
metterlo in contatto con oggetti,
situazioni, giocattoli, avvenimenti
che possano « agganciarsi » con la
sua struttura mentale : cioè
proporgli problemi ed esperienze che
siano alla sua portata, che
sollecitino le sue attese e che
comportino un premio (anche il
sorriso della madre è già un premio).
Per l'apprendimento del linguaggio
esistono (lo abbiamo visto in un
capitolo precedente) alcune regole
essenziali : parlare molto, ripetere,
spiegare. Anche per ogni altro
apprendimento valgono regole
analoghe: dare molte occasioni al
bambino di manipolare oggetti (anche
oggetti semplici che si trovano in
casa), spiegarne il funzionamento,
ripetere. Inventare piccoli problemi
che possano creare interesse nel
bambino, rispettare una gradualità.
La stessa cosa vale per i suoni : un
fondo musicale gradevole di una
musica classica comincerà ad affinare
il suo orecchio a un tipo di musica
che egli non troverà più « estranea
». una volta adulto. Tutto ciò non
deve prendere, naturalmente, la forma
di un'assillante imposizione : non
bisogna cadere nell'eccesso opposto
di vedere il bambino come un imbuto
biologico, nel quale rovesciare
torrenti di stimoli e impulsi,
nutrendolo a forza come si fa con le
oche di Strasburgo. Bisogna
rispettare i suoi istinti, attendere
le sue aperture, non deludere le sue
attese, ascoltare i suoi perché. Fare
in modo che sia lui a porre le
domande. Se si riesce a educare il
bambino più con le sue domande che
con le nostre risposte, si è
certamente ottenuto un grande
successo. Può darsi che il bambino
non capisca tutto quello che gli si
spiega, o che non lo ricordi, perché
magari mentre si parla stava già
pensando ad altro. Ma non ha
importanza. L'importante è che egli
« senta » questo circuito a due
sensi, questo tennis di punti
interrogativi ed esclamativi che
circola intorno a lui, e che nutra la
sua attitudine a esplorare, a sapere.
È importante che continui a porre
delle domande, perché
anche più tardi, nella vita, sarà
questa curiosità mentale a
permettergli di non accontentarsi
delle risposte. Le risposte sono
sempre limitate, provvisorie,
insoddisfacenti. Le domande invece
sono il vero motore dell'attività
mentale : un uomo che non si pone
domande, o che si contenta delle
risposte, non va molto lontano.
L'uomo deve dubitare: il dubbio è un
atteggiamento di ricerca, di
esplorazione : la certezza,
soprattutto quella ideologica o
dogmatica, possono forse renderlo più
integrato, e in un certo senso più
felice, ma con un costo intellettuale
molto elevato, che è quello della sua
rinuncia a dubitare, esplorare, e
quindi a pensare. Questo
atteggiamento creativo non viene oggi
incoraggiato nell'educazione, e tanto
meno nella scuola o in politica.
Eppure è il solo atteggiamento
mentale che potrebbe aiutare i nostri
figli a trovare, con rapidità
crescente, gli adattamenti giusti per
una sopravvivenza che sta diventando
sempre più difficile. / diligenti co!
biberon L'educazione del bambino,
vista in questa prospettiva, assume
quindi un significato ancor più
vasto: la futura classe dirigente di
domani, in questo momento, sta
succhiando il biberon o giocando con
il cavallo a dondolo. È in questo
momento che le madri possono, e
debbono, intervenire per aprire la
loro mente e aiutarli a diventare
uomini del loro tempo, capaci di far
fronte a situazioni in trasformazione
sempre più rapida. Esse debbono sin
d'ora abituarli a sviluppare
l'immaginazione, a essere creativi e
aperti a ogni novità. La qualità
essenziale che distingue l'uomo
dall'animale è una maggiore capacità
di rielaborare le proprie « schede »
(condizionanti) inserite
dall'ambiente, e creare «
combinazioni » mentali nuove. È
questa qualità che consente di
costruire nuove idee e di adattarle
alle situazioni mutevoli dell'ani-
biente, per vivere meglio, o in casi
di emergenza, anche per sopravvivere.
L'animale sopravvive nel suo ambiente
soprattutto attraverso una selezione
fisica degli organismi; l'uomo oggi
può sopravvivere soltanto attraverso
una selezione mentale delle idee. In
natura i cambiamenti ambientali
avvenuti nel corso di milioni di
secoli hanno provocato un continuo
adattamento degli organismi viventi :
ciò è potuto accadere proprio perché
questi cambiamenti sì estendevano su
tempi molto lunghi, e consentivano
alla vita di tenere il passo grazie a
continue mutazioni genetiche che
offrivano « spunti » biologici sempre
nuovi. Oggi, nel campo delle idee,
gli adattamenti mentali nor riescono
più a tenere il passo nei confronti
delle mutate condizioni ambientali.
Questo « scollamento » comporta
rischi gravissimi. Quando si è
verificato in natura (per esempio
sotto forma di brusche variazioni di
clima) ha provocato la scomparsa
delle specie animali che non
disponevano dì una sufficiente
velocità di adattamento. Oggi ci
troviamo, paradossalmente, in una
situazione simile. Non disponiamo di
uno sviluppo mentale sufficiente per
amministrare in modo intelligente
l'enorme sviluppo tecnologico degli
ultimi decenni. Maneggiamo
quotidianamente « bombe atomiche »
ben più dirompenti di quelle di
Hiroshima, come la penicillina. La
penicillina (è solo un esempio tra i
tanti) ha modificato radicalmente
certi equilibri biologici, provocando
(unitamente ad altre « tecniche ») un
aumento verticale della popolazione;
a questo squilibrio non è stato posto
ancora rimedio, né si prevede che lo
si potrà porre in tempo utile, anche
a causa di « morali » che si
applicavano a tempi e situazioni in
cui non esistevano gli antibiotici.
La generazione che cresce dovrà
essere allenata a un adattamento
mentale molto più rapido, se vuole
risolvere i problemi del suo tempo :
dovrà abituarsi a non avere « certez-
ze », ma a rigenerarsi
intellettualmente di fronte a ogni
nuova situazione. È un atteggiamento
che richiede fantasia, e che è il
frutto di una nuova educazione, ormai
divenuta sempre più urgente.
Probabilmente già nella prima età va
impostata questa forma mentìs,
abituando il bambino a porsi delle
domande, anziché ad accontentarsi
delle risposte. In famiglia, nella
scuola, e più. ancora nella vita. /
ghetti culturali Alla base di questa
educazione, come di qualsiasi altra,
deve esservi tuttavia una « capacità
di capire » (cioè l'intelligenza nel
suo senso più lato) che consenta di
partecipare al dialogo, e di non
rimanerne escluso. Questa « capacità
di capire », lo abbiamo visto, non si
sviluppa da sola, ma è il frutto di
un insieme di presenze, di
circostanze, di tecniche. È il
frutto, sostanzialmente, di un
insieme di « incontri » favorevoli,
con la madre, l'insegnante,
l'ambiente culturale. L'incontro è
favorevole (per lo sviluppo mentale)
quando si situa nell'ambito delle
capacità di chi riceve : le cose che
si collocano al di fuori di certe
lunghezze d'onda non sono
percepibili, così come non sono
percepibili gli ultrasuoni, che pure
penetrano nell'orecchio umano. Questo
punto, lo abbiamo già sottolineato, è
molto importante, e i meccanismi
d'apprendimento che operano nel
bambino ci fanno meglio capire che il
discorso è valido anche per gli
adulti. Un giusto « incontro » non è
forse necessario per ogni forma
d'apprendimento, ad ogni età? «
Certamente, » mi risponde il
professor J. Kagan, dell'Università
di Harvard. « È la chiave che
permette ogni sviluppo mentale:
presentare una moderata sfida
intellettuale,
che non sia troppo difficile o
lontana dagli interessi di chi deve
riceverla, altrimenti il messaggio
non riesce a passare, crea noia e
disinteresse. Ciò è vero in
particolare per i veicoli culturali
che si rivolgono a un gran pubblico,
come i giornali, la scuola, la
televisione. » Questa idea
fondamentale non è ancora entrata non
solo nel costume, ma neppure nella
mentalità di una certa « cultura »,
che continua a parlare per
ultrasuoni. Ciò che essa dice o vuole
esprimere attraverso la comunicazione
di massa è al di fuori della gamma di
ricezione dei presunti ascoltatori.
Non si può lamentare un disinteresse
per la cultura e al tempo stesso
essere al di là delle frequenze
udibili. In passato un linguaggio
oscuro, nel rapporto con la plebe,
era una forma di gioco di prestigio
culturale: la gente, in fondo,
apprezzava maggiormente coloro che
pronunciavano ermetiche frasi in
latino, o sentenze sibilline, poiché
ciò appariva come una garanzia di
sapienza, di fronte alla quale ci si
inchinava ammirati... Chi mai
pretendeva di capire un sapiente? E
poi che razza di sapiente sarebbe
stato uno che faceva capire le cose?
Se anche un ignorante poteva capirle,
voleva dire che non erano poi cosi
difficili (e che il sapiente non era
così sapiente)... Questa mentalità,
oscuramente, sopravvive ancora oggi :
sì direbbe che c'è ancora in molti il
« complesso ». di farsi capire, per
timore di perdere un prestigio
culturale. Ciò ha una sua motivazione
psicologica, perché sopravvive
sempre, in buona parte del pubblico,
il rispetto per l'Autorità :
un'Autorità della cultura deve
emanare luce propria, ed essere
abbastanza lontana dalle miserie di
questo basso mondo, verso il quale
deve guardare con condiscendenza
agitando benedicente gli sfavillanti
simboli del prestigio. Mi diceva un
medico svizzero che certi clienti
italiani, dopo la prima visita, non
tornavano più da lui perché
consideravano troppo basso il suo
onorario (e quindi non attendibile la
diagnosi).
C'è, certamente, in molti il timore
di perdere prestigio scendendo troppo
i gradini della comprensione, e dando
prova di umiltà. In altri vi è
soltanto negligenza, o cattiva
abitudine. In altri ancora vi e
incapacità: ed è comprensibile perché
è assai più difficile e faticoso
scrivere in modo semplice. Anch'io,
lo confesso, perdo parecchie nottate
a cercare gli esempi del pasticciere
o dell'imbuto che versa liquido nel
secchio: avrei finito molto più
rapidamente questo libro se lo avessi
scritto in modo « difficile ». (Anzi,
vorrei in proposito, aggiungere
qualcos'altro di personale, dal
momento che parecchi lettori hanno
l'occasione di vedermi in
televisione. Ho sempre cercato, nelle
mie trasmissioni, di inserire
elementi di « incontro » col
pubblico, dal linguaggio chiaro alle
« trovate », dagli esempi alle «
battute », rifiutando quella finta «
serietà » tanto cara all'ufficialità
italiana in ogni campo. Io penso che
la serietà debba essere nei
contenuti, non nella forma. È una
filosofia ancora poco capita da
coloro che hanno un ben misero
concetto del prestigio e della
serietà. Del resto questa necessità
di visualizzare il potere con simboli
espressivi, come fronte corrugata o
intonazioni retoriche, è tanto più
forte quanto più si scende in società
sottosviluppate mentalmente, e gli
etologi trovano oggi la sua chiara
origine in certi atteggiamenti
tipicamente animali, come ad esempio
l'orripilazione.) Un male inteso
concetto di prestigio (oltre
all'incapacità, alla negligenza, o
anche al calcolo) finisce così per
nuocere spesso alla comunicazione,
divenuta oggi talmente essenziale
nella nostra società. Per fortuna, un
numero crescente di persone comincia
a orientarsi verso l'« incontro » con
i destinatari, e non più al sorvolo
ad alta quota. Certi addetti ai
lavori, pur parlando ovviamente tra
loro in codice, quando si servono dei
mezzi di comunicazione per rivolgersi
al pubblico cominciano a utilizzare,
per rispetto, una lingua conosciuta.
Questa esigenza occorre, però, che
sia incoraggiata dal pubblico il
quale ne
è il principale beneficiario, e
incoraggiata da chi ha il potere di
convogliare in questo senso la «
comunicazione ». Nessuno di noi
accetterebbe di sentirsi rispondere
all'ufficio informazioni della
stazione che per andare in mattinata
da Roma a Firenze bisogna prendere il
636 o il 346: vorrebbe sapere a che
ora parte il treno, senza doverselo
andare a cercare ogni volta
sull'orario ferroviario (ammesso che
ce l'abbia). Comunicare in modo
comprensibile, non è più soltanto un
problema di forma : se il messaggio
non arriva, il problema diventa in
realtà di contenuto. Il destinatario
rimane privato di informazioni, viene
segregato in un limbo educativo nel
quale lo mantengono l'incapacità di
comunicare di singole persone fisiche
bene individuabili. Oggi nessuna
società che vuole essere democratica
può permettersi un tale lusso, senza
portarne prima o poi le conseguenze.
Questo « incontro » deve avvenire nel
modo più largo ed esteso possibile, e
deve cominciare già dalla prima infan
zia. Alcuni hanno capito
perfettamente questa esigenza e
stanno scendendo dal loro Olimpo per
cercare di far capire ai bambini
talune cose importanti. La scrittrice
Maya Pines cita il caso del professor
Paul Ro-senbloom che afferma di esser
disceso « dall'università all'asilo
», per mettere a punto certe tecniche
d'apprendimento della matematica tra
i bambini di tre-quattro anni,
essendosi reso conto che certi «
guasti » tra i suoi studenti
universitari trovano le loro radici
proprio nel primo incontro con questa
materia. Egli sta ora cercando
adesioni tra professori di scienze,
d'arte, di lingua, perché facciano
altrettanto con le loro materie.
Anche il famoso psicologo americano
F.B. Skinner si è deciso a scrivere
un manuale di ortografia per i
piccoli. Nuovi fermenti si stanno
sviluppando nella comprensione del
mondo dei bambini e dèi meccanismi
dell'« incontro ». « Le tecniche
educative attuali, » dice il
professor Bruner dell'Università di
Harvard, « risalgono all'epoca delle
ca-
verne. » Questo è vero per gli adulti
come per i bambini. Tutto sembra
ancora da scoprire, in questo campo.
Alcuni ricercatori, stanno ora
tentando di realizzare l'« incontro »
con i più piccoli, anche attraverso
le macchine per imparare. La macchina
per imparare Quando si parla di «
macchine per imparare » scatta
immediatamente in noi un campanello
di allarme: vediamo il cervello
inserito in una specie di
lavastoviglie, con tutti i sistemi
meccanici di stampaggio delle
informazioni, e ci viene in mente
Charlie Chaplin alle prese con la «
macchina per mangiare » nel film
Tempi moderni. fi bene chiarire
subito che il concetto di « macchina
» va inteso naturalmente in modo
molto diverso: cioè come uno
strumento, un attrezzo educativo che
consenta di rendere più efficace
l'apprendimento. Un esempio? Il
libro. 11 libro, stampato a macchina,
si è sostituito alla parola, alla
scuola orale che si teneva
anticamente all'ombra di grandi
alberi; ed ha aumentato enormemente
la capacità di imparare, perché il
libro è un « maestro portatile », che
si può consultare e far ripetere a
volontà. Nello stesso senso anche la
penna è una « macchina » che migliora
l'educazione, così come lo è la
lavagna o il pallottoliere. La prima,
e mai abbastanza lodata, ìnnovatrice
in queste « tecniche » educative, è
stata Maria Montessori, psichiatra
dell'Università di Roma (fu la prima
donna italiana laureata in medicina),
che nei primi anni del Novecento
aveva già capito cose che ancora non
hanno capito oggi molti educatori. La
Montessori inventò (oltre a un nuovo
modo di vedere il bambino e a un
nuovo metodo di insegnamento che ha
precorso in modo pionieristico la
moderna pedagogia infantile), una
serie di « attrezzi » didattici che
permettevano al bambi-
no di avere esperienze anche
sensoriali, come per esempio la
famosa serie di lettere dell'alfabeto
da maneggiare, con un lato ruvido e
l'altro liscio. Alcuni ricercatori
cercano oggi di allargare questo
discorso utilizzando tecniche
elettroniche che consentano un «
incontro » ancor più efficiente.
Molte « macchinette » audiovisive
sono già entrate in circolazione da
tempo; l'uso di filmine, di
diapositive, di magnetofoni si sta
estendendo. Ma in laboratorio
esistono ora macchine di grandi
dimensioni ed estremamente complesse,
come la Edison Responsive Envi-
ronment inventata dal professor Ornar
Moore dell'Università di Pittsburg:
si tratta di una specie di macchina
da scrivere elettrica corredata da un
microfono, un altoparlante, un
proiettore, e regolata da un piccolo
calcolatore elettronico. Il bambino,
già a partire dall'età di due anni,
può « dialogare » con questa
macchina; dapprima con l'aiuto di un
insegnante, poi da solo. Egli si
accorge rapidamente che battere sui
tasti diventa un gioco eccitante :
ogni volta che preme un tasto, da una
finestrella appare la lettera
corrispondente, e l'altoparlante la
scandisce. Dopo un certo numero di
esercizi, la situazione si inverte:
nella finestrella appare una lettera
e il bambino deve cercare il relativo
tasto (un meccanismo libera solo il
tasto giusto, mentre gli altri sono
tutti bloccati). Poi dalle lettere si
passa alle parole, e via via il
bambino quasi senza accorgersene
comincia a comporre le prime parole
semplici, grazie al sistema dei tasti
bloccati. Questa macchina, che ha
dato anche eccellenti risultati con
gli adulti analfabeti, non contiene
un programma rigido, ma flessibile;
in realtà è il bambino stesso a «
guidarla ». È un torrente di domande
e risposte nei due sensi, è un «
tennis » che permette al bambino di
regolare le « variazioni ». trovare i
suoi ritmi ed essere premiato nelle
sue attese. A parte i risultati
sorprendenti ottenuti nella precocità
di lettura (in base a certi test
risulterebbe che i bambini preparati
con questo metodo arrivano a scuola
leggendo già a li-
La serie di lettere ritagliate da
maneggiare ideate da Maria Montessori
stati i primi .. attrezzi » didattici
della moderna pedagogia. I Oggi
esistono « attrezzi » educativi che
costano fino a venti milioni di lire
come • la macchina E.R.E. del
professor O. Moore, che consente a un
bambino di imparare rapidamente a
leggere e a far di conto.
vello di terza o addirittura di
quinta elementare) il professor Moore
insiste molto sul carattere personale
e non programmato della sua macchina
: il bambino è stimolato a condurre
da sé le sue esperienze, a esercitare
la sua capacità di scoprire le
lettere, di creare le parole;
insomma, impara ad imparare
attraverso la macchina. Questo
apparecchio presenta però un grosso
svantaggio: costa circa 40.000
dollari, oltre 20 milioni di lire...
Persino nel Centro in cui veniva
impiegato si sono verificati grossi
inconvenienti finanziari, e si è
dovuto rinunciare a utilizzarlo (il
costo di un ciclo scolastico di
lezioni di venti minuti al giorno si
aggirava intorno alle 300 mila lire
per allievo). Molti altri mezzi
elettronici (più semplici) sono ora
entrati in circolazione : di essi si
può dire ciò che si può dire di un
libro, cioè possono essere eccellenti
o pessimi, a seconda del loro
contenuto e dei compiti che si
prefiggono. Comunque, anche nel
settore degli strumenti didattici,
come del resto nel linguaggio, un
nuovo obiettivo sembra ormai essersi
ben precisato: quello dell'« incontro
», della necessità, cioè, di inserire
nel campo focale di chi deve
apprendere quegli elementi che gli
consentano un aggancio di nuove
conoscenze. La lettura precoce Ci si
può ora porre legittimamente una
domanda: fino a che punto è opportuno
sviluppare precocemente un bambino?
Non vi sono anche dei rischi? Per
esempio, è veramente un bene che egli
impari a leggere a tre anni, pur
ammettendo che questo compito non
costituisca per lui uno sforzo ma
addirittura un piacere? Dare una
risposta non è facile, anche perché
gli psicologi hanno opinioni a volte
molto diverse. Vediamo rapidamente le
loro tesi a favore e contro una
lettura precoce.
Ornar Moore, per esempio, dice con
ragione : « Nessuno consiglierebbe
oggi di spostare l'apprendimento del
linguaggio all'età di cinque anni,
con il pretesto che il bambino
imparerà comunque a parlare : la
stessa cosa vale per il leggere, lo
scrivere, il far di conto. È solo
diverso il mezzo di espressione. » Da
un punto di vista mentale,
chiaramente, è molto meglio che un
bambino (sempre grazie ali'« incontro
») riesca a impadronirsi precocemente
del linguaggio scritto oltreché
parlato : a favore di questa tesi
milita anche il fatto che la lettura
è una « chiave » per accedere ai
libri, e permette quindi al bambino
un salto qualitativo notevole
aprendolo a nuovi stimoli
intellettuali. Non vi sono quindi
dubbi che una lettura precoce,
specialmente se « scoperta » dal
bambino, sia un elemento capace di
arricchirlo notevolmente. I dubbi,
piuttosto, nascono proprio da questo
successo. Non bisogna dimenticare,
infatti, che il bambino non vive in
un laboratorio di psicologia, ma sul
pianeta Terra, a contatto di altri
esseri umani, con i quali deve poter
socializzare, senza sentirsi un
animale esotico, un super-bambino
maturato prima del tempo. Il
professor Rosenthal, del dipartimento
di psicologia del National Institute
of Health, negli Stati Uniti, mi ha
raccontato in proposito un aneddoto
significativo: « Due miei vicini di
casa avevano un bel maschietto,
vivace e intelligente. A tre anni i
genitori gli insegnarono a leggere,
ed egli crebbe precoce in ogni cosa.
Venne il momento della scuola, e il
bambino entrò già con una notevole
superiorità tecnica e mentale, in
mezzo a coetanei che invece
cominciavano appena a sillabare. Dopo
breve tempo egli cominciò a
disinteressarsi della scuola: ciò che
facevano i suoi compagni lo annoiava,
perché già sapeva tutto. I genitori
furono costretti a toglierlo dalla
scuola e fargli continuare i corsi
privatamente, sot-traendolo così a
una vita in comune con altri ragazzi
in classe, (cosa questa che ha la sua
grande importanza neilo sviluppo
della socialità). Ma c'è dell'altro :
il bambino, anche nei giochi, si
annoiava con i coetanei e cercava la
compagnia di ragazzi più adulti, per
i quali tuttavia non era pronto a
causa di altri aspetti del suo
sviluppo. Ne nacquero problemi
psicologici di disadattamento, che
cominciarono a influire sul suo
carattere. » Ecco, dunque, come
un'iniziativa di per sé lodevole può,
in pratica, avere sviluppi negativi.
La soluzione, in casi come questo,
consiste naturalmente nell'inviare il
bambino in scuole in cui egli si
trovi in mezzo a ragazzi che abbiano
avuto analoghe esperienze educative.
In tal caso egli non si sentirà più
un pesce fuor d'acqua, ma ritroverà
un ambiente stimolante. Un caso del
genere si è verificato in una
cittadina americana, in cui era sorto
un nido d'infanzia pilota, improntato
a un metodo che aveva permesso ai
bambini di raggiungere un alto
livello di sviluppo cognitivo. Al
momento dell'ingresso nella scuola i
genitori si quotarono per far
continuare l'esperimento grazie a
speciali corsi di scuola elementare,
rendendosi conto che sarebbe stato un
errore inviare i figli in una normale
classe di prima. L'idea di iniziare
la scuola precocemente per tutti,
all'età di tre anni, fa parte ormai
del programma di alcuni uomini
politici (J.J. Servan-Schreiber in
Francia, tanto per citarne uno). A
New York il problema è già stato
impostato concretamente, e anche in
altri stati americani vi sono
progetti avanzati per realizzare un
insegnamento generalizzato a partire
dai tre anni. Taluni psicologi, come
il professor Raymond Moore (omonimo
del precedente) della Andrews
University, sostengono però che una
scuola così precoce comporta rischi
affettivi, nel senso che il bambino a
quell'età ha bisogno più della madre
che della maestra. Lo psicologo
infantile John Bowlby. dal canto suo,
afferma che oggi i bambini sono
sottratti troppo presto alla madre da
un insieme di cose, e la loro
costruzione affettiva ne risente :
egli dice addirittura che soltanto
nei casi in cui l'educazione dei
genitori è estremamente carente, ìa
scuola può essere preferibile. E
aggiunge : è più logico aiutare i
genitori a essere maestri che
sostituirli. Torneremo su questo
argomento in seguito, poiché esso
apre un discorso assai vasto e
importante. Per concludere su questo
tema dell'educazione precoce, ci
pareva comunque interessante
ricordare non solo i vantaggi ma
anche i rischi di uno sviluppo
intellettuale troppo rapido, che si
situi al di fuori del contesto in cui
vive il bambino. Il rischio
soprattutto di imparare cose, anziché
allenarsi a imparare attraverso le
cose. Il rischio di diventare un «
enfant prodige ». Vi sono dunque
scelte « strategiche » importanti da
effettuare, prima ancora di
realizzare dei successi « tattici ».
Stravincere può rivelarsi un errore
strategico, se non si valutano anche
gli inconvenienti pratici che in
certi casi potrebbero derivarne. Dal
punto di vista tattico, comunque, la
tecnica dell'« incontro », di cui
abbiamo parlato lungo tutto questo
capitolo è quella che consente di
realizzare nel miglior modo gli
obiettivi che si sono scelti. È una
tecnica che vale per ogni forma di
comunicazione e di apprendimento, e
riguarda tanto i bambini quanto gli
adulti, la scuola quanto la società.
Nell'infanzia il suo impatto è
enorme, perché coinvolge subito lo
sviluppo mentale. Il primo e più
importante « incontro » il bambino lo
fa proprio con la madre, che
organizza, sin dall'inizio, il suo
mondo fisico e intellettuale e gli
consente di emergere pian piano dal
buio mentale abituandolo a imparare,
esplorare, immaginare, prima ancora
che a leggere o a scrivere. Esistono
regole di comportamento, per una «
buona » madre in questa primissima
fase? Cercheremo ora di vedere se — e
come — è possibile migliorare il
rapporto educativo tra madre e figlio
prima della scuola, nella vita
familiare di ogni giorno.
La madre «A» non ostacola I nizza la
casa in modo da evit;
briosità del bambin : gli
inconvenienti.
incoraggia. Ma orga-
Vili • LA MADRE La lista delle
competenze Che cosa deve fare, in
pratica, una madre per allevare bene
intellettualmente il suo bambino? La
risposta è molto delicata, perché è
sempre difficile stabilire delle
regole: l'educazione è un fatto
troppo personale per poterla
racchiudere in una serie di
formulette. Si possono però suggerire
certi orientamenti, indicando grosso
modo quali cose è bene fare e quali
altre è bene evitare. Penso che sia
utile, a questo punto, parlare
diffusamente di uno studio effettuato
su larga scala e rivolto a capire
come si comportano nell'educazione le
madri di bambini particolarmente
brillanti. È uno studio effettuato
dal professor Burton L. White
dell'Università di Harvard, uno
psicologo che da oltre dieci anni
lavora sullo sviluppo mentale nella
prima infanzia ed è considerato uno
dei maggiori esperti in questo campo.
Le pagine che seguiranno si basano
sugli appunti presi durante i
colloqui che ho avuto con lui
(all'Università e in casa di madri
che hanno partecipato alle ricerche)
e su un suo rapporto recentemente
pubblicato. White è partito, per così
dire, dalla fine ed è poi tornato
indietro con la « moviola » dello
sviluppo mentale. Per capire il senso
del suo studio, seguiamone
rapidamente l'itinerario. Egli aveva
iniziato la ricerca esaminando
quattrocento bambini, disseminati in
vari giardini d'infanzia a Boston, di
un'età compresa fra tre e sei anni.
Lo scopo era di selezionare i più
sviluppati e i meno sviluppati
mentalmente, in modo da poterli poi
confrontare tra loro. Ne risultarono,
dopo la selezione, due gruppi di
tredici bambini (sempre di età fra i
tre e ì sei anni). Li chiameremo
gruppo A e gruppo C (il B essendo
formato da tutti i restanti, di
livello medio). Dai tests effettuati
si vide che le differenze erano
modeste per quanto riguardava-le
capacità sensoriali e motorie, ma
erano assai grandi per quanto
riguardava le « competenze », cioè in
pratica le capacità mentali, il
comportamento sociale, il linguaggio
ecc. Per definire meglio questo
concetto di « competenze », ecco qui
la lista dei talenti presi in esame.
È una lista che merita di essere
letta con attenzione, perché
definisce già da sola, in pratica,
che cosa si può intendere per bambino
ben sviluppato mentalmente. Abilità
sociali Ottenere e mantenere
l'attenzione degli adulti in un
modo socialmente accettabile.
Utilizzare gli adulti come « risorsa
». Esprimere affetto e ostilità verso
gli adulti. Comandare e seguire i
coetanei. Esprimere affetto e
ostilità verso i coetanei. Competere
con i coetanei. Mostrare fierezza dei
propri risultati. Svolgere in un
gioco il ruolo di adulto, o mostrare
co
munque il desiderio di crescere.
Altre abilità 1) Competenza
linguistica, per esempio capacità
nella
grammatica, ne] vocabolario, nell'uso
estensivo del linguaggio parlato. 2)
Competenza intellettuale, cioè
l'abilità di : rilevare le
discordanze o le stonature anticipare
le conseguenze e) astrarre (numeri,
lettere, regole) mettersi nei panni
di un altro compiere associazioni
interessanti. 3) Abilità, esecutive
a) pianificare e portare avanti
attività che richiedono una serie di
passi successivi /;) utilizzare con
efficienza le risorse disponibili. 4)
Capacità di attenzione, cioè la
capacità di mantenere la
propria attenzione su un'attività
vicina, e al tempo stesso
controllare un evento periferico
(definita anche abilità « bi
focale »). Tutte queste qualità erano
presenti in modo considerevole nel
gruppo A (cioè dei tredici bambini
fra i tre e i sei anni che erano
stati selezionati come i migliori tra
i quattrocento esaminati); invece il
gruppo C, quello che comprendeva i
tredici bambini di « coda », mostrava
scarse attitudini in questo senso. A
che età nascevano e come si
sviluppavano queste competenze?
Operando col metodo dei paragoni
incrociati, White e i suoi
collaboratori si accorsero che esse
erano più sviluppate fra i bambini
del gruppo « A ». di tre anni, che
non fra quelli del gruppo « C », di
sei anni. Per esempio un bambino A di
tre anni usava già correntemente un
adulto come « risorsa », mentre
nessuno del gruppo C lo faceva,
neppure a sei anni. Lo stesso valeva
per l'attenzione « bifocale ».
presente regolarmente in « tutti » i
bambini del gruppo A, e scarsamente
visìbile in quelli del gruppo C.
Queste osservazioni, assieme a molte
altre, portavano chia-
ramente a una conclusione, come
afferma White nel suo rapporto: « Se
la maggior parte delle qualità che
distinguono un bambino di sei anni
ben sviluppato sono già presenti, in
larga, misura, all'età di tre anni,
ciò significa che esse prendono
l'avvio in un periodo ancora
precedente. Queste osservazioni,
insomma, ci portarono a concentrare
gli studi sul periodo da ZZYO a tre
anni. » La seconda fase della ricerca
consistette dunque nell'os servare
come nascevano queste « competenze »
nei primi tre anni di vita, e vedere
se erano collegate a un particolare
comportamento della madre. Esaminando
bambini da zero a tre anni fu subito
evidente che queste differenze non
erano visibili nei primi mesi dopo la
nascita (tranne in casi patologici) :
però nei tests esse apparivano già
chiaramente nel secondo anno dì vita.
Una tecnica adeguata di rilevamento
fu messa a punto nel corso di due
anni di studio, durante i quali il
professor White e ì suoi
collaboratori si recarono nelle case
per osservare da vicino il
comportamento dei piccoli e delle
madri, seguendo attentamente i
bambini nel secondo e nel terzo anno
di età. Cronometro alla mano, veniva
annotato tutto quello che il bambino
faceva, quanto tempo la madre gli
dedicava, quale tipo di rapporto
avevano, come erano organizzati i
suoi giochi, e così via. Ecco le
conclusioni, che possono fornire
preziosi consigli per le madri. Da
dieci a diciatto White ritiene che il
periodo compreso tra i dieci e i
diciotto mesi sìa di fondamentale
importanza per lo sviluppo delle «
competenze », anche quelle cognitive,
cioè intellettuali, di apprendimento.
Il ruolo della famiglia, e della
madre in particolare, è essenziale a
questa età. E infatti un periodo
durante
Verso i 9 mesi una delicata fase si
apre: appaiono contemporaneamente
alcune caratteristiche (fra le quali
l'autonomia di movimentol che pongono
il bambino in situazioni
d'apprendimento del tutto nuove. il
quale appaiono, come tante
ramificazioni, attività molto diverse
e importantissime, che ricevono
dall'ambiente la loro impostazione
pratica. Innanzitutto verso gli otto
o nove mesi cominciano a diventare
consistenti le capacità di capire il
linguaggio parlato; perciò nei mesi
seguenti il rapporto verbale con la
madre influenza fortemente lo
sviluppo della parola. I bambini che
più tardi risulteranno ben sviluppati
nel linguaggio mostrano già a
diciotto mesi una netta precocità nei
confronti degli altri.
Secondariamente, verso i nove o dieci
mesi, appare la capacità di camminare
a quattro zampe, e ciò apre una nuova
fase nel rapporto tra madre e figlio:
il bambino comincia infatti a
conquistare una sua indipendenza nel
movimento, e la madre comincia a
doversi occupare (e preoccupare) dei
problemi che questa nuova fase
addiziona : autonomia di mo-
vimento+curiosità intensa+scarso
controllo dei movimenti -(-ignoranza
dei pericoli + ignoranza del valore
delle cose-f ignoranza dei diritti
degli altri = guai (e quindi l'inizio
di un diverso sistema premi-
punizioni). In terzo luogo, verso la
fine del primo anno, appaiono con più
evidenza due caratteri sociali
soggetti a rapido sviluppo: II
bambino comincia a «situarsi»,
comincia cioè ad
accorgersi di se stesso, della sua
identità. Questa identità è
largamente modellata dall'inter-
azione (« tennis ») con la
madre; Lo scambio nei due sensi
modella anche il suo atteggia
mento di base nei confronti del
prossimo. Il bambino acqui
sisce così il suo « stile » di
animale sociale. Quale importanza ha
tutto questo per lo sviluppo
cognitivo? Enorme, ritiene White. Di
solito, egli dice, negli esperimenti
di apprendimento si esamina un solo
individuo (un uomo, un bambino, un
piccione, un gatto, un cane, una
scimmia) posto di fronte a un compito
singolo (un labirinto, una scatola
puzzle, un test di discernimento
ecc). Nella vita di ogni giorno due
esseri, madre e figlio, sono di
fronte in continuazione, ed è
evidente l'influenza che ha in questo
ambiente naturale, così ricco di
motivazioni, il comportamento della
madre; direttamente o indirettamente,
essa inserisce nell'ambiente tutti
gli elementi (anche fisici) adatti
allo sviluppo dell'apprendimento. «
Io sono convinto, » dice White, « che
il secondo anno di vita (assieme col
terzo) è il più importante per
l'impostazione mentale del bambino e
per l'apparire di certe <
competenze). La madre può avere, in
questo periodo, un'influenza enorme
sullo sviluppo di certi fattori che
saranno essenziali al momento della
scuola; i maestri, infatti,
riceveranno in consegna un cervello
già dotato di < qualità > che
potranno poi sviluppare
ulteriormente. In definitiva, questa
catena di avvenimenti, che prende
l'avvio durante il secondo e il terzo
anno, può influenzare tutto il resto
della vita di un individuo. » Come
deve dunque agire, in pratica, la
madre? La madre consulente « Per
cominciare, » dice White, « vorrei
precisare che ogni madre è in grado
di svolgere un buon lavoro con il
piccolo. La nostra ricerca mi ha
convinto che non occorrono né lauree,
né diplomi. « Direi di più : le madri
< efficienti > non passano la
giornata a occuparsi dei piccoli.
Hanno troppo da fare, per occuparsi
continuamente di loro. Molte hanno
anche un lavoro fuori casa. « II
punto veramente importante (e che
spesso la madre sembra svolgere senza
rendersene conto) è di essere
un'eccellente organizzatrice e
consulente, di saper creare un mondo
materiale, specialmente in casa,
perfettamente adatto ad alimentare la
grande curiosità del piccolo. È un
mondo pieno di piccoli oggetti
maneggevoli e attraenti: non solo
giocattoli, ma oggetti normalmente
destinati a un altro uso (contenitori
in plastica, tappi di bottiglia,
scatole con coperchi, scarpe,
giornali, bottoni, pulsanti ecc); un
ambiente che contiene cose sulle
quali arrampicarsi, o sviluppare
attività fisiche, e che comprende
cose interessanti da vedere, come
persone, televisione, illustrazioni,
e così via. « Oltre a creare un
quadro di vita stimolante, la madre A
ha di solito un comportamento
permissivo e indulgente nei confronti
del piccolo, che viene incoraggiato
al massimo a esplorare. « Vi è poi un
altro aspetto fondamentale: la
consulenza. Accade continuamente,
durante la giornata, che il piccolo
si trovi una situazione per lui
interessante o difficile, e che si
rivolga alla madre per aiuto. In
questi casi essa risponde alle
sue chiamate aiutandolo, o
condividendo il suo entusiasmo : non
soltanto, ma suggerendogli anche
un'idea interessante collegata con la
sua piccola esperienza, cioè <
rilanciandolo >. « Questi < scambi >
(molto brevi, dai dieci ai trenta
secondi) sono orientati verso il
bambino, verso le sue necessità, i
suoi interessi, e non verso quelli
della madre. Ritengo che siano
proprio piccole esperienze di questo
genere a sviluppare e a incoraggiare
nel bambino la curiosità, una qualità
essenziale per conoscere e quindi
arricchirsi mentalmente. « Altre
volte queste madri però non
rispondono subito alle < chiamato,
non smettono ciò che stanno facendo
per andare dal bambino : se non hanno
tempo rimandano a più tardi la
risposta, e glielo dicono, dando cosi
probabilmente al bambino la
sensazione delle cose a venire, cioè
del futuro. Molto raramente esse
passano cinque, dieci o venti minuti
a insegnargli cose quando ha uno o
due anni, ma < producono un gran
numero di mini-insegnamenti al volo,
solitamente su richiesta. « Queste
madri, inoltre, parlano spesso e
molto con il piccolo, utilizzando un
linguaggio comprensibile per lui.
Sono donne che hanno anche in comune
una notevole energia. Il lavoro in
casa, malgrado tutti gli apparecchi
elettrodomestici, richiede infatti
molto impegno, e occorre avere la
voglia e l'energia per rispondere a
tutte queste chiamate. » La
cristallerìa a repentaglio Un altro
aspetto preso in esame dai
ricercatori dell'Università di
Harvard in questo identikit della
madre efficiente riguarda il
comportamento materno nei confronti
di certi problemi pratici posti dal
bambino pìccolo : per esempio la
tendenza a sporcare, a rompere e a
correre pericoli. Il professor White
ritiene che vi sia una evidente
incompatibilità tra il desiderio di
preservare intatto il contenuto di
Il - quadrato » non è un ambiente
molto stimolante per piuttosto a
scoraggiare la sua tendenza a
esplorare.
bambino: esso tende
una casa e la naturale tendenza dei
bambini a una distrutti-vità
innocente. « La madre che si
preoccupa molto della sua casa si
trova in difficoltà, » dice White. «
Essa può sostanzialmente scegliere
fra tre strade da seguire. 1) Può per
esempio impedire tìsicamente al
bambino di entrare in contatto con le
cose creando cancelletti. <recinti),
lettini con le sbarre. A nostro
parere, ciò produce frustrazione nel
bambino e calo della sua curiosità.
2) Può permettere al bambino di
correre liberamente e poi cercare di
fermarlo con le parole o con l'azione
quando è sul punto di rompere
qualcosa. Questo metodo è sovente
senza successo, perché il bambino non
è ancora in grado di capire bene il
senso di ciò che gli si dice (e
inoltre è il periodo in cui sviluppa
un normale < negativismo > nei
confronti degli altri). Nella
migliore delle ipotesi il risultato è
una madre che dice continuamente
<no>, <stai qui>, <stai fermo, <non
toccare quello>, seguiti da minacce
di punizioni. 3) Un altro sistema
consiste nel lasciare il bambino
libero,
ma seguendolo di continuo con una
specie di supervisione costante. È un
sistema che richiede molto tempo e un
dispendio notevole di energie. Poche
madri possono permetterselo. «
Naturalmente però una madre non può
mettere a repentaglio i servizi di
cristalleria o il gatto in maiolica
regalato dalla zia. Che deve fare? »
« Credo che la soluzione migliore
consista nel far sparire tutto ciò
che si può rompere, senza però creare
il deserto intorno al piccolo ma
piuttosto facendo in modo che tutto
quanto si trova a sua portata di mano
possa essere da lui toccato. Si
tratta in pratica di riorganizzare la
disposizione degli oggetti tenendo
conto di questa sua esigenza, creando
un ambiente fatto su misura per lui,
nel quale egli non sia continuamente
bloccato o impedito ma possa
liberamente muoversi senza provocare
danni. » In una delle case che ho
visitato in compagnia di White la
madre mi ha mostrato come aveva
organizzato il « piano terra ». cioè
il livello accessibile alla sua
bambina: tutto poteva essere toccato
o aperto: oggetti, cassetti,
sportelli. Spesso il contenuto veniva
rovesciato sul pavimento: casseruole,
coperchi, tappi, arnesi che non
soffrivano per gli urti ecc.
Naturalmente un tale sistema richiede
molta tolleranza da parte della
madre, perché il disordine è
inevitabile. Ma sembra che la madre-
modello abbia anche questa qualità.
« Abbiamo potuto constatare, » dice
sempre White, « che tra le madri di
bambini del gruppo A (molto ben
sviluppati mentalmente) vi sono poche
casalinghe meticolose: la maggior
parte sembra aver accettato l'idea
che un bebé e una casa senza macchie
sono concetti incompatibili. Il
problema spesso è creato dai mariti
che esigono una casa in perfetto
ordine, anche perché non si rendono
conto di quanto lavoro ciò comporti.
Per evitare veramente il disordine e
le macchie una madre dovrebbe
adottare uno dei tre sistemi cui
accennavamo prima, con esiti poco
brillanti dal punto di vista
educativo. »
Anche qui, insomma, la strada
migliore sembra consistere
nell'organizzare la casa in funzione
del bambino, e non il bambino in
funzione della casa. Riseli! e
pericoli C'è ancora un punto
interessante, in questo rapporto
madre-figlio nella vita quotidiana in
casa: il problema della sicurezza. «
È evidente, » dice White, « che il
bambino corre spesso il pericolo di
farsi male, di cadere, di ferirsi.
Anche in questo caso la maggior parte
delle misure per tener lontano il
piccolo dai pericoli finisce per
compromettere, almeno in parte, lo
sviluppo della sua curiosità
esplorativa. « Abbiamo potuto notare
che anche in questo campo esiste una
diversità di comportamento tra i vari
tipi di madre. Le nostre osservazioni
indicano che le madri del gruppo A
tendono ad essere più aperte di
quelle del gruppo C, cioè sono più
inclini a correre qualche rischio col
loro bambino. « Del resto, alcune
ricerche effettuate da psicologi
indicano che i bambini hanno un
sistema innato di controllo più
efficiente di quanto non crediamo.
Per esempio certi studi mostrano che
nel momento in cui incominciano a
camminare a quattro zampe i bebé
hanno già sviluppato un'attitudine
notevole a discernere (e temere) la
profondità, il vuoto; inoltre tendono
a evitare di muoversi da posizioni
sicure. « In certe tribù africane, i
bambini hanno accesso ad armi e
utensili taglienti, senza che ne
risultino ferite o conseguenze gravi.
Io penso veramente che i bambini
siano in generale molto più attenti
di quanto pensiamo. Non voglio con
questo dire che non si debbano
prendere tutte le precauzioni
possibili : esiste una giusta misura,
come in ogni cosa, e certe madri
decisamente troppo protettive
sembrano interferire in modo
eccessivo nel buon sviluppo del
bambino. »
Anche in questo caso l'importante è
organizzare un ambiente in cui i
pericoli siano ridotti al minimo. Un
esempio fra tanti, ormai divenuto
quasi pratica corrente: le capsule in
plastica che sì infilano nelle prese
elettriche, rendendole inoffensive. È
un piccolo accorgimento, ma che ha
anche un valore psicologico per la
madre. Ognuno, del resto, guardandosi
in giro nell'appartamento può
individuare gli eventuali pericoli e
porvi rimedio, con un po' di
fantasia. / pannolini e il cervello
« In definitiva, » professor White.
« quali sono, secondo lei, le qualità
necessarie per essere una buona
madre? » « Per riassumere direi
innanzitutto che una buona madre deve
essere una buona organizzatrice e
consulente del mondo del bambino, e
abbiamo visto in quale senso. Poi,
oltre che di una buona dose di
energia per far fronte a tutti i vari
compiti, deve disporre di molta
pazienza. Un bambino è lento in molte
cose, e può spazientire un adulto con
la sua tendenza a persistere in
comportamenti ripetitivi e a imparare
in modo apparentemente poco rapido,
se confrontato con un adulto. Senza
un profondo amore per il suo piccolo
una madre può non essere troppo
incline a dedicargli tanta energia e
pazienza. « Una cosa che invece può
sorprendere riguarda il tempo : una
buona educazione mentale richiede
naturalmente del tempo, ma non tanto
come credevamo prima di cominciare
queste ricerche. Non soltanto alcune
delle nostre madri A hanno un lavoro
a mezza giornata che le tiene lontane
dal bambino, ma abbiamo calcolato che
quelle che rimangono a casa l'intera
giornata trascorrono meno del dieci
per cento del loro tempo a ìnter-
agire con i figli. In un modo assai
efficace, però, come abbiamo visto.
« È nostra impressione che non molte
madri si rendano conto in pratica di
tutto questo. Certamente la
maggioranza
delle madri < C > non pensa che
questo primo periodo della vita abbia
un profondo significato per lo
sviluppo mentale del bambino. Ma
anche molte madri A non si sono mai
poste questo problema : esse agiscono
in modo eccellente senza seguire una
teoria o un metodo. Spontaneamente
gratificano i loro figli di molta
attenzione e considerazione, come se
ciò facesse parte di un naturale modo
di agire nella vita. » « Esistono
differenze per quanto riguarda il
tipo di comportamento materno tra
famiglie di diverse condizioni
sociali ed economiche? » « Sì,
esistono differenze : le famiglie
povere hanno più figli, hanno meno
opportunità di occuparsi bene dei
bambini, la vita è più diffìcile, e
tutto questo influisce notevolmente.
Però abbiamo trovato madri A e C nei
vari gruppi sociali : abbiamo per
esempio trovato ottime madri, da
questo punto di vista, in famiglie
numerose che si trovavano in
diffìcili condizioni economiche. «
Ciò che ci è parso importante è
l'atmosfera psicologica in cui la
madre si trova: se è depressa, o
infelice del suo modo di vivere,
probabilmente non riesce a compiere
un buon lavoro educativo con i suoi
figli, e dar loro una buona partenza.
Nessuna delle nostre madri A ha un
atteggiamento del genere verso la
vita mentre alcune del gruppo C si
trovano proprio in queste condizioni.
» A parte i problemi sociali che
hanno un loro peso notevole nel
creare questa situazione (torneremo
sull'argomento), e a parte l'ambiente
culturale che circonda il bambino, in
quale misura queste osservazioni
pratiche sulla « tecnica » di esser
madri possono essere d'aiuto? Se
alcune madri agiscono bene d'istinto,
è possibile dare una mano alle altre
e modificare le cose? « In molti casi
sì, » risponde White. « Credo
effettivamente che seguendo certi
consigli si potrebbe migliorare
l'educazione dei piccoli nel primo
periodo di vita. Stiamo appunto
cercando di capire certi meccanismi,
in modo da poter
aiutare meglio le madri. C'è ancora
tutto un immenso lavoro da compiere.
» « Per concludere, professore, non
le sembra che esista una carenza
grave in questo campo? In altre
parole, ancora oggi la madre, al
momento della nascita del bambino,
riceve fiori, babbucce, cuffiette e
tanti auguri; ma poi si ritrova sola
con i suoi problemi, nessuno le
insegna come agire per educare con
successo il proprio figlio. » «
Certo, ci preoccupiamo più dei
pannolini del bambino che del suo
sviluppo mentale, quasi che
l'intelligenza e le capacità
intellettive del bambino possano
fiorire da sole, spontaneamente. Per
migliaia di anni questo compito è
stato delegato alla scuola, e
l'educazione è quasi sempre iniziata
a sei anni, se non dopo. Ora
cominciamo a capire che le cose
stanno diversamente, e che persìno
certi piccoli dettagli quotidiani nei
rapporti tra madre e figlio possono
influenzare enormemente lo sviluppo
mentale. « Sinora non si è mai
pensato a educare i genitori, ma io
penso che questa lacuna verrà presto
colmata. Penso che anche la società
si renderà presto conto della
necessità di mettere l'accento sul
primo periodo di vita per prevenire i
problemi, anziché porvì rimedio più
tardi. » In altre parole il bambino
deve trovare la sua maestra già a
livello familiare, individuale, molto
prima che la scuola abbia inizio.
Appare quindi evidente che se si
vuole migliorare l'« impronta » del
primo periodo di vita è anche in
direzione della « matrice » che
occorre muoversi: la madre dovrà
essere uno degli obiettivi essenziali
di ogni serio tentativo di
rinnovamento dell'educazione. È
questo un campo ancora tutto da
scoprire. Del resto più si procede
nell'esplorazione dei meccanismi
mentali più ci si rende conto che
esistono (fuori e dentro la famiglia)
enormi possibilità di svegliare nel
bambino l'intelligenza e i talenti
che dormono tra le pieghe del suo
cervello.
È una vera rivoluzione educativa
quella che sta uscendo dalle ricerche
in corso e che dovrà coinvolgere non
solo il ruolo della madre ma anche,
come vedremo, quello della scuola,
degli insegnanti, degli asili-nido,
della televisione. Questo modo nuovo
di vedere i problemi educativi è
ormai diventato indispensabile
soprattutto nel nostro paese, che
deve recuperare un notevole ritardo
mentale. Uno studio internazionale
pubblicato nell'ottobre del 1973 (il
più grande studio comparativo
effettuato sul profitto scolastico a
varie età realizzato dai più
autorevoli pedagogisti italiani e
stranieri e appoggiato anche dal
nostro ministero della pubblica
istruzione) mostra che vi è
(mediamente) un calo crescente nelle
prestazioni mentali dei nostri
ragazzi, nei confronti di quelli
degli altri paesi sviluppati, man
mano che la scuola aumenta di
difficoltà e richiede processi
mentali superiori. Alle soglie
dell'università essi si trovano a un
livello mentale (medio) non molto
distante per certi aspetti da quello
che si registra nei paesi in via di
sviluppo. È diffìcile stabilire
perché e a quale momento si registri
questo calo, e come spartire le
responsabilità (la scuola, comunque,
mostra chiaramente le sue colpe,
all'analisi dei dati): scuola e
famiglia, madri e insegnanti si
intrecciano in questa costruzione del
bambino. Questi risultati,
deprimenti, mostrano che è quindi ora
di occuparsi seriamente della più
urgente delle riforme: quella del
cervello.
Neiprimi tre s nnidi vita si può
passare da i inazona di sottosvii
uppo r nent alei
unazo na di br illa intell igt
inza. 0 v iceversa. Prove d
laboratorio indie ai io e he s
puògì jngere z . di ffer enze di
35-40 pi nti nel q iente
intellettivo.
IX • PRIMA DELLA SCUOLA //
sollevamento pesi cerebrale Ecco
dunque le madri all'opera, a plasmare
il cervello del figlio, nelle case
operaie della periferia o nei
villaggi di montagna, negli attici
dei quartieri alti o nelle tende dei
nomadi. Pian piano il cervello prende
forma. Chi riuscirà a svilupparlo
meglio, a renderlo più efficiente? È
un concorso in cui le regole,
evidentemente, non sono uguali per
tutti : all'inizio, ciò che vi è di
uguale (o meglio di simile) sono le
potenzialità, le capacità innate del
bambino. Ma il gioco è subito
alterato dal fatto che alcune madri
posseggono già una tradizione
familiare di « trainer », dispongono
di palestre e piscine culturali,
sanno come si alleva un campione:
altre madri invece no. In altre
parole quando i bambini arrivano a
scuola, all'età di sei anni, le
differenze possono essere talmente
grandi da creare una situazione di
vero handicap per i più svantaggiati,
con la conseguente apparizione di
classi differenziali e di una «
mortalità scolastica » che porta le
stimmate dell'ambiente familiare. È
un problema che conoscono bene gli
insegnanti, specialmente quelli che
si trovano nei grandi centri
industriali, dove questi contrasti
vengono esaltati dalle condizioni di
vita ambientale. Un tempo si pensava
(ma molti lo pensano ancor oggi) che
queste diversità nell'intelligenza
scolastica fossero come le calamità
naturali, come la pioggia, la neve o
la grandine: facevano parte della
vita e sembrava quasi normale che il
figlio di genitori ignoranti fosse a
sua volta poco intelligente. Inoltre,
se non riusciva a scuola, se era un
ripetente cronico, la colpa era anche
sua : non collaborava, non si
sforzava di capire, era svogliato,
era fiato sprecato cercare di
aiutarlo. In realtà, lo abbiamo visto
nel corso di tutto il libro, le
capacità scolastiche di un bambino
sono il frutto del curricuìum vìtae
del cervello. Ciò che è avvenuto (o
non è avvenuto) nei primi anni può
anzi provocare un effetto ancor più
evidente in una società
intellettualmente sviluppata, dove
l'accento è messo sul massimo
rendimento delle capacità mentali
dell'individuo. In proposito esistono
osservazioni assai interessanti,
dalle quali sembra di poter desumere
che la « deprivazione » iniziale
provoca conseguenze molto più gravi
in una società di tipo occidentale
che non in una società primitiva. In
Guatemala ho incontrato il professor
J. Kagan, che aveva appena terminato
una ricerca tra gruppi di indios in
alcuni villaggi nei pressi di
Chichicastenango. In questi villaggi,
egli mi ha detto, i bambini, nel
primo periodo di vita, vengono «
stimolati » pochissimo dalle madri,
che li lasciano per la maggior parte
del tempo da soli in fondo alle
capanne : « Però questi bambini, »
afferma Kagan, « all'età di dieci
anni non sono diversi dagli altri,
come sviluppo intellettuale. » Egli
spiega il fenomeno col fatto che
queste società di tipo primitivo non
conoscono una competitivita
scolastica del tipo di quella che si
verifica nelle nostre società
occidentali. A suo avviso tra questi
indios, in assenza di « traumi »
competitivi, le curve di sviluppo
intellettuale dei vari bambini
tendono a salire parallelamente, e i
punti d'arrivo a dieci anni non sono
molto distanti tra loro; nelle nostre
scuole, invece, chi parte
svantaggiato subisce sin dall'inizio
un « confronto » che lo scoraggia
anche dal punto di vista psicologico
ed emotivo.
Negli animali chi viene eliminalo
nei combattimenti per la conquista
del rango e della femmina si « adatta
•• a questa condizione di vinto,
anche dal punto di vista biologico,
perdendo la sua aggressività
sessuale. Una frustrazione sembra
dunque avere conseguenze anche
ormonali e condizionare il successivo
comportamento. in modo tale che la
sua curva di sviluppo non tende più a
salire parallelamente con le altre,
ma finisce per perdere quota e
allontanarsi sempre più dal plotone
di testa. È estremamente difficile
valutare gli andamenti di queste «
curve » di sviluppo e i loro punti di
arrivo (e ancor più difficile
compararle tra loro). È certamente
vero però che una frustrazione
psicologica (dovuta alla
competitivita) può influire
notevolmente sul rendimento a scuola
di un ragazzo che parte svantaggiato.
È una legge che vale, del resto,
anche nello sport, dove chi rimane
indietro si scoraggia e perde il
passo, mentre chi è in testa trova le
energie per accelerare ancor più il
ritmo in vista del traguardo. (È
interessante notare che un meccanismo
analogo è stato osservato anche nella
sessualità tra gli animali; chi perde
i tornei per la conquista della
femmina, perde anche, in seguito, la
sua aggressività sessuale.)
Personalmente, però, penso che
l'esempio dei villaggi primitivi
guatemaltechi contenga anche un altro
insegnamento, ancora più importante.
Per capirlo meglio potremmo rimanere
nel campo dello sport, e dire che in
una gara di sollevamento pesi tutti,
più o meno, danno gli stessi
risultati quando si tratta di
sollevare venti o trenta chili (come
avviene nei villaggi guatemaltechi
dal punto di vista mentale). Le
differenze notevoli cominciano ad
apparire quando si chiede di
sollevare cento chili, o anche di
più. Chi non è allenato non ce la fa.
In altre parole, in una scuola in cui
contano moltissimo qualità come il
linguaggio o la capacità di astrarre
o di concentrarsi su un problema, chi
riesce a sollevare solo cinquanta
chili mostra subito tutta la sua
debolezza: non regge più il confronto
con gli altri e finisce rapidamente
in fondo alla classifica o
addirittura viene escluso dalla
competizione. È quindi molto più
grave essere « deprivati » in una
grande città industriale che in un
villaggio nell'interno del Guatemala.
/ deboli diventano più deboli Questo
meccanismo, a mio avviso, mostra
quanto sia divenuto importante oggi
lo sviluppo mentale; infatti molto
più che in passato il successo, nel
nostro mondo, è determinato proprio
dalla capacità di risolvere i
problemi (e non soltanto quelli
scolastici). Nella storia
dell'evoluzione si sono sviluppati
certi « talenti » che permettevano di
affermarsi e sopravvivere (la forza,
la velocità, l'odorato, il mimetismo,
il volo ecc); in questa selezione
risultavano perdenti i più deboli, i
meno veloci, quelli che si
mimetizzavano meno bene o che non
fiutavano in tempo i pericoli.
Nell'uomo l'« organo » di selezione è
diventato sempre più il cervello:
oggi, infatti, per affermarsi è molto
più importante essere istruiti che
forti; la stessa aggressività, i
tornei, le lotte, si sono trasferiti
dai pugni alle parole. La diffusione
dell'istruzione, la scuola per tutti,
hanno permesso a strati sempre più
larghi di accedere allo sviluppo
mentale, ma proprio per questo la «
punizione »
è molto più dura per chi incespica e
non riesce a tenersi in equilibrio
sul treno della scuola: egli vede
allora il convoglio allontanarsi, e
gli altri passeggeri diventare sempre
più irraggiungibili. Paradossalmente,
insomma, la diffusione
dell'istruzione finisce per
svantaggiare proprio coloro che si
trovano negli ultimi gradini della
classifica culturale, vale a dire i
bambini che vivono nelle sacche
mentalmente arretrate. Ciò avviene
perché la scuola, che comincia con
apparente parità per tutti, in realtà
accoglie bambini che sono già stati
nutriti per cinque o sei anni con
succhi culturali familiari, e la
preparazione « atletica » della loro
mente è già stata in buona parte
impostata. Chi non ha avuto la
possibilità di iniziare bene a causa
di un ambiente sfavorevole avrà molte
difficoltà nel recuperare il ritardo;
il più delle volte sarà risucchiato
da una spirale di avvenimenti, che
concatenandosi tra loro lo
porteranno, in pratica,
all'insuccesso. Naturalmente si è già
tentato di correggere certe
situazioni di più evidente svantaggio
al momento dell'ingresso nella
scuola, ma il recupero a questo punto
si è dimostrato assai difficile. Lo
si è visto negli Stati Uniti dove si
è cercato di affrontare il problema,
con il progetto che si chiama appunto
Hcad Start (inizio della testa)
destinato ai bambini poveri,
specialmente quelli che vivono nei
ghetti negri. Si tratta di corsi pre-
scolastici che cercano di ridurre il
ritardo dovuto all'ambiente di
provenienza. Questo progetto aveva
sollevato grandi speranze quando fu
avviato nel 1965 dal presidente L.
Johnson, nel quadro di sviluppo della
« Grande Società ». Sfortunatamente
oggi si può constatare che i
risultati sono in realtà molto al di
sotto delle aspettative, per almeno
tre motivi. Intanto la durata dei
corsi è apparsa nettamente
insufficiente: per rimontare lo
svantaggio iniziale questi bambini
arretrati avrebbero bisogno di
programmi molto più sostanziosi. Il
secondo punto riguarda l'impostazione
stessa dei programmi, più orientati
verso lo sviluppo della socialità che
verso lo sviluppo delle capacità
mentali. Il terzo punto, infine,
quello fondamentale, riguarda proprio
l'età: non è a livello pre-scolastico
che si possono risolvere alla radice
i problemi, ma molto prima. [1
progetto Head Start (malgrado ì suoi
indiscussi meriti e l'aiuto portato
ai bambini svantaggiati sul piano
dell'igiene, della socialità e della
prevenzione sanitaria) è la
dimostrazione che il punto d'attacco
per modificare veramente questo
svantaggio si trova molto più a
monte, e che per essere efficace deve
penetrare molto più in profondità. La
controprova la fornisce un
eccezionale esperimento in corso a
Milwaukee. nel Wisconsin : una specie
di Head Start « totale » che è la
dimostrazione dell'importanza del
primo periodo di vita (quello
trascorso con la madre) per lo
sviluppo mentale. Un salto tra due
mondi Questo esperimento è diretto
dal professor Rick Heber a Milwaukee.
una cittadina nei pressi del lago
Michigan. « 11 nostro studio, » mi ha
detto Heber, « è cominciato con la
constatazione che negli Stati Uniti i
tre quarti dei ritardati mentali
nascono e crescono in zone rurali
molto povere o nei quartieri più
diseredati delle città. Le
percentuali più alte si hanno in
quartieri poverissimi o abitati da
gruppi di minoranze, quartieri dove
c'è un alto tasso di disoccupati,
dove le abitazioni sono sovraffollate
e le case cadono a pezzi. In questi
agglomerati urbani delle periferie il
numero dei ritardati mentali è venti
volte più alto della media americana.
« A Milwaukee abbiamo preso appunto
in esame un quartiere cittadino
caratterizzato dall'alta percentuale
di ritardati, e abbiamo scoperto che
un numero limitato di famiglie, in
particolare, contribuiva a rendere
così elevata la media. La
caratteristica più tipica di queste
famiglie era la scarsa capacità
mentale delle madri. Infatti i
quattro quinti dei bambini
che in età scolastica avevano un
bassissimo quoziente di intelligenza
(al di sotto degli 80 punti)
risultavano appunto essere figli di
donne con un quoziente intellettivo
inferiore a 80. In altre parole,
dalla nostra inchiesta è risultato
che il fatto di essere poveri e di
vivere in un ghetto non causa
automaticamente un ritardo mentale :
quello che sembra invece determinante
è il basso indice intellettuale della
madre. « Abbiamo notato molti tratti
tipici in queste madri d'intelligenza
limitata (che non si riscontrano in
altre famiglie del quartiere) : molto
spesso sono indifferenti, non badano
molto alla casa, sovente sono
separate dal marito, o hanno comunque
un rapporto instabile. Alcune di
queste madri non sembrano avere
alcuna nozione del futuro, né per sé
né per i propri figli, e formulano
aspirazioni che mancano di qualsia-si
senso della realtà. In genere
dedicano pochissimo tempo alla
conversazione e al rapporto con il
bambino. » I trenta bambini prescelti
dal professor Heber, tra questi
candidati al sottosviluppo mentale,
venivano quotidianamente portati al
Centro e affidati alle cure di
personale specializzato sin dai primi
mesi di vita. Ogni bambino, fino
all'età di quindici mesi, disponeva
di un'assistente personale. Non
veniva sottoposto ad alcun
trattamento, ma riceveva
semplicemente quella stimolazione che
ogni buona madre può dare al suo
bambino, se è in grado di capirne le
necessità. Verso un anno e mezzo si
metteva già l'accento sullo sviluppo
del linguaggio e dei processi
cognitivi, per esempio attraverso
l'interpretazione delle forme e dei
colori. A partire dai due anni molte
attività venivano svolte in gruppi di
tre o quattro bambini. A questo
livello già si cominciavano a
introdurre concetti matematici di
base e ad allenare i bambini a saper
distinguere suoni e immagini, per
rendere più facile, in seguito,
l'apprendimento della lettura. Ma
anche in questa prospettiva la
priorità era sempre data al
linguaggio come principale strumento
di conoscenza. Questo programma,
inoltre, andava di pari passo con un
UN GRAFICO ELOQUENTE Questo grafico
mostra l'andamento delle curve di
intelligenza di due bambi vati
diversamente: partendo dallo stesso
livello il bambino che vive con una
madre arretrata scende a 85 punti,
quello allevato nel centro dei
professor Heber saie a 125- La zona
ombreggiata al centro indica i valori
medi di intelligenza della
popolazione americana Programma di
riabilitazione materna, che
consisteva nell'ad-destrare le madri
a una serie di attività casalinghe, e
nel renderle coscienti
dell'importanza del loro ruolo per Io
sviluppo e la crescita mentale dei
figli. I risultati di questo
esperimento, che dura ormai da quasi
sei anni, sono davvero eccezionali, e
possono essere ben illustrati dal
grafico qui sopra. La curva inferiore
indica ciò che accade, di solito, ai
bambini che vivono in questo ambiente
familiare estremamente arretrato : il
loro sviluppo mentale perde quota, e
al momento dell'ingresso nella scuola
essi posseggono un quoziente di
intelligenza di soli 80-85 punti. La
curva superiore invece mostra
l'andamento dell'intelligenza tra i
bambini che frequentano il Centro del
professor Heber: il livello raggiunto
all'età di sei anni è di circa 125
punti'. Un'educazione adeguata, cioè,
ha permesso un salto da una zona di
sottosviluppo mentale a una zona di
brillante intelligenza.
I bambini educati nel Centro di
Milwaukee non hanno avuto bisogno di
alcuna manipolazione biologica, né di
pillole o elettrodi: semplicemente
sono stati assistiti da persone che
cercavano di svegliare in loro la
curiosità, l'attenzione, l'interesse
a imparare, anche ad esplorare. Non
sono stati imbottiti di nozioni, ma
stimolati a esprimersi e a diventare
creativi. Hanno imparato a usare il
linguaggio come uno strumento per
organizzare le idee e agire sulla
realtà. Al momento dell'ingresso a
scuola, il linguaggio non giocherà
più come uno strumento discriminante
a loro sfavore. Questi ragazzi, in
altre parole, non avranno più bisogno
di classi differenziali, di programmi
speciali o di corsi di recupero, che
li porrebbero in un ghetto educativo;
essi potranno invece iniziare con
vera parità intellettuale la scuola
di tutti. Queste ricerche, malgrado
certe critiche metodologiche,
mostrano che un tale risultato (per
questi bambini che vivono in
condizioni estremamente arretrate)
può essere ottenuto soltanto
intervenendo sin dalla prima fase
dello sviluppo mentale, quando il
cervello è ancora una creta
plasmabile. Sentiamo come commenta
questi risultati il professor Heber.
Una sottrazione continua « Le nostre
scoperte attuali, » mi ha detto
Heber, « tendono sostanzialmente a
dimostrare che il ritardo mentale che
si riscontra in queste sacche di
povertà (nei casi in cui non ha
origini organiche) può essere
senz'altro evitato se si riesce a
fornire a un individuo un'esperienza
educativa stimolante sin dal primo
periodo di vita. « Ciò che distingue
il nostro programma da altri
programmi pre-scolastici, è proprio
il fatto di essere basato sulla
precocità dell'intervento; non solo,
ma il nostro sforzo è diretto in modo
specifico a sviluppare soprattutto le
facoltà mentali.
« La cosa che ci ha stupiti, in
questo senso, è stata la grande
possibilità di crescita intellettuale
di cui dispongono i bambini. Tutti
noi che ci occupiamo di questo
programma crediamo fermamente che
ogni bambino (e non soltanto quelli
che provengono da un ambiente
deprivato) possa imparare molto di
più di quanto non avvenga oggi e
raggiungere risultati molto superiori
dal punto di vista intellettuale e
scolastico. I bambini nascono con
enormi capacità, e noi adulti non
facciamo che sottrarre continuamente
qualcosa a questo potenziale di
partenza. » « Per tutte queste
ragioni occorre cominciare il più
presto possibile? » « Sì, ne sono
convinto. Le nostre ricerche ci
inducono a ritenere che se un bambino
attraversa un periodo <buio> durante
il suo sviluppo mentale non potrà
porre efficacemente riparo alle
lacune più tardi, quando dovrà
confrontarsi a scuola con altri
bambini. Personalmente ho ora una
lunga esperienza di educazione dei
ritardati, e mi sono reso conto che
non è difficile insegnare loro
nozioni, o fatti, in modo che li
ricordino : però è molto difficile
insegnare a un ritardato a pensare in
modo indipendente, a essere creativo.
« È quello, invece, che siamo
riusciti a fare con questi candidati
al ritardo mentale presi in tempo,
nella prima infanzia. Tutto ciò che
il nostro gruppo ha realizzato nel
Mil-waukee aveva proprio questo
scopo: cercare di fornire al bambino
gli strumenti fondamentali con i
quali egli riuscisse a risolvere i
suoi problemi. È questo
l'atteggiamento verso la vita che
siamo riusciti a inculcare nei
piccoli condotti ogni giorno al
nostro Centro: non un atteggiamento
apatico, ma creativo, che in seguito
permettesse loro di modificare a
proprio vantaggio gli avvenimenti, e
non di subirli. « È un atteggiamento
che si impara sin da piccoli,
attraverso un buon rapporto educativo
con la madre : quando questo rapporto
è particolarmente carente, si può
rimediare con dei corsi speciali,
come quelli che noi abbiamo
organizzato.
« Oggi, insomma, ne sappiamo
abbastanza per evitare il
sottosviluppo mentale e permettere ai
bambini dì utilizzare il loro
patrimonio cerebrale in modo assai
più completo. » « Ritiene che questa
dimostrazione da voi data in
laboratorio possa modificare in
avvenire il sistema educativo su
larga scala? » « Sarei molto
immodesto se pensassi che queste
ricerche potranno modificare un
sistema tradizionale di educazione,
che qui negli Stati Uniti è rimasto
sostanzialmente immutato durante
l'ultimo secolo. Ma molti altri studi
spingono nella stessa direzione, e
sono certo che nel prossimo decennio
assisteremo a un profondo mutamento
in campo educativo, nel nostro paese.
Penso che l'inizio dell'educazione
scolastica comincerà, per tutti, a
tre anni, e forse anche prima per ì
bambini meno fortunati. » « Ma lei
pensa che sarà veramente possibile
cominciare ancora prima dei tre anni?
Un programma del genere sarebbe
realizzabile dal punto di vista
finanziario? » « Io credo di sì, e le
spiego subito il perché. Intanto non
ritengo necessario fare tutto ciò che
noi abbiamo fatto nel nostro Centro
per ogni singolo bambino : a mio
parere molte madri, anche negli
ambienti poveri, possono essere
all'altezza di diventare buone
maestre per i loro piccoli. « II
campo d'intervento si restringerebbe
quindi soprattutto a quella minoranza
di madri < altamente rischiose >,
come noi le definiamo, che
difficilmente potrebbero diventare
buone educatrici, per una loro
intrinseca incapacità mentale. È ai
figli di queste madri che noi
pensiamo. Il costo per un loro
salvataggio non deve spaventare : non
è soltanto un dovere morale, ma anche
un buon investimento. Infatti questi
bambini, lasciati a se stessi, non
potrebbero portare da adulti il loro
contributo alla società, e molti
finirebbero in istituti di ritardati
mentali. Tutto ciò, a lungo andare,
costerebbe alla collettività molto
più di un'educazione precoce, capace
di porre rimedio all'handicap
iniziale. »
// caso del kìbbutz L'esperimento del
professor Heber, che consiste nel
sottrarre praticamente certi bambini
all'influenza familiare a partire
dall'età zero, solleva naturalmente
un problema non indifferente: quale
ripercussione può avere tutto questo
sullo sviluppo affettivo del bambino?
È vero che, come abbiamo visto, egli
non ha bisogno di una madre biologica
ma di una madre psicologica, ed è
vero che un sostituto materno (come
avviene nelle adozioni) può essere
anche migliore dell'originale : ma è
evidente che i) bambino necessita di
un rapporto individualizzato e
stabile che difficilmente si può
trovare in un centro assistenziale,
per quanto ben organizzato. È
interessante ricordare in proposito
che una situazione del genere (che
esclude praticamente la madre dal suo
ruolo e-ducativo) esiste già nella
realtà: nei kibbutzim di Israele. I
bambini, nei kibbutzim, infatti,
vengono affidati sin dalla nascita a
centri comunitari che si
sostituiscono alla famiglia, poiché
padre e madre lavorano e non
potrebbero occuparsi di loro. Per
ragioni di natura diversa, dunque,
quasi come in un esperimento di
laboratorio, nei kibbutzim tutti i
bambini vengono sottratti già all'età
zero all'ambiente familiare, e oggi,
a distanza di anni, si possono forse
valutare i risultati di questa
educazione, che viene spesso accusata
di produrre ragazzi brillanti
intellettualmente, ma « piatti » dal
punto di vista affettivo. Per capire
meglio le cose mi sono recato a
visitare alcuni di questi centri
educativi in Israele. È bene
precisare, naturalmente, che quello
israeliano è un esperimento molto
particolare, poiché si riferisce a
situazioni sociali che toccano solo
una piccola parte della popolazione
(i kibbutzim riuniscono solo poco più
del due per cento degli abitanti di
Israele); però vale la pena di
osservare i risultati un po' più da
vicino. E vedremo poi perché.
Innanzitutto, due parole
sull'organizzazione dei kibbut-zim,
per inquadrare il problema. Sono
villaggi sparsi nelle campagne, di
qualche centinaio di persone, persone
che si ritrovano unite da una stessa
convinzione ideologica (alcuni
kibbutzim sono religiosi, altri atei,
alcuni marxisti, altri no); il
sistema di vita però, è ovunque
simile. La proprietà è collettiva (le
terre, le officine, le case
appartengono alla comunità) e il
lavoro viene svolto da ognuno sul
piano di parità : stessi stipendi per
tutti, con rotazione a turno per i
lavori sgradevoli (ho incontrato alla
mensa un ingegnere che per un anno
faceva il suo turno di lavapiatti,
prima di tornare a lavorare nella
piccola officina del kibbutz). Le
case non hanno la cucina, per la
semplice ragione che nessuno pranza
in casa: moglie e marito lavorano
fuori tutto il giorno, e per evitare
perdite di energie e di tempo, i tre
pasti della giornata sono «
centralizzati » in un ristorante
comune al centro del villaggio (dove
tutto è gratuito, naturalmente). In
queste condizioni è evidente che i
bambini debbono essere affidati a un
« nido d'infanzia totale », che
diventa il loro vero luogo di
residenza. Infatti il bambino,
portato sin dalla nascita a questo
nido, non abiterà mai più con i
genitori : mangerà, dormirà, studierà
nel centro insieme agli altri
bambini, e andrà solo in visita ogni
giorno dai genitori che abiteranno da
soli. Dal biberon al servizio
militare egli sarà via via preso in
carico da centri comunitari di vario
tipo che faranno fronte a tutte le
sue esigenze. L'assistenza è
indubbiamente di primissimo ordine :
i bambini sono riuniti in piccoli
gruppi di sei, e ogni gruppo dispone
di un'istitutrice specializzata e di
un'assistente. Essi vengono seguiti
quotidianamente in tutte le loro
attività, e per ogni « gradino »
educativo vi sono insegnanti e
assistenti appositamente preparate.
Si cerca, tra l'altro, di educare i
bambini al senso uguali-
Nei kibbutzim, per evitare invidie
e sviluppare il senso ugualitario i
bambini (riuniti in gruppi omogenei
di sei) hanno gli stessi giochi. Vi
sono anche giostre e auto a sei posti
per lavorire lo spirito d'equipe.
tario e sociale: vi sono persino gli
stessi giocattoli per tutti (sei
palette, sei dondoli, sei rubinetti
per l'acqua); alcuni giocattoli, come
giostre o auto, sono a sei posti per
sviluppare lo spirito di squadra. Ma
l'affetto della madre dove trova
posto in questa organizzazione? Ecco
la risposta del professor M. Gerson,
che dirige la formazione del
personale specializzato per
l'educazione nei kibbutzim. Affetto e
produttività « Capisco che visto da
fuori questo sistema possa
sorprendere e turbare, » dice il
professor Gerson, « ma se lo si
guarda più da vicino ci si accorge
che le cose stanno in modo molto
diverso, specialmente dopo i
progressi realizzati in questi ultimi
anni. Non solo è un errore pensare
che l'affettività non possa
svilupparsi in questi bambini a causa
del sistema educativo, ma direi,
anzi, che è vero il contrario.
« Innanzitutto bisogna dire che la
madre, nel kibbutz, è posta in
condizioni dì occuparsi molto di suo
figlio : nei primi mesi è esonerata
dal lavoro e può andare continuamente
al centro per occuparsi di lui, per
allattarlo. In seguito, quando il
bambino è un po' più grande e si
trova al nido, i genitori possono
andare a trovarlo in qualunque
momento, a qualunque ora. I kibbutzim
sono piccole comunità, di qualche
centinaio di abitanti, e non occorre
prendere l'autobus per andare dal
posto di lavoro al nido : tutto si
trova nel raggio di poche centinaia
di metri. Lei potrà vedere molto
spesso dei genitori in bicicletta (è
il mezzo di trasporto più diffuso)
che durante il giorno fanno una breve
sosta al centro educativo per
salutare i figli e giocare un attimo
con loro. « Ma c'è soprattutto
qualcosa di molto più importante: il
lavoro nel kibbutz è organizzato in
modo che i genitori siano entrambi
liberi ogni giorno dalle quattro alle
sette del pomeriggio (senza doversi
occupare di alcun altro problema,
neppure del pranzo della sera). In
quelle ore i bambini vanno a casa con
loro, stanno insieme, giocano e
vivono intensamente questo lungo
momento della giornata sotto ogni
punto di vista, anche affettivo. Mi
dica lei, in Italia o in qualsiasi
altro paese, quale padre e madre
hanno ogni giorno due o tre ore
libere da dedicare esclusivamente ai
figli, per giocare e occuparsi di
loro, senza sobbarcarsi continuamente
il ruolo di punitori, ma dedicando
loro le ore migliori? » Una domanda
imbarazzante, non v'è dubbio. Il
sistema del kibbutz, con i suoi pregi
e i suoi difetti, consente
effettivamente un rapporto intenso
dei figli con i genitori, in
particolare con il padre che
partecipa in misura notevole
all'educazione: è una figura «
presente ». Nessun padre, nella
nostra vita scombinata di città, può
stare così a lungo con i propri figli
: spesso li vede solo a tavola, di
sfuggita, con il sottofondo della
radio o della televisione. A volte
non lì vede neppure, perché quando
torna dal lavoro sono già a letto,
oppure è atteso come un punitore per
le malefatte della giornata. Nel
kibbutz ho visto invece ogni giorno
genitori e figli giocare nei prati
davanti a casa nei loro lunghi
pomeriggi liberi, come a noi può
accadere solo qualche volta la
domenica. Il bambino in realtà è una
figura centrale, e trova
un'organizzazione fatta su misura per
lui, forse fin troppo su misura. Il
problema sembra piuttosto un altro :
questi bambini, cioè, finiscono per
trovarsi in un ambiente fortemente
isolato dal punto di vista della
circolazione delle idee e del
confronto di opinioni, a causa della
rigida « omogeneità » culturale del
kibbutz. È un problema che già
sentono i giovani e di cui si rendono
conto onestamente i genitori: il
kibbutz infatti è una forma di
comunità che richiede una grande
carica ideologica, un clima da
epopea, che esalti e giustifichi la
rinuncia. Se le situazioni mutano
tutt'intorno, questo tipo di chiusura
verso l'esterno perde di motivazioni
e riemerge la necessità di nuove
aperture. Per quanto riguarda
l'affettività, comunque, genitori e
figli sono indubbiamente messi in
condizione di fertilizzare il loro
rapporto. Un'esigenza di natura quasi
biologica comincia però a farsi
sentire fortemente tra le madri :
molte di esse ora richiedono che il
piccolo resti a dormire a casa.
Finora questo non è stato possibile,
mi hanno detto, per ragioni
organizzative e anche per una
filosofia interna che intende evitare
alla donna impedimenti nella sua vita
personale e anche sociale (quasi ogni
sera vi sono riunioni sui problemi
economici e agricoli della comunità).
L'impressione mia, però, è che oggi
molte madri preferiscano una minore
libertà e magari una minore
produttività nella coltura della
barbabietola, pur di avere il bambino
con sé a casa. C'è in questo, forse,
un istinto di protezione che vuole
essere reintegrato nelle sue antiche
pulsioni: una madre ha bisogno non
soltanto di giocare col piccolo ma
anche di sentire il suo respiro la
notte, o di svegliarsi per un suo
colpo di tosse. Ha bisogno di
condividerne tutti i momenti, e anche
di preoccuparsi per lui. Nidi o
parcheggi? Al di là dei suoi difetti
e dei suoi pregi (non dimentichiamo
che questo sistema consente una vera
parità educativa), l'esperienza del
kibbutz può insegnare anche a noi
parecchie cose. È innegabile,
infatti, che anche nella nostra
società il modo nuovo di vivere, il
lavoro femminile, la lontananza dei
nonni, creano sempre più la necessità
di affidare il bambino per l'intero
arco della giornata a dei centri, ad
asili-nido che svolgano la loro
funzione essenziale nell'educazione e
che non siano soltanto dei «
parcheggi » per bambini. Sotto questo
punto di vista, i nostri « kibbutzim
» cittadini sono molto meno
organizzati, e il cervello del
bambino viene lasciato un po' alla
buona sorte. Gli esperimenti del
professor Heber, di cui parlavamo
prima, indicano oggi senza equivoci
che il quoziente intellettivo di un
bambino può passare da zone di
sottosviluppo mentale a zone di
brillante intelligenza (o viceversa,
naturalmente) a seconda
dell'ambiente; e mostrano quindi
quale prezioso patrimonio
intellettuale viene affidato a chi è
responsabile di questa assistenza. Il
bambino ha bisogno di ben altro che
di una custodia: gli studi in corso
rappresentano in questo senso una
vera rivoluzione delle idee per
quanto riguarda lo sviluppo
cognitivo, e non possono rimanere
senza conseguenze sul sistema
educativo e assistenziale. Oggi una
donna che lavora a chi può affidare
serenamente il cervello del proprio
figlio? Se ci guardiamo intorno, ci
rendiamo conto che il panorama è
abbastanza sconsolante. Pur
tralasciando i casi estremi (ho la
testimonianza diretta di una madre
che si è accorta che la sua bambina
veniva « drogata » con dei
tranquillanti perché dormisse, dalla
don-
na che la « custodiva » a pagamento,
assieme ad altri otto o nove bambini)
non si può dire che la scelta, tra
quanto viene offerto di privato e di
pubblico, possa esser fatta a cuor
leggero: il vero problema sembra la
preparazione del personale
specializzato, e gli asili-nido ne
sono un esempio. Un servizio sociale
Gli asili-nido sono indubbiamente
destinati a conoscere un'espansione
crescente, per un insieme di ragioni
pratiche evidenti, ed è quindi bene
che sin d'ora il problema venga
impostato nei giusti termini, in modo
che si sappia, anche dal punto degli
investimenti sociali, in quale
direzione muoversi. « Penso che in
proposito sia necessario distinguere
un certo numero di cose che spesso
vengono confuse tra loro, » mi ha
detto il professor Giovanni Bollea,
direttore dell'Istituto di
neuropsichiatria infantile
dell'Università di Roma. « Intanto
sarebbe bene chiedersi : l'asilo-nido
è solo una necessità per le madri che
lavorano, o può anche essere uno
strumento capace di aiutare
psicologicamente il bambino? Direi
che è importante rispondere a questa
domanda, perché vi è spesso un'ansia,
o un senso di colpa o di ribellione
da parte di molte madri, alla
prospettiva di dover portare il
figlio all'asilo-nido. Ebbene, in
campo scientifico, si sta da più
parti ridimensionando il concetto di
< carenza affettiva > : questa
mancanza di affetto può essere
infatti quantitativa (cioè una
mancanza totale o parziale della
madre) ma può essere anche
qualitativa, cioè la conseguenza di
una < non accetta-zione>, cosciente o
subcosciente, del figlio. « Questa <
non accettazione > può avere molte
cause, ma una, importante, può
trovare origine nell'attuale aumento
dei matrimoni tra i giovani. La
giovane coppia si trova infatti
nell'impossibilità di concedersi il
minimo divertimento, di svolgere una
normale vita sociale proprio per la
presenza del
figlio piccolo, e l'assenza sempre
crescente di nonni cui affidare il
bambino. « Sorge così una frequente
non-disponibilità intima per i figli:
essa è alla base di una carenza
affettiva di qualità, che può essere
molto più nociva della carenza
affettiva di quantità, rappresentata
dall'asilo-nido. « D'altro canto è
bene aggiungere che il bambino, già
nei primi mesi di vita, si abitua
facilmente al ritmo casa-asilo e alla
parziale assenza della madre, purché
alla madre siano riservate le
principali manipolazioni, tra cui il
bagno serale e l'allattamento (se è
ancora misto). Inoltre le esperienze
e le stimolazioni dell'asilo possono
essere beneficile per quanto riguarda
la maturazione della mobilità, del
linguaggio, e della socializzazione.
« Per quest'insieme di ragioni io
ritengo che l'asilo-nido non sia
soltanto una necessità per le madri
che lavorano, ma debba essere
considerato anche un vero e proprio
servizio sociale per il quale è
urgente fare gli sforzi necessari. «
L'asilo va ormai visto come
un'attrezzatura di residenza, sia sul
posto di lavoro (aziendale) sia
quando si è a casa (di quartiere o di
caseggiato). « L'asilo di quartiere
(e soprattutto di caseggiato) dovrà
esser aperto, almeno quattro giorni
la settimana, sino alla mezzanotte,
ed essere attrezzato per ricevere
anche bambini dai tre ai sei anni, in
modo da dare alla giovane coppia la
possibilità di una vita di società
fuori dalle ore di lavoro, proprio
per evitare l'insorgere di una serie
di rapporti anormali nel triangolo
familiare. » « Naturalmente tutto
questo richiede un notevole sforzo
finanziario e un personale
adeguatamente preparato. » « Certo.
Occorre innanzitutto che il rapporto
numerico sia quello giusto: una
puericultrice ogni quattro lattanti,
oppure una ogni cinque divezzi.
Questo è un postulato essenziale per
un buon asilo. Poi occorre che la
puericultrice disponga di specifiche
doti attitudinali (equilibrata, non
possessiva,
paziente, facilmente comunicativa); e
inoltre che sia preparata non come
una tecnica preposta alla custodia
(<non deve cadere >, <non deve
ammalarsi >, <non deve essere
bagnato, <deve nutrirsi)) ma alla
costante stimolazione percettiva del
piccolo. « La puericultrice deve
conoscere i problemi dello sviluppo
psicologico e motorio del bambino e
le sue necessità e modalità di
comunicazione. Deve anche saper
osservare i ritardi in questi
settori, ed eventualmente, sotto la
guida del consulente, stimolare
opportunamente il piccolo. « Vi è
dunque la necessità assoluta e
prioritaria che ogni Regione pensi
alla preparazione del personale:
dobbiamo cominciare a considerare il
nido un servizio essenziale, per la
famiglia moderna. » // livello di
guardia I problemi da affrontare a
livello di asili-nido sono dunque
immensi e richiedono uno sforzo
prioritario. D'altra parte, per
svolgere nelle migliori condizioni
questa assistenza (anche dando per
scontata l'esistenza del personale
adatto) occorrerebbero cifre
astronomiche. Negli Stati Uniti è
stato calcolato che un centro modello
costerebbe l'equivalente di 3000
dollari l'anno per bambino (cioè
oltre un milione e mezzo di lire) :
questo è infatti il costo del centro
per l'infanzia di Syracuse, nello
Stato di New York, che accoglie
bambini a partire dai sei mesi. Tra
il nulla e il centro modello esiste
evidentemente tutta una gamma di
soluzioni intermedie : gli esperti
ammoniscono però a non scendere sotto
un certo « livello di guardia »,
poiché riducendo il personale,
risparmiando sulle attrezzature e
sugli stipendi (e quindi sulla
qualità) l'asilo-nido tende a
diventare piuttosto un brefotrofio,
con i gravi danni per il bambino a
cui si è già accennato.
In altre parole un « centro modello »
per l'infanzia e un brefotrofio
possono essere la stessa cosa, così
come un buon chirurgo e un pessimo
chirurgo sono entrambi « dottori » :
però a uno si può affidare con
fiducia la pancia, all'altro è bene
non affidare neppure i calli. Ciò
significa che per risolvere veramente
il problema dell'assistenza ai più
piccini occorrerebbe, oltre a molto
denaro e a molto personale, un alto
livello educativo che appare oggi
ancora assai lontano dalla realtà.
Purtroppo questi problemi sono spesso
visti in chiave « amministrativa »,
sotto il profilo della quantità e non
della qualità: numero degli asili
nido, quantità di bambini assistiti,
volumetria delle aule e numero degli
attaccapanni. In realtà non si può
amministrare il cervello come un
ufficio postale; la qualità degli
educatori è fondamentale, se si
vogliono ottenere certi risultati.
Tutte queste considerazioni, insomma,
fanno emergere, per ritocchi
successivi, un ritratto dell'asilo
nido assai diverso da quello
convenzionale; l'insistenza
giustamente espressa dal professor
Bollea sulle qualità umane e
professionali delle puericultrici e
sul rapporto personalizzato che deve
esistere con i piccoli, mostra bene
che è necessario lavorare subito in
questa direzione, se si vogliono
creare centri veramente capaci di
accogliere ed educare dei cervelli
umani. È un problema, del resto, che
non riguarda soltanto gli asili-nido,
ma ogni grado di istruzione: educare
gli educatori è ormai diventato uno
degli obiettivi sociali più urgenti.
Non è un compito facile, soprattutto
perché richiede tempo e denaro. Ma
ogni giorno che passa è perduto, ed è
in questa direzione che occorre
muoversi con priorità rispetto ad
altri investimenti. I costi debbono
essere valutati in una prospettiva
d'insieme di sviluppo di un paese,
guardando più in là dei prossimi
cinque minuti. Proprio per questa
ragione l'asilo-nido non può essere
che
uno degli aspetti di questa
rivoluzione scolastica : educare gli
educatori significa infatti
cominciare a educare i genitori, che
costituiscono il primo e vero
retroterra culturale del bambino
aiutandoli a svolgere meglio il loro
ruolo di maestri. L'azione sulla
famiglia Questa idea è già alla base
di taluni studi, che tenendo conto
delle circostanze presenti, cercano
di vedere come è possibile operare
direttamente sulla famiglia. «
L'asilo-nido, » dice il professor
Aldo Visalberghi, ordinario di
pedagogia nell'Università di Roma e
direttore del Centro Nazionale
Italiano per le Tecniche Educative
(CNITE), « sta diventando una
necessità sempre più evidente e ovun-
que si comincia a diffondere oggi una
presa di coscienza circa il suo
valore educativo e sociale (anche per
rispondere alle nuove esigenze della
donna, che non potrà rimanere
fossilizzata nel ruolo di < casalinga
>, perpetuando una evidente
sperequazione tra i sessi nella
società). « Si dovrà giungere quindi
a asili-nido di azienda, di
caseggiato, di fattoria favorendo per
la donna una elasticità nel lavoro,
graduata eventualmente con l'età di
sviluppo del bambino. Detto questo,
tuttavia, non sappiamo fino a che
punto l'asilo-nido possa veramente
costituire una soluzione ottimale se
non vi sarà parallelamente un'azione
svolta anche a favore della famiglia.
Tutte le ricerche mostrano infatti
quanto sia importante l'ambiente
familiare, che è il luogo in cui il
bambino riceve la sua vera impronta
educativa: in ogni attimo della
giornata, sin dal momento in cui è
sveglio, egli è aperto a uno <
scambio > con gli adulti che gli sono
accanto. Una famiglia (anche non
colta) che si occupi normalmente del
bambino lo circonda di stimoli
autentici, di piccoli insegnamenti e
di esperienze che in continuazione lo
arricchiscono, anzi ne formano, entro
certi limiti, ]'< intelligenza >.
« La possibilità di riprodurre tutto
ciò in istituzioni come gli attuali
asili-nido, ci rende assai perplessi.
Forse se disponessimo veramente di
puericultrici di prim'ordine (e in
gran numero) ciò potrebbe essere
possibile. Ma ne siamo ben distanti.
E siamo ancora più distanti dai
risultati del professor Heber che
sono stati ottenuti mettendo una
persona a disposizione di ogni
neonato, cioè effettuando in pratica
una sostituzione della madre durante
buona parte della giornata. « Tutto
questo mi fa ritenere che se da un
lato gli asili-nido sono un'esigenza
molto importante e vanno realizzati
nel migliore dei modi (proprio per
evitare il rischio di diventare dei
puri e semplici luoghi di custodia
con l'inevitabile deprivazione
mentale che ne deriverebbe), d'altro
lato è anche in direzione della
famiglia che occorre agire. Occorre
preparare i genitori, le madri (e in
particolare certe madri) ai loro
compiti educativi : infatti, anche
per quanto riguarda lo sviluppo
dell'intelligenza e della creatività,
la qualità del rapporto materno è
essenziale. « Numerose osservazioni
(effettuate in vari paesi e qui da
noi in Italia) mostrano del resto che
anche la donna che lavora può essere
un'eccellente madre, se è in grado di
compensare le sue assenze con
l'intensità e la qualità del
rapporto. » L'asilo-nido sembra
dunque essere necessario ma non
sufficiente. Se da un Iato, cioè, è
urgente convogliare gli sforzi verso
un'assistenza precoce, garantendo
centri che siano all'altezza del
delicato compito cui sono preposti,
d'altro lato è importante cominciare
un'azione all'interno stesso del
nucleo familiare. Un'azione che a
livelli diversi raggiunga ogni tipo
di famiglia, cercando di aiutare e di
migliorare, in particolare, la
capacità educativa delle madri. In
questo quadro d'insieme si inserisce
un'idea decisamente nuova, che sembra
essere il prossimo e più ambizioso
progetto di molti ricercatori : la
scuola in casa.
È in famiglia che il bambino
sviluppa la sua capacità di imparare.
Arr la ha spesso alle sue spalle
lunghissimi anni di occasioni perdute
vando a scuo-
X • LA SCUOLA IN CASA Da casalinga a
maestra L'idea di coinvolgere i
genitori nell'educazione scolastica
dei figli, sin dalla primissima
infanzia, viene oggi portata avanti
da varie parti e si muove in diverse
direzioni, come vedremo nel corso di
questo capìtolo: il punto di partenza
è la constatazione che ì mezzi
scolastici tradizionali sono
inadeguati a far fronte ai nuovi
compiti educativi, e che occorre
stimolare e mobilitare le forze
disponibili all'interno stesso della
famiglia per operare un salto
qualitativo. L'idea di base, in
fondo, è che la donna (non soltanto
nella società, ma anche in casa) deve
essere riqualificata, e deve imparare
a occuparsi più del cervello del suo
bambino che dei pannolini: da «
casalinga » deve diventare « maestra
». Per questo non le è necessario un
diploma, ma semplicemente un aiuto
appropriato e intelligente. Esistono
vari esperimenti pilota in questo
campo. Per esempio due psicologi
americani, Susan Gray e Phyllis
Levenstein, stanno cercando di creare
« scuole in casa » attraverso
assistenti volanti, che visitano a
intervalli regolari le famiglie e
lavorano in collaborazione con loro,
suggerendo i mezzi più appropriati
per stimolare lo sviluppo mentale dei
bambini, senza creare noia o
costrizione. Essenzialmente questi
visitatori funzionano più come
consulenti che come maestri, fornendo
consigli e idee ai genitori.
Spesso, per evitare una certa
diffidenza che può nascere nei
confronti degli psicologi, essi
tendono a presentarsi come «
dimostratori di giocattoli ».
Infatti, tra il materiale che portano
alle famiglie, figurano molti giochi
educativi, adatti all'età del piccolo
e suscettibili di sviluppare
gradualmente certe sue capacità. Ma
nel campo dell'educazione a domicilio
alcuni ricercatori si sono spinti
molto più in là. Vorrei citare in
proposito quello che ho visto
realizzare in Israele. I kibbutzim in
questo caso non c'entrano: si tratta
di un esperimento effettuato in un
normale quartiere cittadino, tra
famiglie di basse condizioni
economiche, alla periferia di
Gerusalemme. Esso riguarda per ora
bambini al di sopra di tre anni, ma è
già allo studio la possibilità di
estenderlo anche a bambini più
piccoli. Ecco quanto mi ha detto la
dottoressa Lombard, psicoioga
all'Università di Gerusalemme, che ha
ideato e diretto questo nuovo
tentativo di scuola-domicilio. «
Ebbene, noi cerchiamo di raggiungere
direttamente le famiglie, prima
ancora che il bambino arrivi alla
scuola materna istruendo le madri sul
modo di aiutare i piccoli a
sviluppare le proprie capacità
mentali. Pensiamo infatti che quando
il bambino arriva alla scuola materna
sia già tardi, ed esista già un
problema dovuto alle carenze
educative familiari, in un ambiente
culturalmente povero. Cerchiamo
quindi di agire direttamente sulla
madre, e di insegnarle ad essere
anche un'educatrice. » « In che cosa
consiste esattamente il vostro
intervento? » « La madre riceve, una
volta la settimana, la visita di
un'altra donna che appartiene alla
stessa comunità (non un'insegnante o
una psicoioga) e che le porta del
materiale didattico preparato da noi.
Io credo che sia importante operare
attraverso < collaboratrici > che
provengano dall'interno stesso della
comunità (scelte tra quelle che
risultano più adatte) per
due motivi : innanzitutto per ragioni
psicologiche, in quanto la madre si
trova più a suo agio sapendo che
questo aiuto le viene dal suo stesso
ambiente; e poi perché in questo modo
noi veniamo a disporre di una rete di
assistenti che nessuna Università o
Ente potrebbe fornire. Queste
collaboratrici portano dunque ogni
settimana del materiale didattico,
spiegano come deve essere usato, e
poi la madre continua da sola col
bambino, ogni giorno per venti-trenta
minuti. » « È una specie di corso a
domicilio, insomma, che la stessa
madre tiene al figlio, trasformandosi
in maestra. » « Sì. Si tratta di
piccoli giochi di abilità, di
indovinelli, di problemi accompagnati
da disegni divertenti. Abbiamo
cercato di presentare queste lezioni
in modo che il bambino si interessi a
seguirle. È un corso completo che
dura da ottobre fino a maggio, per
tre anni consecutivi. » « Ma non è un
programma un po' troppo impegnativo?
» « No, i risultati ci hanno dato
ragione: su quarantotto famiglie che
avevano iniziato il corso ben
quarantacinque l'hanno portato a
termine. È stato un grosso successo.
E credo che abbia una sua spiegazione
: una volta che ha capito l'utilità
di queste piccole lezioni quotidiane,
la famiglia si rende conto che grazie
ad esse il bambino può crescere
meglio intellettualmente, e può
entrare più preparato nella scuola e
nella vita. Ciò è assai importante
per famiglie che hanno sofferto di
frustrazioni. « Un altro fattore
psicologico non trascurabile, credo
sia la visita settimanale
dell'assistente, che in un certo
senso costituisce con la sua presenza
un impegno continuo. » « Ma non si
pongono problemi pratici, soprattutto
per queste madri che generalmente
hanno molti figli e poco tempo? » «
Queste lezioni, per la verità, non
richiedono molto impegno. Se la madre
vuole, il tempo lo trova,
organizzandosi. Il problema è che in
un ambiente povero le madri
solitamente soffrono anche di cattiva
organizzazione. Ma se capi-
scono il valore di questa iniziativa,
riescono a seguirci. Abbiamo famiglie
con dieci figli che rispondono
positivamente. « D'altronde, proprio
in seguito al successo ottenuto,
prevediamo di estendere l'esperimento
a bambini ancora più piccoli, o
addirittura di cominciare prima della
nascita, preparando la madre sin
dalla gravidanza a diventare una vera
maestra per i propri figli. » L'uovo
e la gallina Esperimenti analoghi
sono stati condotti con successo
anche negli Stati Uniti. A Flint,
Michigan, la dottoressa Mil-dred
Smith ha potuto constatare che
l'iniziativa di portare materiale
didattico in casa di famiglie
economicamente svantaggiate, e di
chiedere l'aiuto dei genitori, è
stata accolta con favore nel novanta
per cento dei casi, e quasi tutti i
genitori hanno chiesto, in seguito,
la continuazione del programma.
L'idea di cominciare dalla famiglia
ha fatto ora sorgere negli Stati
Uniti un nuovo programma sperimentale
sovvenzionato dal governo, chiamato
Home Start (inizio in casa), che se
avrà successo potrà condizionare il
futuro sviluppo dell'educazione pre-
scolastica americana. \SHome Start
vuole essere il correttivo, in un
certo senso, del programma Head
Start, di cui abbiamo parlato nel
precedente capitolo. Con questo nuovo
programma si intende infatti agire
sulla famiglia direttamente, a una
fase molto precoce dello sviluppo
infantile, tentando di rimuovere
almeno in parte quelle cause che sono
all'origine di un insuccesso nella
scuola, e molto spesso anche nella
vita. Il discorso qui si allarga
nuovamente, e da educativo torna ad
essere sociale. È evidente che questi
due aspetti sono strettamente
connessi e si influenzano a vicenda:
non si può risolvere veramente l'uno
se non sì tiene conto anche
dell'altro.
Educazione e società sono come l'uovo
e la gallina, si generano a vicenda.
Cominciando ad agire sulla famiglia
(non soltanto attraverso
l'educazione, ma aiutando in senso
lato i genitori a essere veramente
tali) certi psicologi, come il
professor Sheldon White
dell'Università di Harvard, pensano
che sia possibile inserirsi, per così
dire, nel nucleo ovulare del
problema, provocando una mutazione
capace di produrre una serie di
effetti a catena nel ciclo
educazione-società. « Se si indaga un
po' a fondo nella storia di bambini
che lasciano la scuola e diventano
sfaccendati o delinquenti, » mi ha
detto Sheldon White, « ci si accorge
che il problema non comincia a
scuola, ma prima. Io non credo che
basterà agire sulla scuola; dovremo
muoverci in direzione della famiglia,
per aiutarla a sviluppare meglio il
bambino. Non si può realizzare alcun
tipo di riforma scolastica e
prescolastica che non tenga conto
della famiglia. » « Lei ritiene che
questo tipo di intervento possa avere
come effetto il cambiamento di certe
situazioni sociali anche a lunga
scadenza? » « Questo è l'obiettivo.
Vede, se si cerca di migliorare le
condizioni sociali agendo sul
reddito, sulle case, sul lavoro, sul
tempo libero, sull'occupazione,
sull'assistenza, in definitiva ci si
accorge che nella nostra società c'è
gente che in pratica non ha mai avuto
una vera partenza nella vita. C'è
gente nata in ambienti poveri, da
genitori che non erano in grado di
occuparsi di loro, o di fornire loro
un'educazione adeguata. Certi
bambini, all'età di due o tre anni,
hanno già accumulato tali esperienze
negative da rimanere pessimisti per
il resto della vita. L'interesse a
questi problemi dell'infanzia non è
nuovo, è cominciato già all'inizio
del secolo, anzi molto prima, due
secoli fa, con le questioni del
lavoro infantile, della scuola per
tutti ecc. Oggi però esperimenti
condotti su animali, e anche su
neonati, ci hanno dato la
dimostrazione scientìfica che certe
carenze dei primi anni di vita ben
difficilmente potranno essere
compensate negli anni successivi.
Molti barn-
bini perdono la corsa all'età di due
anni, alcuni già alla nascita. « In
realtà molte famiglie povere
saprebbero come allevare i figli se
ne avessero la possibilità, il tempo,
la sicurezza. Molte donne non
avrebbero bisogno di una laurea in
pedagogia ma di una possibilità di
essere veramente madri. Oggi c'è un
interesse crescente per questi
problemi perché ci si rende conto che
la possibilità di intervento si pone
a questo livello. » Un servizio
civile educativo? Molti altri
esperimenti-pilota sono in corso,
particolarmente negli Stati Uniti,
diretti ad aiutare le madri nel loro
ruolo di educatrici. Il professor
Earl Schaefer, del National Institute
of Mental Health, organizzò tempo fa
un programma di visite a domicilio di
educatrici specializzate, che per un
anno dedicarono un'ora al giorno a
bambini residenti nei quartieri più
poveri di Washington, aiutando anche
moralmente le madri. Nel giro di un
anno i bambini mostrarono (grazie a
questa semplice visita) un aumento di
10-15 punti nel quoziente di
intelligenza, nei confronti di altri
bambini che non partecipavano al
programma. Il costo di un'azione del
genere è naturalmente molto elevato,
poiché un'educatri-ce può seguire non
più di quattro o cinque bambini al
giorno, tenuto conto degli
spostamenti da una casa all'altra. Ma
i risultati ottenuti indicano che
varrebbe la pena di cercar di
organizzare questa assistenza in modo
meno costoso: per esempio con dei
volontari, o un servizio civile
obbligatorio. E torno qui a un'idea
già espressa in un mio precedente
libro: credo infatti che molti dei
problemi sociali, e in particolare
quelli dell'assistenza, potranno
essere risolti soltanto ricorrendo a
una nuova formula d'intervento, cioè
a un servizio civile obbligatorio che
veda i giovani di ambo i sessi
svolgere compiti per i quali diventa
sempre più difficile o
costoso trovare il personale. È una
formula che può valere per lavori
sgradevoli (assistere e pulire i
vecchi nei cronicari), o scomodi (i
turni di notte negli ospedali) o
finanziariamente troppo gravosi: per
esempio, appunto, l'educazione a
domicilio e l'aiuto alle madri
bisognose. Tutto ciò comporterebbe
una radicale trasformazione del
servizio militare, che diventerebbe
così un fattore prezioso di progresso
sociale e anche intellettuale del
paese. Torneremo in seguito su questo
argomento, molto importante. Altri
esperimenti educativi dimostrano che
si possono ottenere buoni risultati
aumentando la « produttività » delle
educataci. Per esempio a Mount Vernon
— riferisce la scrittrice Maya Pines
— esiste un « Centro per lo sviluppo
del bambino », dove le madri
accompagnano i piccoli per una sola
ora al giorno. Mentre i piccoli
vengono istruiti, le madri possono
disporre di macchine per cucire (si
potrebbe anche pensare di abbinare il
centro a una lavanderia a gettone, o
a un super-mercato ecc). Per ogni
gruppo di dodici o quindici bambini
vi sono tre adulti : una maestra con
diploma Montessori, una maestra
tirocinante e un'assistente: la
proporzione è quindi di un adulto per
ogni gruppo di quattro o cinque
allievi. Nonostante questa
proporzione, grazie ai turni di
un'ora, il Centro (che rimane aperto
mattino e pomeriggio) riesce con le
sue sei insegnanti ad avere contatto
con 125 bambini ogni giorno. La
signora Rambusch, animatrice del
Centro, afferma che quest'ora di
lavoro ben fatto può essere più
efficace di due ore e mezzo o tre di
scuola materna. Infatti, quando si
toglie il tempo per la distribuzione
dei succhi di frutta, quello per
andare al gabinetto, quello per
giocare all'aperto e così via. non
rimane a una normale scuola materna
che un'ora e mezzo di lavoro
effettivo. Durante l'ora preziosa che
trascorrono al Centro i bambini
ricevono un insegnamento intenso, e
diretto particolarmente allo sviluppo
delle loro capacità cognitive. Essi
si interessano talmente alle attività
che alla fine della le-
zione cedono malvolentieri il posto
ai bambini del turno successivo. In
altre città sono cominciati a sorgere
dei centri comuni-tari che raccolgono
i bimbi di due o tre caseggiati. Per
ora sono degli insegnanti a tenere i
corsi, ma la formula potrebbe essere
allargata con la partecipazione
diretta dei genitori, sollecitandoli
a diventare non solo promotori ma
anche protagonisti di questa
educazione prescolastica. Infatti se
l'aiuto statale è importante, sarebbe
illusorio affidarsi completamente
all'assistenza pubblica con la
deleteria abitudine di considerare
che i diritti sono i propri e i
doveri quelli degli altri. Un modo
nuovo di essere madre La
partecipazione diretta dei genitori
appare a molti psicologi un fattore
essenziale per l'organizzazione di
una struttura prescolastica più
efficiente, e nulla vieta che le
madri entrino esse stesse nelle aule
per aiutare le insegnanti, lavorando
sotto la loro direzione.
Un'esperienza significativa in questo
campo è stata svolta dalla dottoressa
Caroline Saxe, pedagogista
dell'Università di New York e
precorritrice di nuove tecniche
didattiche. « Abbiamo portato molte
madri in classe, » mi ha detto la
dottoressa Saxe, « con risultati
decisamente proficui. Donne, badi
bene, che non hanno necessariamente
un'elevata preparazione o titoli di
studio, ma che sono in grado di
lavorare con piccoli gruppi di
bambini, comprendendone i problemi e
le esigenze. È un esperimento che
contìnua con successo. La loro
collaborazione si è mostrata
preziosa; esse ci trasmettono
continue informazioni su quanto
avviene nell'aula, e insieme a noi
partecipano alle decisioni da
prendere in merito a questo o quel
bambino, per cercar di risolvere i
suoi problemi, sia nella scuola sia
in casa. » Accanto a queste
iniziative di vario tipo a livello
prescola-
stico, tutto un immenso campo si apre
anche per quanto riguarda il ruolo
dei medici e dell'assistenza
sanitaria in generale. Sono canali di
intervento molto importanti ed
efficienti, rimasti sinora
praticamente confinati
all'informazione igieni-co-sanitaria.
Da parte di psicologi ed educatori si
chiede che anche a questo livello
venga ampliato il discorso,
coinvolgendo lo sviluppo mentale,
oltre che quello fisico, del bambino
e tenendo conto di tutte le scoperte
fatte in questi ultimi anni sullo
sviluppo del cervello. Una tale
azione, è ovvio, deve cominciare già
dalla clinica ostetrica, al momento
della nascita, e deve correre
parallelamente all'assistenza
sanitaria: non dovrebbe essere
difficile raccogliere l'unanimità sul
concetto che l'aumento regolare del
peso è importante, ma che quello
dell'intelligenza lo è forse ancor di
più. Questa rivoluzione nello svilppo
cognitivo, d'altronde, può rivalutare
non soltanto il bambino ma anche la
madre. Infatti, rendere la madre
consapevole e protagonista di questa
meravigliosa e stimolante impresa,
vale a dire la nascita di una mente,
significa nobilitare ancor più il suo
compito. Per questo occorre che oggi
una madre diventi più « educatri-ce »
che « casalinga ». Immersa nei
pannolini, nelle pappe e nei
rigurgiti, essa si sente spesso
frustrata intellettualmente; ma può
ritrovare una diversa prospettiva se
è consapevole che la sua
intelligenza, il suo talento, la sua
sensibilità sono praticamente le sole
cose che permettono a un batuffolo
umano di emergere dalla notte animale
e di diventare un essere pensante.
Tocca a lei plasmare, modellare,
stimolare la nascita
dell'intelligenza, della creatività,
della personalità: il suo compito è
molto simile a quello dì uno
scultore, di un pittore, di un
musicista. Il figlio è in buona parte
una sua « composizione », per la
quale occorre altrettanto talento di
quanto può occorrerne a un artista
per realizzare una creazione
personale. E forse di più.
Televisione e cervello La madre può
essere consigliata e aiutata in
questo suo compito anche da uno
straordinario mezzo moderno: la
televisione, le cui possibilità di
impiego sono solo agli inizi.
Disporre di una buona televisione
significa disporre a domicilio di un
insegnante, di un consigliere e di
una scuola capace di portare al
bambino un fiume di stimoli fecondi.
Evidentemente anche in questo caso il
discorso verte subito sui contenuti:
la televisione è semplicemente un
veicolo tecnico per trasportare
immagini, suoni, informazioni, idee.
È come un megafono, attraverso il
quale si possono dire delle idiozie o
delle cose intelligenti. Non basta
quindi dire di fare dei programmi
educativi, occorre che lo siano
veramente. Altrimenti è come per ì
brefotrofi. Naturalmente la
televisione ha il grosso
inconveniente di comunicare a senso
unico: non permette una risposta
attiva, un « dialogo »
personalizzato. A pensarci bene,
tuttavia, anche un libro pone il
lettore in una situazione analoga.
Diciamo quindi che la televisione
deve essere usata nel modo giusto,
come un torrente al quale attingere
per arricchirsi di immagini,
informazioni, idee, da utilizzare poi
nel proprio « montaggio » cerebrale.
Il video non può certo sostituire né
la madre né la scuola, ma può aiutare
tutte e due. Utilizzato propriamente,
quale migliore mezzo può esistere per
raggiungere i piccoli attraverso un
insegnamento adatto alla loro età e
ai loro interessi? Negli Stati Uninti
ora un programma speciale è dedicato
ai bambini che ancora non frequentano
la scuola materna. Il programma,
divenuto estremamente popolare, si
chiama « Sesame Street ». Tutte le
mattine per una intera ora milioni di
piccoli americani sono dinnanzi al
teleschermo per seguire le avventure
di divertenti personaggi che
insegnano loro a risolvere piccoli
problemi, a contare, a leggere, a
capire concetti astratti, ad
arricchire il vocabolario.
Il programma, diffuso inizialmente da
una stazione educativa, ha avuto un
tale successo che anche le stazioni
commerciali lo mettono ora in onda.
Le trasmissioni sono state ideate da
un gruppo di psicologi, pedagogisti,
educatori con la collaborazione di
registi, scrittori, presentatori di
grandi capacità. Debbo dire che, come
professionista della televisione, ho
molto ammirato la qualità e
l'intelligenza di questi programmi, e
soprattutto il grande sforzo
immaginativo e tecnico nel preparare
e realizzare le trasmissioni. Esse si
inseriscono perfettamente nel
discorso dell' « incontro » nel senso
che sono fatte su misura per la mente
del bambino, entrano nel suo raggio
di competenze e di interessi, e
riescono ad arricchirlo e stimolarlo,
presentando in modo divertente cose
che potrebbero essere pedanti e
noiose. (Resta però un problema : una
minoranza di bambini, quelli che
soffrono di un ambiente culturale
particolarmente arretrato, non
riescono a trarre sufficiente
beneficio neppure da queste
trasmissioni. Il loro distacco
mentale gioca già in maniera
decisiva...) Ora a « Sesame Street »
si è aggiunto un altro programma per
i più grandicelli, dopo la scuola: «
Electric Company ». La prossima
iniziativa, affermano oggi numerosi
educatori, dovrebbe rivolgersi alle
madri. Noi in televisione insegniamo
alle madri a cucinare, a vestirsi, a
innaffiare le piante, perché non
insegniamo anche a educare i figli?
« Occorrono ora trasmissioni speciali
per le madri, » mi ha detto il
professor S. White, uno dei promotori
di « Sesame Street ». « Penso che un
giorno le avremo. » Attraverso la
televisione, o meglio attraverso
buoni programmi, si potrà forse
trasformare in modo imprevedibile
l'ambiente familiare, agendo sia sul
bambino sia sulla madre e migliorando
il loro reciproco incontro.
Personalmente, ritengo la televisione
uno strumento capace di modificare
profondamente tutto il sistema
educativo, accelerando anche certi
processi di trasformazione delle
idee. A tutti i livelli,
naturalmente, e non soltanto a quello
infantile.
L'investimento più redditizio;
quello sul cervello.
XI • EDUCAZIONE E SOCIETÀ
Destinazione scuola Chiunque si
affacci in questo mondo nuovo, aperto
dalla ricerca sul cervello, si rende
conto delle occasioni perdute, del
tempo sprecato, degli errori e delle
lacune che hanno sempre accompagnato
la scuola. Per generazioni si è
pensato che prima di una certa età il
bambino non fosse pronto per lo
studio (mentre in realtà erano gli
educatori a non essere pronti per il
bambino) e si sono diagnosticati i
ritardi o le incapacità riferendoli a
fattori più biologici che ambientali
mentre ora si possono vedere con
trasparenza cristallina quanto sono
determinanti le influenze
dell'ambiente. C'è comunque una
lezione che non deve assolutamente
andar perduta oggi, e che balza
evidente da tutte queste ricerche: la
priorità dell'immaginazione.
L'immaginazione è la qualità più
tipicamente umana, quella che
consente di creare, inventare,
capire. È la qualità che consente
all'uomo di trovare un margine di
libertà, di sfuggire, in parte, alla
sua condizione di marionetta mossa
dai fili genetici e ambientali (e
approfondiremo questi temi nel
prossimo capitolo). L'immaginazione
consente anche al bambino di
sviluppare le sue qualità artistiche,
nel senso più lato. Con la nostra
mania di etichettare tutto noi
dividiamo solitamente gli uomini in
artisti, impiegati, professionisti, e
così via. In realtà esistono
musicisti che sono semplici impiegati
della tastiera,
mentre esistono medici, meccanici e
persino ragionieri che sono veri
artisti nel loro campo. La creatività
si può esprimere in qualsiasi
situazione o lavoro, ed è certamente
la vera ricchezza dell'uomo: un
bambino può essere allenato fin dalla
prima età a sviluppare questo
atteggiamento creativo nei confronti
della vita. Occorre però che
l'educazione non lasci atrofizzare e
rinsecchire l'artista che c'è in ogni
individuo alla nascita. Tutto il
senso delle ricerche in corso è del
resto proprio questo : riscoprendo il
mondo dell'infanzia ci sì rende conto
dell'importanza che ha per il bambino
l'esplorazione, la curiosità,
l'immaginazione. Ciò vale anche e
soprattutto per la scuola, che al di
là degli esperimenti di laboratorio
rimane poi la realtà quotidiana,
rimane al momento attuale il solo
vero strumento pratico attraverso il
quale è possibile agire sullo
sviluppo cognitivo del bambino.
L'educazione scolastica non può
evidentemente restare estranea a
tutte le più recenti scoperte sui
meccanismi del cervello, dal momento
che il suo ruolo è (o dovrebbe
essere) proprio quello di plasmarlo
nel migliore dei modi. La partita
continua Nell'arco di tutto questo
libro abbiamo cercato di illuminare
soltanto la prima zona della vita,
quella compresa tra zero e tre anni,
che fino a poco tempo fa era ancora
avvolta in un buio antico. Non
bisogna però pensare che a tre anni
tutto sia finito, che il bambino
viaggi ormai su binari
definitivamente fissati e che perda
la sua plasmabilità nei confronti
dell'ambiente. Questo modo di vedere
le cose potrebbe essere pericoloso,
perché porterebbe a una comoda
conclusione,e cioè che è inutile
intervenire sulla scuola dal momento
che i giochi sono
già fatti in famiglia. In questo
senso insuccessi come quello
dell'Head Start possono essere
pregiudizievoli, perché possono
indurre, per eccesso, a una specie di
fatalismo, a una rinuncia ad agire là
dove invece esiste ancora largo
spazio per un'azione adeguata. Se è
vero che nel primo periodo della vita
l'impronta è importantissima (e tutto
quanto abbiamo visto finora
costituisce una vera rivoluzione nel
modo di vedere il neonato e di
pensare gli stessi problemi
educativi) occorre cercare di
prolungare, di trasferire nella
scuola quelle idee di base che
valgono per i meccanismi mentali dei
primi anni di vita. Infatti il
bambino, entrando a scuola, ha ancora
una lunga strada da percorrere nel
suo sviluppo intellettuale. Potremmo
forse riprendere a questo punto
l'esempio iniziale della scacchiera,
e dire che se le prime mosse sono
quelle che contano, e che se una
serie di mosse iniziali sbagliate può
compromettere la partita, è
altrettanto vero che anche le mosse
successive sono importanti. Anzi, in
un certo senso diventano decisive
quando si tratta di rimediare a
eventuali sbagli iniziali e
migliorare le sorti del gioco. In
altre parole, la scuola, proprio alla
luce di queste e di altre esperienze,
ha un ruolo oggi da svolgere che
appare sempre più delicato per
l'educazione e la formazione di un
individuo. Il professor Parisi
dell'Istituto di psicologia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche a
Roma, mi ha detto, in proposito : «
Tutti questi studi dimostrano in modo
chiarissimo l'importanza cruciale dei
primi anni di vita, e direi anche che
ci offrono un quadro nuovo,
sorprendente, inaspettato, della
nascita della mente. D'altra parte
non se ne deve trarre la conclusione
che gli anni successivi, gli anni
della scuola, siano privi di
importanza, poiché il bambino
possiede ancora un enorme grado di
modificabilità che la scuola deve
saper sfruttare al massimo. Il
problema fondamentale è sapere quale
tipo di scuola noi vogliamo. A mio
parere queste ricerche
indicano chiaramente che soltanto una
scuola capace di rispettare alcune
esigenze naturali del bambino, che
hanno probabilmente una base
biologica, riesce a permettere uno
sviluppo completo della sua
personalità e della sua intelligenza.
« Quali sono queste esigenze? In
sostanza, l'esigenza di esplorare
l'ambiente fisico e sociale, partendo
da motivazioni e da interessi che
sono i suoi, e che non vengano
imposti dall'esterno; l'esigenza di
esprimersi con tutti i mezzi
possibili, specialmente col
linguaggio verbale; l'esigenza di
comunicare col prossimo, in
particolare coi propri coetanei. «
Ora, la scuola così come noi la
conosciamo trascura e inibisce il
soddisfacimento di queste esigenze.
C'è ancora tutto un lavoro da fare,
la scuola deve ancora trarre le
conseguenze di queste ricerche, e
trasferirle dal laboratorio nel vivo
delle classi. Non dobbiamo soltanto
vedere con occhi diversi il bambino,
ma dobbiamo anche travasare questi
insegnamenti nelle nostre scuole
materne ed elementari. In Italia,
come in ogni altro paese, psicologi e
pedagogisti si battono ormai da tempo
(e con poco successo), perché si
aprano le finestre alle nuove idee
che circolano e le si facciano
entrare nelle aule. E viene qui in
mente un episodio, ironico ma anche
amaro, che risale a tanti anni fa,
addirittura all'inizio del secolo. Un
giorno Maria Montessori presentò alla
licenza elementare dei bambini
ritardati, che era riuscita a
recuperare con corsi speciali,
preparandoli all'esame. I bambini
ottennero il certificato, tra
l'ammirazione generale. A proposito
di questo loro successo Maria
Montessori scrisse : « Mentre tutti
ammiravano i progressi dei miei
deficienti, io mi chiedevo ì motivi
per cui bambini cosi pieni di salute,
così felici come quelli delle normali
scuole elementari venivano istruiti
in modo talmente misero da renderli
uguali, nelle prove di intelligenza,
ai miei deficienti! » È necessario un
commento?
Investire sul cervello Ora sappiamo
quali sono i sentieri
dell'intelligenza e quali i sentieri
del sottosviluppo mentale. Volendo
trame le conseguenze dovremmo
affrontare, sostanzialmente, due
problemi: riorganizzare radicalmente
l'educazione dei piccoli (e anche
degli adulti), e reperire i necessari
mezzi finanziari. Per il primo
aspetto esistono già idee abbastanza
chiare, schemi educativi, tipi di
programmi. TI professor J. Goodlad,
dell'Università di California, per
esempio, propone una scuola in casa
da zero a quattro anni, una scuola
elementare precoce dai quattro ai
sette anni, e poi un normale corso di
studi. Per le donne che lavorano,
l'assistenza potrebbe essere
completata da asili-nido adeguati.
Altre formule sono state avanzate, e
su questo piano delle idee
teoricamente non esistono problemi
poiché gli « addetti ai lavori »
sembrano d'accordo su alcuni principi
di base, che potrebbero poi essere
articolati in modo non rigido per
soddisfare esigenze diverse. Il
problema, naturalmente, sorge appena
si tratta di applicare queste idee.
Se si valuta il costo di un
insegnamento del genere e si guarda
poi dentro le casse dello stato, ci
si rende conto che le spese sarebbero
così alte da far apparire tutte
queste belle teorie un'utopia da
dimenticare in fretta. A questo punto
si pone allora una scelta molto più
profonda, alla quale si può
rispondere sì o no, ma che si delinea
in termini assai meno astratti.
Ricorriamo a un esempio. Supponiamo
che una società di calcio disponga di
un certo bilancio. Essa lo
distribuirà nelle varie voci: un
tanto per gli stipendi dei giocatori,
un tanto per le spese dello stadio,
un tanto per l'amministrazione, per
le trasferte ecc. Ma quali dovranno
essere le sue vere priorità? Avere
buoni giocatori o avere un bello
stadio? Segnare molte reti o disporre
di molte magliette di ricambio?
Vincere il campionato o viaggiare in
alberghi di lusso?
Possibilmente tutte e due le cose,
certo. Però di fronte a una scelta
precisa, la priorità andrà ovviamente
alla squadra. Di fronte a una
difficoltà in classifica, nessuno si
chiederà se è meglio investire i
fondi disponibili in un nuovo
centrattacco o in un nuovo impianto
di gabinetti. Anche perché è evidente
che una buona squadra procurerà buoni
incassi, coi quali si potranno
migliorare le tribune, costruire
nuovi gabinetti, e anche distribuire
premi ai giocatori. Io penso che per
il bilancio di uno stato possa valere
un discorso analogo. Penso, cioè, che
sia molto più redditizio investire
sul cervello che investire in
acquedotti, strade, ponti. È più
importante produrre uomini che
impianti. È un'illusione pensare che
la scorciatoia consista nel
trapiantare i mezzi di produzione :
sarebbe come voler creare degli
scrittori investendo in macchine
tipografiche. Se un terreno è arido
nessun trapianto di alberi potrà mai
riuscire. Occorre invece prima
fertilizzare il terreno: poi
basteranno i semi a far crescere
un'intera vegetazione. Tutto il
discorso che abbiamo fatto sinora
sullo sviluppo mentale di un
individuo è infatti indiscutibilmente
valido anche per lo sviluppo mentale
di una collettività. Per crescere
intellettualmente, il bambino non ha
bisogno di buoni abiti, o di grandi
alloggi, ma di una buona educazione
familiare, di buoni insegnanti, di
buone scuole. Per la crescita
intellettuale di una società il
discorso è analogo, perché una
società non è altro che la somma di
un gruppo di individui, cioè di
cervelli : in pratica, quello che una
collettività di uomini esprime è il
frutto di un'azione combinata di vari
gruppi di neuroni, che inter-agiscono
e si influenzano a vicenda.
Benessere, giustizia, democrazia non
sono alberi che possono crescere in
un terreno cerebrale arido:
trapiantarli è illusorio, se non si
fertilizzano prima i neuroni. È una
realtà che non è stata ancora
sufficientemente compresa, nei suoi
aspetti biologici (e nelle sue
conseguenze politiche).
Uno sforzo prioritario Se si entra in
quest'ordine di idee, se si pensa
veramente che la priorità debba
essere data agli investimenti
cerebrali, cioè all'educazione intesa
nel suo senso più lato, è anche
possibile guardare con occhio diverso
il bilancio dello stato, e chiedersi
se veramente non sarebbe più
redditizia una diversa distribuzione
delle risorse. A questo punto si
presenterebbero varie possibilità di
scelta, a seconda dell'impegno che si
ritiene utile dedicare allo sviluppo
mentale. La soluzione più radicale,
per voler accorciare rapidamente le
distanze e creare una pressione
acceleratrice, consisterebbe nel
considerare la scuola e l'educazione
nel quadro di un'economìa di guerra.
Come ogni paese in guerra concentra
le priorità di spesa sullo sforzo
bellico, limitando tutti gli altri
investimenti e consumi (perché è più
importante costruire carri armati che
scarpe, aeroplani che case) così
l'educazione potrebbe conoscere uno
sforzo prioritario analogo. E non
sarebbe certo necessario razionare il
pane o abolire il riscaldamento
domestico, per « spremere » i fondi
necessari a una vera rivoluzione
educativa. Partendo da questa
soluzione radicale, e indietreggiando
per scalini successivi, si può
ipotizzare a ogni livello intermedio
una soluzione più « bilanciata ». Ma
il meccanismo si baserebbe sempre
sullo stesso principio. Personalmente
ritengo che in certi casi basterebbe
operare trasformazioni qualificanti
all'interno di un settore. Per
esempio, si parlava prima di un
servizio civile obbligatorio che
impegni i giovani in opere di
assistenza e in compiti educativi :
ebbene, se si pensa ai bilanci del
ministero della difesa ci si rende
conto che i mezzi materiali non
mancherebbero certo, né mancherebbero
gli impianti, o gli edifìci o gli
automezzi. 11 problema naturalmente è
di volerle, queste cose, e su questo
punto credo che il discorso diventi
molto diverso. Una cosa
è parlare delle possibilità di
realizzare certi obiettivi, un'altra
è parlare della volontà di
realizzarli. Qui allora il discorso
sembra diventare utopistico: ma solo
in apparenza. Infatti anche
l'esercitazione di salvataggio fatta
sui transatlantici in crociera fa
sorridere i passeggeri : ma quando
suona veramente l'allarme la gente
non esita ad arrampicarsi sulle funi
o a gettarsi nell'acqua gelida da
dieci metri d'altezza. Non è più
un'astrazione, ma una realtà. Sempre,
nella storia della vita, sono state
certe spinte genetiche o ambientali a
determinare il comportamento degli
individui; a giudicare se esso era «
buono » o « cattivo » presiedeva un
principio implacabile, la
sopravvivenza. Individui o specie che
si ponevano in contrasto con questo
princìpio pagavano severamente i loro
sbagli. Oggi è sempre più evidente
che dobbiamo adeguarci culturalmente,
se vogliamo migliorare la nostra
sopravvivenza fisica. Possiamo
ignorare questa realtà e continuare a
fumare sigari Virginia sul ponte
della « promenade », però quando il
pompiere di servizio suona l'allarme
non possiamo più tapparci le
orecchie. Gli squilibri crescenti che
oggi ci minacciano, gli stessi
inquinamenti, non sono il frutto
della tecnologia ma del suo cattivo
uso. Contro i veleni dell'ambiente
non servono i filtri, perché il
guasto è altrove. Il vero problema
ecologico è quello del cervello. Noi
viviamo al di sopra dei nostri mezzi
cerebrali, non meritiamo, mediamente,
gli strumenti tecnologici di cui
disponiamo. Se una nuova educazione
non dilaga rapidamente creando un
tessuto culturale più esteso, capace
di capire e affrontare i problemi
nuovi, c'è il rischio reale di una
grave frattura di cui già si
intravvedono le conseguenze. Per
essere in equilibrio con le leggi
biologiche che da sempre governano la
vita sulla terra, è necessario che
gli uomini diventino più
intelligenti. Un nuovo tipo di
educazione può forse tentare questa
tra-
sformazione attraverso la più urgente
delle riforme: quella del cervello.
Le conoscenze esistono per impostare
i problemi, ie risorse possono essere
reperite. Possiamo decidere di
ignorare tutto questo. Ricordiamoci
però che ogni centesimo speso altrove
è sottratto allo sviluppo mentale, e
forse alla nostra scialuppa di
salvataggio. // razzismo culturale La
riforma del cervello è, del resto, la
sola condizione anche per lo sviluppo
della democrazia, che è una conquista
tipicamente intellettuale. Infatti,
dove può trovare la sua base «
l'uguaglianza » tra gli individui se
non nella parità mentale? In mancanza
di questa fondamentale parità la
società rimarrà sempre stratificata e
conoscerà tensioni crescenti. Le
differenze tra individui (e tra
società) trovano infatti la loro
radice proprio nel diverso livello di
sviluppo culturale. Lo stesso «
razzismo » trova una delle sue più
solide basi proprio in questo
divario. Quando si parla di razzismo
si pensa alla segregazione dei negri
in certi paesi, si pensa agli autobus
per bianchi e per « colorati », ma il
razzismo è molto più profondo e
ramificato, e a chi si scandalizza,
giustamente, di queste
discriminazioni è bene chiedere : «
Avete la domestica? Pranza a tavola
con voi o la segregate in cucina? La
sera viene a conversare in salotto o
rimane nel suo sgabuzzino? » Ecco una
forma molto sottile, ma altrettanto
diffusa, di « razzismo » : è una
discriminazione che non scandalizza
quasi, tanto appare inevitabile e
persino ovvia. Essa trova le sue
radici proprio nel divario educativo,
e la controprova la fornisce
l'esempio della ragazza « au pair »,
che spesso svolge un lavoro non molto
diverso dalla domestica, ma che
pranza a tavola e la sera conversa in
salotto. La sua preparazione
culturale le consente, appunto, di
essere « alla pari ».
Il discorso, del resto, qui si
allarga ancor più. Infatti il giorno
in cui una vera parità intellettuale
sarà raggiunta (già oggi la scuola
dell'obbligo comincia a creare tra i
giovani una consapevolezza dei loro
diritti assai più viva) difficilmente
potrà continuare ad esistere
l'attuale stratificazione sociale.
Uscendo dalla stessa scuola chi
accetterà ancora di andare in una
galleria in fondo a una miniera
quando il compagno andrà in un
ufficio in cima a un grattacielo?
Perché alcuni dovrebbero lavare i
piatti e altri sedersi al ristorante?
Questa stratificazione del lavoro è
consentita oggi dalla disparità
educativa, che automaticamente
provoca una classifica nelle
retribuzioni e nel prestigio
professionale (e personale). Ma
quando si giungerà a una vera parità
nell'istruzione chi dovrà andare a
fare il battilastra. o a riparare le
fognature, o assistere di notte i
paraplegici? E per quale ragione
dovrebbe andarci proprio lui, invece
del suo compagno di banco? Si può
pensare di adottare il criterio del
« merito » e creare, come in Unione
Sovietica, delle strutture
scolastiche a imbuto, dove a livelli
diversi vengono selezionati i «
migliori ». All'università il numero
è chiuso, cioè entrano soltanto gli
studenti con i voti più alti, e in
quantità corrispondenti alle
previsioni della pianificazione.
Però, anche ammettendo che questa
selezione si svolga nel migliore dei
modi, il risultato finale non può
essere che una nuova stratificazione
in classi mentali (e professionali):
vi sarà nuovamente il battilastra e
l'ingegnere, lo spazzino e
l'intellettuale. Non solo : ma tutto
quello che abbiamo visto nel corso
del libro, ci permette oggi di capire
chiaramente che oltre all'eredità
genetica (che falsa già in partenza
la scala dei « meriti » individuali,
predeterminando le capacità mentali)
vi è l'influenza enorme esercitata
dall'ambiente familiare, che
condiziona il rendimento a scuola del
bambino e quindi i suoi successi
nelle « selezioni ». Ciò significa
che anche quando si parte da zero,
con assoluta parità (ma ciò non è
possibile), la seconda generazione
si ritrova già con un handicap (o un
vantaggio) familiare considerevole.
Quando il figlio dello spazzino «
selezionato » e quello
dell'intellettuale « selezionato »
entrano nella stessa aula non sono
già più in condizioni di parità. In
un mondo in cui le differenze, nelle
selezioni, si misurano in centesimi
di secondo, un piccolo distacco può
cominciare a divaricare due linee di
tendenza, con il chiaro e prevedibile
risultato di divaricare anche due
destini. Lo studio dei meccanismi del
cervello ci mostra oggi con molta
chiarezza che non è certamente questo
un modello che possa portare all'«
uguaglianza » tra gli uomini. Del
resto chi opera la selezione, e con
quali criterì? In quale misura
un'intelligenza « divergente » si
incasella in questo schema
prefissato? La legge fondamentale, in
natura, non è quella della
uguaglianza, ma della diversità; gli
uomini possono essere eguali soltanto
se possono essere diversi. In una
società di cantanti un indivìduo
stonato sarebbe privato di ogni altra
possibilità di esprimersi : anche
attraverso le selezioni più oneste,
si ritroverebbe in fondo alla
classifica. Credo ehe le società
mentalmente sviluppate di domani si
orienteranno verso modelli culturali
molto diversi, che consentiranno a
tutti di esprimersi più
compiutamente, senza sopprimere la
competitivita, anzi aprendole nuove
porte. Saranno modelli orientati
verso le differenze più che verso le
uguaglianze, e basati sulla parità
nel mondo del lavoro. Le corvées Non
credo infatti che in avvenire sia
ancora possibile una stratificazione
analoga a quella attuale. Potrà
esserlo in una società autoritaria o
arretrata tecnologicamente e
mentalmente; ma in prospettiva
dovremo dirigerci verso una più equa
distribuzione dei compiti sgradevoli.
Il lavoro (sembra quasi una banalità)
dovrà essere uguale per tutti.
Già in precedenza ho accennato
all'inevitabilità, a mio avviso, di
un servizio civile obbligatorio per i
giovani di ambo i sessi, destinato a
compiti educativi e assistenziali che
difficilmente potrebbero essere
risolti in modo diverso. Un criterio
analogo probabilmente dovrà essere
adottato in seguito anche per tutti i
cittadini adulti, al fine di spartire
i lavori duri, alienanti, penosi,
noiosi, umili ecc. Come nel servizio
militare vi sono le « corvées » della
legna, o dei gabinetti, o della
cucina, così nelle società
mentalmente avanzate dovranno esservi
« corvées » destinate a produrre i
beni di consumo di base, necessari a
tutta la collettività. Come in
Svizzera, per esempio, si parte ogni
anno per un breve periodo di servizio
militare, analogamente ognuno partirà
per un servizio civile (per esempio
tre mesi l'anno), in una fabbrica, in
una miniera, in una fattoria o nei
servizi cittadini. Sarà un periodo di
lavoro molto intenso, senza molte
pause e senza molti comforts, di tipo
« militarizzato ». Si potrebbe
pensare, per esempio, di sostituire
un'eventuale settimana lavorativa
supercorta, di tre o quattro giorni
(prevedibile in avvenire), con questo
blocco « concentrato » in modo da
permettere l'accumulazione di un
minimo vitale per il resto dell'anno,
pagabile per esempio sotto forma di
stipendio mensile assicurato. Questo
periodo annuale di « ferma » civile
consentirebbe a ognuno di disporre di
un'indipendenza economica di base per
i restanti nove mesi, e di dedicarsi
poi a un lavoro « artigianale »
scelto in funzione delle proprie
attitudini (e non imposto dalle
circostanze), e di « riciclare » le
proprie conoscenze attraverso una
scuola permanente. Ognuno, cioè,
potrebbe essere indipendente dopo
aver pagato il suo debito di lavoro,
così come si pagano le tasse.
Quest'idea di spartirsi non soltanto
le fette di torta ma anche la
lavatura dei piatti, comincia a
lievitare un po' ovun-que, con
formule diverse (che vanno da un
lungo periodo di corvées in età
giovanile a un più frequente
alternarsi in età
adulta) molti studiosi in varie parti
del mondo si riallacciano
sostanzialmente a questo concetto
ugualitario del lavoro, che è
certamente destinato a emergere in
avvenire col progressivo diffondersi
della parità educativa. Il professor
Aldo Visalberghi, che da tempo si
occupa dei rapporti fra educazione
tecnica e professionale e strutture
sociali, ed ha guidato una ricerca
internazionale su questo tema nel
quadro del progetto « Educazione per
il xxi secolo » (le conclusioni della
ricerca sono pubblicate in italiano
col titolo Educazione e divisione del
lavoro, La Nuova Italia. 1973), mette
giustamente l'accento sul legame che
esiste tra modelli di questo tipo e
investimenti educativi. Anch'egli
ritiene che, a più breve scadenza, il
servizio civile obbligatorio dovrà
cominciare già con i giovani di leva.
« Noi pensiamo che il servizio
militare debba cambiare
completamente, » mi ha detto il
professor Visalberghi, « per
diventare un servizio civile
(comprensivo anche di un periodo di
addestramento militare di breve
durata, finché sarà necessario). In
questo modo i giovani potrebbero
svolgere attività non soltanto utili
alla collettività, ma anche atte a
sviluppare la loro naturale tendenza
a un effettivo impegno sociale (già
oggi in Germania 7 giovani su 10
chiedono di poter effettuare il
servizio civile anziché quello
militare). « In questo quadro si
potrebbe pensare naturalmente a dei
volontari, scelti per attitudine e
preparazione, capaci di aiutare certe
famiglie nell'educazione dei piccoli.
Parallelamente si comincerebbe ad
abituare i giovani a quei lavori
frustranti e scostanti (che oggi sono
compiuti solo da certi individui e
per tutta la vita), iniziando così
quel processo di trasformazione che
renderà possibile in avvenire una
forma di rotazione nei lavori meno
ambiti, quelli che oggi gli europei
fanno fare in gran parte alla
manodopera immigrata. » Utopie? Ne
riparleremo nella parte conclusiva
del libro, perché anche in questo
campo l'avvenire sembra riservarci
qualche sorpresa.
i termini divers
XII • BIOLOGIA E LIBERTÀ Come si
lecca un pavimento Torniamo ora ai
nostri bambini. Il loro sviluppo
mentale, lo abbiamo visto, è regolato
da precisi meccanismi, ormai
abbastanza conosciuti, validi per
ogni livello di istruzione e per ogni
età. E abbiamo anche visto che,
seguendo una strada piuttosto che
un'altra si può benissimo far
evolvere un individuo o una società,
oppure mantenerli entrambi nel loro
sottosviluppo mentale. Ma la crescita
cognitiva, naturalmente, è soltanto
uno degli aspetti dell'educazione: vi
è un altro aspetto molto importante
di cui vorremmo ora parlare un po'
più diffusamente, quello della
disciplina. I genitori infatti si
trovano continuamente a dover fare i
conti con la realtà quotidiana, a
dover scegliere tra il consenso e il
rifiuto, tra il dialogo e lo
scappellotto, tra il sì e il no :
quale tipo di educazione è meglio
adottare? Fino a che punto è bene
essere autoritari oppure permissivi?
Io penso che nel dibattito aperto
oggi sui vantaggi e sugli
inconvenienti dell'uno o dell'altro
sistema di educazione nascono a volte
degli equivoci, perché non sempre ci
si intende su termini come « libertà
», « personalità », « libera
espressione di se stessi » ecc. La
ricerca scientifica porta oggi alcune
risposte a certe domande, e in questo
capitolo cercheremo di esaminare in
modo molto spregiudicato il concetto
di « li-
berta », sfrondandolo da tutta la
carica emotiva che si porta appresso.
Per cominciare, direi che tutti noi
genitori soffriamo di una specie di
complesso di colpa: temiamo di non
essere abbastanza « moderni »,
sentiamo dire tante cose
sull'educazione « repressiva », sul
diritto dei giovani di esprimersi
liberamente, che ci chiediamo fino a
che punto sbagliamo quando cerchiamo
di condizionarli, di esercitare la
nostra autorità. È certo un bene
interrogarsi su questi problemi,
aggiornare continuamente le nostre
idee, capire (anzi precedere) il
mondo mentale dei giovani. Tuttavia
sarebbe un errore lasciarsi vincere
da questo complesso dì colpa e
seguire le mode senza averle ben
capite. Intanto credo che sarebbe
utile rinfrescarsi la memoria (e
rinfrescarla ai giovani) su che cosa
è stato veramente l'autoritarismo
familiare in passato. Per questo ho
pensato di riprodurre qui qualche
passaggio tratto da La corte
pontificia e la società romana,
scritto nella seconda metà
dell'Ottocento da David Silvagni.
David Silvagni era un rampollo della
borghesia romana, fuggito dal
bigottismo familiare verso il
liberalismo risorgimentale, e
divenuto prefetto negli anni dopo il
1870. Egli raccolse in quattro volumi
i ricordi giovanili di un mondo che
aveva conosciuto bene dall'interno:
un mondo in cui i neonati venivano
tenuti fasciati come salami (con le
braccine dentro le fasce) imbottiti
di amuleti, e gli scolari vivevano
chiusi per tutta la giornata «
stretti, pigiati in seggiole forate
». Scrive Silvagni : « Quella noiosa
posizione non si lasciava che per
dire orazioni, o per fare merenda, o
per recitare salmodie che avrebbero
addormentato un sordo... In casa i
ragazzi ci stavano poco; alzati di
letto andavano a scuola, tornati da
scuola andavano a letto. Molti
giungevano all'adolescenza senza aver
mai veduto risplendere la luna in
cielo.
« Dalla rigorosa educazione paterna,
dove la moglie chiamava il marito
signor Pietro o signor Paolo, e i
figli si indirizzavano ai genitori
col voi o col signor padre e signora
madre, passavano sotto la rigorosa
disciplina della scuola ove, a
similitudine di quanto avveniva in
piazza, trovavano la sferza, la
berlina (il banco dell'asino) la
umiliazione di stare in ginocchio,
spesso con le mani sotto le
ginocchia, e la sudiceria di far
croci in terra leccando le lordure
del pavimento con la lingua... « In
casa non era permesso di far giochi o
sollazzi salvo vestire da prete o da
chierico facendo l'altarino, ossia
riducendo a giocattoli le immagini,
gli arredi e i vasi che si usano nel
mistico sacrifìcio della messa... «
Naturalmente si celebravano in
famiglia i tridui e le novene che non
potevansi ascoltare in chiesa, era
rigorosamente osservato il digiuno
nella Quaresima, il magro del venerdì
e sabato, nelle vigilie dei santi e
nei quattro tempi prescritti dalla
Chiesa. Per mangiare di grasso la
famiglia o la persona sofferente
doveva munirsi di certificato medico,
vistato dal parroco a pagamento... «
Quando era concesso di parlare si
faceva sommessamente e frivolamente.
Ogni discorso di filosofìa, di
politica, o di religione era
vietato... » Forti, dentro e fuori
Un'educazione di questo genere (anche
se tratteggiata forse a tinte aspre
nei ricordi inaciditi del prefetto
Silvagni) non doveva essere poi molto
lontana dalla realtà, e non soltanto
per quel che riguarda le famiglie
borghesi della Roma papalina. Per
secoli, l'autoritarismo, in forme
diverse, è quasi sempre stato una
regola in ogni tipo di educazione e
anche in ogni tipo di società. Le
condizioni di vita « secernevano » un
tempo regimi
forti, all'interno e all'esterno.
Questo autoritarismo esisteva in ogni
genere di rapporti : quello tra
superiori e dipendenti, tra marito e
moglie, tra vincitori e vinti, tra
popolazioni ricche e povere, tra
maestri e scolari, tra padroni e
operai, tra potere e opposizione. E
ciò portava nel più naturale dei modi
alla segregazione femminile, alle
bacchettate sulle dita,
all'oppressione poliziesca, alla
censura, alle catene per i carcerati,
allo sfruttamento dei più deboli, al
colonialismo. Non dovremmo però
cadere nell'errore di pensare che un
tempo l'uomo era « cattivo », che
oggi è più « buono ». A mio parere
esistono certi automatismi
ambientali, in base ai quali una
collettività tecnologicamente ed
economicamente poco avanzata «
secerne » inevitabilmente
l'autoritarismo. Esso esiste in
natura, in tutte le società animali,
come legge essenziale di
sopravvivenza : nella società umana
questa legge può essere « trasgredita
» nella misura in cui la
sopravvivenza non è messa in
pericolo. La rivoluzione delle idee,
la protesta, i movimenti di
liberazione (femminili, scolastici,
sindacali, culturali, politici,
giudiziari, coloniali) sono sempre
esistiti, come aspirazione. Ma
difficilmente possono realizzarsi
senza un'alta « produttività »
permessa dal progresso tecnico, che
consente molte cose, prima tra le
quali l'educazione generalizzata e la
circolazione delle idee. Se, per
ipotesi, l'umanità dovesse andare
incontro a un collasso economico
planetario (come alcuni prevedono, a
causa di uno squilibrio crescente tra
popolazione, risorse naturali,
produzione industriale e
inquinamenti), e se il tenore di vita
tornasse a essere quello di cento o
duecento anni fa, nel giro di una
generazione o due riemergerebbero
l'analfabetismo, la miseria,
l'ignoranza, e, tutto trionfante,
l'autoritarismo. Uno sguardo
indietro, comunque, ci consente di
renderci conto che il nostro
autoritarismo è una primula di bosco,
se confrontato con quello del
passato, anche se è vero che i
confronti debbono essere fatti in una
scala in movimento, e che le tendenze
evolutive, le « nuove frontiere »
vanno valutate
all'interno di ogni società (chi
deteneva il primato del salto in alto
mezzo secolo fa, oggi non sarebbe
neppure più ammesso a gareggiare in
uno stadio). L'autoritarismo (e anche
la « repressione ») sono
evidentemente concetti molto
elastici, che vanno valutati in
rapporto al tipo di società in cui si
inquadrano. Il passato ci mostra
quanto sia mutata la « scala » dei
valori in movimento e quanto sia
liberale la nostra educazione nei
confronti di quella di tutte le
generazioni precedenti. È importante,
naturalmente, situarsi nel proprio
tempo, camminare con esso: tuttavia
non bisogna lasciarsi vincere da
complessi di colpa che possono
condurre all'eccesso opposto :
infatti i nuovi miti sulla « libertà
» del bambino rischiano di produrre
guasti altrettanto gravi di
un'educazione autoritaria. Il
concetto di permissività rischia di
essere mal interpretato, facendo
scambiare illusioni per realtà,
fantasmi e fate morgane per cose
concrete. Il discorso sulla libertà
(che porta poi per gradini successivi
al cosiddetto rispetto della libertà
del bambino, del suo « io innato »,
della sua personalità) è un discorso
molto complesso e semplice al tempo
stesso. Per denudarlo di tutti i
nastrini colorati che lo ricoprono
quasi interamente, occorre rivedere
le cose da principio. Occorre tornare
indietro con la moviola del tempo,
guardando le immagini che hanno
preceduto la comparsa dell'uomo, per
capire certi meccanismi essenziali
che ci possono chiarire le idee anche
in materia di libertà educativa. Una
imbarazzante contraddizione
Rapidamente, ricapitoliamo qualche
concetto utile che può servire da
filo conduttore. Tutta la scienza
moderna ci rivela che siamo macchine
elettrochimiche capaci di reagire
all'ambiente, e che Tener-
nascita dell'uomo educazione
{acquisita Q ... e quelle acquisite,
che risultano dalle e-sperienze
ambieniali; cioè dall'educazione.
nascita della vita Ogni individuo
porta in sé due « piramidi » di
memorie: quelle genetiche {istinti)
che risultano da agganci tisi
dall'inizio della vita...
comportamento istinti +• educazione
comportamento riulta dalla
sovrapposizione continua di queste
due piramidi di memorie: ogni «
scelta » chiama in causa « tutte » le
esperienze precedenti genetiche e
acquisite.
lliersi, nascendo, il filamento di
DNA del resto, ir corso della
Un individuo non può scegliersi
neppure i genitori e gli educatori.
Lo sviluppo della sua rete educativa
dipende dall'ambiente e dalle persone
che lo circondano. È uno sviluppo che
non può avvenire spontaneamente, ma è
frutto dei condizionamenti
ambientali.
già che fa muovere la giostra dei
nostri atomi è ancora quella
originata dalla esplosione cosmica di
dodici-quindici miliardi di anni fa.
Da allora (lo abbiamo visto nel corso
dei vari capitoli), vi è stato un
progressivo aumento di strutturazione
molecolare, che ha portato dalle
atmosfere iniziali alle macromolecole
capaci dì stampare copie di se
stesse, dalle forme batteriche agli
esseri pluricellulari, dai rettili
all'uomo. Ogni essere vivente, dai
vermi d'acqua dolce all'uomo,
possiede due tipi di memorie: quelle
genetiche contenute nei
cromosomi, e quelle acquisite nel
corso della vita attraverso
l'apprendimento (stimolate da un
sistema premi-punizioni). Ogni nostro
comportamento è il frutto di queste
due « piramidi » di memorie, che si
sovrappongono e interagiscono. Ogni
« scelta » (anche la più banale)
richiesta da uno stimolo ambientale,
chiama indirettamente in causa «
tutte » le esperienze precedenti,
genetiche e acquisite. Proprio per
questa ragione la nostra « macchina »
cerebrale non può funzionare senza
memorie, cioè senza le informazioni
che l'ambiente le inserisce
continuamente. Oualsiasi piccola
esperienza, qualsiasi parola si
incide infatti nel cervello e modella
la rete dei circuiti, permettendo
l'attività mentale e condizionando al
tempo stesso il successivo
comportamento. Ciò significa che se
veramente si volesse evitare di «
condizionare » un individuo
bisognerebbe evitare addirittura di
parlargli, o di mostrargli immagini o
di fornirgli qualsiasi esperienza. Ma
è evidente che in tal caso un
cervello non sarebbe in grado di
funzionare : sarebbe, come abbiamo
già avuto occasione di dire più
volte, un computer senza schede, o un
uomo senza memorie. Un individuo «
vergine » di informazioni sarebbe
l'equivalente di un feto. Vi è quindi
una contraddizione evidente, tra
educazione e libertà. Educare vuoi
dire, biologicamente, condizionare il
comportamento di un individuo :
rinunciare a farlo significherebbe
lasciare ad altri il ruolo di
condizionatori. Accade per gli esseri
umani ciò che accade nella
specializzazione cellulare:
inizialmente le prime cellule che si
sdoppiano a partire dall'ovulo
fecondato posseggono una grande
potenzialità, potrebbero diventare
cellule della pelle, o delle ossa,
oppure dei muscoli ecc. Poi pian
piano, a seconda della posizione in
cui si trovano, si specializzano in
modo irreversibile, cioè l'ambiente
circostante le « induce » a diventare
una cosa piuttosto che un'altra,
sottraendo loro la capacità di
riconvertirsi. Nell'educazione
avviene qualcosa di analogo:
l'ambiente
Ogni singolo neurone porta in sé
questa duplice impronta: genetica
(nel nucleo) e acquisita (nella
struttura cellulare).
l'insieme della rete cerebrale a la
risposta per ogni comporta-
circostante « induce » sin dalla
nascita un individuo a specializzarsi
cerebralmente, sottraendogli man mano
la capacità di riconvertirsi. Ma,
naturalmente, soltanto un processo di
specializzazione può dar la nascita a
un organismo (e a una personalità).
Altrimenti le cellule rimarrebbero
allo stadio di agglomerati
indifferenziati (e il cervello
rimarrebbe in un inalterato buio
mentale). Queste considerazioni
biologiche rimettono ovviamente in
questione la possibilità del bambino
di esprimersi liberamente, o di
sfuggire ai condizionamenti
dell'educatore. Autoritarismo e
permissività, libertà e
condizionamento assumono quindi un
significato assai diverso, visti in
questa nuova prospettiva. /
controìlori invisìbili Lo psicologo
americano B.F. Skinner riporta in
proposito nel suo libro Beyond
Freedom and Dignity (Alfred Knopf
Editore, New York) un passaggio molto
significativo di Jean-Jacques
Rousseau, tratto da Emile. Rousseau,
rivolgendosi agli insegnanti,
scriveva : « Lasciate che il bambino
si ritenga [responsabile] del suo
controllo, mentre in realtà siete voi
a controllarlo. Non esiste più
perfetta dominazione di quella che
prende le apparenze di libertà: in
tal modo, infatti, si carpisce la
stessa volontà. Il bambino, che non
sa, che non ha ancora appreso, che
non sa far nulla, non è forse alla
vostra mercede? Non potete forse
influenzarlo a piacere, costruendogli
il mondo nel quale evolve? Le sue
attività, i suoi piaceri, i suoi
dolori, i suoi giochi non sono forse
nelle vostre mani senza che egli lo
sappia? Senza dubbio egli fa ciò che
vuole, ma in realtà fa ciò che voi
volete che egli faccia. » Rousseau.
osserva Skinner, si rivolgeva ai
maestri, ed era sottinteso che essi
avrebbero dovuto operare per il bene
del piccolo. Però è evidente che
analoghi tipi di condizionamento
costituiscono il nutrimento cerebrale
di ogni individuo per tutta la sua
vita. Il fatto è, dice giustamente
Skinner, che di solito noi non ce ne
rendiamo conto : la gente è contraria
a che vi siano forme di controllo nel
comportamento, ma esse esistono
sempre e ovunque : la sola differenza
è che il più delle volte non
riusciamo a vederle. Già Voltaire
osservava con grande acutezza : «
Quando posso fare ciò che voglio,
sono libero. Però non sono libero di
volere ciò che voglio... » Noi, dice
Skinner, attribuiamo, per esempio,
merito a una persona che si comporta
bene, che « sceglie » tra il bene e
il male. Ma a guardare un po' più in
profondità ci accorgiamo che le cose
stanno diversamente. Egli cita, in
proposito, il filosofo inglese
dell'Ottocento John Stuart Mill, il
quale diceva che la sola bontà degna
di questo nome è quella di una
persona che si comporta bene anche
quando le è possibile comportarsi
male: è questo, per esempio, il caso
di una persona che può decidere di
non frequentare una casa di
tolleranza, dando prova così di
libertà e di dignità attraverso una
sua libera scelta. Skinner obietta
che la scelta non è libera, perché in
realtà esistono una quantità di «
controlli invisibili » che fanno
agire un uomo in quel modo, e che
derivano proprio dalla sua educazione
: per esempio il timore di perdere
prestigio se scoperto in quel luogo
di malaffare, la paura di malattie
veneree, l'idea del peccato legata ai
precetti religiosi, e così via.
Questo meccanismo vale per ogni forma
di comportamento; basterebbe scavare
un po' e si troverebbero tutti i fili
sotterranei che fanno agire un
individuo nella vita. Skinner, nel
suo libro che ha suscitato molto
scandalo negli Stati Uniti e altrove,
smonta tutte le molle e le rotelline
del comportamento umano, divertendosi
a un jeu de massacre della « dignità
» e della « libertà », con evidente
intento provocatorio, mostrando il
ruolo dei rafforzamenti positivi e
negativi, delle punizioni, dei premi,
delle censure, e delle varie
combinazioni di tutti questi
elementi. Egli fruga nel cervello
umano come un doganiere nel bagaglio
di un prestigiatore, mostrando i
doppi fondi delle scatole, i
nascondigli dei piccioni, i trucchi
degli anelli magici o della donna
tagliata a pezzi. Skinner, insomma,
tira ai suoi contemporanei una torta
in faccia, imbrattando tutti i bei
pensierini sulla responsabilità,
sulla libera scelta, sull'uomo «
autonomo », al fine di creare un
trauma benefico che porti a un nuovo
tipo di cultura: una cultura capace
di capire questa lezione e di trar-ne
le conseguenze prima che sia troppo
tardi, prima cioè che l'uomo «
autonomo » porti a una catastrofe, a
causa proprio della sua incapacità di
essere autonomo e di operare le
scelte giuste. Tutto ciò mostra, in
ogni caso, l'illusione della «
permissività ». La permissività,
scrive Skinner, non è una politica ma
un abbandono. Rifiutare il controllo
significa in pratica lasciare che il
controllo sia effettuato da altri.
// contestatore contestato La libertà
di volere (o meglio di volere ciò che
si vuole) appare dunque oggi assai
difficile da ritrovare tra i
meccanismi cerebrali. Ogni individuo
è il frutto di una partita a scacchi
che l'ambiente e l'eredità giocano
nel suo cervello. Nei primi anni di
vita il bambino neppure « sa di
sapere », e in seguito la sua
consapevolezza deriverà proprio dalla
posizione dei pezzi sulla scacchiera,
cioè dal modo in cui altri (i
genitori in particolare) li avranno
disposti. Dov'è allora il « se stesso
» indipendente dall'ambiente? Coloro
che si occupano dei meccanismi
cerebrali cominciano oggi a bussare
alle stanze dei filosofi. È
interessante, per esempio, riportare
quanto il professor J. Delgado,
dell'Università di Yale (celebre per
i suoi esperimenti sul cervello),
scrive nel suo libro Physical Contro]
of thè Mina* a proposito del « se
stesso » di cui parla Marcuse. « II
concetto di questo mitico <Io> è così
forte che ha permeato anche il
pensiero di autori originali e
rivoluzionari come Marcuse. Secondo
Marcuse, infatti, la libertà interna
designa quello spazio privato nel
quale un uomo può diventare e
rimanere se stesso... Oggi lo spazio
privato è stato invaso e abolito
dalla realtà tecnologica. » « La
questione di base, » scrive Delgado,
« è : chi è questo se stesso, e qual
è l'origine dei suoi elementi
strutturali? C'è forse qualche
condizione sperimentale che consenta
di formare la mente di un bambino
diversamente che attraverso le <
forze esterne > dei genitori, degli
insegnanti, della cultura, sulle
quali il bambino non può avere alcun
controllo? Bisogna allora
classificare < falsi > i bisogni del
bambino, dal momento che gli sono
stati inculcati? Dov'è l'uomo
interno? » Questa dipendenza di un
bambino dall'ambiente che lo circonda
dimostra che, in fondo, qualsiasi
educazione è autoritaria, nel senso
che traccia nel bambino indifeso
tutto un
sistema di circuiti e di tracciati
lungo il quale passerà il traffico
delle sue idee. La forza
dell'immaginazione Ma allora,
dobbiamo rinunciare a ogni forma di
« libertà », di autonomia interna?
Siamo soltanto sospinti da forze
esterne, come palle da biliardo che
rimbalzano, si scontrano, rotolano, e
poi finiscono in buca, regolate da
triangolazioni e leggi dinamiche?
Personalmente cerco di essere più
ottimista di Skinner. Infatti il
comportamento dell'uomo non è
regolato solo dall'ambiente e
dall'ereditarietà: vi è anche una
componente interna che provoca una
forma più raffinata di
condizionamento, cioè
l'immaginazione. Infatti, se è vero
che una qualsiasi esperienza si
imprime nella nostra memoria, è anche
vero che noi possiamo, attraverso
l'immaginazione, simulare nuove
esperienze non vissute. Queste
esperienze simulate si imprimono nel
nostro cervello creando nuove schede,
nuovi tracciati cerebrali : ciò è
dimostrato dal fatto che noi «
ricordiamo » i nostri pensieri e le
nostre fantasie (o i nostri sogni),
che diventano così delle memorie (non
inserite direttamente dall'esterno,
ma frutto di una elaborazione
interna). Il nostro comportamento
cioè può essere modificato anche da
esperienze simulate, che creano un
nuovo condizionamento. Un tale
meccanismo esiste anche nell'animale,
ma in misura molto limitata.
Nell'uomo (grazie allo spessore della
corteccia che contiene un gran numero
di neuroni « elaboratori » in
particolare nelle zone frontali),
questa capacità di immaginare è
sterminata. Immaginare significa in
pratica utilizzare i « pezzi » del
Lego mentale (cioè le memorie, di
origine sia interna sia esterna) e «
rimontarli » diversamente per
ottenere nuove strutture.
ando il fissaggio di nuove sue
strutture celebrali: si organo
statico, ma azione: " maten al mento
** le sue cellule nervose, emorie. Ma
un uomo può anche modificare da ò
autocondizionare, quando pensa e
immagina.
Il nostro cervello è nella situazione
di un bambino messo in un recinto con
un trenino fatto di pezzi di Lego;
egli può smontarlo e costruire un
aeroplano, una casetta, o
un'automobile, o inventare nuovi
giocattoli di sua fantasia. È questo
il « margine » di libertà di cui noi
disponiamo; la possibilità, in un
certo senso, di « autocondizionarci
», attraverso la continua
ricomposizione degli elementi. Ma è
anche il nostro limite : infatti le
nostre costruzioni mentali saranno
sempre predeterminate dai pezzi
disponibili. Non solo: ma questa
stessa capacità di «
autocondizionarci » dipende in larga
misura dall'ambiente: lo stimolo a
essere immaginativi è infatti a sua
volta una forma di condizionamento
ambientale. Più un bambino dispone di
« pezzi » e più è sollecitato a
rielaborare le sue strutture, più
diventa creativo o cresce
mentalmente. Ma se gli vengono dati
solo pochi pezzi o solo quelli di una
certa forma — oppure se lo si
scoraggia a « rielaborare » — le sue
costruzioni, materiali o
intellettuali, saranno molto limitate
(e la sua « libertà » sarà molto
modesta).
Questo meccanismo mentale mostra bene
perché sia necessario nella vita e
anche in politica stimolare gli
individui a « creare » (e quindi
anche a dissentire) grazie al più
largo ingresso di « elementi », cioè
di informazioni; mentre i sistemi
chiusi, dogmatici, attraverso la
censura, dichiarata o no, vogliono
far circolare solo alcuni schemi
mentali in modo che vengano costruiti
solo certi tipi di strutture.
Soltanto un ingresso sempre più largo
di informazioni, e la loro
rielaborazione continua può
permettere agli uomini di far fronte
ai cambiamenti ambientali sempre più
rapidi. Quello che avviene con
l'immaginazione è simile a ciò che è
avvenuto in natura coi cromosomi
(pare che lo stesso meccanismo sia
vero anche per gli anticorpi nel
processo immu-nitario) : è una
lotteria continua di possibili
strutture (o idee) « montate » coi
materiali a disposizione; quelle
adatte all'ambiente in trasformazione
sopravvivono e si affermano,
permettendo la continuazione e
l'evoluzione della vita.
L'immaginazione ha appunto questo
ruolo nella sopravvivenza. Senza
immaginazione non c'è adattamento ai
cambiamenti ambientali. Oggi il vero
problema è proprio quello della «
velocità » degli adattamenti :
l'ambiente cambia con grande rapidità
e noi non siamo in grado di tenere il
passo, per una serie di ragioni. Una
di queste ragioni è il permanere di
« strutture » del passato (idee
politiche, morali, superstizioni,
miti, filosofie), che pensano di
essere ancora in grado di risolvere i
problemi del presente o addirittura
quelli del futuro. / due livelli
Prima di concludere il capitolo
vorrei proprio soffermarmi brevemente
su questi problemi per alcune
considerazioni che mi sembrano
importanti e che sarebbe bene fare
sin d'ora anche per rispondere a un
certo numero di domande che pos-
sono nascere di fronte a un tale «
smontaggio » dei meccanismi biologici
e cerebrali. Tutto quanto abbiamo
visto nel corso del libro, infatti,
non deve demoralizzarci troppo: se,
andando a frugare tra le molecole,
scopriamo dei meccanismi che ci
possono turbare perché ci mostrano
l'uomo come una marionetta biologica
(la cui « libertà » consiste
nell'andare alla ricerca dei pro-pri
fili), in realtà prendere coscienza
di certi fatti significa capire
meglio la nostra natura e quindi
poter vivere meglio il nostro tempo.
Questa ricognizione in profondità,
nell'in-finitamente piccolo, non deve
farci perdere il senso delle
proporzioni : la nostra misura rimane
sempre quella dell'uomo e non delle
molecole. Intorno a noi, nella vita,
non vediamo infatti degli enzimi ma
degli esseri umani, non ci rivolgiamo
a « piramidi » di comportamenti, ma a
uomini e donne che reagiscono, amano,
odiano, ridono, soffrono. È questa
forse la nostra debolezza, ma è anche
la nostra forza, perché ci consente
di vivere in una dimensione che è la
nostra. Come la consapevolezza che
dovremo un giorno morire non ci
impedisce di vivere serenamente, «
dimenticando » l'angoscia della
morte, così la consapevolezza di
tutti i nostri condizionamenti e
delle leggi biologiche che ci
regolano può essere tranquillamente
« dimenticata », quando non ci serve.
La speleologia molecolare, cioè, deve
essere utilizzata nel modo giusto;
come una esplorazione in profondità
che ci permette di migliorare la
conoscenza di noi stessi e del nostro
comportamento, senza però impedirci
di vivere serenamente in superficie,
alla luce del sole, in una avventura
vitale che ci appare ancora più
meravigliosa e che dobbiamo poter
esprimere nel modo più degno. Proprio
per questo dobbiamo evitare che
comportamenti sbagliati vengano a
compromettere la qualità della nostra
vita. Se siamo sdraiati in riva al
mare e contempliamo il tramonto,
possiamo benissimo dire che « il sole
si tuffa nel mare, incendiandolo », e
vibrare segretamente di fronte a
questo
spettacolo semplice e grandioso; non
ci verrebbe mai in mente di
osservarlo con una calcolatrice,
consultando le tabelle
gravitazionali. Però se dovessimo
inviare un'astronave in orbita
sapremmo che non è il sole a tuffarsi
in mare, e naturalmente consulteremmo
le tabelle gravitazionali per
regolarci su come tracciare la rotta.
Tutto qui. È un problema di «
competenze ». Questa distinzione
essenziale (che è poi quella che
rende compatibili scienza e poesia)
non viene ancora accettata
nell'attività mentale. Scoprire
l'esistenza di « tabelle
gravitazionali » del cervello
rappresenta quasi un'offesa alla
dignità, all'autonomia, e alla
libertà dell'Uomo con la U maiuscola.
Ma chiediamoci seriamente: possiamo
affidare la guida dell'astronave a
chi crede che sia il sole a girare
intorno alla terra? Possiamo, in tal
caso, essere tranquilli sull'avvenire
dei nostri figli? Oggi, purtroppo,
quando si tratta di « mettere in
orbita » una decisione importante,
non si tiene conto delle tabelle
mentali ma si vola a « vista »,
guardando gli ostacoli che sono a
portata di mano, come in passato,
quando bastava girare il manubrio per
cambiare direzione. Nella nostra
epoca, invece, le astronavi hanno
bisogno di un volo strumentale (e di
manovre compiute con un largo
anticipo), e non possono essere
guidate da ciclisti. In altre parole
dobbiamo essere sempre in grado di
controllare le conseguenze delle
nostre decisioni e delle nostre
manovre, specialmente quando esse
riguardano l'intera collettività; per
questo occorre guardare senza timore
la marionetta che è in noi e
accettarne le implicazioni. Per il
resto è bene vivere in compagnia dei
poeti, dei sentimenti e persino delle
nostre passioni. Ma è come per il
vino: bisogna essere sobri quando si
è al volante. Questo « doppio livello
» (che poi corrisponde alla parte
istintiva e a quella razionale del
cervello) è una delle principali
conquiste da raggiungere, per il
singolo come per la società. È la
qualità che permette di essere
uomini. Senza la U maiuscola, ma con
molto più dignità. Un quadro d'azione
Torniamo ora al nostro punto di
partenza, dopo questo percorso che ci
ha portati dal prefetto Silvagni ai
meccanismi dell'immaginazione e della
sopravvivenza, e concludiamo. Alcune
cose appaiono abbastanza evidenti, e
cercheremo di riassumerle. II
cervello del bambino non può
sottrarsi ai condizio
namenti degli educatori, anzi
l'attività mentale nasce proprio
da questi condizionamenti; ne è, in
un certo senso, il risultato.
È inutile quindi volersi sottrarre al
ruolo di « manipolatori di
cervelli », perché ciò
significherebbe lasciare la manipola
zione ad altri, oppure al caso; La
libertà del bambino di essere « se
stesso » non può
esistere per le sopracitate ragioni.
L'unico « se stesso » inna
to è quello dato dal patrimonio
genetico, che determina la di
versità biologica di ogni individuo.
Ogni uomo (come ogni
mucca, pollo o asparago) ha una sua
« personalità » gene
tica, nel senso che i suoi cromosomi
sono diversi da quelli di
qualsiasi altro essere vivente. Non
vi sono due uomini gene
ticamente uguali( tranne nei casi dei
gemelli), così come non
vi sono due mucche o due polli
uguali. Questo substrato ge
netico (lo abbiamo visto nel n
capitolo) fornisce però soltanto i
comportamenti istintivi e le «
potenzialità » individuali :
predispone, per esempio, a un certo
temperamento, o a una certa
intelligenza, o a certi talenti (e di
ciò si deve tener conto
nell'educazione che deve essere a sua
volta « personalizzata »). Ma il
substrato genetico non può esprimere
alcunché senza l'inserimento di «
memorie » (condizionanti);
La sola « libertà » è quella
consentita dall'immagina
zione, che attraverso l'elaborazione
continua di dati permette
di « simulare » delle esperienze e di
arricchire il cervello con
nuove strutture « pensate ». È una
forma di autocondiziona
mento che è però, a sua volta,
condizionata dall'ambiente:
soltanto attraverso l'educazione,
infatti, un bambino può
essere « indotto » a sviluppare anche
la sua creatività; L'apprendimento
avviene attraverso un sistema premi-
punizioni che non può essere
soppresso, e che fa inevitabil
mente parte dell'educazione.
Ingenuamente in alcune comuni
tà hippy si è pensato di poter
sopprimere l'aggressività e le
frustrazioni nei bambini eliminando
punizioni e premi (persi-
no eliminando l'amore materno, inteso
come ricompensa).
Ciò è fuori dalla realtà, non
soltanto perché il sistema premi-
punizioni ha ramificazioni sterminate
(e in gran parte « invi
sibili »), ma perché, cercando di
raggiungere un tale equili
brio, si arriverebbe piuttosto a uno
stallo, a un immobilismo
emotivo: la vita, invece, è fatta di
movimento, di domande
e di risposte, di accelerazioni e
decelerazioni cardiache, di
pianti e di risa, di successi e di
fallimenti, di attese, di spe
ranze e di mille altre cose che
distinguono un essere palpi
tante da un essere spento, la stessa
vita dalla morte; Premi e punizioni
implicano l'esistenza di certi « valo
ri » che servano da punti di
riferimento, che rappresentino
per il bambino il « bene » e il «
male », le cose « buone » e
quelle « cattive ». L'educazione, in
altre parole, ha biologi
camente bisogno di certi principi che
ne costituiscano l'inte
laiatura, i paletti d'orientamento.
Ecco quindi che per pennellate
successive il ruolo dei genitori si
trova ad essere meglio definito,
soprattutto nei primi anni di vita,
che sono determinanti per
l'impostazione generale del rapporto
col figlio, e che costituiscono la
base di un futuro armonioso sviluppo.
Il bambino, cioè, deve avere dinnazi
a sé un modello da rispettare e in
cui credere, in grado di fornirgli un
quadro
d'azione; al tempo stesso deve essere
stimolato a esplorare, e anche a
crearsi eventualmente nuovi modelli.
Autoritarismo e permissività assumono
allora un altro significato : quello
di autorevolezza e di creatività.
Cerchiamo ora di vedere in concreto
come questo possa realizzarsi.
Quali valori trasmettere alla
prossima generazione?
XIII • I SENTIERI DELL'EDUCAZIONE /
modelli e la moda Quando si parla di
educazione il discorso diventa
naturalmente molto delicato e le
generalizzazioni sono assai difficili
: ogni situazione familiare è
diversa, ogni bambino è diverso, e
voler definire regole o « valori »
adatti per tutti sarebbe come voler
fare indossare a tutti un abito della
stessa taglia. L'abito dev'essere
confezionato di volta in volta su
misura, adattarsi alle esigenze,
tener conto dei difetti, delle
qualità, tener conto anche
dell'evoluzione dei tempi e della
stagione in cui deve essere
indossato. Il fatto è che oggi i
genitori sono spesso in difficoltà
nel trovare i « modelli » giusti :
vedono intorno a sé una tale quantità
di linee e tendenze, una tale
rapidità nei cambiamenti della moda
da rimanere a volte disorientati.
Essi si chiedono fino a che punto il
loro « modello » educativo è ancora
valido. « Essere genitori, oggi, non
è soltanto un mestiere difficile : è
anche qualcosa di assai diverso dal
passato. Da un genitore noi oggi ci
aspettiamo tutto: pretendiamo che sia
stimolante, sensibile, affettuoso,
che si occupi dei problemi della
scuola, che non sia totalitario. In
verità facciamo di tutto per rendere
estremamente complesso questo
mestiere, offrendo ben poche
indicazioni sul come impararlo. » Chi
mi dice queste cose è il professor D.
Coopersmith, del-
l'Università di Davis, in California.
Ed è certamente vero che di fronte al
loro immenso e delicatissimo compito
educativo (in continua evoluzione),
una madre o un padre dispongono di
ben pochi aiuti e consigli. Nel campo
dell'educazione quasi niente è stato
fatto per collaborare con la
famiglia, che è purtuttavia il luogo
in cui il bambino si forma nel primo
periodo (e non soltanto in quello)
della vita. Vi sono corsi per sarti,
orologiai, cuochi, vigili urbani,
giardinieri, rocciatori,
accalappiacani, soffiatori di vetro,
rumoristi, maestri di sci, suonatori
di triangolo, ma non esistono corsi
per genitori, che in un certo senso
debbono essere tutte queste cose al
tempo stesso. « Finora, bisogna
ammetterlo, nessuno se ne è
preoccupato molto, » dice
Coopersmith. « Si leggono rubriche a
caso, sui giornali o sui settimanali,
ma non sono molti i posti in cui
trovare le risposte giuste. To penso
che la scuola possa svolgere, per i
genitori, un ruolo molto utile. Nel
nostro istituto, che si occupa di
bambini piccoli, abbiamo creato un
corso per genitori, che è molto
apprezzato e seguito. Con i genitori
discutiamo sui metodi educativi e sul
modo di affrontare i problemi
quotidiani dei figli. Con questi
corsi intendiamo fornire una
preparazione generale e venire
incontro ai problemi che via via si
presentano. » « Ecco, parliamo un
po' di metodi, professor Coopersmith.
Qui negli Stati Uniti ha avuta molta
diffusione, negli ultimi decenni, un
< modello > permissivo; ma da qualche
tempo c'è un ripensamento, e si
discute molto sui danni che possono
derivare non solo da un'educazione
autoritaria, ma anche da
un'educazione permissiva. » « Sì. Ma
come sempre non è facile intendersi
su questi termini, e definire con
precisione cosa si intenda per l'uno
o l'altro tipo di educazione. Direi
comunque che oggi molte ricerche ci
portano a concludere che è
preferibile una combinazione delle
due cose, o meglio una combinazione
di disciplina e di < occasioni di
scelta >. Il bambino infatti ha bi-
sogno di alternative, ha bisogno di
un'educazione che lo aiuti a
scoprirsi da solo, ma d'altro canto
gli è necessario un quadro, una
cornice in cui situarsi e misurarsi.
Oggi prevale quindi l'idea che sia
bene fornirgli un quadro ambientale
ben definito, all'interno del quale
lo si abitui a prendere decisioni, a
responsabilizzarsi di fronte a
un'alternativa. » « In altre parole è
bene definire le regole del gioco,
così come esistono in qualsiasi
attività della vita, e, nel rispetto
di queste regole, fare in modo che il
bambino possa esprimere le sue
qualità? » « Sì, questo, a mio
parere, è proprio il punto: il
bambino deve sapersi situare in
rapporto a qualcosa o a qualcuno, ha
bisogno di punti di riferimento. Ciò
richiede l'esistenza di certi valori
sui quali il bambino possa misurare o
giudicare i propri successi; e tutto
questo richiede certe regole e quindi
una certa disciplina. « Di solito si
pensa alla disciplina come a un mezzo
per impedirgli di agire a piacimento,
ma vi è un altro aspetto più
importante della disciplina : quello
di mettere il bambino in condizioni
di esprimersi, e anche di sviluppare
quell'autodisciplina e quel senso di
responsabilità che sono alla base di
ogni educazione, unitamente al
rispetto di se stesso. « È
un'illusione credere che il bambino
sia più < libero > al di fuori di un
quadro d'azione tracciato per lui dai
genitori. Io penso che sia vero il
contrario : cioè, il rischio maggiore
di manipolare i figli, in un certo
senso, esiste proprio quando pensiamo
di non manipolarli. » Quale tipo di
punizione? Prima di entrare nel
discorso dei « valori » (che ci
porterà assai lontano), cerchiamo di
vedere meglio come interpretare il
concetto di disciplina. Naturalmente
entriamo qui in pieno nel campo dei
premi e delle punizioni, e nasce
subito una
domanda alla quale i genitori debbono
dare, ogni giorno, una risposta
pratica : fino a che punto è bene
usare le punizioni nell'educazione di
un bambino? Lo psicologo americano
F.B. Skinner, campione del
condizionamento su animali (riesce a
insegnare ai colombi a giocare a
ping-pong, oppure a guidare un
missile) invita, giustamente, a
distinguere tra due tipi di
punizioni: quelle che tendono a
reprimere un comportamento, e quelle
che tendono a crearlo. La differenza
è sottile (perché reprimendo un
comportamento se ne crea un altro),
ma il senso del discorso appare
subito chiaro con qualche esempio.
Se, come taceva l'antico re
Mitridate, si ingerisce ogni giorno
un po' di veleno l'organismo si
abitua a reagire contro di esso, a
vincerlo, e le ditese in questo modo
si rafforzano. Analogamente, se le
condizioni ambientali sono avverse,
l'uomo può essere stimolato a
superarle; per sottrarsi a queste «
punizioni », nel corso dei secoli ha
costruito case contro il freddo,
pozzi contro la sete, tecniche
agricole contro la fame, medicine
contro le infezioni. L'altro tipo di
punizione tende invece a essere più
esplicitamente repressiva, per
indurre l'individuo a non comportarsi
in un certo modo. In realtà il più
delle volte chi viene punito non
tende a modificare il proprio
comportamento, ma a evitare la
punizione (un bambino punito per
giochi sessuali, dice Skinner, non è
meno incline a continuarli). Questa
distinzione (anche se i suoi confini
sono molto sfumati) indica in
sostanza un principio importante: in
campo educativo, anche attraverso le
punizioni, è meglio puntare al
premio. In altre parole, mentre le
proibizioni non comportano alcuno
sbocco creativo, anzi, portano
generalmente alla rinuncia e ai
sotterfugi, le avversità possono
essere uno stimolo per modificare il
comportamento in vista di un premio.
L'uomo che costruisce case per
difendersi dal freddo, infatti, lo fa
non solo per sottrarsi a una «
punizione », ma an-
che per ottenere in « premio » un
ambiente più confortevole. Il sistema
qui è bivalente, funziona nei due
sensi. Un'educazione intelligente può
funzionare nello stesso modo: non
sopprimendo la punizione ma
utilizzando quella più adatta a
stimolare il bambino. Tutti i
ricercatori che ho incontrato sono
d'accordo, del resto, nel ritenere
che è meglio puntare sulla
ricompensa, per stimolare il bambino
in una nuova direzione, anziché
ricorrere alla punizione per
bloccarlo in quella in cui si trova.
Il professor White mi diceva di aver
osservato che le madri « A » (di cui
abbiamo parlato in un precedente
capitolo) si comportano appunto in
questo modo. La stessa cosa mi
dicevano Heber e Hunt. Naturalmente
non è facile inventare continuamente
queste strategie, anche perché spesso
il genitore, giustamente, si
spazientisce. Per esempio, se un
bambino piccolo strilla, fa i
capricci, che razza di « schema »
bisogna adottare? « Io penso che un
genitore deve naturalmente
preoccuparsi che non vi siano ragioni
ben precise per questo suo
comportamento, » dice Coopersmith, «
ma ritengo che non si debba neppure
essere continuamente al suo servizio.
La regola di fare tutto ciò che il
bambino esige è una sciocchez-za, ed
è un sistema che non funziona perché
finisce per rovinarlo. Occorre
prestare attenzione ai suoi bisogni,
studiarlo, cercare di capirlo. Ma se
il bambino non < rispondo, è meglio
ristabilire le distanze e lasciarlo
sfogare. « Per quanto riguarda poi le
punizioni, abbiamo potuto constatare
che è preferibile non usare punizioni
fisiche, e neppure usare la minaccia
della perdita d'affetto. Non si deve
mai dire: <Se non fai questo non ti
voglio più bene>; è una minaccia
terribile per tutti, per i bambini
come per gli adulti. Il sistema più
efficace, credo, è quello di
ricorrere a strategie di questo tipo
: < Se non fai la tal cosa ti
chiederò di andare in camera tua.
Quando sarai disposto a uscir fuori
per parlare, uscirai e parleremo; ma
non voglio perdere tempo a
litigare con te, e ad ascoltare tutto
quello che mi dici. Ci sono cose su
cui non transigo. > Penso che un
sistema di questo tipo, basato più
sul dialogo che sulla punizione
fisica, sia più efficace e
soprattutto più educativo. »
L'importante, insomma, è di trattare
il bambino come un essere pensante, e
non come un animaletto. E a questo
proposito torna alla mente quello che
la dottoressa G. Ortar diceva a
proposito del linguaggio : se il
bambino desidera uscire sul balcone e
la madre vuole impedirglielo, una
frase come « Non uscire! » è
l'equivalente di un ordine repressivo
(è una sberla verbale); una frase,
invece come « Non uscire, perché fa
freddo e senza maglione ti prendi un
raffreddore » è un modo per renderlo
consapevole dei motivi della
proibizione. Molti psicologi mi
dicevano che il primo tipo di
comportamento (condito con ceffoni) è
un comportamento diffuso tra le madri
« C », l'altro tra le madri « A ».
Tutto questo discorso, in sostanza,
non intende togliere alle madri la
soddisfazione di qualche scappellotto
« mollato » al momento giusto: vuole
piuttosto indicare una direzione, un
metodo, che in definitiva si rivela
più redditizio. Del resto, ciò è in
armonia con tutto quanto abbiamo
detto nei capitoli precedenti : anche
nel sistema premi-punizioni è bene
puntare più sulla creatività che
sulla deprivazione. Una punizione
puramente repressiva non aiuta il
bambino a esprimersi. Il bambino,
come un attore, è più aiutato dal
desiderio degli applausi che dal
timore dei rischi. Le regole dei
gioco Anche per riuscire a inculcare
una disciplina esiste naturalmente un
« montaggio progressivo », valgono
cioè tutte le regole che abbiamo
visto, nel corso del libro, per lo
sviluppo della personalità del
bambino. È assai diffìcile modificare
le cose quando la « partita » è già
in fase avanzata: il
rapporto disciplinare tra genitore e
figlio va impostato sin dalle prime
mosse, e costruito poi
progressivamente. Non si può essere
« permissivi » a tre anni e «
autoritari » a otto (o a
quattordici); occorre abituare sin da
piccolo il bambino a certe regole, in
modo che egli le accetti
naturalmente, sviluppando sin
dall'inizio i suoi « adattamenti » al
sistema premi-punizioni. Anche la
disciplina diventa in tal modo un
condizionamento: come sul terreno
vergine del piccolo cervello il
genitore traccia inevitabilmente i
percorsi delle idee e dell'attività
mentale, analogamente, stabilendo
certe regole di « traffico ». egli
delimita un quadro d'azione. Questi
controlli funzionano tanto meglio
quanto più sono « invisibili » (cioè
diventano automatici), e quanto più
permettono al bambino di esplorare,
di creare, di immaginare. Dire
continuamente a un bambino « fai
questo, fai quello » non significa
educarlo ma renderlo dipendente.
Indipendenza e disciplina non sono
cose in contraddizione, così come per
un giocatore di bridge non vi è
contraddizione tra le sue scelte di
licitazione e di giocata, e le norme
fissate dalla Federazione
internazionale. Per questo è bene che
il bambino impari a comportarsi più
in base a un'esperienza diretta che
ubbidendo a ordini ricevuti : nel
quadro d'azione definito dal genitore
egli deve infatti avere l'occasione
di muoversi e avere « incontri » che
gli consentano di arricchire le sue
esperienze e la sua capacità di
prendere decisioni, rafforzando così
il suo senso di responsabilità. In
questa cornice genitori e figli si
possono incontrare molto meglio, e
possono sviluppare su basi « certe »
quel tennis, quel continuo rinvio di
domande e risposte che consente il
sorgere di un dialogo. In questo
continuo scambio, soprattutto il «
premio » (inteso anche come consenso
per il suo comportamento) diventa un
incentivo, una « claque » psicologica
che crea un'atmosfera più stimolante.
Tutto questo, però, chiaramente può
avvenire solo su un
buon terreno, richiede, cioè, un
clima familiare adatto : non si può
educare un bambino seguendo soltanto
le istruzioni dì un manuale, lo si
educa soprattutto con l'esempio. Il
bambino imita tutto ciò che vede e
sente intorno a sé, assorbe come una
spugna tutti i succhi del suo
ambiente. L'autorevolezza del
genitore nasce dal rispetto che il
figlio ha per lui. Anche il genitore,
dunque, e non solo il bambino, deve
osservare certe regole del gioco. Non
si può « barare » a lungo,
nell'educazione. Soprattutto perché
il sistema disciplina-indipendenza
deve basarsi su certi valori, o
principi, che rappresentano i vari
articoli del comune regolamento da
rispettare. Quali debbono essere
questi valori? Quali valori? Un tempo
a questa domanda si poteva trovare
abbastanza facilmente una risposta.
Il mondo cambiava lentamente e i
valori (come le morali) potevano
essere trasmessi da una generazione
all'altra come un'eredità culturale
che conservava a lungo la sua
validità. Oggi la velocità dei
cambiamenti è talmente alta che mette
in crisi non solo i valori ma anche i
genitori, i quali si chiedono fino a
che punto i loro insegnamenti sono
diventati anacronistici (oppure se
non è il mondo che sta girando in
maniera sbagliata). Credo che per
orientarsi un po' meglio in questo
campo sarebbe bene allargare il
discorso, e cercar di considerare
l'insieme dell'educazione come una
palestra, in cui il bambino viene
addestrato e allenato in vista della
sua carriera di atleta. Abbiamo già
visto nei capitoli precedenti che il
bambino impara ad amare il prossimo
amando la prima persona che incontra
nella vita, cioè la madre; impara ad
avere un rapporto sicuro con gli
altri attraverso un buon rapporto
materno (ri-
cordiamo sempre che la parola « madre
» non va intesa in senso stretto, ma
si applica alla persona, o alle
persone, padre compreso, che gli sono
vicine nel primo periodo della vita).
Così pure abbiamo visto che non è
tanto importante imparare delle cose,
quanto piuttosto « imparare a
imparare » attraverso le cose. lì
significato di tutto questo, penso, è
che nei rapporti affettivi o in
quelli sociali o nell'apprendimento,
la madre — e la famiglia —
rappresentano un centro di
addestramento in cui il bambino
comincia a usare gli attrezzi più
diversi, impara a esercitarsi e a
sviluppare le sue qualità : scopo
della palestra e dei vari attrezzi
non è tanto di farlo diventare uno
specialista delle pertiche o della
sbarra o dell'asse di equilibrio,
quanto piuttosto di metterlo in
grado, attraverso questa preparazione
di base, di affrontare altre
discipline sportive. In altre parole
occorre dare al bambino i mezzi
mentali per affrontare la vita, più
che prepararlo a un compito
specifico. Occorre dargli una
formazione di base che gli permetta
di agire nelle circostanze più
diverse. Crescendo, infatti, il
bambino si allontana man mano dalla
« nicchia » familiare e comincia a
entrare in contatto con il mondo
esterno: la scuola, le letture, le
esperienze, le conoscenze, i viaggi,
e così via. I genitori perdono
l'egemonia culturale e anche
l'esclusività affettiva dei primi
anni di vita: col passare del tempo,
il bambino estenderà fuori dalla
famiglia non solo i suoi interessi,
ma anche i suoi affetti (attraverso
le amicizie, gli amori, il
matrimonio, i figli). Per quanto
riguarda i « valori », il meccanismo
a mio parere è abbastanza simile,
poiché tutta l'educazione è un fatto
unitario, anche se noi, per comodità,
la suddividiamo in tante fettine
applicandovi delle etichette. Data la
rapidità crescente dei cambiamenti
culturali è difficilmente pensabile
che un genitore, per quanto « moderno
», possa trasmettere al figlio un
modello valido per il resto della
vita : ciò sarebbe molto presuntuoso
e poco intelligente.
Deve invece cercare di stimolare la
sua capacità di giudicare le
situazioni e di trovare le risposte
giuste. Non deve cioè insegnargli un
percorso, ma insegnargli a guidare.
Le strade possono essere tante nella
vita, nuovi tracciati possono
emergere in continuazione:
l'educazione è quindi una scuola-
guida che deve consentire, anche per
quel che riguarda i « valori », di
avere una visuale quanto più ampia
possibile, e di disporre di una
preparazione adatta a far fronte ai
cambiamenti. È in questo quadro
d'insieme che un genitore deve saper
trasmettere i suoi « valori », le sue
regole di vita, che sono per il
bambino gli « attrezzi » naturali
dello sviluppo. « Un genitore, » dice
Coopersmith, « deve sapere offrire al
proprio figlio un modello, pur nella
consapevolezza che non è l'unico
possibile. Egli deve saper dire al
figlio: <Queste sono per me le cose
importanti, e desidero che tu le
abbia perché sono cose valide : io
stesso le vivo e dico a te di
viverle. Tu non devi essere un mio
riflesso perché potresti diventare
una persona sbagliata, devi costruiti
la tua personalità, devi esplorare in
giro e arricchirti, ci sono tanti
modi diversi di essere uomo. Ma
queste cose io desidero che tu le
abbia e le conosca. > Con i bambini
molto piccoli questi valori possono
essere trasmessi solo in maniera
molto limitata. Ma in ogni fase dello
sviluppo il bambino può < captare >
il comportamento dei genitori. » «
Lavorando a contatto con i genitori,
» dice ancora Coopersmith, « mi sono
reso conto che molto spesso essi non
sono convinti dei loro stessi valori,
e mancano di certezze. Molti valori
tradizionali vanno scomparendo, ed è
difficile infondere sicurezza agli
altri quando ne manchiamo noi stessi.
La cosa peggiore, però, è rifugiarsi
in un atteggiamento di rinuncia,
poiché ciò equivale a privare il
figlio di un punto di appoggio, di un
metro per misurare i propri successi,
e quindi anche di un punto di
riferimento per sviluppare la stima
di se stesso.
« Occorre invece guardare bene nel
proprio interno, e cercare quali sono
le cose importanti; è una
introspezione che non facciamo
spesso, né volentieri. Confesso che
anche per me la difficoltà maggiore
incontrata con i figli è stata quella
di dover scoprire quali sono
veramente i miei valori. Non le
parole, ma ciò che vi è dietro. » Una
bomba a orologeria L'educazione è
quindi un fatto troppo legato a
situazioni personali perché si
possano proporre artificialmente dei
contenuti validi per ogni
contenitore. Credo che un genitore
debba cercare di proporre al figlio
la parte migliore di sé: non solo, ma
debba cercare di viverla, perché non
si può offrire soltanto un modello,
ma anche un esempio. Detto questo è
però evidente che oggi la cosiddetta
« crisi dei valori » non emerge
soltanto a livello familiare, ma ha
radici molto più vaste e riflette una
situazione più generale. Essa ci
coinvolge un po' tutti e pone una
serie di problemi importanti (in
politica, nella vita, nella morale)
per i quali occorre trovare al più
presto delle risposte. Il discorso
allora si allarga e diventa molto più
articolato. Personalmente ritengo che
la crisi attuale sia dovuta alla
mancanza di una visione chiara del
mondo in cui ci stiamo muovendo:
com'è possibile, infatti, dare agli
altri istruzioni sulla strada da
seguire se non si vede dove si sta
andando? Vi è ancora molta confusione
su questi problemi perché non si
accetta una realtà molto semplice : i
« valori » debbono essere messi in
crisi. È un'esigenza di tipo
biologico: qualsiasi dottrina
politica o morale infatti è
necessariamente provvisoria. Come si
può pretendere che certe regole siano
sempre valide se le situazioni
cambiano? Sarebbe come voler guidare
un aereo supersonico con il libretto
d'istruzioni dell'aereo a elica : se
vi sono guai a bordo (come è
inevitabile)
che senso ha dire che la situazione
di volo non rispetta più le regole o
che « il libretto è entrato in crisi
»? Il fatto è che non bisognava
neppure salirci, sul jet, con quel
manuale, e non aspettare la
collisione. A questa confusione
mentale contribuisce anche buona
parte della cultura di oggi, rivolta
più verso il passato che verso il
futuro: essa ha abbandonato l'uomo
moderno, l'ha lasciato solo e non si
è ancora affiancata alla ricerca
scientifica, per scoprire quei «
valori » nuovi che già si intravvedo-
no emergere da tutti gli studi in
corso, per trame gli insegnamenti
necessari. La cultura, come la morale
o la politica, è però costretta a
breve scadenza a immergersi
rapidamente nel futuro, se vuole
aiutare in tempo l'uomo moderno ad
affrontare la sfida intellettuale più
importante di tutta la sua storia :
quella che lo vede cambiare di era.
La nostra generazione, infatti, quasi
senza accorgersene è giunta alle
porte di un nuovo mondo, e vi è
giunta impreparata, con un bagaglio
mentale inadeguato ai tempi, incapace
di adattarsi alla rapidità dei
cambiamenti da lei stessa provocati.
Non è più possibile, oggi, condurre
per mano un bambino verso questo
futuro senza capire che cosa si sta
preparando : non è più possibile
occuparsi di tanti piccoli dettagli
nella sua educazione giornaliera
senza rendersi conto che una
gigantesca mareggiata si sta formando
al largo, e che il bambino, nei suoi
pannolini superassorbenti, si dirige
festante verso quest'ondata
micidiale. Essere un genitore del
proprio tempo vuoi dire soprattutto
guardare avanti, scandagliare
l'avvenire per proteggere il proprio
piccolo, cominciando col prendere
consapevolezza dei pericoli che si
profilano. Ecco perché ho pensato di
dedicare l'ultimo capitolo di questo
libro ai problemi posti dallo
sviluppo della nostra società, cioè
ai problemi che dovranno affrontare i
bambini che hanno oggi da zero a tre
anni, quando entreranno in scena
nella vita attiva. Essi dovranno
esser pronti a un salto qualitativo
nel modo di pensare e di essere,
basandosi su valori che già si
possono chiaramente intravedere. Per
fronteggiare questa « mutazione » non
basterà essere pronti nell'anno
duemila: già oggi i genitori devono
operare una conversione mentale su se
stessi, poiché proprio in questo
momento si sta preparando il mondo
che la prossima generazione riceverà
in consegna. È quindi adesso che
bisogna agire sulla realtà. Sarebbe
veramente inutile preoccuparsi tanto
dell'avvenire materiale e
intellettuale di un bambino, e non
accorgersi che nella sua culla si
trova già una bomba a orologeria.
Chi disinnesca la bomba a
orologeria?
XIV'VERSO IL FUTURO Verso un
collasso? Sul futuro dell'umanità nei
prossimi decenni esistono alcuni
autorevoli (e agghiaccianti) studi,
nei quali si afferma che se non si
interviene al più presto per
correggere certi squilibri (in
particolare l'aumento della
popolazione) la prossima generazione
conoscerà una crisi senza precedenti.
L'ormai celebre rapporto preparato da
un'equipe di ricercatori del MIT, il
Massachusetts Institute of
Technology, per conto del Club di
Roma (un'associazione internazionale
animata da Aurelio Peccei che
comprende manager industriali,
scienziati, economisti, umanisti,
dirigenti di organismi
internazionali) mostra i rischi di un
collasso planetario come conseguenza
del crescente saccheggio delle
risorse terrestri (che non sono
illimitate e non possono essere
rinnovate) e degli inquinamenti
provocati da un'umanità che cresce in
misura maggiore delle sue stesse
disponibilità agricole future. In
mancanza di correzioni adeguate la
crisi comincerebbe a farsi sentire
tra una ventina di anni, o forse
prima, e rapidamente nei decenni
seguenti precipiterebbe in modo
inarrestabile. La caratteristica
atroce di questa crisi sarebbe
infatti proprio quella di non poter
più essere fermata, una volta
divenuta evidente in tutta la sua
gravita, così come un automobilista
che viaggia a 200 chilometri orari
non rie-
sce più a frenare in tempo quando
l'ostacolo si trova a cinquanta metri
di distanza. È un allarme tanto più
grave in quanto le ideologie
politiche dominanti sembrano ignorare
questa dinamica dei processi di
sviluppo esponenziale : « La grande
maggioranza delle autorità politiche
di tutti i paesi, » osserva il
rapporto, « sembra indirizzata a
perseguire obiettivi che appaiono in
contrasto con queste indicazioni ».
Il rapporto dell'equipe del MiT-Club
di Roma ha provocato un grande
dibattito nel mondo economico: ha
sollevato numerose critiche ma anche
consensi sempre più vasti. Al di là
di certe cifre o scadenze, infatti,
il suo indiscusso merito è stato
quello di aver esaminato per la prima
volta in termini globali i problemi
del nostro pianeta (cioè l'ecosiste-
ma-Terra, in cui industria,
inquinamenti, popolazione, consumi
agricoli e di materie prime,
aumentando a ritmo esponenziale * si
influenzano a vicenda in modo
preoccupante). Gli autori stessi
avvertono ripetutamente che non si
tratta di una « previsione » ma di un
freddo calcolo tecnico, realizzato
con un modello che è ancora,
necessariamente, primitivo e
incompleto. È come un radar, essi
dicono, che indica i pericoli di
navigazione e segnala la presenza di
iceberg, in modo che il pilota possa
evitarli : il radar cioè non «
prevede » la collisione ma indica ciò
che accade se si continuerà sulla
stessa rotta. Per evitare gli iceberg
è necessario però compiere delle
manovre, e compierle in tempo. In
altre parole il rapporto del MIT pone
apertamente il problema delle
decisioni politiche che dovranno
necessaria-
mente intervenire per modificare
certe curve di sviluppo teo-riche. Ma
chi modificherà le cose? Come?
Quando? Dove? Con quali metodi e
risultati? Gli autori del rapporto
indicano, dal canto loro, una
soluzione possibile (ma urgentissima)
per evitare un disastro nell'arco
della prossima generazione:
sostanzialmente si tratterebbe di
bloccare l'aumento delle nascite e di
fermare 10 sviluppo quantitativo
della produzione industriale (rimet
tendo in discussione il « mito »
economico del nostro tempo,
cioè il Prodotto Nazionale Lordo, con
conseguenze appena
immaginabili) per orientarsi verso
un'altra qualità di svilup
po, capace di mantenere in equilibrio
l'ecosistema-Terra. Una seconda serie
di studi è ora già in corso per
approfondire i problemi e indicare i
nuovi « modelli » sociali ed
economici, capaci di far fronte alla
situazione. Per esempio 11 professor
Linemann, della Università di
Amsterdam, in
collaborazione con il professor Jan
Tinbergen, premio Nobel
per l'economia, sta cercando di
valutare ciò che sarà neces
sario fare di fronte all'ormai
inevitabile raddoppio della po
polazione nel giro di una trentina di
anni. « Sono stati necessari secoli,
» mi ha detto in proposito Alexander
King, direttore generale degli Affari
scientifici all'ocsE
(l'Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico), « per
realizzare strutture capaci di
assicurare l'attuale livello di vita,
case, strade, scuole, agricoltura,
servizi ecc. Come si farà a
raddoppiare tutto ciò nel giro di
trenfanni? » Un eventuale raddoppio
di tutti questi beni, naturalmente,
avrebbe come risultato — non
dimentichiamolo — soltanto il
mantenimento del livello di vita
attuale, che è ben lontano
dall'essere soddisfacente,
soprattutto per il Terzo Mondo...
(che conoscerà l'aumento di
popolazione più alto, e quindi più
micidiale). È evidente, inoltre, che
le curve di questo sviluppo si
muoveranno in modo diverso nelle
varie parti del mondo, e in prò-
posito un'altra ricerca condotta
negli Stati Uniti e in Germania
studia « modelli di crescita » per
grandi settori continentali omogenei.
Per il Terzo Mondo un'equipe di
ricercatori nell'America Latina tenta
di stabilire in quale modo i limiti
delle risorse potranno ancora
consentire uno sviluppo economico
decente nei paesi poveri. Queste
ricerche si svolgono (è bene che si
sappia) tra il disinteresse della
classe politica dominante. Mi diceva
il pro-fessor Linemann che il suo
studio sarà ritardato di un anno
perché mancano i fondi per disporre
di qualche collaboratore in più nella
raccolta e nell'elaborazione dei
dati. Intervenire ora Tutti questi
studi indicano abbastanza chiaramente
in quale mondo ci stiamo avviando,
quale tipo di prospettiva si apre per
i bambini di oggi se non si
interverrà in tempo a correggere
certe abnormi « curve » di crescita.
Noi continuiamo a vivere
spensieratamente, dissipando in una
sola generazione molto più di quanto
sia stato consumato da tutte le
generazioni precedenti messe insieme.
Ma è evidente che la « belle époque »
che stiamo vivendo non potrà durare a
lungo se non correremo presto ai
ripari, per riequilibrare le voragini
di scompensi che si stanno veri-
ficando in ogni campo. Per ora il
valzer continua con la vaga
convinzione che « si troverà qualcosa
», si « inventerà qualche nuova
trappola » per risolvere i nostri
problemi, e quelli dei nostri figli.
Ma nessuno sa dire veramente se il
ritmo delle nuove invenzioni potrà
soddisfare le esigenze che crescono
in misura esponenziale. Il problema
sembra del resto essere non soltanto
il ritmo dello sviluppo, ma anche la
sua qualità. Ho parlato a lungo di
questi problemi con alcuni tra i
massimi esperti mondiali (ho
incontrato decine di economi-
sti, biologi, industriali,
sociologhi, scienziati atomici,
psicologi, agronomi, che studiano
queste prospettive); al di là delle
divergenze individuali vi è la
convinzione generale che sarà
inevitabile modificare profondamente
i nostri comportamenti sociali, etici
e culturali per far fronte alla sfida
del futuro. Non possiamo superare il
« muro dello sviluppo » con strutture
alari inadeguate: non è assolutamente
possibile pensare di arrivarci con i
vecchi modelli. I vecchi modelli
servono per volare nel passato ma non
nel futuro. Tutto ciò richiede
naturalmente una vera rivoluzione non
solo tecnologica (e non dimentichiamo
che si continuano a lesinare i soldi
per la ricerca) ma anche una
rivoluzione mentale, che parta da una
visione completamente diversa
dell'uomo, del suo ambiente, degli
equilibri necessari. La nuova qualità
di sviluppo richiederà idee nuove,
idee che non soffrano di alcun
complesso nei confronti dei miti del
passato. Aver fiducia nelle capacità
dell'umanità di vincere questa sfida
vuoi dire scommettere
sull'intelligenza dell'uomo, sulla
sua capacità di adattarsi alle
situazioni con nuove soluzioni,
invenzioni, comportamenti. È quello
che tutti ci auguriamo: ma proprio
per questo è necessario oggi puntare
sempre più sull'immaginazione, sulle
idee, sul cervello. Durante tutta la
storia della vita vi è stata una
selezione naturale degli organismi,
con il prevalere dei più adatti: oggi
è necessaria una selezione naturale
delle idee. Se non si rendono
inoffensivi in tempo i ciclisti che
vogliono guidare l'astronave, i
bambini che si affacciano oggi alla
vita avranno poche probabilità di
avere un avvenire decente. L'unica
nostra « chance » è una vera
rivoluzione mentale, che consenta di
affrontare in modo diverso la realtà,
e di operare con più intelligenza le
scelte politiche. Questa rivoluzione
mentale può costituire, per chi sa
scorgerne il significato profondo, un
ideale nuovo e entusiasmante, capace
di
imprimere un nuovo indirizzo
all'azione individuale e collettiva,
e di produrre un salto di qualità
nella visione dei problemi della
nostra società. (I giovani sapranno
scorgere in tempo questa nuova
dimensione?) Personalmente penso che
sia un dovere per un genitore non
soltanto trasmettere al figlio questo
atteggiamento di totale apertura, ma
di viverlo egli stesso, agendo anche
come cittadino per stimolare le
condizioni favorevoli a una
correzione di rotta. Il conto alla
rovescia è già cominciato : la crisi
di domani la stiamo preparando oggi,
in questo momento, senza neppure
rendercene conto. Lo sviluppo mentale
deve perciò essere non solo del
bambino, ma anche dell'adulto. E deve
cominciare con la ricerca di nuovi «
valori » che costituiscano un punto
di riferimento per far fronte agli
immensi problemi che si stanno
avvicinando. La lanterna magica Credo
che questa ricerca di nuovi valori
rischi francamente di essere
illusoria se ci si limita a prendere
come punto di riferimento (tentando
di trasferirli nella realtà di oggi)
quelli del passato. I « manuali » di
volo cambiano coi tempi. Ogni epoca
ha avuto le sue regole di
sopravvivenza e le sue morali che si
adeguavano di volta in volta alle
mutevoli situazioni ambientali. Nella
nostra società, ad esempio, sarebbe
« immorale » gettare il nonno dal
balcone perché è diventato inabile al
lavoro. Invece in certe isole
dell'Indonesia si facevano salire i
vecchi su alti alberi di cocco e poi
si scuoteva fortemente l'albero: chi
non riusciva a rimanere aggrappato
cadeva e veniva così eliminato dal
gruppo, perché ritenuto non più
idoneo a portare il suo contributo
alla lotta comune per la
sopravvivenza. Non è, del resto, un
caso isolato : « selezio-
ni » analoghe, per vecchi e bambini,
si ritrovano in quasi ogni tipo di
società primitiva. Viste
isolatamente, certe morali possono
quindi apparire contradditorie, ma
non lo sono. Perché esse, in pratica,
si riallacciano tutte a un meccanismo
di base che dalle macromolecole
all'Homo sapiens ha sempre regolato
la vita e i comportamenti sul nostro
pianeta. Per ritrovare questo
meccanismo basta seguire i fili che
ci fanno agire quotidianamente e
penetrare nel nucleo della macchina
umana: grazie a questa immersione in
profondità è possibile scorgere
facilmente la matrice che presiede ai
nostri « valori » : la sopravvivenza.
Infatti tutte le belle parole che
accompagnano i nostri giudizi (onore-
disonore, giustizia-ingiustizia,
rispetto-disprezzo, bontà-cattiveria,
egoismo-altruismo ecc.) sono soltanto
ombre cinesi, sono proiezioni di una
lanterna magica all'interno della
quale si trova il meccanismo della
conservazione propria e della specie.
Riscoprendo in una chiave nuova
(sociale, morale, economica,
politica, mentale) l'antichissima
regola della sopravvivenza, è così
possibile oggi ritrovare un solido
punto di riferimento che ci permette
di valutare meglio i cambiamenti, di
giudicare i valori e le morali, di
capire se essi sono in contrasto non
con le nostre schede mentali, ma con
la continuazione della vita. La
sopravvivenza, infatti (lo abbiamo
visto nel capitolo sulla
memorizzazione) è il valore
fondamentale che ha sempre regolato
tutto il nostro comportamento,
individuale e sociale, al di là dei
cambiamenti, delle mode, delle
morali. Scavando un po' lo si ritrova
in ogni nostro gesto: esso ha
accompagnato tutta la nostra storia
della vita ed è sempre stata la
pietra di paragone, nel corso della
evoluzione, per decidere ciò che era
« bene » e ciò che era « male ».
Basta guardare indietro, nella nostra
storia, per rendersene conto.
Sopravvivere per vivere Noi, per
esempio, consideriamo che è « bene »
tenere ai bambini la testa fuori
dell'acqua, poiché altrimenti
affogherebbero, ma un miliardo o due
di anni fa i nonni dei bisnonni dei
nostri bisnonni eccetera (che erano
animali acquatici) consideravano,
giustamente, che era vero l'inverso :
il « bene » era stare con la testa
sottacqua, perché nell'aria i loro
figli sarebbero rapidamente morti.
Sempre, nel corso della storia, i
vari gruppi umani hanno definito il
« bene » e il « male », il lecito e
l'illecito in base al loro conresto,
in continua evoluzione. Al di là
delle morali (sempre transitorie)
l'importante era di essere in
equilibrio con l'ambiente, fornendo
la risposta giusta per restare in
vita e riprodursi. Col tempo ciò ha
dato origine a certi simboli e valori
(o disvalori) che sono altrettanti
semafori per indicare quello che è
bene fare (oppure no) per sé e per il
gruppo. Basti pensare ai valori,
lutti di sopravvivenza, che sono
collegati con i più antichi
comportamenti, come la fuga e la
lotta (coraggio, viltà, egoismo,
nerezza, astuzia, forza, debolezza,
resistenza, patriottismo ecc.) oppure
ai tabù sessuali per la conservazione
del seme nella discendenza
(verginità, fedeltà, gelosia,
fertilità) o alle tecniche per
sopravvivere meglio (trappole, armi,
medicine, invenzioni di ogni genere).
Attraverso i tempi vi è stato un
trasferimento sempre crescente
dall'individuo al gruppo delle
strategie di sopravvivenza, dando
così nascita a certe « regole »
progressivamente elaborate in leggi,
in morali, in modelli sociali, che
sono in pratica altrettante «
risposte » al problema fondamentale
della conservazione propria e della
specie. Ecco quindi che, riscoprendo
la sopravvivenza come valore di base,
diventa anche possibile trovare una
chiave adatta per interpretare i
problemi posti oggi dalla società
moderna. Capire a fondo questa regola
essenziale significa ritrovare
una « stella polare » che permetta di
valutare i cambiamenti, individuando
quelli necessari e quelli pericolosi;
significa poter regolare la nostra
navigazione, adottando nuovi « valori
» e gettando via senza rimpianti i
vecchi. Proprio per questo nessuna
dottrina, o morale, o politica, può
dire una volta per tutte ciò che è «
bene » fare o non fare. Non si può
tracciare una rotta per lo Stretto di
Messina che sia valida anche per la
scogliera del Mar dei Coralli. Oggi
la tecnologia sta portando tali e
tanti cambiamenti nel nostro mondo
sociale, morale, economico,
filosofico, politico e mentale, che è
necessario inventare di volta in
volta le soluzioni adatte, altrimenti
si rischia il naufragio. L'importante
è avere sufficiente immaginazione per
adattarsi continuamente ai tempi,
senza chiedersi se ciò è in armonia
oppure in contrasto con regole che
valevano nel paleozoico tecnologico.
Questo richiede, naturalmente, una
profonda revisione di certe vecchie
idee sull'uomo e sul mondo, che ci
portiamo dietro come risultato di una
lunga serie di condizionamenti
educativi. Richiede cioè una «
rielaborazione » costante delle
nostre schede mentali, con nuovi «
agganci » permessi dalle nuove
conoscenze. Il « bene », insomma, non
è tenere la testa sopra o sotto
l'acqua, ma non asfissiare. La
socialità come egoismo Guardando
agire gli uomini attraverso questa
lente di ingrandimento, è facile
scorgere i « fili » del loro
comportamento quotidiano. Ed è anche
facile scorgere il continuo «
negoziato » tra la sopravvivenza
propria e quella del gruppo cui si
appartiene, cioè tra « egoismo » e «
socialità ». La contraddizione tra
conservazione propria e della specie
in realtà è solo apparente, poiché si
tratta, in fondo, della stessa spinta
a sopravvivere che si presenta sotto
aspetti diversi.
Un essere pravvive gra;
e so- Una popolazione cellulare
sopravvi i egoi- •• socialilà ». Ogni
cellula concorre
grazie alla nantenere la ogni singola
egoismo più
Si potrebbe, infatti, dire che nelle
società è avvenuto un processo
analogo a quello che si verifica
nelle cellule di un organismo. Per
esempio un paramecio, organismo
unicellulare che vive autonomamente,
deve basare la sua « morale »
sull'egoismo: sopravvive solo se
riesce a vincere la sua battaglia
quotidiana di sopravvivenza singola.
Invece una cellula che fa parte di
una popolazione cellulare (per
esempio un tessuto) vive soltanto
grazie all'aiuto reciproco delle
cellule vicine (o anche di quelle
lontane). La natura ci offre in
proposito molti esempi illuminanti
come quello delle spugne dove una
società composta da microorganismi «
individuali » fa circolare al suo
interno le sostanze nutritive grazie
a una solidarietà istintiva.
Analogamente, l'uomo delle caverne
doveva essere « egoista », vivendo
isolatamente: però, una volta
scoperta e adottata la tecnica della
caccia in gruppo con altri uomini,
doveva diventare « altruista », cioè
accettare il principio della
spartizione del bottino e dell'aiuto
reciproco.
Per sopravvivere meglio, in una
collettività diventa cioè più
redditizio ricorrere all'altruismo
che all'egoismo. La socialità,
insomma, più che un « buon sentimento
», è in realtà una diversa e più
efficace forma di egoismo. Ciò è vero
ancora oggi, naturalmente; in una
scala molto più vasta. Talmente vasta
che se ne perdono i contorni e si
finisce per non più « sentire »
questa solidarietà, senza la quale il
sistema funziona male e si ammala.
L'« egoismo di gruppo » funziona
ancora bene quando gli interessi sono
ben visibili o fortemente emotivi
(interessi corporativi, o di classe,
o di squadra, o di partito); ma non
quando richiede uno sforzo di
immaginazione, un'astrazione mentale.
E qui entriamo in pieno nei problemi
del nostro tempo, con una chiave che
ci permette di diagnosticare meglio
molti dei nostri mali sociali. Il
modo di vivere attuale, infatti,
accentua questo senso di distacco dal
gruppo. La vita in città ne è
l'esempio tipico : l'isolamento
psicologico dell'individuo, la
sensazione di vivere in mezzo ad
estranei fa risorgere per contrappeso
l'egoismo individuale. Si torna al
riflesso di difesa dell'organismo
unicellulare. La classe politica deve
rendersi conto che disegnare una
città, un ambiente di lavoro, un
sistema di trasporti o di servizi,
significa fare un'operazione analoga
a quella che svolgono gli psico-
biologi quando disegnano speciali
gabbie per studiare il comportamento
dei topolini : essi possono costruire
gabbie per farli diventare
aggressivi, o apatici, o
intelligenti, o omosessuali, o
criminali, oppure per farli vivere in
equilibrio con l'ambiente.
Personalmente penso che sia
necessario in avvenire un ritorno al
« villaggio », inteso in senso
moderno: è, cioè, necessario tornare
verso forme di organizzazione di vita
in cui la solidarietà di gruppo possa
di nuovo emergere. Questo richiede
naturalmente un diverso modo di
costruire le città, di
ubicare i posti di lavoro, di
organizzare i quartieri, e mostra
quanto siano importanti le
attrezzature collettive, che vanno
dal verde pubblico agli impianti
sportivi, dai centri culturali
all'idea stessa della piazza, oggi
sparita nel nuovo modo di costruire.
Quello della città è solo un esempio,
perché un discorso analogo vale per
il lavoro, per il tempo libero, per
la stessa abitazione : si possono
disegnare « situazioni » in cui
l'individuo può reagire in un certo
modo, oppure altre « situazioni » in
cui reagisce in modo contrario. È
ingenuo chiedere all'uomo di oggi (o
di ieri) di essere « altruista »
quando i « fili » biologici mossi
dall'ambiente lo fanno comportare
automaticamente in modo « egoista ».
L'antica idea della « libertà »
individuale di scegliere in modo
autonomo il proprio comportamento (la
libera scelta di essere « buoni » o
« cattivi ») crea anche qui una
contraddizione che è necessario
superare al più presto, attraverso
una politica adeguata che tenga conto
di tutto quello che lo studio dei
meccanismi cerebrali permette oggi di
capire. / valori di gruppo Quale
insegnamento di fondo possiamo
intanto trarre? Soprattutto, direi,
che occorre creare non solo le «
situazioni » ma anche i «
condizionamenti » adatti a sviluppare
i valori di gruppo se si vogliono
risvegliare i meccanismi di
sopravvivenza della specie. Infatti,
come un organismo non può funzionare
se manca quel sistema di « induzione
» che porta ogni cellula a
comportarsi in modo adatto al
mantenimento della struttura
d'insieme, così nelle società umane
di vaste dimensioni è necessario
trovare i meccanismi psicologici
giusti, se si vuoi sviluppare la
socialità. Naturalmente, è un
obiettivo che si può raggiungere con
più facilità attraverso un amalgama a
forte colorazione ideologica; un
modello « chiuso », dogmatico, si
presta assai meglio di uno « aperto »
nel dare un senso corale all'azione
collettiva, riesce assai meglio e più
rapidamente a far identificare
l'individuo con la specie. È quindi
probabile che, sotto la spinta degli
avvenimenti si giunga in avvenire a
società-alveare, in cui regna
l'ordine totale, almeno in apparenza,
e in cui l'individuo diventa un'ape
laboriosa (e magari felice) che
svolge il suo lavoro senza conoscere
il dubbio, la critica, l'originalità.
Ma proprio per questo si tratta di
tipi di società incapaci di creare al
loro interno quegli « anticorpi »
culturali e politici adatti a
correggere continuamente gli errori
di rotta; si tratta, cioè, di modelli
incapaci di sollecitare e accogliere
quelle « mutazioni » intellettuali
che garantiscono la continua
diversificazione e quindi la
possibilità d'adattamento. Dal canto
suo, un modello « aperto », cioè un
modello che istituzionalmente
accoglie il dissenso (e ne fa anzi un
attrezzo politico essenziale) si
trova in difficoltà nel creare, in un
clima individualista, un'autentica
solidarietà collettiva. Ma, in un
certo senso, è condannato a riuscire,
oppure è destinato a scomparire. Il
mondo attuale, infatti (grazie
soprattutto alla tecnologia che ha
reso possibile lo sviluppo economico,
educativo e sociale) tende verso
certe parità che noi chiamiamo, con
un po' di enfasi, uguaglianza,
democrazia, giustizia. Tutto ciò, per
funzionare bene, esige che le regole
del gioco siano rispettate, e che
vengano sviluppati al massimo certi
« principi » suscettibili di
aumentare la coesione e la
solidarietà del gruppo. Perché questa
operazione abbia successo, una
società moderna deve porsi come
obiettivo prioritario la più larga
diffusione, nel tessuto sociale, di
quei valori di gruppo capaci di
assicurare la sopravvivenza.
Cominciando, naturalmente ad agire
attraverso l'educazione, la famiglia,
la scuola, l'informazione. Credo, per
esempio, che valori come il rispetto
dei diritti
altrui, la lealtà, la tolleranza, la
comprensione, la non acccttazione dei
soprusi, il coraggio civile,
l'abitudine a mettersi nei panni
degli altri, l'apertura mentale,
diventeranno valori sempre più
necessari, per una società che voglia
sopravvivere decentemente. Purtroppo,
sia nella scuola sia nell'ambito
familiare non si tiene
sufficientemente conto di questa
prospettiva. La scuola, in
particolare, istruisce ma non educa:
come si può pretendere di avere
cittadini di serie « A » se non si fa
quasi nulla nel campo dell'educazione
civile, nella formazione del
carattere, nel rispetto del prossimo
e di se stessi? Non basta certo
leggere sui libri di storia l'esempio
di forza d'animo e di onestà: occorre
trasferire nel comportamento
quotidiano certi principi educativi,
cominciando a viverli nella stessa
comunità scolastica in cui si opera,
ed esigendolo poi nella vita sociale
e soprattutto in quella pubblica. La
vera rivoluzione politica, per le
società che vogliano adottare il
modello « aperto », passa
necessariamente attraverso questa
strettoia; essa significa, in
pratica, il tramonto di molti
privilegi, a cominciare da quelli del
potere. Quello della « moralità
pubblica » è un valore di base senza
il quale non si può giungere al
consenso e all'adesione (e quindi
alla socialità). È una chiave di
volta sempre più evidente del sistema
democratico: senza di essa (cioè
senza lottare seriamente contro i
privilegi, i favoritismi, i
nepotismi, la corruzione, il
sottogoverno) non è possibile
sviluppare il senso sociale e
permettere un buon funzionamento del
meccanismo d'insieme. Non si può
chiedere l'adesione e la solidarietà
quando l'esempio pubblico non
corrisponde al modello proposto. Ciò
è possibile in una società
sottosviluppata mentalmente, o
autoritaria, ma non in una società
avanzata: a un certo stadio infatti
emergono inevitabilmente meccanismi
autoregolatori che modificano le
situazioni. O le sostituiscono. Oggi
è divenuto necessario ripensare a
fondo i nostri modelli di sviluppo
politico, sociale ed economico. Siamo
giunti, in un certo senso, alla fine
del neolitico e dobbiamo avviarci
verso il post-capitalismo e il post-
marxismo per trovare le soluzioni
adatte alle nuove esigenze evolutive.
/ meccanismi dell'utopia Quando si
discute di modelli sociali o politici
futuri più o meno utopistici (e mi
riferisco qui anche al discorso fatto
in precedenza sulle « stratificazioni
» mentali e sulle « cor-vées ») si ha
tendenza a non tener conto delle
velocità esponenziali dello sviluppo.
Poniamoci però una domanda semplice :
in questa spirale che coinvolge la
tecnologia, l'economia, l'industria,
la filosofia, la morale, può davvero
la politica continuare a procedere
per conto suo? È pensabile che i
modelli politici proseguano a
viaggiare in bicicletta mentre il
mondo viaggia sulle astronavi? Lo
studio dei sistemi viventi e degli
ecosistemi rivela meccanismi di
retroazione automatici che
intervengono inesorabilmente e che
sono indifferenti a qualsiasi nostro
giudizio, dottrina o dogma.
Analogamente lo studio del
comportamento umano mostra che l'uomo
non è né « buono » né « cattivo », né
egoista, né altruista: semplicemente
si comporta a seconda delle esigenze
ambientali, in particolare quelle di
sopravvivenza. Qualsiasi tipo di
società (anche la nostra per i
posteri...) può essere considerata
utopistica se mancano le condizioni
adatte per poterla realizzare. Quando
invece tali condizioni esistono, i
cambiamenti sociali e politici
possono intervenire quasi
automaticamente. Ebbene, noi oggi
vediamo già chiaramente almeno tre
curve di sviluppo che ci allontanano
gradualmente dai modelli attuali per
condurci verso altri modelli che oggi
consideriamo utopistici. Da un lato
vi è lo sviluppo tecnologico che
comporta l'au-
mento della produttività (con la
possibilità di produrre un oggetto in
un tempo sempre più breve e con
fatica sempre minore). D'altro canto
vi è lo sviluppo mentale che creerà
una crescente parità educativa (già
oggi in alcuni paesi la scuola
dell'obbligo si estende fino a sedici
anni e si estenderà ancor più in
avvenire); questo porterà come
probabile conseguenza a individui
capaci di « secernere » una classe
dirigente diversa da quella attuale,
e capaci anche di accettare nuovi
modelli sociali basati più sul
cervello che sul « ventre ». Queste
due forme di sviluppo (tecnologico e
mentale) costituiscono già le
premesse di una tendenza
profondamente innovatrice. Ma a
questi due fattori se ne aggiunge un
terzo, altrettanto importante: le
trasformazioni dello sviluppo
industriale che chiederanno, anzi
esigeranno, comportamenti sociali
molto differenti da quelli odierni.
Queste tre forze spingono verso un
tipo di società inevitabilmente
diversa, che dovrà fare i conti con
l'affollamento crescente del pianeta,
con l'esaurirsi delle materie prime,
con la scarsità del cibo, con
l'aumento degli inquinamenti e con
gli immensi problemi del Terzo Mondo.
La prossima società, quindi, potrà
essere solo intelligente e
ugualitaria, oppure dovrà essere
estremamente violenta. Gli uomini e i
gruppi sociali, in altre parole, non
hanno la libertà di scegliere in
astratto i modelli di comportamento,
ma « secernono » quelli resi
possibili, o necessari, dalle
condizioni ambientali (e mentali) del
momento. Qualunque modello può essere
un'utopia o una realtà a seconda
delle circostanze. Se, per esempio,
proponete a una donna di
cinquant'anni di salire lungo una
grondaia dal secondo al terzo piano,
vi chiederà se siete matti : ma se
questa signora (che io ho conosciuto)
si trova in mezzo all'incendio dei
Grandi Magazzini di Bruxelles, per
salvarsi si arrampicherà
effettivamente lungo la grondaia. I
comportamenti degli individui in
certe circostanze sono
guidati da potenti impulsi di
sopravvivenza. Oggi questa regola
sembra attutita, perché non siamo
ancora fisicamente di fronte ai
pericoli: occorrerebbe
un'immaginazione che le nostre
società non posseggono ancora, per «
simulare » mentalmente le situazioni
che si stanno creando e porvi rimedio
prima che si presentino all'ultimo
momento davanti ai nostri occhi.
Proprio per questo, forse, non si
farà più in tempo a modificare le
cose, e, non avendo preso
tempestivamente le ne-cessarie misure
antincendio o cercato di spegnere
subito le fiamme, sarà forse troppo
tardi persino per arrampicarsi sulla
grondaia. Ma se riusciremo a
sviluppare un modello sociale
possibile, compatibile con le
esigenze, e rispondente allo sviluppo
armonioso di tutta la collettività,
sarà probabilmente verso società
frugali, sviluppate tecnologicamente
(e soprattutto mentalmente) che
dovremo dirigerci. E in tal caso
penso che la vera utopia sia di
credere che la gente, in quelle
condizioni, accetterà ancora le
attuali « stratificazioni ». Frutti e
veleni Eccoci giunti al termine di
questo viaggio fantastico e
inquietante attraverso la mente del
bambino, dalle origini co-smiche del
suo cervello fino alla sfida
intellettuale del futuro. È stato,
credo, necessario allargare in questo
modo il discorso, perché ogni bambino
che nasce è sospeso tra passato e
avvenire : porta dentro di sé tutta
la storia della vita e del cosmo, ed
è, al tempo stesso, proiettato a
velocità crescente verso un mondo
nuovo, per il quale deve sviluppare
gli adattamenti necessari. Nascendo,
il bambino ha tre miliardi di anni
dal punto di vista genetico e zero
anni dal punto di vista culturale.
Lo straordinario di questa situazione
è che, mentre le memorie genetiche
(gli istinti) hanno richiesto tutta
la storia della vita sulla terra per
codificarsi nei cromosomi, le memorie
acquisite (la cultura) vengono tutte
accumulate nell'arco di una sola
vita. Cioè nel corso della sua
esistenza un uomo può immagazzinare
tutte le esperienze culturali delle
generazioni precedenti. È un po' come
se un'antilope, ha detto giustamente
B.F. Skinner, guardando una giraffa
potesse pian piano diventare come
lei. È appunto quello che avviene
nello sviluppo mentale del bambino.
Guardandosi intorno egli si modella
sull'ambiente che lo circonda: può
diventare un intellettuale o un
bambino-lupo, può essere trasformato
dalle parole, dalla cultura, dalla
tenerezza, dai racconti, dai cibi,
dai sorrisi, dall'intelligenza di chi
gli sta vicino. Per questa ragione
l'educazione è un « insieme » di
tanti elementi che si rafforzano a
vicenda (affetti, apprendimento,
socialità, amore, linguaggio) e che,
per pennellate successive,
contribuiscono a fare emergere il
ritratto di un bambino. Questa
educazione, naturalmente, viene
recepita in modo sempre diverso,
perché ogni bambino possiede
un'identità biologica diversa:
l'educazione deve essere quindi
personalizzata, un genitore deve
tentare di « incontrare » il proprio
figlio cercando i tasti giusti,
creando un ambiente psicologico a sua
misura (esiste sempre la maniera
giusta, se si ha la pazienza e la
fantasia per trovarla), in modo che
la sua personalità genetica possa
esprimersi convenientemente. Questa
personalità genetica non deve però
essere scambiata per un « se stesso
», un « io » ancora inespresso ma già
esistente che il bambino deve poter
esprimere « liberamente ». Sarebbe
un'ingenuità crederlo, poiché il
neonato non contiene nulla, è una
pagina bianca, una pellicola vergine
sulla quale può essere impressa
qualsiasi cosa. Egli ha
biologicamente bisogno di
condizionamenti ambientali per poter
nascere
mentalmente, altrimenti non potrebbe
esistere come essere pensante.
L'importante (soprattutto oggi) è che
fra i condizionamenti venga inserito
anche il riflesso condizionato
dell'immaginazione : un bambino,
cioè, deve essere « condizionato » a
immaginare, a rielaborare le sue
idee, per « montare » strutture
mentali sempre nuove, adatte ai
continui cambiamenti dell'ambiente.
Questa capacità di riadattarsi
continuamente è la sola qualità che
permetterà agli uomini di domani (ma
anche a quelli di oggi) di
sopravvivere mentalmente (e forse
tìsicamente) in un mondo in
evoluzione sempre più rapida : ma ciò
sarà possibile soltanto se sin d'ora
si prenderà coscienza di questi
problemi, problemi che sono diventati
immensi, e sempre meno risolvibili.
Purtroppo, guardandoci intorno, ci
rendiamo conto che esiste oggi uno
scoraggiante ritardo culturale, tale
da compromettere gravemente
l'avvenire dei nostri figli. Essere
un uomo colto oggi, molto più che in
passato, vuoi dire essere un uomo del
proprio tempo, con lo sguardo puntato
verso l'avvenire : non si può più
fare dell'archeologia culturale (come
si continua a fare), se prima non si
è capito profondamente il messaggio
del futuro. Ciò può essere scomodo,
perché obbliga a continui
ripensamenti e riconversioni. Ma è
proprio questa la forza dell'uomo
pensante, la qualità che lo distingue
dall'animale; senza questa
rigenerazione culturale l'avvenire
che consegneremo ai nostri figli
rischia di essere soltanto un frutto
avvelenato. Osservato da un'altra
galassia il destino umano può
apparire poca cosa: un breve momento,
tra l'esplosione iniziale e
(probabilmente) quella finale. Ma,
vissuta dall'interno, questa vita è
per noi la cosa più preziosa: è una
fiaccola che dobbiamo cercare di
trasmettere a lungo, di mano in mano,
seguendo un percorso che sembra
addentrarsi sempre più in quella che
è la vera vocazione dell'uomo : la
conoscenza. Ma siamo ancora
all'altezza di questo compito?
Potrebbero piacerti anche
- Bambini indaco: Un dono sconosciuto Sembrano "bambini difficili", ma hanno una marcia in più.Da EverandBambini indaco: Un dono sconosciuto Sembrano "bambini difficili", ma hanno una marcia in più.Nessuna valutazione finora
- I 10 Segreti Dell'arte Del Succ - Steve Allen PDFDocumento1.552 pagineI 10 Segreti Dell'arte Del Succ - Steve Allen PDFcarlo iottiNessuna valutazione finora
- Tre Parole Magiche (Tradotto): La chiave del potere, della pace e dell'abbondanzaDa EverandTre Parole Magiche (Tradotto): La chiave del potere, della pace e dell'abbondanzaNessuna valutazione finora
- IpnosiDocumento28 pagineIpnosiStefano NepiNessuna valutazione finora
- Vita Morte Karma ReincarnazioneDocumento29 pagineVita Morte Karma ReincarnazioneMoffa Antonio LucianoNessuna valutazione finora
- Channeling: Come contattare la propria Guida SpiritualeDa EverandChanneling: Come contattare la propria Guida SpiritualeNessuna valutazione finora
- Incantesimi e rituali di protezione energetica. Scudi energetici e difesa magicaDa EverandIncantesimi e rituali di protezione energetica. Scudi energetici e difesa magicaNessuna valutazione finora
- Significati e Contenuti Della Numerologia e PDFDocumento7 pagineSignificati e Contenuti Della Numerologia e PDFLeman32kNessuna valutazione finora
- La nuova PNL: L'arte di raggiungere i propri obiettivi.Da EverandLa nuova PNL: L'arte di raggiungere i propri obiettivi.Nessuna valutazione finora
- Viaggio nella Gnosi. Una via per ritrovare se stessiDa EverandViaggio nella Gnosi. Una via per ritrovare se stessiNessuna valutazione finora
- Kaushik - La Lunga Notte Dell'AnimaDocumento104 pagineKaushik - La Lunga Notte Dell'AnimaAlessandro LangellaNessuna valutazione finora
- Articoli Algoritmo LifeDocumento7 pagineArticoli Algoritmo LifeGianfranco Martine100% (1)
- Bartlett Richard - La Fisica Dei MiracoliDocumento293 pagineBartlett Richard - La Fisica Dei Miracoliwanto70Nessuna valutazione finora
- Farfalle CelestiDocumento258 pagineFarfalle CelestiFrancoNosedaNessuna valutazione finora
- Istologia 12 - Ipofisi Ed EpifisiDocumento2 pagineIstologia 12 - Ipofisi Ed EpifisiAnonymous oG0VPL2YNessuna valutazione finora
- Riprogrammare Il SubconscioDocumento1 paginaRiprogrammare Il SubconscioGiulio MarazzaNessuna valutazione finora
- La profezia che si autoavvera: Come usare le aspettative per ottenere tutto quello che vuoiDa EverandLa profezia che si autoavvera: Come usare le aspettative per ottenere tutto quello che vuoiNessuna valutazione finora
- Bambino InterioreDocumento4 pagineBambino Interiorechiara_pica100% (1)
- Bambini Cristallo: La transizione da Indaco a CristalloDa EverandBambini Cristallo: La transizione da Indaco a CristalloNessuna valutazione finora
- Fondazione KesheDocumento36 pagineFondazione KesheAndrea JarekNessuna valutazione finora
- Al di là dell’anima: Narrazioni ed esperienze medianicheDa EverandAl di là dell’anima: Narrazioni ed esperienze medianicheValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- MayaDocumento14 pagineMayaMiky Survivor Botti100% (1)
- Avventure Fuori Dal Corpo - William BulhmanDocumento111 pagineAvventure Fuori Dal Corpo - William BulhmanthaplayahNessuna valutazione finora
- Parole Magiche 2Documento15 pagineParole Magiche 2MaurizioNessuna valutazione finora
- Capisaldi Della Dottrina Dell'entità 'A'Documento8 pagineCapisaldi Della Dottrina Dell'entità 'A'Giulio Dimaria100% (1)
- Uso clinico del test dello specchio nell'attività diagnostica e prognosticaDa EverandUso clinico del test dello specchio nell'attività diagnostica e prognosticaNessuna valutazione finora
- Treben Maria - Estratto Da La Salute Dalla Farmacia Del Signore - Erbe Svedesi - Storia, Preparazione, IndicazioniDocumento4 pagineTreben Maria - Estratto Da La Salute Dalla Farmacia Del Signore - Erbe Svedesi - Storia, Preparazione, IndicazioniRete Quantica100% (1)
- Arcangelo MirandaDocumento34 pagineArcangelo MirandaLuca Dal SantoNessuna valutazione finora
- Scienzapreghiera PDFDocumento4 pagineScienzapreghiera PDFwaines7100% (1)
- Bambini IndacoDocumento8 pagineBambini Indacoskymate64Nessuna valutazione finora
- Luce - Appunti di viaggio per la tua anima: Per comprendere l'essenza di quello che ti accade e trasformare la tua vita. Guida pratica alla ConsapevolezzaDa EverandLuce - Appunti di viaggio per la tua anima: Per comprendere l'essenza di quello che ti accade e trasformare la tua vita. Guida pratica alla ConsapevolezzaNessuna valutazione finora
- ArcangeliDocumento3 pagineArcangeliMayra BinaNessuna valutazione finora
- Corsi Sereni2Documento14 pagineCorsi Sereni2Adriano PahorNessuna valutazione finora
- (Ebook - ITA - MEDICINA) IPNOSI, Una Introduzione Psicofisiologica PDFDocumento112 pagine(Ebook - ITA - MEDICINA) IPNOSI, Una Introduzione Psicofisiologica PDFAdriano PiantellaNessuna valutazione finora
- La legge di attrazione è rivelata nella BibbiaDa EverandLa legge di attrazione è rivelata nella BibbiaNessuna valutazione finora
- Meditazione Della GratitudineDocumento11 pagineMeditazione Della GratitudineAdriana GabitoNessuna valutazione finora
- Sogna il mondo che vuoi. Vivi il mondo che sogni. Sii il tuo sognoDa EverandSogna il mondo che vuoi. Vivi il mondo che sogni. Sii il tuo sognoNessuna valutazione finora
- Corpo e Coscienza - Crescere in Consapevolezza: Un viaggio nel nostro sistema energeticoDa EverandCorpo e Coscienza - Crescere in Consapevolezza: Un viaggio nel nostro sistema energeticoNessuna valutazione finora
- Il Fattore AladinoDocumento9 pagineIl Fattore AladinoClaudioNessuna valutazione finora
- Il Lavoro Alchemico Salvatore BrizziDocumento50 pagineIl Lavoro Alchemico Salvatore BrizziMarco CasoniNessuna valutazione finora
- Angeli UmaniDocumento3 pagineAngeli UmanistarlighteringNessuna valutazione finora
- 1618799329Documento36 pagine1618799329Angelica McdowellNessuna valutazione finora
- Metodo Bates Coreconcept 3 PDFDocumento54 pagineMetodo Bates Coreconcept 3 PDFalbtrosNessuna valutazione finora
- 06 PrecognizioneDocumento5 pagine06 PrecognizioneAnnamaria Fele Di LorenzoNessuna valutazione finora
- Practitioner in PNL Nuovo Documento Completo Di PresentazioneDocumento5 paginePractitioner in PNL Nuovo Documento Completo Di PresentazioneNocom Roberto MicarelliNessuna valutazione finora
- Nati per essere liberi: Consigli e pratiche per portare armonia in sé e nelle relazioni affettive attraverso il metodo delle costellazioni dell’amoreDa EverandNati per essere liberi: Consigli e pratiche per portare armonia in sé e nelle relazioni affettive attraverso il metodo delle costellazioni dell’amoreNessuna valutazione finora
- My Fullness - 13 Storie (quasi miracolose): Trasformazioni straordinarie di persone comuniDa EverandMy Fullness - 13 Storie (quasi miracolose): Trasformazioni straordinarie di persone comuniNessuna valutazione finora
- StarWire: come vedere con i propri occhi quel debole fascio di luce rosso rubino scuro, che va da stella a stella...Da EverandStarWire: come vedere con i propri occhi quel debole fascio di luce rosso rubino scuro, che va da stella a stella...Nessuna valutazione finora
- Robert Powell La Saggezza PDFDocumento39 pagineRobert Powell La Saggezza PDFrilassati100% (2)
- La tua mano nella Mia: Doni d'Amore degli Angeli per vivere la vita nella gioiaDa EverandLa tua mano nella Mia: Doni d'Amore degli Angeli per vivere la vita nella gioiaNessuna valutazione finora
- Igor SibaldiDocumento5 pagineIgor SibaldiGiorgio MattaNessuna valutazione finora