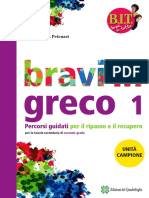Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
An Pa 16-17 PDF
An Pa 16-17 PDF
Caricato da
Giuseppe UcciardelloTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
An Pa 16-17 PDF
An Pa 16-17 PDF
Caricato da
Giuseppe UcciardelloCopyright:
Formati disponibili
P. Oxy. XXXIX 2880 (LIRICA CORALE?
):
NUOVA EDIZIONE E NOTE DI COMMENTO*
1. Il papiro
P. Oxy. XXXIX 2880 (1910.1 Mertens-Pack3; 4373 LDAB) un frammento di rotolo papiraceo (cm 4,3 x 8,7), pubblicato da E. Lobel1, proveniente dalla parte inferiore sinistra di una colonna di scrittura (sopravvivono resti di 11 ll.), utilizzato solo sul lato perfibrale; si preserva parte del vacuo
intercolonnare sinistro (almeno cm 2,5) e il margine inf. (almeno cm 4,1).
La distanza interlineare non supera di solito cm 0,2; interessante notare
che quanto preservato al di sopra di l. 1 uno spazio bianco di ca. cm 0,3:
assai probabile che si tratti di una scelta casuale (dato il carattere informale
della grafia e, nel complesso, dellintera mise en colonne). Non c traccia di
kollesis.
La scrittura una maiuscola informale, corsiveggiante, inclinata leggermente a destra per effetto della velocit del ductus, ricca di numerose legature (ll. 2 a, 6 te), pseudolegature (contatti tra lettere sono presenti in ogni
linea) e di tratti congiuntivi (l. 11 pa); Lobel assegnava il frammento al I d.C.,
senza addurre paralleli; in realt alcuni elementi (il t tolemaico con ampia
svasatura della traversa divisa in due parti e ripiegamento del trattino iniziale
*
Il presente contributo nasce nellmbito di una revisione globale dei fragmenta lyrica
adespota che ho intrapreso da tempo e che ha costituito loggetto della mia dissertazione dottorale (Frammenti di lirica corale adespota: edizione e commento, Diss. Catania 2000). Sono
estremamente grato alla Prof.ssa M. Cannat Fera e a G.B. DAlessio per aver letto queste
pagine e per averle arricchite con suggerimenti e correzioni. Ho ispezionato il frammento sia
direttamente presso le Papyrology Rooms dellAshmolean Museum (ora nella Sackler Library),
sia, in sguito, su riproduzione fotografica e immagine digitale; ringrazio R. Coles per lassistenza prestatami durante il mio soggiorno oxoniense (agosto 2000).
1
In The Oxyrhynchus Papyri, Part XXXIX, London 1972, p.13 e pl. I. Unottima riproduzione digitale del pezzo si trova sul web allindirizzo <http://www.papyrology.ox.ac.uk/
POxy>.
24
GIUSEPPE UCCIARDELLO
sinistro, u in un tempo con verticale convessa a sinistra) trovano addentellati in pezzi in scritture usuali datati dal I a.C. alla prima met ca. del I d.C.;
si cfr. in dettaglio:
i) PSI X 1129, affitto di terreno (24 a.C.)2;
ii) P. Ryl. II 183 (a), quietanza di avvenuta ricezione di foraggio (16
d.C.)3;
iii) P. Ryl. II 119, petizione allexegetes di Alessandria (54-67 d.C.)4;
Questi confronti suggeriscono una possibile assegnazione del pezzo a
cavallo tra I a.C. e I d.C.
Allo stesso copista del testo andranno attribuiti la paragraphos e la coronide finale, la correzione a l. 2 (ndri corretto in ndri con taglio di -ae ripetizione di a)5, lo spirito aspro e laccento acuto di l. 6 (ot[)6. Nessun
caso di iota ascritto accertabile, n abbiamo esempi sicuri del comportamento del copista per elisione/scriptio plena (a meno che a l. 7 ed a l. 11 non
si accolgano rispettivamente le divisiones pe r i d>edr[ e me t> paur[ con elisione rispettata ma non segnalata graficamente). Lelevato grado di corsivit della
scrittura contrasta con il margine inferiore ampio, caratteristico di manoscritti
di lusso: si tratta forse di un esemplare copiato per uso privato dallo stesso
possessore-studioso.
2. Testo
Stampo qui di sguito il testo del frustolo; per comodit si presenta a
sinistra una trascrizione diplomatica, a destra il testo critico:
2
Facs. in Scrivere libri e documenti nel mondo antico. Catalogo della mostra di papiri
della Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze 25 agosto-25 settembre 1998, a cura di G. CAVALLO, E. CRISCI, G. MESSERI, R. PINTAUDI (Pap. Flor. XXX), Firenze 1998, tav. 101.
3
Facs. in R. SEIDER, Palographie der griechischen Papyri, Band II, Tafeln, 2. Teil: Literarische Papyri, Stuttgart 1970, Taf. 16 n 23.
4
Facs. in SEIDER, ibid., Taf. 17 n 25.
5
H. MAEHLER, Literarische Texte unter Ausschlu der christlichen, APF 32 (1986),
p. 84 pensa, sia pur dubitanter, ad un ndrei corretto in -ai, ma lispezione delloriginale
mostra come non vi sia alcuna traccia compatibile con un e sotto il frego orizzontale.
6
Si esclude cos la possibilit di articolare e supplire oteot[e; oteot[w di Page
resta lopzione pi probabile.
P. Oxy. XXXIX 2880 (lirica corale?): nuova edizione e note di commento
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
qelwngar[
andr[[a]]\a/i [
poredamm[
tabroto[
makarei[
outeoiot[
nwma [
megateic[
dedr[
t pedoic[
metepau [
qlwn gr [
ndri p[
pore d> mm[i(n)
ta broto[
makrei[(n)
ote o ot[w()
nwma [
megateic[
ridedr[
ta pedoic[n metepaur[
10
25
10
P. Oxy. 2880 (in Sackler Libr.-Oxonii adservatur): I a.C. - I d.C.
2 [ : h. vert. h. transv. parte sin. coniuncta: p prima facie, sed ga[ secludi non potest || 7 n:
punctum incertum in media l. | [ : punctum summis litt. adaequatum, alterum in fibra detacta: vel i p.q. n (Lobel); tum atr. vix supra l. cum litt. u congruens, postremo litt. triang.: d
possis || 9 d: lineola curvata in summa l. et vest. diffusa (k dispexit Coles, p malui, de
litt. t cogitat DAlessio), tum arcus in summa l. cum litt. rot. congruens, circulus in summa l.
et hastula infra l. quae ad litt. r pertinere possint; postremo h. vert.: i possis || 10 t : arcus in
l.; supra, h. obl. dextr. desc. litt. subseq. coniuncta: a fere certa || 11 [ : atr. punctum ad h.
vert. sub l. pertinens: r pro certo habeo
1-2 dist. Page || 3 pre vel ]/pore Page, qui mm[i(n) suppl.; pre malui propter o (l. 6) || 4
dist. Page || 6 dist. et suppl. Page || 7 de gn ma dubitat Lobel; gnmai (vel gnma) d [ - temptavi || 8 megateic[: mga tec[o, megateic[- Page || 9 to r i (-/]tori, Ek-/]tori inter alia) d
d dr[, per (vel pri) dedr[, per d>dr[am-, perid edr[om- possis || 10 disdr[, sed etiam pe r
tinxi et supplevi || 11 m t > paur[ -, m te paur[ -, -/]me te par[ - inter alia possis
3. Contenuto e attribuzione
3.1. Contenuto
Nella sua stringata, ma, come sempre, lucida ed.pr. E. Lobel parlava di
un frustolo riconducibile a lirica corale, ma non riusciva a stabilire alcuna
relazione tra quanto si leggeva in queste linee e la produzione superstite di
Pindaro, Bacchilide e Simonide7; il frammento stato poi ristampato da Page
(S 459 SLG) e Campbell (frg. 931k).
7
Cos anche le recensioni al volume di Lobel: cfr. W. LUPPE, Gnomon 46 (1974), p.
26
GIUSEPPE UCCIARDELLO
Se si vuole avanzare qualche ipotesi sul contenuto, occorre prima di tutto
considerare a l. 3 pore d > mm[i(n): se consideriamo il verbo come un imperativo, potremmo ricondurre il testo alla sfera innodica o eucologica (cfr. per
pre Pind. Isthm. VII 49 mmi d>, cruv kmv qllwn, pre, Loxa; vd.
anche lutilizzo del Du-Stil a l. 6 ote o ot[?). Altrimenti avremmo un tempo storico (con o senza aumento); in ogni caso almeno le ll. 3-6 dovrebbero
far parte di un discorso diretto verso qualcuno. Un altro elemento rilevante
in questo contesto, che sembra far propendere per la prima alternativa, qlwn
a l. 1; il verbo nellaccezione di volentieri, benevolo ricorre in poesia nei
moduli espressivi della preghiera e risulta frequentemente connesso con un
imperativo: cfr. e.g. Pind. Isthm. VI 42-45
E pot> mn,
Ze pter,
qum qlwn rn koua,
nn e, nn ecai p qepeai
lomai []
Aeschyl. Choe. 19-20
Ze, d me teaqai mron
patr, geno d mmaco qlwn mo8.
A l. 9 la sequenza r i d edr[ offre varie soluzioni di lettura e di integrazione, illustrate in apparato; soffermiamoci su alcune di esse.
In primo luogo occorre subito dire che le tracce superstiti delle prime due lettere non
sono pienamente perspicue, a causa dellabrazione della superficie del papiro che non ha conservato molto: la linea curva alta e una traccia rotondeggiante che sembra chiudersi per formare un piccolo cerchio possono essere ben compatibili con la sequenza to: cfr. per -to- l. 4;
per un caso di o non perfettamente rotondo, ma dal tracciato angoloso, vd. l. 6. Tuttavia le
medesime tracce potrebbero avere unaltra interpretazione: la prima traccia curvilinea potrebbe essere ricondotta ad un p vergato in un solo tratto, in cui la riduzione dei tempi di esecuzione del tratteggio e la corsivit del ductus hanno trasformato la barra orizzontale in un tratto curvo: si tratta di una variante grafica attestata nelle scritture usuali dalla second met del
II a.C.9. La sua assenza nel brandello papiraceo qui in esame (p ricorre solo nella forma con
647 (definisce il frammento un Wartetext); CL. PREAUX, CE 48 (1973), p. 179; O. MONTEVECCHI, Aegyptus 55 (1975), p. 291; P. MERTENS, BO 32 (1975), p. 211.
8
Sul linguaggio delle sezioni eucologiche in poesia vd. in generale S. PULLEYN, Prayer
in Greek Religion, Oxford 1997, pp. 132-155 (in particolare pp. 144-145).
9
Sullevoluzione del tratteggio nelle scritture usuali in papiri ed ostraka vd. in dettaglio
P. Oxy. XXXIX 2880 (lirica corale?): nuova edizione e note di commento
27
barra orizzontale: vd. ll. 2.3[?].10.11) non dovrebbe, a mio giudizio, indurre ad escludere a
priori questa interpretazione, proprio perch in una scrittura usuale come questa, niente affatto formalizzata, lo scrivente poteva benissimo utilizzare varianti grafiche per il medesimo segno:
si confronti il tratteggio del segno e, che viene realizzato ora con la variante a curve praticamente sovrapposte (l. 11 -me-), ora con quella, deformante, ad un solo tempo di esecuzione (l. 6 -oute-), in legatura con la lettera precedente, per cui il calamo non viene affatto sollevato. Quanto alla seconda lettera, la traccia rotondeggiante alta potrebbe essere la curva superiore di un e che chiude a cupola sulla estremit della barra mediana, rappresentata dalla traccia sottostante, quasi obliqua rispetto alla curvatura del tratto10.
Se accogliamo la lettura to r i dedr[, abbiamo un ventaglio di possibilit
ampie, inclusa anche lintegrazione Ek-/]to r i con cui potremmo ricondurre tutto il frustolo ad una scena di argomento epico.
Ma anche con peridedr[ le possibilit sono numerose:
a) si potrebbe integrare la tessera omerica per d dr[at: drat attestato solo in Omero11, in un brano relativo alla costruzione della pira funeraria per Patroclo: Hom. Il. XXIII 167-169
k d> ra pntwn
dhmn ln kluye nkun megqumo >Acille
pda k kefal, per d drat mata nei
b) la sequenza potrebbe essere interpretata come una forma del perfetto
periddroma duso esclusivamente poetico (rispetto al prosastico dedrmhka),
attestato per solo a partire dallepoca ellenistica (in Call. Ai. frg. 66, 6 Pf. =
Massimilla; Apoll.Rh. III 676; Nic. Ther. 503. 631; Or. Syb. I 140; Dion. Per.
41; Man. II 298, III 338; Q. S. XII 556; Nonn. Dion. I 345, II 187, VII 345,
XXVIII 65.220, XXIX 5, XXX 268, XXXI 2, XXXVII 70.523, XLI 283,
XLII 55, XLV 37; Paraphr. Ioh. IX 184; AP IX 437, 5 = Theocr.[?] Epigr.
IV 5). Tra le varie occorrenze segnalo Nonn. Dion. XXXVII 70, un verso sulla
fiamma che si accende con difficolt, allinterno della descrizione dellenorme
pira costruita dai servitori di Dioniso, su cui avvengono sacrifici umani ed
animali:
o d purn fqimnou periddromen ptmenon pr
P. DEGNI, La scrittura corsiva greca nei papiri e negli ostraca greco-egizi (IV secolo a.C.-III d.C.),
Scr. e Civ. 20 (1996), pp. 21-88 (in particolare pp. 58-59).
10
La traccia, ben visibile sulloriginale con un forte ingrandimento, pu essere scorta
anche sulla riproduzione digitale disponibile on line (vd. n. 1).
11
Altrove ricorre solo la forma dart: cfr. Choer. Sam. frg. 4, 5 SH ppwn dart prwp>
e vd. Lexicon des frhgriechischen Epos, II, Gttingen 1991, col. 222.
28
GIUSEPPE UCCIARDELLO
Entrambe le possibili integrazioni acquistano maggiore plausibilit se
si considera l. 8, in cui si pu leggere (con Page) mga tec[o; tra i significati del termine interessante notare luso, a quanto pare unicamente pindarico, di pira funeraria: Pind. Pyth. III 38-39
ll> pe tecei qan n xulnJ
ggonoi koran, la mfdramen
lbron <Afatou
in questultimo passo va notato12 anche luso di mfdramen con un significato (correva dintorno la vampa rapace di Efesto)13 pressoch analogo a quello di periddromen in Nonn. Dion. XXXVII 70 (corre intorno): lintero brano quasi una riscrittura di Hom. Il. XXIII 192-225, ma, sebbene in questo
canto dedicato ai giochi per Ofelte Nonno si accosti al modello omerico (lintero canto XXIII dellIliade) con una fedelt forse mai manifestata altrove14,
non va esclusa lipotesi che qui sia anche presente una sfumata memoria del
luogo pindarico15.
3.2. Lingua e stile
Gli elementi di lingua sono decisamente interessanti:
i) accentazione non dorica: cfr. l. 6 ot[w(); in Alcmane, Stesicoro e
Ibico avremmo avuto ot16;
12
Ringrazio la Prof.ssa M. Cannat Fera per aver richiamato la mia attenzione sullintegrazione periddr[om- e sul suo rapporto col passo pindarico.
13
La traduzione di B. GENTILI in Pindaro. Le Pitiche, a cura di B. GENTILI, P. ANGELI
BERNARDINI, E. CINGANO e P. GIANNINI, Milano 1995, p. 93.
14
Analisi dettagliata del canto in H. FRANGOULIS, Nonnos transposant Homre. tude
du chant 37 des Dionysiaques de Nonnos de Panopolis, RPh 69 (1995), pp. 145-168 (materiali ripresi in Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques. Tome XIII: Chant XXXVII, Texte tabli et Traduit par H. FRANGOULIS, Paris 2003). Utili osservazioni anche in Nonno di Panopoli.
Le Dionisiache (Canti XXV-XXXIX), III, Introduzione, Traduzione e Commento a cura di
G. AGOSTI, Milano 2004, pp. 669 ss.
15
Nella sua edizione di Nonno, la FRANGOULIS (ibid. p. 113), cita solo Hom. Il. XXIII
192 od pur Patrklou kaeto teqnhto.
16
Cfr. P. Oxy. XXXV 2735, frg. 1, 6 (= Ibyc. [?], frg. S 166, 6 PMGF) p[a]nt; 27 (=
Ibyc. [?], frg. S 166, 27 PMGF) out. Vd. sul problema M. GARCA TEIJEIRO, Vestigios de acentuacin dialectal en textos dricos y elicos, in Dialectologica Graeca: Actas del II Coloquio
Internacional de Dialectologa griega, edd. E. CRESPO, J.L. GARCA RAMN, A. STRIANO, Madrid
1993, pp. 147-65 ed ora G. UCCIARDELLO, Sulla tradizione del testo di Ibico, in Lirica e Teatro
in Grecia. Il Testo e la sua ricezione (Atti del II Incontro di Studi, Perugia 23-24 gennaio 2003),
a cura di S. GRANDOLINI, Napoli 2005, pp. 48-53.
P. Oxy. XXXIX 2880 (lirica corale?): nuova edizione e note di commento
29
ii) dialetto:
(a) l. 3 mm[i(n) e le correlate forme eoliche con nasale geminata non compaiono quasi mai nella paradosi di Alcmane, Stesicoro, Ibico17; Pindaro lautore con maggiori occorrenze18; isolato mmi in Bacch. Dith. XVII 25; nessun
caso apparente in Simonide, se non forse in frg. 542, 26 PMG dove, al posto
del corrotto peiq> mn (per la responsione occorre un trocheo), si proposto p t> mmin (Schneidewin, Bergk)19. Le forme geminate tornano poi nel
corpus bucolico20.
(b) a l. 10 pedoic[ probabilmente una forma di pedoicnw, attestato
solo in Bacch. XVI 9 nqea pedoicnen; le forme dorico-eoliche in peda- sono
le uniche attestate per Alcmane (in trad. diretta cfr. frr. 1, 58; 3, 8; 5, frg. 2,
ii, 10 PMGF; in trad. indiretta vd. frr. 17, 5 e [forse] 19, 5 PMGF), Stesicoro
(frr. S 109, 3 PMGF = P. Oxy. 2619, frg. 21, 321; 222a, frg. 41, 3 = P. Oxy. 3876,
frg. 41, 3 ] ped [?22) Ibico (frr. 282, 46 e 321, 3 [congettura] PMGF);
17
Vd. M. NTHIGER, Die Sprache des Stesichorus und des Ibycus, Zrich 1971, pp. 39
ss.; G. HINGE, Die Sprache Alkmans. Textgeschichte und Sprachgeschichte, rhus 2001 (versione on-line allindirizzo <www.georgehinge.com>), pp. 314-316. Lunico esempio certo in
tradizione papiracea di mmi in P. Lille 76a ii + 73 i 26 (= Stes. frg. 222b, 226 PMGF).
18
Elenco in NTHIGER, Die Sprache (cit. n. 17), p. 40. possibile che le scelte siano
dettate da motivi metrici; per gli eolismi pindarici cfr. C. VERDIER, Les olismes non-piques
de la langue de Pindare, Innsbruck 1972 e soprattutto la recente trattazione di A.C. CASSIO,
I dialetti eolici e la lingua della lirica corale, in Dialetti e lingue letterarie nella Grecia arcaica.
Atti della IV Giornata ghisleriana di Filologia classica (Pavia, 1-2 aprile 2004), a cura di F.
BERTOLINI e F. GASTI, Pavia 2005, pp. 13-44.
19
Diehl, Page e Gentili, tra gli altri, correggono in mn, correzione che O. POLTERA, Le
langage de Simonide, Basel 1997, pp. 525-526 rifiuta, perch non attestata nella paradosi dei
lirici; lo studioso svizzero propende per mmin. Ma si potrebbe anche emendare nellenclitica
dorica e ionica min attestata nei grammatici ed in autori dorici (Ap. Dysc. de pron. p. 96, 2123 [per lo ionico] e ibid. 97, 28 Schneider [per la forma dorica, con citazione di Sophr. frg. 87
K.-A.]), ben compatibili con un autore di base dorica, ma con diversi tratti ionici come Simonide; su queste forme enclitiche attestate dai grammatici e non sempre considerate con la dovuta attenzione da parte degli editori moderni cfr. J. VENDRYES, Trait dAccentuation grecque,
Paris 1945, pp. 96-97 con le testimonianze antiche, ed ora, in dettaglio, S. KACZKO, mn, min,
min da Omero a Sofocle: problemi linguistici e editoriali, RFIC 130 (2002), pp. 257-298 (che
promette una trattazione dettagliata dei pronomi personali delle declinazioni in -a ed in-o).
20
Vd. M.T. MOLINOS TEJADA, Los dorismos del Corpus Bucolicorum, Amsterdam 1990,
pp. 141-149.
21
Su questa base lo stesso Lobel corresse a Stes. frg. 210 PMGF (ex Aristoph. Pax 775)
met in ped: vd. in proposito NTHIGER, Die Sprache (cit. n. 17), pp. 52-53 ed ora anche
G. SCHADE, Stesichoros, Papyrus Oxyrhynchus 2359, 3876, 1619, 2803 (Mnemosyne Supplement
237), Leiden-Boston-Kln 2003, p. 210.
22
In questo frg. la presenza di ped non certa, a causa della frammentariet dellin-
30
GIUSEPPE UCCIARDELLO
Simonide e Bacchilide hanno sempre met (tranne il gi menzionato Bacch.
XVI 9 pedoicnen)23. La paradosi di Pindaro offre quasi sempre met; i pochi
casi in cui ha ped sono assai interessanti; fra essi vanno notate le occorrenze
con prefissi verbali: Ol. XII 12 pedmeiyan; Nem. X 61 pedaugzwn; Nem.
VII 74 pedrcetai; pae. IV 37 pedcei[n; frg. 25 pdoiko; frg. 26 ped tma;
frg. 27 pedacen M24.
iii) a l. 11 la sequenza metepaur[ offre tre articolazioni:
a) met>paur[ con elisione non segnata (vel mete paur[), con cui abbiamo la congiunzione mta (oppure mte, ma la forma solo in arcadico;
cfr. lomerico mfa in Hom. Il. VIII 508)25, nota da epigrafi di Cirene (cfr.
SEG IX 32. 72. 85)26, Creta (cfr. LexGort IX 48 con la grafia mtt> |)27, Arcadia (IG V/2, 4, 12; IG V/2, 6, 30)28; fra i testi letterari essa attestata solo
in Call. Hymn. V 55; VI 92.111.12829;
sieme; inoltre, la stessa attribuzione a Stesicoro di tutti i frr. del P. Oxy. 3876 non a mio avviso sicura: cfr. il mio contributo Sulla tradizione (cit. n. 16), pp. 22-23. Su questo papiro (ascritto a Stesicoro) vd. anche E. GANGUTIA, Hipotes: de la Odisea a Estescoro en POxy. 3876, Emerita 72 (2004), pp. 1-23 (ma le argomentazioni ricostruttive addotte non mi sembrano molto
convincenti).
23
Ma a proposito di Simonide va detto che tutte le occorrenze sono di tradizione indiretta, in cui potevano anche avvenire fenomeni di normalizzazione di tratti dialettali.
24
Cfr. NTHIGER, Die Sprache(cit. n. 17), pp. 52-53. Gli ultimi tre esempi risultano
assai interessanti perch trditi da Eustazio, nel proemio al commento pindarico (. 21, p. 17,
6-8 Kambylis), in un capitolo in cui si sottolinea proprio limpronta dialettale fortemente eolica di Pindaro: aolzei d t poll, e ka m trib deiin Aolda, ka kat Dwrie d
frzei (ibid., p. 16, 18-19 Kambylis): sul passo si vd. A. KAMBYLIS, Eustathios ber Pindars Epinikiendichtung, Hamburg 1991, pp. 33 ss.; M. NEGRI, Eustazio di Tessalonica. Introduzione al
commentario a Pindaro, Brescia 2000, pp. 105-115. 125 ss.
25
Cfr. C.D. BUCK, The Greek Dialects, Chicago 1955, p. 104.
26
Cfr. F. LONATI, Grammatica delle iscrizioni di Cirene, Firenze 1990, p. 178 e soprattutto C. DOBIAS-LALOU, Le Dialecte des Inscriptions grecques de Cyrne (Karthago 25), Paris
2000, pp. 122.182.189. Sulla etimologia della forma vd. F. BADER, Autour du rflchi anatolien:
tymologies pronominales, BSL 77 (1982), pp. 106-107. 124-127.
27
Vd. M. BILE, Le dialecte crtois ancien. tudes de la langue des inscriptions, Recueil
des inscriptions postrieures aux IC (tudes Crtoises 27), Paris 1988, pp. 216.262.298.
28
Vd. L. DUBOIS, Recherches sur le dialecte arcadien, Louvain-La-Neuve 1986, I, p. 232;
II, pp. 34-36. 39-48 (ristampa delle epigrafi in questione).
29
La tradizione manoscritta callimachea (cfr. R. PFEIFFER, Callimachus, II, Oxonii 1953,
Praef. LV-XCI) ha la forma epica mfa corretta da Pfeiffer (ad loc.) e dai successivi editori in
mta (forma attestata in P. Oxy. 2226 per VI 92.111 e P. Oxy. 2258 a VI 128). A V 55 Pfeiffer
lasci il trdito mfa che A. BULLOCH, Callimachus, The Fifth Hymn, Cambridge 1985, p. 162,
ha corretto in mta, ricordando come una forma analoga potesse isolarsi proprio nel nostro
P. Oxy. XXXIX 2880 (lirica corale?): nuova edizione e note di commento
31
b) -me te paur[ (vel t>paur[ ), con cui potremmo avere una forma dialettale dorica di duplice intelligenza: 1. la desinenza dorica della prima persona plurale dellattivo nota tra i lirici solo in Alcmane e poi ripresa nel dorico di Teocrito e del corpus bucolico30; 2. la forma dorica m/m del pronome personale, variamente attestata in poesia ed in prosa dorica31;
c) -me come terminazione di una forma aggettivale (casi diretti al neutro) o verbale (2 pers. sing. attiva di un tempo storico); in questultimo caso
si tratta ancora di un discorso diretto (come per ll. 3-6)?
Se a) la soluzione corretta, la sequenza paur[ potrebbe rinviare ad una
forma verbale; il candidato pi probabile sembra paurkw32: in considerazione dei passi sopra addotti desunti da Pind. Pyth. III vale la pena ricordare anche ibid. 35-36 (ancora un contesto di morte con limmagine successiva del fuoco)
ka geitnwn
pollo paron, m
d fqaren: polln d> {n} rei pr x n
prmato nqorn twen lan.
3.3. Metrica
La paragraphos, la coronide finale e la mancanza di altri segni interlineari inducono a credere che siamo in presenza di una struttura estesa per almeno 11 linee:
l. 1 + - +- [; l. 2 - + + [; l. 3 + + - [; l. 4 -+ + - [; l. 5 + + - +- [; l. 6 - + + - [;
l. 7 - +- [; l. 8 + + - [; l. 9 +- + - [; l. 10 + + - [; l. 11 - + - [
Maehler riconosce dattili con inizio ascendente o anapesti33; volendo continuare a perseguire uninterpretazione moderna delle sequenze, possibile, e forse ancora pi probabile, uninterpretazione dattilo-epitritica delle
frustolo. Callimaco poteva desumere la forma dal dialetto di Cirene, in cui essa era attestata
(si veda a proposito la nota opinione di C.J. RUIJGH, Le dorien de Thocrite: dialecte cyrnien
dAlexandrie et dgypte, Mnemosyne 37 [1984], p. 60 = Scripta minora ad linguam graecam pertinentia. Edenda curaverunt A. RIJKSBARON, F.M.J. WAANDERS, II, Amsterdam 1996,
p. 409 sulla lingua degli Inni V e VI), ma il fatto che essa si trovi anche in lirica induce ad avanzare lipotesi che la fonte callimachea potesse anche essere letteraria.
30
Cfr. per Alcmane HINGE, Alkmans (cit. n. 17), pp. 328-329; per Teocrito e i bucolici vd. MOLINOS TEJADA, Los dorismos (cit. n. 20), pp. 281-283.
31
Cfr. HINGE, Alkmans (cit. n. 17), p. 316 s.
32
Devo il suggerimento a G.B. DAlessio.
33
Cfr. MAEHLER, Literarische Texte (cit. n. 5), p. 84.
32
GIUSEPPE UCCIARDELLO
stesse34. Tuttavia i confronti vanno istituiti non gi con la colometria moderna di matrice bckhiana, ma con quella antica attestata nei papiri o negli Scholia metrica vetera a Pindaro: cos lattacco in (+ + -) potrebbe prefigurare, tra
laltro, un proodiakn dmetron katlhkton (+ + - - - + + -, cfr. Ol. XII str.
g/; Pyth. I ep. id/), o un proodiakn dmetron katalhktikn (+ + - - - + -, cfr.
Ol. VII ep. ib/) secondo la terminologia antica (nei tre casi si tratta sempre di
contesti la cui moderna interpretazione dattilo-epitritica)35.
3.4. Conclusioni
Ogni considerazione circa il problema attributivo del nostro frammento non pu che fondarsi sullarticolazione che si vuol dare a l. 11. Se la divisio -me te paur[ (vel t>paur[ ) corretta, il pezzo potrebbe essere laconico
o appartenere ad una composizione pi tarda in una lingua letteraria a base
dorica, laddove con mt(a) paur[ abbiamo un dialettismo noto in area dorica e utilizzato da Callimaco (ed anche in questo caso una composizione tarda
che recuperi elementi entrati nella dizione poetica con Callimaco non pu
essere esclusa; se poi a l. 8 accogliamo peridedr[om- abbiamo ancora un elemento attestato a partire dallet ellenistica). In entrambi i casi si tratta di soluzioni che vincolano a rimanere nellmbito della lirica a base dorica e sembrano
quindi escludere la sfera eolica (non presa in esame da Lobel), verso la quale
altri elementi (l. 3 mm[i(n) l. 10 pedoic[) potevano ben indirizzare.
Stando ai dati del papiro, unattribuzione a Simonide, Bacchilide o Pindaro sembra possibile, sia pure con la cautela che comporta avanzare ipotesi di questo tipo basate su un testo cos frammentario; statisticamente parlando,
la presenza di eolismi milita a favore di Pindaro, a cui non sarebbe forse incongrua la forma tipicamente dorica mta (la pi antica attestazione pare essere in LexGort IX 48, met del V sec.), se consideriamo altri particolari dorismi pindarici (come gl-, teqm, tka etc.)36 assenti nella documentazione
34
A giudicare dai numerosi casi di attacchi di cola con d2 [+ + -] in Pindaro: cfr. Ol. VI
ep. 2b; Pyth. III ep. 9; IX str. 1.3, etc.; in Bacch. cfr. I str. 1. In proposito vd. M.L. WEST, Greek
Metre, Oxford 1982, p. 73.
35
Cfr. Scholia metrica vetera in Pindari carmina, edidit A. TESSIER, Leipzig 1989, p. 40
s.v. proodiakn.
36
Vd. in dettaglio O. HOFFMANN-A. DEBRUNNER-A. SCHERER, Storia della lingua greca,
I, trad. it. Napoli 1969, pp. 98-99; R. HIERSCHE, Grundzge der griechischen Sprachgeschichte, Wiesbaden 1970, pp. 140-143. Sui dorismi di Simonide e Bacchilide cfr. HOFFMANNDEBRUNNER-SCHERER, ibid., pp. 94-96; HIERSCHE, ibid., pp. 136-139; NTHIGER, Die Sprache
(cit. n. 17), pp. 86 ss.; R.A. FELSENTHAL, The Language of Greek Choral Lyric: Alcman, Stesichorus, Ibycus and Simonides, Diss. Univ. of Wisconsin-Madison 1980, pp. 127 ss. Naturalmente
P. Oxy. XXXIX 2880 (lirica corale?): nuova edizione e note di commento
33
disponibile di Simonide e Bacchilide. Se poi coglie nel segno anche la possibile ricostruzione di ll. 8-9 con la lettura pe r i d edr[ ed un uso di teco tipicamente pindarico, avremmo un altro elemento che ci indirizza verso il lirico
tebano.
Messina
Giuseppe Ucciardello
non sicuro che tutte le forme sopra citate risalgano a Pindaro e non siano invece dovute
allattivit editoriale alessandrina. Allo stesso modo una forma come mt(a) poteva venire
introdotta nel testo in luogo dellomerico mfa, per meglio caratterizzarne, in senso dorico, la patina dialettale.
Potrebbero piacerti anche
- Bgreco1 Mondo1Documento20 pagineBgreco1 Mondo1pompeyo22Nessuna valutazione finora
- 1 Elementi Di Fonetica Greca1 PDFDocumento7 pagine1 Elementi Di Fonetica Greca1 PDFdferrixxNessuna valutazione finora
- Tabella Tastiera GrecaDocumento2 pagineTabella Tastiera GrecaLeleScieriNessuna valutazione finora
- PapirologiaDocumento71 paginePapirologiaAleNessuna valutazione finora
- Alfabeto Greco e Dittonghi 2Documento3 pagineAlfabeto Greco e Dittonghi 2EdvardvsNessuna valutazione finora
- Test Ortografia e FoneticaDocumento11 pagineTest Ortografia e FoneticaFrancesco GarozzoNessuna valutazione finora
- Tastiera SuperGreekDocumento4 pagineTastiera SuperGreekvitriol71Nessuna valutazione finora
- Grammatica Greca - Con Indice e RingraziamentiDocumento154 pagineGrammatica Greca - Con Indice e RingraziamentiVincenzo SelvaggioNessuna valutazione finora
- 1 Elementi Di Fonetica Greca1Documento7 pagine1 Elementi Di Fonetica Greca1dferrixxNessuna valutazione finora
- 1 Lezione Greco 2023-02 OttobreDocumento6 pagine1 Lezione Greco 2023-02 OttobreErnestoNessuna valutazione finora
- Greco Antico - Segni Diacritici, Regole Dell'Accento, Segni Di InterpunzioneDocumento3 pagineGreco Antico - Segni Diacritici, Regole Dell'Accento, Segni Di InterpunzioneMicheleCondòNessuna valutazione finora