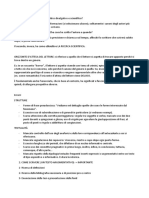Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Rancesco Annino Arco Annino Aniele Aras: Recensioni
Rancesco Annino Arco Annino Aniele Aras: Recensioni
Caricato da
Giulia SarulloTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Rancesco Annino Arco Annino Aniele Aras: Recensioni
Rancesco Annino Arco Annino Aniele Aras: Recensioni
Caricato da
Giulia SarulloCopyright:
Formati disponibili
162
RECENSIONI
con un solo tratto verticale forse per la non trasparenza o la rovina del tratto orizzontale superiore della T. In questo modo avremmo una formula pi coerente per sintassi. Alla fine centodue Tavole di ottima qualit con fotografie, apografi e altri manufatti o materiali archeologici. Sisani in apertura si proponeva di colmare per quanto possibile il vuoto costituito dallassenza, a tuttoggi, di una moderna ricostruzione scientifica, globale ed interdisciplinare, della storia della regione prima e parallelamente allarrivo di Roma. Vi riuscito. Giovanna Rocca
Theodor Mommsen e il Lazio antico. Giornata di Studi in memoria dellillustre storico, epigrafista e giurista (Terracina, Sala Valadier, 3 aprile 2004), a cura di F RANCESCO M ANNINO , M ARCO M ANNINO , DANIELE F. MARAS, Roma, LErma di Bretschneider, 2009, pp. 189.
Tra i numerosi omaggi1 che sono stati offerti a Theodor Mommsen in occasione del centenario della sua morte, avvenuta il 1 novembre 1903, si colloca liniziativa della Societ per la Storia Patria della Provincia di Latina. Per motivi organizzativi, il convegno si svolto il 3 aprile 2004 e ha visto la partecipazione di numerosi studiosi che con i loro interventi hanno contribuito ad analizzare i diversi aspetti della figura di Mommsen, nonch i suoi rapporti con le realt locali e gli sviluppi delle discipline sorte dal lavoro del grande tedesco. Dopo lIntroduzione di Francesco Mannino, il volume degli Atti del Convegno si apre con quattro contributi incentrati sulla figura di Mommsen (Mario Mazza, Mika Kajava, Giuliano Crif, Francesco Mannino), seguiti da un contributo di cerniera (Silvia Orlandi) che introduce ai rapporti tra Mommsen e le comunit locali (Giovanni Pesiri, Massimiliano Di Fazio), per poi concludersi con quattro interventi (Daniele Maras, Pietro Longo, Marco Mannino e Ascanio DAndrea, Claudia Cenci) relativi a studi epigrafici realizzati nella Provincia di Latina. Data lampiezza e la complessit degli argomenti trattati, non sar possibile dedicare in questa sede uno spazio appropriato a tutti i contributi; ci limiteremo dunque a presentare i diversi
Tra gli altri si ricordano: BUONOCORE 2003, ALFLDI 2004, Theodor Mommsen 2004, MARTNEZ-PINNA 2005.
1
RECENSIONI
163
interventi soffermandoci su alcuni spunti che risultano interessanti nel quadro attuale dellepigrafia latina. La prima relazione di Mario Mazza introduce la figura di Mommsen in rapporto allantiquaria italiana nellOttocento accompagnando la trattazione con una ricca notazione bibliografica che ripercorre la letteratura sullargomento dalla met dellOttocento a oggi; dopo aver descritto il quadro dellantiquaria italiana e romana in particolare, Mazza si sofferma sui rapporti tra Bartolomeo Borghesi, erudito sommo maestro di epigrafia e numismatica (p. 13) e il Rasiermesser, come veniva chiamato Mommsen per la sua incisivit nella critica e la sua rapidit di giudizio. Questo aspetto del suo carattere mi ricorda un episodio citato nelle Memorie di F. Barnabei: entrambi ospiti dellAmbasciata germanica a palazzo Caffarelli sul Campidoglio, Mommsen rimprover Barnabei di essere troppo avverso allo Helbig, ma di fronte alla sua veemente risposta (a proposito dellimbarazzo causato da questultimo per gli scavi di Conca) si gir e in tedesco disse alla principessa Von Bulow Il professor Barnabei ha un pochino di ragione, dimostrando cos di andare oltre le amicizie e riconoscere la verit. Alla figura di Mommsen come epigrafista dedicato il saggio di Mika Kajava, che si sofferma sul metodo mommseniano di lavorare a tappeto, instancabilmente e senza sosta (p. 34). Dalla descrizione di Kajava emerge la figura di un uomo devoto al suo lavoro, appassionato ai testi inscritti, che mal tollerava lincuria in cui talvolta venivano conservate le sue preziose epigrafi, e vengono sottolineati gli importanti principi introdotti da Mommsen nello studio epigrafico, come lassoluta necessit dellautopsia. Altri dettagli sulla personalit di Mommsen emergono dai contributi di Giuliano Crif, che, oltre a un doveroso elogio al grande Maestro (p. 45), propone alcuni aneddoti di vita vissuta dello studioso tedesco, e di Francesco Mannino, che tracciandone la biografia restituisce limmagine di un Mommsen nella sua dimensione di uomo, con particolare attenzione alla sua esperienza politica. Il focus ritorna sullepigrafia con il lavoro di Silvia Orlandi, la quale offre unanalisi dei rapporti di Mommsen con la complessa figura di Pirro Ligorio e dei suoi codici. Lautrice si sofferma sul grande valore dellapporto mommseniano allo studio delle opere ligoriane al fine di distinguere le epigrafi vere dai falsi di cui sono disseminati le pagine di Ligorio, sottolineando inoltre come sia merito del Mommsen e dei suoi collaboratori, primo fra tutti Wilhelm Henzen, aver individuato, in alcuni casi, le fonti epigrafiche autentiche da cui Ligorio aveva tratto ispirazione per la confezione dei suoi falsi (p. 57).
164
RECENSIONI
Seguono due contributi centrati sulla cittadina di Fondi. Il primo, di Giovanni Pesiri, traccia la storia dei rapporti tra Mommsen e la comunit fondana, in particolare con Giovanni Sotis, personaggio di spicco della citt della quale fu anche sindaco, che accompagn lo studioso tedesco nella sua breve visita a Fondi e che con lui rimase in contatto inviandogli segnalazioni utili alla compilazione del CIL X. Dalla relazione di Pesiri, emergono poi le grandi difficolt cui dovette andare incontro Sotis nel realizzare limpresa, ispirata dalla visita di Mommsen, di costituire un museo che raccogliesse tutte le iscrizioni rinvenute nel territorio. Il secondo contributo, di Massimiliano Di Fazio, ricostruisce le complesse vicende di una tessera hospitalis che Mommsen attribuisce senza dubbio a Fondi. Dal racconto delle vicende antiquarie, tuttavia, sorge qualche dubbio circa la provenienza fondana delloggetto. Lautore suggerisce dunque la possibilit che la tessera provenga dal territorio di Pietrabbondante, presso la quale sono attestati i toponimi Borgo Funti e Vallone Funti . Lipotesi viene suffragata dallanalisi del contesto storico in cui venne ad essere prodotta la tessera, pi coerente col quadro storico e sociale dellarea pentra che del territorio fondano (p. 99). Con la relazione di Daniele Maras si apre la sezione del volume dedicata agli studi epigrafici recenti. Prendendo lavvio dalla recente pubblicazione dellalfabetario di Lanuvio2, Maras propone unanalisi interessante della diffusione dei tipi alfabetici nel Lazio arcaico, applicando il metodo della tipologia e delle tabelle di seriazione o di associazione al materiale epigrafico latino relativo al periodo tra il VII e V secolo a.C. Due sono state le linee su cui si sviluppato il lavoro (i cui risultati sono mostrati in due tabelle): da una parte una linea che potremmo definire cronologica che segue levoluzione del sistema scrittorio tra VII e V secolo, per la quale Maras isola tre fasi il cui cambiamento segnalato dalla scomparsa di un lotto di tipi grafici, cui fa riscontro la comparsa di alcuni altri, eventualmente in sostituzione (p. 109); dallaltra unanalisi delle associazioni esclusive di alcuni tipi grafici (tralasciando le iscrizioni di VII secolo viziate della loro forte vicinanza al modello etrusco) che porta allindividuazione di almeno due modelli alfabetici differenzianti entro il corpus latino arcaico (p. 112). proprio questultimo modello di analisi che fornisce i dati pi interessanti, in quanto ha permesso di identificare un gruppo di segni che compaiono esclusivamente in iscrizioni non romane, come ad esempio la S a quattro tratti3. La presenza di (alme2
ATTENNI - MARAS 2004. A questo proposito, molto interessante lipotesi di escludere dal novero delle
RECENSIONI
165
no) due diversi modelli scrittori nel Latium vetus stata recentemente ripresa da Giovanna Rocca4 in un lavoro sul Lapis Satricanus. Sulla base di alcuni elementi epigrafici (e non solo), la Rocca propone di attribuire liscrizione satricana a un foyer scrittorio non romano nel quale sembrano affiorare tracce di sabinit. NellAppendice I a questo lavoro, a cura di chi scrive, si operato un confronto epigrafico tra il Lapis Satricanus e alcune iscrizioni del Lazio arcaico dal quale sono emerse alcune congruenze significative tra questo e alcune iscrizioni provenienti dai confini sudorientali del Latium vetus: la coppa del Garigliano, i frammenti dellara di Corcolle, laltare di Tivoli. Queste conclusioni ben si accordano con i risultati cui pervenuto Maras, ovvero confermano lesistenza di tradizioni scrittorie diverse tra Roma e i territori circostanti, forse influenzati dalla vicina Sabina. Dopo Maras, segue il lavoro di Pietro Longo, che si propone di rivedere il discorso Gaeta (p. 119) presentando testi inediti5 insieme ad altri gi noti per un totale di 31 iscrizioni proposte secondo un criterio non esplicitato. La descrizione dei pezzi, accompagnata da un ricco corredo fotografico, il pi delle volte supportata dal controllo autoptico delliscrizione che, talvolta, ha permesso una correzione del testo rispetto alle edizioni precedenti. il caso ad esempio delliscrizione n. 17 (CIL X, 6151), che nel CIL viene riportata su quattro righe, mentre in realt il testo distribuito su cinque righe pi una sesta (non presente nel Corpus) probabilmente aggiunta in un secondo momento; lAutore, inoltre, corregge la lettura del nome del dedicante da Matinus a Magnus. Altre correzioni riguardano la n. 20 (CIL X, 6166, non citato dallAutore), il cui testo fu inviato al Mommsen nel 1879 da Gaetano dAragona, la n. 8 (CIL X, 6098) per la quale alla fine r. 2 esclude una lettura, pr(aetor) (non proposta nel CIL da Mommsen), e la n. 196 per la quale Longo afferma: rispetto alla lettura del CIL, differisce da quella di chi scrive nella seconda, quarta e soprattutto sesta riga (p. 139). Un controllo delledizione del CIL ha tuttavia rivelato che nessuna differenza sussiste tra la seconda riga riportata nel Corpus e quella di Longo, idem per la quarta. Nella sesta,
iscrizioni latine il graffito proveniente dallarea delle Scalae Caci per riproporne lattribuzione al falisco sulla base di criteri paleografici (pp. 107-108). 4 ROCCA 2009, allinterno di questo stesso volume. 5 Non possibile stabilire il numero esatto di testi inediti presentati, dal momento che questi non vengono segnalati in maniera esplicita dallAutore. 6 LAutore tralascia di riportare il numero del CIL delliscrizione (CIL X, 6093) mentre in un altro caso attribuisce ad uniscrizione (n. 11, non reperita nel volume X del Corpus) il numero CIL di unaltra iscrizione n. 10, CIL X, 6138.
166
RECENSIONI
lunica differenza nella nuova edizione del testo riguarda la prima i della quale oggi non rimane traccia. Risulta per curioso che allattenta analisi dellautore sia sfuggito un errore nelledizione del CIL che alle rr. 7-8 riporta prae-tori invece di pr-aetori, come pure curiosa la menzione di una O molto grande (p. 127) in riferimento alliscrizione n. 7 (CIL X, 6140) che recita M(arcus) Bullani(us) [- f(ilius)] / Aim(ilia tribu) pra+ [- - -]. Lo spunto pi interessante del lavoro di Longo riguarda le iscrizioni nn. 10 e 11 per le quali si ipotizza, sulla base di somiglianze epigrafiche e materiali, la possibilit che i due pezzi appartenessero al medesimo blocco, forse uniscrizione posta da una coppia di magistrati, L. Atra[- - -] e L. Sta[- - -], questultimo forse ricordato in un altro frammento (n. 12) L. Stat[- - -]. Chiudono il volume dedicato a Mommsen due saggi relativi a studi epigrafici nella provincia di Latina. Il lavoro di Marco Mannino sul sepolcro di L. Domitius Phaon prende lavvio da unepigrafe ripetuta con poche variazioni su otto cippi ritrovati nel territorio tra Fondi e Sperlonga. Il testo sancisce la sacralit del luogo e il diritto di dimorarvi accordato alla domus di Domitia L. f. Lepida, zia di Nerone, ed firmata da L. Domitius Phaon, liberto di Nerone che assistette limperatore nei suoi ultimi giorni di vita. Il lavoro di Mannino accompagnato da unAppendice di Ascanio DAndrea che analizza il territorio circostante alla zona del sepolcro di Phaon mediante strumenti informatici. Infine, il saggio di Claudia Cenci analizza due epigrafi, una greca e una latina, risalenti al VII secolo d.C. poste su una colonna del portico della Cattedrale di Terracina. Liscrizione greca un augurio di lunga vita per gli imperatori, identificati in Costante II e Costantino IV suo figlio: si tratta dellunica testimonianza epigrafica del passaggio dellimperatore a Terracina. Liscrizione latina, invece, riferisce che il foro stato mundificatus al tempo del duca Giorgio. La Cenci propone una nuova interpretazione del termine mundificatus, solitamente interpretato come pulito/sistemato, forse da collegarsi alla riconsacrazione degli edifici pagani posti nel Foro (p. 184). Lipotesi che la colonna fosse inizialmente posizionata nel Foro suffragata dal fregio musivo della Cattedrale nel quale accanto alla chiesa raffigurata una colonna, che lAutrice propone di identificare con quella che reca le iscrizioni. Il volume si presenta dunque come un omaggio molto articolato al lavoro interdisciplinare di Mommsen, arricchito dalla presenza di studi innovativi in campo epigrafico che al tempo stesso dimostrano come lopera del maestro tedesco continui con grande entusiasmo anche a cento anni dalla sua scomparsa. Giulia Sarullo
Potrebbero piacerti anche
- Lista Biblioteca Notturna PDFDocumento215 pagineLista Biblioteca Notturna PDFweraNessuna valutazione finora
- Rivoluzione Copernicana PDFDocumento7 pagineRivoluzione Copernicana PDFEnrico Maria GiustNessuna valutazione finora
- FOIBEDocumento36 pagineFOIBEAnonymous MJYL2BJMzrNessuna valutazione finora
- Laboratorio ScritturaDocumento2 pagineLaboratorio ScritturaJey NiangNessuna valutazione finora
- Bezoar IDocumento2 pagineBezoar IGilbertoBruciaferriNessuna valutazione finora
- TelemedicinaDocumento25 pagineTelemedicinaorionUPC100% (1)
- M1780311a DeR Bretonnia 1Documento3 pagineM1780311a DeR Bretonnia 1Matteo SintoniNessuna valutazione finora
- Narciso e Boccadoro Di Hermann HesseDocumento1 paginaNarciso e Boccadoro Di Hermann HesseFrancesco CiliaNessuna valutazione finora