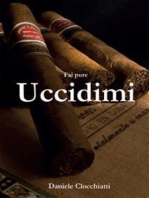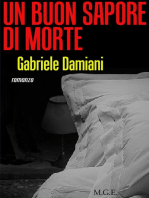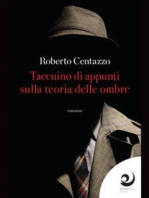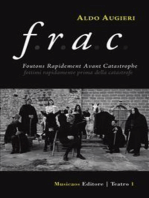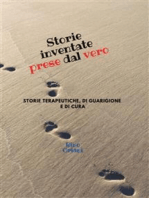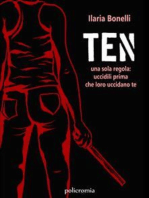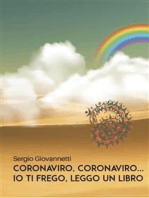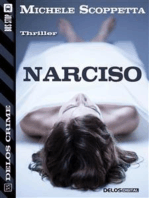Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Perdere Pezzi (Autobiografia Musicale)
Caricato da
James LiseCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Perdere Pezzi (Autobiografia Musicale)
Caricato da
James LiseCopyright:
Formati disponibili
Prima di essere accusato di plagio è necessario premettere che nella stesura del racconto ho
(deliberatamente) inserito stralci (più o meno travisati) delle seguenti canzoni: “Vivere”, “Siamo
soli” e “Gli Angeli” di Vasco Rossi; “Mangiafuoco”, “La fata”, “Tu grillo parlante”, “Dotti, medici e
sapienti e “Il professor Cono” di Edoardo Bennato; “Il cancro” e “Quello che perde i pezzi” di Giorgio
Gaber; “Sterili” e “Baratto” di Renato Zero; “Bocca di Rosa” e “Mègu megùn” di Fabrizio De André;
“Rien ne va plus” di Enrico Ruggeri; “Come salvarsi la vita” di Roberto Vecchioni; “Cogli la prima
mela” di Angelo Branduardi; “Il frate” di Francesco Guccini; “Se stiamo insieme” di Riccardo
Cocciante; Autobiografia industriale” di Claudio Lolli e “C’è da spostare una macchina” di
Francesco Salvi.
PERDERE PEZZI (Autobiografia musicale)
“È passato tanto tempo. Vivere!
È un ricordo senza tempo. Vivere...”
In ospedale le sciagure hanno un peso diverso. Una sera arrivò nella
mia stanza un ragazzo ligure poco più grande di me. Era un giovane
operaio che si era tagliato le prime falangi delle tre dita centrali della
mano sinistra.
Quando sul posto di lavoro si viene a conoscenza di una notizia del
genere l’incidente può assumere proporzioni talvolta persino esagerate
rispetto a quanto veramente accaduto. In ospedale invece, più abituati alle
disgrazie, si tende a minimizzare: “Le prime falangi mozzate? E’ andata
bene. Poteva restare sotto alla macchina operatrice con l’intera mano.
Sarebbe stato molto più grave.”
E’ vero: non c’è limite al peggio. Eppure avere l’impressione di
essere scampati ad un rischio maggiore fa spesso mettere il cuore in pace.
Inoltre la consapevolezza che ci sia qualcuno in condizioni peggiori della
propria toglie il diritto a lamentarsi. Talvolta rinfranca pure. Forse è
questo il motivo per cui si dice: “Mal comune, mezzo gaudio”.
In effetti i dottori erano tutti d’accordo sul ridimensionare le
conseguenze del tragico accaduto: “Oggi le falangi le riattacchiamo in
men che non si dica. Basta agire per tempo. Quelle del ragazzo sono
arrivate qui in buono stato. Andrà tutto bene”.
A fine dell’intervento chirurgico la notizia del buon esito passa dal
chirurgo ai parenti, dai parenti agli amici, dagli amici ai compagni di
stanza alla velocità della luce. Come una freccia dall’arco scocca e corre
veloce di bocca in bocca:
“Tutto a posto. Le dita sono di nuovo complete e le unghie
riprenderanno a crescere. L’ha detto il dottore”
“L’ha detto il dottore”: frase mantra in corsia. Se lo dice il dottore
persino l’incredibile diventa quotidianità. Che sia un miracolo?
A volte, stando in corsia, vien fatta di pensare che siamo tutti dei
sopravvissuti. Siamo li: questo è il vero miracolo. Altro non è dato
pretendere. Siamo lì e siamo vivi, anche se tutto può ancora succedere.
Guariremo? Chi lo sa? Usciremo? Chi può dirlo? Si pensa solo a salvarsi
la vita. Salvarsela con il rimorso di arrivare quando la nave è già partita
oppure giurando il falso incrociando le dita. Però salvarsela, la vita.
Anche nel mio caso, a dar retta allo “specialista”, le cose andavano
alla grande. L’unico problema era rappresentato dall’identificazione del
punto del corpo da cui togliere osso. Perone o anca? Se le ossa, all’interno
del nostro corpo, in qualche modo stanno insieme, ci sarà un perché.
Volevo scoprirlo alla svelta così da smettere di logorarmi in congetture
sterili.
Ma il dottore la pensava in altro modo. Per lui un osso qua poteva
metterlo là, disobbedendo a certe regole “divine”. Per forza. Il vero dio,
almeno lì dentro, era lui: il dottorone. Io invece avrei voluto dirgli: “uh,
medico mio, medicone. Uh, scendi giù dal seggiolone”. Ma sarebbe stato
inutile. Il professore aveva tanto studiato e questo lo faceva apparire un
po’ distratto ma, quando parlava, sapeva quel che diceva.
Captando certe frasi, avulse dal contesto, non sembrava nemmeno
di stare in ospedale: “Se da un costola è nata Eva volete che noi (plurale
maiestatis), da una fibula, non ridiamo l’uso di una mano per agguantare
una mela? E’ giovane, bello e fiero e deve poter cogliere la mela”.
Ecco dov’ero! Stavo in una sorta di paradiso in terra, frequentato
solo da dotti, medici e pazienti sapienti ma intanto, viziato dal linguaggio
medico-etico, fraintendevo molto di quello che ascoltavo in giro.
Sull’episodio del giovane ligure, a forza di origliare qua e là, mi
feci un film tutto mio, un assurdo “Sbombone” (come chiamavo i sogni
ad occhi aperti).
Al momento dell’incidente un collega del mutilato aveva visto
schizzar via dita come se piovesse. Per niente impressionato
dell’accaduto si era tolto la maschera, mostrandosi finalmente per quello
che era: l’angelo custode. Angelo ovviamente camuffato da persona
ordinaria. Me lo figuravo mentre si levava la bluastra casacca da operaio
restando con indosso la sola biancheria intima.
Sul retro della camiciola c’erano disegnate due alucce stilizzate.
Davanti c’era stampata la scritta “ESISTO”, tanto per togliere ogni
dubbio agli scettici. Eppoi bastava vederlo all’opera per rendersi conto
della sua vera natura. Un angelo custode arriva con le lucciole e le cicale,
ti insegna la strada buona e soprattutto sa bene quello che bisogna fare.
Difatti aveva immediatamente raccolto quei mozziconi di dita per
riporli in idoneo contenitore, ovvero una busta di plastica trasparente di
quelle per conservare il cibo nel congelatore. Le falangi venivano così
trasportate con urgenza a Pisa, in elicottero. Nessuno sapeva chi avesse
guidato quell’aeromobile. C’era persino chi era disposto a giurare che
fosse telecomandato.
Io ero l’unico ad aver capito il trucco. Gli angeli possono diventare
invisibili. Oppure possono entrare nel corpo di altri. Allora mi immaginai
un dottore in camice bianco scendere da quel mezzo volante. Non era
affatto un caso che l’elicottero fosse atterrato sopra al tetto a terrazza del
reparto ortopedico.
Gli angeli sono di una precisione... “chirurgica”.
L’uomo teneva con se la busta di plastica trasparente. All’interno,
avendo la possibilità di guardare attentamente, si vedevano i tre
frammenti di dita imbevuti di sangue. Quelle falangi, staccate dal resto
della mano, potevano ancora muoversi per loro conto come fossero
palline della roulette. Niente di strano, questo succede anche alla coda
mozzata di una lucertola. L’intervento fu super-rapido. Bastarono 3
minuti di anestesia locale, un minuto a dito. Et voilà, ed il medico se ne
va. Rien ne va plus e l’angelo non c’è più. Nessuna incognita apparente
di uno zero fra il rosso del sangue ed un ematoma nero. Il fato ha suturato
le ferite, il ragazzo è pronto per nuove partite.
Lo “Sbombone” terminò così, con l’immancabile lieto fine. Dopo
questa visione affibbiai al compagno di stanza il nomignolo di
“Lucertolino”.
Il bello è che in testa mi partivano queste visioni idilliache sulle
vicende circostanti nonostante la mia reale condizione. Ero chiuso in
quell’ospedale ormai da mesi ed una intera equipe di “professoroni” stava
ancora studiando come porre rimedio ad una prima operazione andata a
“puttane”. Per me si vociferava di un intervento in anestesia totale dalla
durata a dir poco imprecisata. Per me si aspettava addirittura l’arrivo di
un team di esperti in microchirurgia plastica. Mi venne il dubbio che lo
sfigato fossi soltanto io:
“...Ma non ho ancora capito,
fra risa per donne e per Dio,
se fosse lui il disperato o il disperato son io...
Ma non ho ancora capito con la mia cultura fasulla
chi avesse capito la vita,
chi non capisse ancor nulla...”
Ah, se avessi conosciuto “Il frate” di Francesco Guccini! La
canzone si adattava perfettamente alla situazione. Lucertolino, rispetto a
me, era veramente fortunato. Fino a qualche giorno prima ero l’unico che
poteva camminare e muoversi da una camera all’altra in cerca, durante
l’ora dei pasti, di qualche baratto favorevole. Un bicchiere di vino a te, la
tua bistecca di maiale a me (si trattava di paziente vegetariano). Giravo
come un pazzo e gridavo: “Se ti do il fegato tu che mi dai? Ehì, ti do la
ciccia, tu che mi dai?”. Smerciavo cibarie ed allegria.
Una volta scambiai una scatola di fagioli della dispensa personale
con quattro piatti di lasagne. Accettai il baratto con un veterano del
reparto, di quelli con scarse speranze di uscire presto da lì. Le lasagne
erano portata fissa una sola volta alla settimana. Per avere quanto mi
aspettava attesi un mese intero. Tempo ne avevamo entrambi. Capacità di
spostamento, soltanto io.
Adesso invece pure il “piccolo sauro” ligure andava in giro per le
corsie che sembrava un indiavolato. Eppoi non si chetava neanche un
secondo, sparando cazzate a raffica. In pratica, rompeva i coglioni. Lui
non ci badava ed insisteva.
Per dirla con un termine delle sue parti, era un vero “belin”.
Quando mi raccontò per l’ennesima volta, con dovizia di particolari
“splatter”, il misfatto che l’aveva portato lì, avrei voluto mozzargli la
lingua.
Chissà se pure quella si riattaccava subito? Morivo dalla voglia di
scoprirlo.
Non lo sopportavo. Era uno di quelli a cui sembrava figo scrivere
sul diario sentenze del tipo: “Per te mi ucciderei con un coltello... di
burro” oppure “Per te mi butterei giù... dal marciapiede”. Lui diceva che
le frasi d’amore classiche non funzionavano più. Alle ragazze bisognava
dire qualcosa di ironico, leggero, disimpegnato. A me sembravano solo
scemenze, invece lui ci rideva sopra. Rideva di niente o almeno così
appariva ai miei occhi un po’ invidiosi. Eppure c’era qualcosa che lo
turbava nel profondo ed ogni due per tre andava in crisi. Guardava la sua
mano sinistra e si augurava di poter tornare a porre i polpastrelli sulla
chitarra elettrica.
La sua chitarra elettrica di qua, la sua chitarra elettrica di là,
l’amplificatore, il distorsore, il wah-wah. L’elenco proseguiva con altre
impronunciabili quanto irrinunciabili diavolerie.
Una mattina si mise a sedere sul mio letto mentre cercavo di
convincere Morfeo ad offrirmi una seconda possibilità. La notte
precedente, tanto per cambiare, avevo tenuto compagnia ai ragazzi con
problemi di scoliosi. Mi ero infilato nel letto che era già mattino. Mi
sentivo più cotto del solito ed avevo fatto una gran fatica ad
addormentarmi. Poi, dopo poche ore di sonno, era suonata la sveglia
“umana”, rappresentata dagli infermieri muniti di bacinella ed
asciugamano per la giornaliera lavata di faccia di gruppo. Appena usciti
gli inservienti avevo ritirato su coperte e lenzuola con la speranza di
tornare a dormire in tempi brevi.
Purtroppo non avevo tenuto conto di Lucertolino. Lui si era
accomodato vicino a me chiedendomi se ero sveglio. Non risposi. Lui
cominciò ugualmente a parlare. Sarà stato il tono di voce piuttosto alto,
sarà stato l’accento ligure, sarà stato che reggevo poco il soggetto, fatto
sta che ero in allarme. Potevo abbandonare qualsiasi velleità di
concedermi una pur minima pennichella.
“Stai a vedere che ora riparte daccapo e si mette nuovamente a
raccontare come la sua povera mano gli sia rimasta nella pressa da taglio”
– questo pensavo fra me e me – “se lo fa giuro che gli allungo un cazzotto
sul naso”.
Non fu necessario sferrare alcun pugno. L’argomento era
totalmente nuovo: “Conosci il grillo parlante?” - mi chiese. Ormai avevo
gli occhi aperti e non potevo certo continuare a fare scena muta ma mi
pareva che la domanda fosse a trabocchetto in quanto eravamo entrambi
cresciutelli per Pinocchio. Per non dargli corda non feci motto. Annuii
con un cenno della testa. La seconda domanda arrivò rapidissima:
“Mangiafuoco?”.
E’ uno scherzo, questo? E’ forse un gioco? Quali fili voleva
muovere quel compagno di sventure? Urgeva un tentativo di
ragionamento minimamente sensato. Fenomeno non semplice nel mio
stato di trans da insonnia indesiderata. Dunque, i quesiti vertevano
entrambi sulla favola scritta da Carlo Lorenzini. Fino a lì non ci pioveva.
Siccome ci trovavamo in quel del presidio ospedaliero di Santa Chiara -
Pisa - Toscana - Italia, questioni del genere mi sembravano del tutto
inutili. Inoltre, al momento in cui eravamo diventati “colleghi”, mi ero
presentato come da etichetta. Nome, cognome, residenza e via dicendo.
Possibile che egli ignorasse che provenivo, più o meno, dalle parti di
Collodi? Chi nasce nei dintorni di tale località difficilmente può evitare
di cadere, prima o poi, nel pozzo profondo dei racconti che hanno al
centro il burattino di legno. Io c’ero schizzato dentro da piccino piccino
ed ancora ne portavo le conseguenze.
Come Obelix, che per essere finito da bambino dentro il pentolone
della pozione magica non può più berne anch’io, in fatto di insegnamenti
dettati dalla morale cattolica ottocentesca, potevo ritenermi saturo. Ero
cresciuto con il patema che le bugie avessero le gambe corte o facessero
crescere il naso.
“Ti verrà un naso così”, mi veniva detto a mani aperte. Fra una
mano ed un’altra c’era, senza esagerare, almeno mezzo metro. Orrore.
Con un appendice del genere mi sarei vergognato ad uscir di casa. Meglio
dire la verità. Magari rivista e corretta, ma assai plausibile. Rielaborare la
realtà, secondo il personale punto di vista, mica equivaleva a dir
menzogne (quantomeno era quello che speravo).
Inoltre non dovevo fare il bimbo cattivo. A suon di imitare
Lucignolo potevano spuntarmi le orecchie d’asino e trasformarmi in
ciuchino in un “amen”. Comunque non credo che pensai a tutto questo
prima di rispondere.
Con lui tagliai corto e sbottai: “Ho presente Geppetto,
Mangiafuoco e so pure chi è la fata Turchina!”. Nel frattempo avevo
alzato la voce: “Turchinaaa. Hai presente?”. Ero lì lì per perdere la
pazienza. Mi veniva di continuare con una vociaccia piena di ragni, di
granchi, di rane ed altre cose un po' strane: “Conosco la fata Turchina e
quel disgraziato di un granchio che grida chetati al vento”.
Poi mi frenai e chiusi il discorso in calando, quasi rassegnato:
“Conosci la fata Turchina?”
“Vuoi dire La fata” - mi corresse. Era veloce a replicare e son
convinto che, nel frattempo, dentro la sua testa, ripassasse qualche verso:
“C’è solo un fiore in quella stanza
e tu ti muovi con pazienza
la medicina è amara ma
tu già lo sai che la berrà...”
Trovai inutile contraddirlo. Sperai che fosse finita lì ma mi
illudevo. Ci sarebbe voluta una fata vera, capace di farlo sparire. Invece
niente. Le magie, in quell’ambiente, erano riservate ai medici.
Medici veri e non corvi o civette.
Così bevvi, ancora una volta, l’amara medicina, dei suoi discorsi.
Passi pure l’excursus sui riff di chitarra presenti nell’album “Burattino
senza fili” di Edoardo Bennato, uscito da poco (ecco dove voleva arrivare
con le sue domande!). Ma, al ripartire del racconto “pulp” su come avesse
perso parte delle sue preziose mani, giunse immediata la mia reazione:
“Non ti preoccupare” – lo rassicurai caustico – “a furia di operazioni a me
è rimasto solo un gran testone ed un testicolo per la riproduzione”.
Controbattere alle sue lagne con “Quello che perde i pezzi” di Giorgio
Gaber si rivelò mossa vincente. Evidentemente “Lucertolino” non
conosceva il repertorio del “cantattore” milanese, così resto di sasso e si
chetò.
Quella volta fui io a ridere di gusto.
“...vivere!
È un po' come perder tempo
Vivere e sorridere...”
Potrebbero piacerti anche
- Fashion Victims: Pamphlet inutile sulla morte da CoronavirusDa EverandFashion Victims: Pamphlet inutile sulla morte da CoronavirusNessuna valutazione finora
- Quello che non so di te (Collana Literary Romance)Da EverandQuello che non so di te (Collana Literary Romance)Nessuna valutazione finora
- Viaggio nonostante tutto: Appuntamento con BauhbaliDa EverandViaggio nonostante tutto: Appuntamento con BauhbaliNessuna valutazione finora
- Lettera di un perito meccanico a un aspirante poetaDa EverandLettera di un perito meccanico a un aspirante poetaNessuna valutazione finora
- Good Look. Chemioterapia, ricordi di viaggi, fiori e ricette di cucinaDa EverandGood Look. Chemioterapia, ricordi di viaggi, fiori e ricette di cucinaNessuna valutazione finora
- Finalmente Primavera: La mia lotta e la mia convivenza con il linfomaDa EverandFinalmente Primavera: La mia lotta e la mia convivenza con il linfomaNessuna valutazione finora
- A Dottò, me fa male er Biafra?: Ovvero confessioni di un malandrinoDa EverandA Dottò, me fa male er Biafra?: Ovvero confessioni di un malandrinoNessuna valutazione finora
- Storie inventate prese dal vero. Storie terapeutiche, di guarigione e di curaDa EverandStorie inventate prese dal vero. Storie terapeutiche, di guarigione e di curaNessuna valutazione finora
- Cicatrici oltre il buio. Perdonare il passato e rendere la difficoltà uno spettacolo magnificoDa EverandCicatrici oltre il buio. Perdonare il passato e rendere la difficoltà uno spettacolo magnificoNessuna valutazione finora
- Coronaviro, Coronaviro... Io ti frego, leggo un libroDa EverandCoronaviro, Coronaviro... Io ti frego, leggo un libroNessuna valutazione finora
- Daniel Pennac - La Lunga Notte Del Dottor GalvanDocumento15 pagineDaniel Pennac - La Lunga Notte Del Dottor GalvanStefano Liverani100% (1)
- Cocchio LunaDocumento9 pagineCocchio LunaJames LiseNessuna valutazione finora
- Il CompleannoDocumento8 pagineIl CompleannoJames LiseNessuna valutazione finora
- Le Confessioni Di BDocumento4 pagineLe Confessioni Di BJames LiseNessuna valutazione finora
- Controllo TotaleDocumento5 pagineControllo TotaleJames LiseNessuna valutazione finora
- CastelliDocumento8 pagineCastelliJames LiseNessuna valutazione finora
- Santa Brigida 1 AnnoDocumento4 pagineSanta Brigida 1 AnnoangeloNessuna valutazione finora
- La Pesca MiracolosaDocumento2 pagineLa Pesca Miracolosaaceto_giacomoNessuna valutazione finora
- Boulez - Memoriale Analisi (Italian)Documento8 pagineBoulez - Memoriale Analisi (Italian)sertimoneNessuna valutazione finora
- Caporal EttiDocumento27 pagineCaporal EttiemanueleNessuna valutazione finora
- Glauco e ScillaDocumento2 pagineGlauco e ScillaSusy GalloNessuna valutazione finora
- Qualcomm San Diego MapDocumento1 paginaQualcomm San Diego Mapj0880jNessuna valutazione finora
- Mini Guida Altezza Arretramento SellaDocumento8 pagineMini Guida Altezza Arretramento SellacactusmtbNessuna valutazione finora