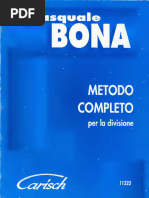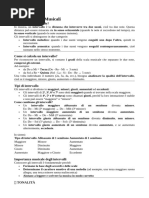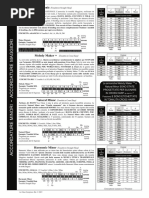0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
233 visualizzazioni75 pagineBona Divisione
Caricato da
dabCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
233 visualizzazioni75 pagineBona Divisione
Caricato da
dabCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Gon PRR R RRR ER eee
a im
; Metodo completo y
| per la divisione ]
4 bi
Vs id
a a
« P. BONA §&
m4 ae
" —ae
i elementari di te: r
a a
8 m' Rocco C Li
Mi Ls
fl i"
el i
fel vg
te . ie
mI Il
il i
rel P|
i i
2 i
1 2 NF WR AO A
PF BOWd
METODO COMPLETO
PER LA DIVISIONE
(CON UAGGIUATA DI
WOZIOM! ELEMENTARI D1 TEORIA MUSICALE }
NUOVA EDIZIONE Riveduta dal Cav, ROCCO CRISTIANO
Teoria della Musica
La musica é I’arte dei suoni i quali vengono graficamente indicati mediante le NOTE che so-
no sette: Do Re Mi Fa Sol La Si. Esse si pongono sul RIGO che & un pentagramma formato da 5
lince parallcle le quali racchiudono fra loro 4 spazi. = a
Il figo & dunque il rracciazo sul quale si svolge la grafia musicale. Tanto le linee che gli spazi
del rigo si contano dal basso all’alto, come si dimostra:
RIGO
HH
Non essendo il rigo sufficiente a contenere I’intera successione dei suoni si aggiungono delle
lineette (frammenti di linea) dette Tagli Addizionali. | tagli possono essere posti tanto al disopra
Gel rigo (per le note acute) come al disotto (per le note gravi).
= (verso l’scuto)
(verso il grave)
All inizio del rigo si mette un segno denominato CHIAVE - esso serve a determinare il nome
delle note a seconda della loro posizione sul rigo. Le chiavi sono sette, ma per ora ci occuperemo
solo della principale: CHIAVE DI SOL detta anche di VIOLINO (4).
La chiave di Sol poggia sulla scconda linea ¢ da il suo nome #d ogni nota collocata sulla me-
desima II" linea. Stabilito questo punto di partenza si avra ascendendo la seguente successione: La
nel I spazio; Si nella II" linea; Do nel Hl spazio; e cosi via. Discendendo invece l'ordine sara
inverso e cioe: Fa nel 1° spazio; Mi nella I* linea Re sotto il rigo ecc. ecc.
FIGURE: per esprimere un qualsiasi pensiero musicale non basta produrre dei suoni differenti,
ma occorre stabilirne la durata o valore , percid le note hanno una differente figurazione a seconda
che il loro suono debba essere piii o meno prolungato.
D/altra parte la successione dei suoni pud essere interrotta da silenzi pure pitt o meno prolun-
gati, per indicare i quali si usano le Figure dé Pause. Ogni FIGURA DI NOTA ha la sua
corrispondente FIGURA DI PAUSA come appare evidente dai seguenti prospetti:
Tua sisi riservai
PROSPETTO DELLE FIGURE E DELLE PAUSE ui
Denominaziorie’ Figure delle Note (Suoni) Figure delle Pause (Silenzi) Valore.
Semibreve Intero
Minima Meta
Semiminima ——4 === 4) auto
Croma = S= (4) onao
Semicroma = === (is) Sedicesimo
Biscroma = S= @) temdine
Semibriseroma == Se (4) secsantaquattresimo
EQUIVALENZA DEI VALORI
Vunita o intery
it nn Pr
4 wes r t r
“E t ocr SS co
equivale
a
Per aumentare il valore delle figure la grafia musicale dispone di due mezzi: i! Punto e la Le-
gatura.
LA LEGATURA é una linea curva che unisce due note di suono eguale e ne fa un unico valore,
In altri termini essa assomma o fonde la durata delle due note - possono esservi anche tre o pitt no-
te tutte legate fra loro,
Dimostrazione: PP =? Il ert so NER ET to ll
IL PUNTO posto dopo una nota o pausa ne aumenta la durata della meta del relativo vatore.
exempio: p> = rr Ips i] f° 6 poe 2
Le note (0 le pause) possono essere seguite da due e, raramente, anche tre punti; ogni punto
aumenta della meta il valore di quello precedente:
Esempio: f= F to 4 Ef oo LT PTE (] =e 27
TEMPI E MISURE: il Tempo regola la suddivisione razionale della musica in tante Misure o
Battate comprendenti ognuna un'eguale somma di valori-ogni misura ¢ delimitata mediante una
linea (o stanghetta) che attraversa il rigo verticalmente cosi
wisuramisara wisara
Ww
La somma dei valori che debbono essere contenuti in ogni misura ¢ indicata dai Tempi che
sono raffigurati da segni o numeri frazionati posti all’inizio di ogni composizione. I Tempi posso-
‘no essere pari o dispari.
TEMPI PARI PIU USATI
Tempo ordinario C o 4 sibatte in 4 movimenti: 2 in battere e 2 in levare
‘Tempo a Cappella o tagliato @o & si batte in 2 movimenti: 1 in battere e 1 in levare
Tempo due quarti -} si batte in 2 movimenti: 1 in battere e 1 in levare
‘Tempo sei ottavi (0) -& si batte in 2 movimenti: 1 in battere e 1 in levare
‘Tempo dodici ottavi () AB si batte in 4 movimenti: 2 in battere e 2 in levare
TEMPI DISPARI PIU USATI
Tempo tre quarti-} Tempo tre ottavi - Tempo nove ottavi si batte in 3 movimenti: 1 in
battere e 2 in levare.
SINCOPE per ben comprendere I’effetto della sincope @ necessario esaminare come & composta
Paccentazione delle misure o battute. Es: Una misura di tempo ordinario (@o-4) si compone di
quattro movimenti (0 tempi, o semiminime). Per effetto naturale noi sentiamo pith marcatamente
Vaccento sul 1° e 3° movimento che percid si chiamano tempi forti, mentre meno accentuati il
2° @ 4° mov. detti per questo tempi deboli
Poiché la sincope non é che una accentazione contraria al naturale si verificher& allorch¢ una
nota comincia su un tempo debole e si protrae fino al tempo forte successivo.
‘Nel tempo di % il I° movimento é forte,il II* ¢ debole
Nel tempo di # i I° movimento é forte,il II° e III° deboli.
Sincope Stncope Sine. Sine. Sine. sinc,
movimenti> t. 4, t. 4. f. 4. fda.
NOTE SOVRABBONDANTI:sono gruppi di note contrastanti con la normale divisione del-
la misura.. Le pit frequenti sono:
Torzina gruppo di 3 note da eseguirsi nel tempo di 2di esse.
Sestina gruppo di 6 note da eseguirsi nel tempo di 4 di esse
TERZINE
SESTINE,
Zz “e
oppure « onpure :
Altri gruppi di 5, 7, 9 € pit note sovrabbondanti s’incontrano di rado; quasi sempre tali
gruppi vanno eseguiti nel tempo di un movimento.
Si da pure il caso di Note in diminuzione, praticamente all’inverso delle note sovrabbondan-
Div. regolare Div. in dim.n¢ Div. regolare Div. in dim.2e Div. regolare Div. in dim.n¢
mk TA ta Reif
o_ SINT, 54S), TMA, 728 JI,6 Jddddd,Jdd4,
Se ee ee tee
(2) NB. Il tempo $ per maggior chiarezza si pud battere in 6 movimenti.
(1) NB. Trempi $e per la stessaragione esigono accentazione dei vari moviment.
v
GRADO SCALA la scala é una successione di note procedenti gradatamente all’insu (scala a-
scendente)0 all’ingit (scala discendente).
Le note che formano la scala vengono chiamate Gradi Congiunti poiché si succedono passan-
do dall’una all’altra nota immediatamente vicina. Gradi Disgiunti si chiamano invece allorché le
note procedono in ordine saltuario.
Gradicongiunti Gadi disgiunti SCALA
=
dnd PMT UMMM ee
INTERVALLO?per intervallo si intende la distanza che intercorre fra due suoni differenti. I! pit
piccolo intervallo ¢ il Semitono - due semitoni formano il Tono.
Per classificare un intervallo basta enuuuerare, contando dal grave all’acuto, i gradi congiunti
compresi fra le due note. Per esempio dal Do 3° spazio al Fa 5° linea si ha: do, re, mi, fa, cicé
quattro note e quindi intervallo di IV*. Ecco alcuni esempi:
[Link]? [Link] VIZ Int.¢1 Wf Int. dt VIE Int.4i III [Link] VIII:
SOL la si DO MI fasollast DO DO RE MI RE
(quattrogradi) (sei gradi) (due graai)
ALTERAZIONI ogni nota pud essere alterata (innalzata o abbassata) mediante i cosiddetti Acci-
denti che sono
# Diesis Innalza la nota di un Semitono.
b Bemolle Abbassa la nota di un Semitono.
Doppio Diesis Innalza la nota di un Tono.
Doppio Bemolle _Abbassa la nota di un Tono.
4 Bequadro Annulla I’effetto degli altri accidenti e riporta la nota allo stato na-
5) Doppio bequadro rurale
Le alterazioni sono permanenti se collocate dopo la chiave ed hanno effetto per intera durata
del pezz0; sono momentanee se collocate davanti alla nota ed in tal caso hanno effetto per una sola
misura.
Le alterazioni poste in chiave seguono un ordine fisso immutabile in quanto servono a deter-
minare le diverse tonaliti di cui ci occuperemo pitt avanti. [ Diesis si succedono per quinte ascen
denti: ja, do, sol, 7e, Ja, mi, si. TBemolli procedono per quarte ascendenti: si, mi, la, re, sol, do,
en dies
SCALE-TONALITA abbiamo visto che la scala ¢ una successione di gradi congiunti; i pit im-
portanti gradi della scala sono denominati: Tonica (1 grado); Caratteristica (IM grado); Dominante
W grado); Sensibile (VIL grado).
wl
La scala é DIATONICA quando procede per toni ¢ semitoni. Essa pud essere di Modo Mag-
giore € di Modo Minore.
La Scala Maggiore si compone di 5 Toni ¢ 2 Semitoni, questi ultimi si trovano fra il 3° ¢ 4°
grado e fra il 7° e 8° grado.
SCALA DI DO MAGGIORE
GRADI: Tow vowwwiew wv
Tonica Caratter. Domin. —_Sensib, Tonia
SCALA DI SOL MAGGIORE SCALA DI FA MAGGIORE
=a
Si osservi che tanto la scala di Do maggiore che quelle di Sol e Fa (queste ultime per effetto
delle alterazioni in chiave) hanno la medesima successione di toni e semitoni (2 toni, 1 semit., 3
toni, 1 semit..
sem
La Scale Minore differisce dalla Scale Maggiore principalmente nell’Intervallo fra il 1° grado
(tonica) ed il 3° grado (caratteristica) in quanto nel Modo Maggiore & di una terza maggiore (2 to
ni), nel Modo Minore,\"Intervallo ¢ di una terza minore (1 tono ¢ 1 semitono).
Vi sono due specie di scale minori: Armonica e Melodica
LA MINORE (Armonica) LA MINORE (Melodica)
desreiiatittress
ha il 7° grado (sensibile) alterato ha il 6° € 7° grado alterati ascendendo e naturali
discend.
‘Ogni scala rappresenta la propria TONALITA, ciot la relazione che le note hanno fra loro,
determinata dalle alterazioni permanenti.
Ogni tonalita maggiore ha la propria somighiante minore (0 relativa minore), la cui tonica si
trova una terza sotto (3 semitoni).
’er esempio: Do maggiore ha la propria relativa in La minore; Si maggiore ha la relative in
Sol } minore ecc.
In complesso le Tonalita e relative scale sono 30 fra maggiori e minori come dal seguente:
RIASSUNTO DELLE TONALITA
DIESATE
[mee DO [Link]. RE magg. LAmagg. MI mage. SI magg. ¥a}magg. DO# magg,
TONICA
[ min, “Stxnim, acme, Simin, FAR min, DOfmln. SOLPuin. REAMIn, Lab min,
[mee me 31 Amaiy. S|? meer. rh mage. Yat mage. Eb mae. SoLbmage. DoF mee.
TONICA oy = =5: 2 SS
nin, SRE Ma, SOLmin. DO min, FAmin, sibmin, MIPmin. LAP min.
vw
SCALA CROMATICA:una successione di semitoni forma la scala cromatica 0 semitonata. Le
alterazioni vengono fatte coi diesis ascendendo ¢ coi bemolli discendendo. Essa non appartiene ad
alcuna tonalita e pud iniziare da qualsiasi nota, naturale o accidentata.
SCALA CROMATICA
=e >
La scala cromatica comprende 12 semitoni: 7 diatonici e 5 [Link] semitono e diatonico
se si trova fra due note diverse (Doff - Re) ed & cromatico quando risulta fra due note uguali, una
delle quali alterata (Si-Sib),
SETTICLAVIO:con questo termine si indica il complesso delle Chiayi musicali che appunto so.
no sette. Le chiavi sono di tre specie: di Fa, di Do, di Sol. Le pit usate sono quella di Sol (Violino)
€ quella di Fa (Basso). II seguente rapporto mette in evidenza la corrispondente posizione della me
desima nota (Do centrale).
SETTICLAVIO E RAPPORTO DELLE CHIAVI
f coavipira | [ CHIAVI DIDO | 1 catave |
= _ 9 DISOL
ee ee
(Basso) (Baritono) (Tenore) (Contralto) (Soprano) (Soprano) {Vioitno)
ABBELLIMENTI gli abbellimenti sono note estranee alla divisione regolare della misura ed
‘hanno lo scopo di ornare la melodia. Gli abbellimenti pid usati sono cinque:
Appogglatura (poco usata modernamente) sottrae alla nota il valore da essa rappresentato.
Acciaccatura sottrae alla nota una piccolissima parte del valore di quest’ ultima.
Mordente formato di sue notine ad esecuzione velocissima; pud essere superiore ed inferiore
Gruppetto formato di tre o quattro notine; pud essere diritto € rovesciato.
Trillo 2 il pit rapido possibile alternarsi di due suoni congiunti,
[sprooel[accrac™ |[uonp’ || anupperro [rattazo (con prevarazione
; © risolazione)
notasione a a ee
——
sup int ffairitto — | rovescteto
esecusione
vii
ANDAMENTO - ESPRESSIONE:i principali termini di andamento sono: Largo, Grave, Len-
to, Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Allegretto, Presto, Mosso, e possono avere gradazio
ne come: Larghetto, Allegretto, Andantino, ecc. tutti termini comprensibili facilmente. L’anda-
mento & sovente soggetto ad accelerazioni o rallentamenti che vengono indicati con: rall., accell,
tit, @ tempo, poco meno, poco pitt, ecc.
La Corona @ fa prolungare la nota o la pausa sulla quale & segnata a piacere dell"esecutore.
Lespressione 0 colorito si annota con: p (piano), grp pianissimo), ¥ (forte) gf (fortissimo),
af (mexzofome), mp (menopianc). gf(sforzate), ores, (crescendo), dirs (Qiminuendo,
Assai frequentemente s*incontra la legatura di portamento che impone V’esecuzione delle no-
te legate senra alcuna interruzione, Per contro, il punto sopra le note significa esecuzione stacca-
ta:
note legate note staceate
ABBREVIAZIONL si ripete il brano di musica racchiuso dal Ritornello|
lo porta la I*e I volta, nel ripeterlo si passa alla Il* tralasciando la I? D.C,
al€ppeseguire il brano compreso fra i due segni.
ALTRE ABBREVIAZIONI:
Notazione:
Esecuzione:
Tremolo a piacere
Notazione:
Esecuzione
ESEMPI DI ESECUZIONE
I numeri 1, 2,3,4, indicanoi quarti che costituiscono 1a battuta, ¢ la sillaba Do.0.0.0
indica di allungare la pronunciazione segnando leggermente ciascun quarto, Le parole
Uno, due, tre, quattro servono ad accennare i quarti d’ aspetto
Perle figure del valore di quattro quarti, sien note, che aspetti.
123 4 1 2°38 4 4d
Do-o-0.0
Pronuneias*
Uno Tre Quattro Uno Due Tre Quattro
Perle figure del valore di due quarti
i 2 BOA 41 203 4 1 2 3 4 4 2 3 4
So-ol So-0l So-cl [no Due Uno Due Sool 80 - ol Uno Duc
Per le figure del valore di un quarto,
1 2 8 A a 2 8 4 %, 2 3 4 1 2 3 4
Uo Do Do Soi sol Sol Sel Do to Do oko tro Sol Uno Sol
Per Je note o pause ¢ol punto, e per le pause di un ottavo.
1 34 2 A 1423 4 4234 4 23 4
eS
Do.9.6 Do Do. oDo [Link] Do Luv Due Tre Tao Due Pre Do Do Tan Do Tao
Per le note aggruppate.
-
Do Re Do Re Mi Do Re Mi Fa Do Mi Sol Mi Sal Mi
Do Mi Sel Mi Do Sol Mi Sol Do
Riteniamo utile riportace qui questa pagina originale di P. Bons che puo servire come esempic a scansione pratice.
Scale per conoscere i nomi delle note in tutte le chiavi
CHIAVE DI VIOLINO
Ascendente
Re Do gj
Sia
2e o Lb Sl
$
e
19
Ibe
ile
Wt
lip
loz
é ——
Mi Fa Sol
la Si Ty Ba
trhe
Per Estensione
as =
se
L’allievo quando sia in possesso del nome delle note che compongono Ie prime due
Scale potra. passare alla lettura della prima parte
CHIAVE DI BASSO
Fa Sol La Si Do Do Si ta sol py
Re Mi
Do Mi Re be
BS = es
Ascendente Discendente
F See
sue oe ; ie LSS SS
one Mom ot te Sm MS wi Re DS
Sol Sol
Mi Fa Fay
aj pth Se see a 5 PB wm uo xy
yer eo = 2 SF = SSS es
weeFSPzrSEZgS=Ezza=E
Do De 12 3 Ss
Si te Do st te ol me mt Re
© De
Reo Mie Fa@ Se
1
‘xis oO rs =
RIEPILOGO oN
rae
aS a
SSS he IS OS
SF Les NT DOS
Per Estensione ~
fav
al
ze
CHIAVE DI TENORE
Ascendente Disoendente
—— =
Sa 2 ea SS
Do Re Mi Fe Sol La Si Do Do Si La Sol Fe Mi Re Do
Le si Do Do Si Ls
i Fa Sol Pe Sol pe
Do Re Mi ef 2e Mi Re py
——— 2 2 & Se 5 4h
Do
Pe So La St
_ si bo ke Ceo 22
=
8 =e
SSS oe =
oe La
SSR vo we MM Sol
CHIAVE DI SOPRANO
Ascendente ex_Diseendente
— =r :
= es
Do Re Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Re Do
Fa Sol be Sd Pe Mi gy
2 Zo ‘ Do
i = a
3S
a <= ss
ve S
Do Re Mi Fa Sol Sd Fa Mi Re Do Si La Sl
si Do
=
CHIAVE DI MEZZO-SOPRANO
Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi Re Do
Ascendente Discendente —
" cs
Do Re Mi Fa Sod Ie St PO PO Si Le sa me an
Be
eal
—=> oo
Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol Mu Mi Re Do Si La Sol
Do Re Mi Fa Sol
soa La Si 2
Fa saa oo e222 Ft
= o_o = == =
ead si Do Re Mi
Toe Mi Fa Sot La 8
CHIAVE DI CONTRALTO
Ascendente Discendente 7
=
>See SSS
Do Re Mi Fe Sol La St Si te so me Mi Re ne
aI
2 4l
4
Dem # AH a yw RS
La soi
CHIAVE DI BARITONO
Do Re Mi Fa Sd La Si Do Do Si La Sol Fa Mi Re Do
i
Dn es
7 : =
Ascondente Discendente
9g
0
es
Sol La Si Do Re Mi Ke Sol Sol Fa Mi Re Do Si La Sol
Sol fe Mi Re
sol ta St Do Si ta gol
=4l|
= ue ko sire lao
Feci precedere queste seale allo scopo che I’allievo prenda cognizione delle note
nella chiave di cui andra a far studio di lettura, raccomando peré diesercitarsi anche
nella chiave di Violino in cui é scritto il presente metodo, ancorché questa, non gli appar-
tonesse.
PARTE PRIMA
Scale di Semibrevi
Lento
Idem di Semiminime
Idem di Crome
4.
Idem di Semicrome
6.
Idem.
Saltidi Quarta
Salti di Quinta.
12:
Idem.
Salti di Sesta.
15.
4
Idem. °
16. eS SSS SS
s ¥ T T r
Idem.
10
Salti di Settima.
18.
“SS
Salti d’Ottava.
21. ——
Idem,
Y
Pa a
22. =
.
Idem.
23.
Salti di Nona.
27.
Idem.
28.
Sati di Decima,
30.
Idem.
31.
Idem.
2 2
ee ee oor.
Salti misti.
BR.
33.
Idem.
34.
.
Idem.
35.4
36.
Scala con diverse figure
387,
38:
39.
Pigcoli Solfeggio Esempi di figure frammiste da pause
&
3
=
SoS
Ja
>
43.
0h SS eS
Del punto semplice
53.
Idem,
54.
Del punto doppio
5%.
a
16
Esempio misto.
58.
La legatura, che trovasi sopra due note diegual nome 0 posizione, fa tacere
il nome della seconda. conservandone il valore.
59.
pS
7
E necessario che i! Maestro faccia conoscero all’allievo icasi in cui il punto, la le.
Gatura ele sincope producono V’istesso effetto.
Punto semplice
Legatara Sincope Legatura
ESEMPIO: fA
DELLA SINCOPE
=|
|
=
aan ee
a]
es
Esempi dituttii salti allo seopo di sciogliere la lingua prima di passare ai
Solfeggi della Parte seconda.
67.
68. he
Salti misti =
73. Sara Sta
SCALE DI BISCROME
Fam
oe ie
A.
FINE DELLA I PARTE
PARTE SECONDA
21
Maestoso.
76.
22
Andante
77
Allegro moderato.
78
23
Andantino.
Larghetto,
80 Ser
24
Allegro moderato assai.
81.4
Andante mosso.
25
Larghetto.
83.
Allegretto.
86 : —=
a7
Moderato assai.
87.
28
Sostenuto
89,
—
<= = +
eS.
Moderato assai.
30
Andante
ot ae bees TTT
: Fert } on
a
Allegretto,
93.
@ piacere ear
(WY Accentar bene aneorebh Cadenza,
32
Andante.
Moderato assai.
95. §
34
Allegretto moderato assai —-
ae =
96.
Allegretto moderato.
98. 2
@) a piacere
Gopi ete
FINE DELLA Ll, PARTE,
(@) Accentar bene ancorché Cadenza.
8 PARTE TERZA
Questa parte contiene pressoché tutte le combinazioni della divisione in tutti
gli otto tempi, segni di richiamo, ¢ le abbreviature piii usitate.
Allegro moderato
99.
40
Andante mosso
a 3 ot Zz
101.
Al
Larghetto
102.
Maestoso
42
ot be
6
=
==
103.
£
oe
=
=
=
or te
Allegro giusto
104,
Andante sostenuto a5
106.
46 .
Allegro vivace
73.
107.
Adagio
108. bia th
=
48
Andantino grazioso
a enue
fee a
(aye eae
Moderato assai
110.
E F
Sea
50
Moderato
i. 3
_ Grave
LRG ee
con espressione
5
2 Adagio
us. ES Pager eas
54
Allegro con brio
1S
=
a
ee,
Ae
pe
ae
abet
*
ret
Sostenuto
118. but fr 5
56
117.
Segni di abbreviazioni e di richiamo
Allegro mosso
at _
sferstes
*
Allegro spiritoso 57
58
Altri segni di abbreviazioni
Allegro
119.
[Link]%y 8 ara
Pit mosso
oe
Sar
SS
60
Tn quest’ ultimo Solfeggio sono riuniti tuttiitempi onde abituare 1’ Allievo al
cambiamento istantaneo.
Allegro moderato
120.
Allegretto
a piacere
Andante mosso
61
Allegro giusto +
5 SS ee rE a tee fees
ce = Se
oO Andantino
62
Vivace
t=
Sostenuto
)
hy
te
i
>
cate
i.
ei tet
=
Allegro molto
bee pferpieipeitsierett eiten tite
SSS
a
FINE DELLA III. PARTE
sh
8
Potrebbero piacerti anche
- Teoria Musicale - Pasquale Bona - Metodo Completo Per La Divisione PDFNessuna valutazione finoraTeoria Musicale - Pasquale Bona - Metodo Completo Per La Divisione PDF75 pagine
- Pasquale Bona Metodo Per Il Solfeggio e La DivisioneNessuna valutazione finoraPasquale Bona Metodo Per Il Solfeggio e La Divisione111 pagine
- Teoria Musicale e Solfeggio Per MargheritaNessuna valutazione finoraTeoria Musicale e Solfeggio Per Margherita25 pagine
- BONA Pasquale Metodo Per La Divisione CoNessuna valutazione finoraBONA Pasquale Metodo Per La Divisione Co112 pagine
- Poltronieri - Lezioni Di Teoria Musicale PDF75% (4)Poltronieri - Lezioni Di Teoria Musicale PDF138 pagine
- Teoria Musicale - Nerina PoltronieriNessuna valutazione finoraTeoria Musicale - Nerina Poltronieri138 pagine
- Che Cosa Sono Le Chiavi e A Cosa ServonoNessuna valutazione finoraChe Cosa Sono Le Chiavi e A Cosa Servono7 pagine
- Appunti Di Lezioni Di Teoria MusicaleNessuna valutazione finoraAppunti Di Lezioni Di Teoria Musicale11 pagine
- Lazzari, Teoria Musicale e Lettura Ritmica INessuna valutazione finoraLazzari, Teoria Musicale e Lettura Ritmica I48 pagine
- MÚSICA - Il Solfeggio E La Teoria MusicaleNessuna valutazione finoraMÚSICA - Il Solfeggio E La Teoria Musicale15 pagine
- Elementi Base Di Teoria e ArmoniaNessuna valutazione finoraElementi Base Di Teoria e Armonia57 pagine
- Compendio Di Teoria Musicale - Francesco Alessandro GrilloNessuna valutazione finoraCompendio Di Teoria Musicale - Francesco Alessandro Grillo34 pagine
- Teoria Musicale Dispensa Per Principianti PDFNessuna valutazione finoraTeoria Musicale Dispensa Per Principianti PDF20 pagine
- Nozioni Elementari Di Teoria Musicale - Simone MarinoNessuna valutazione finoraNozioni Elementari Di Teoria Musicale - Simone Marino16 pagine
- Silvano Carella - Elementi Fondamentali Di Teoria Musicale100% (2)Silvano Carella - Elementi Fondamentali Di Teoria Musicale142 pagine
- Pozzoli, Sunto Di Teoria Musicale - I Corso100% (4)Pozzoli, Sunto Di Teoria Musicale - I Corso23 pagine
- HOT STUFF Accordi 100% Corretti - Donna SummerNessuna valutazione finoraHOT STUFF Accordi 100% Corretti - Donna Summer2 pagine
- Alphonse de Liguori - Quanno Nascette NinnoNessuna valutazione finoraAlphonse de Liguori - Quanno Nascette Ninno2 pagine