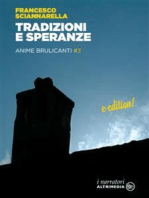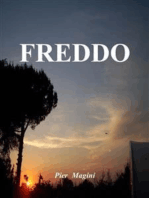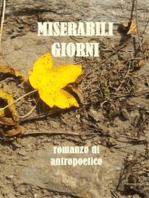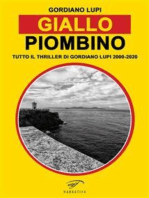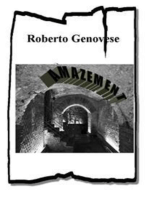Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Enrico Vaime. I Cretini Non Sono Più Quelli Di Una Volta
Caricato da
Alex Mirò0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
957 visualizzazioni39 pagineTitolo originale
Enrico Vaime. i cretini non sono più quelli di una volta
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
TXT, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato TXT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
957 visualizzazioni39 pagineEnrico Vaime. I Cretini Non Sono Più Quelli Di Una Volta
Caricato da
Alex MiròCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato TXT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 39
Enrico Vaime
I cretini non sono più
quelli di una volta
Aliberti editore
Tutti i diritti riservati
© 2008 Aliberti editore
Promozione e distribuzione RCS Libri
Sede legale:
Piazza del Popolo, 18 00187 Roma
Tel. 06 36712863
Sede operativa:
Via Meuccio Ruini, 74 42100 Reggio Emilia
Tel 0522 272494 - Fax 0522 272250 - Ufficio Stampa 329 4293200
Aliberti sul web:
www. alibertieditore. it
www. alibertistudi. it
www. myspace. com/ editorealiberti
www. myspace. com/ alibertistudi
www. blogaliberti. it
info@alibertieditore. it
I cretini non sono più quelli di una volta
I
La rivoluzione è scomoda
«Milano va presa di petto. Se non vuoi che ti prenda
per il culo».
Gliela rimproveravo ogni volta questa frase facilotta
a Nino. Che pure in genere ammiravo nel suo
comportarsi da uomo elegante e sicuro di sé e del
proprio ruolo in una società che sembrava averlo
accolto nel suo provvido seno (seppure da poco).
Mi portava con lui a mezzogiorno al Biffi Scala
dove un pasto corrispondeva più o meno a una settimana
di paga (mia). Per lui era un sopportabile
prelievo dalla liquidazione, un rivolo che scivolava
via senza scalfire la sua signorile tranquillità né turbava
il distacco dell'uomo che, nella propria scala di
11
valori, aveva collocato il denaro verso il fondo.
Quando lo licenziarono dal giornale non si scompose
minimamente. Assunse un'aria annoiata (dissero
i testimoni oculari della scena) e interruppe il
dirigente incaricato del non facile congedo, sudato e
quasi al panico, con un gesto della mano. Un gesto
(come l'avessi visto) leggero e benedicente, tipicamente
suo.
«Mi chiami un taxi» disse con naturalezza.
Il licenziatore (che poi prese il suo posto un po'"a
sorpresa ma mica tanto) cercò una reazione sdrammatizzante.
«Ci davamo del tu» modulò con voce piena di
garbo.
Nino ripeté il movimento della mano. E, con un
sorriso lieve quanto il gesto, gli indirizzò un confidenziale:
«Chiamami un taxi. Stronzo».
Erano trascorsi più di sei mesi. E Nino era ancora
a spasso. In parola con diversi editori, ma la sua
era una situazione non facile.
Bravo era bravo. Ma recuperato al giornalismo
delle grandi testate da troppo poco tempo per cancellare
un passato barricadero nell'informazione di
12
partito. C'era persino chi gli rimproverava quella
ritirata che poteva sembrare strategica, quell'abbandono
di campo, sul rumore dei cingoli dei carrarmati
sovietici. Addio al mestiere un po'"avventuroso
senza macchia e senza paura.
Si trovarono delle macchie. E arrivò la paura. E
anche l'invito a entrare nella grande famiglia di un
grande quotidiano di grandi tradizioni (e grandi
rese, negli ultimi anni).
Cercavano teste lucide e facili da tagliare in caso
di pericolo. E Nino lasciò Roma e si trascinò al
Nord insieme a un pugno di fedelissimi, una banda
che conobbi nel tempo, nella quale il reducismo
(spesso cordogliante) era fortunatamente bandito.
Molto uniti, solidali. Affettuosi persino, fra loro.
Anche negli scazzi violenti, fatali fra maschi che agiscono
nello stesso territorio, si comportavano come
dei fratelli che litigano, ma si capisce che la disputa
è destinata a ricomporsi.
Ci vorrebbe un episodio significativo per spiegare...
Ricordo una scazzottata sulla riva del Naviglio, una
rissa furiosa che sembrava potesse finire solo con
13
l'eliminazione dell'altro. Nino e Roberto erano due
furie inarrestabili. Io, estraneo al litigio che non
ricordo neanche perché fosse scoppiato, cercai di
intromettermi. Inutilmente.
I due si scambiavano colpi micidiali. Nino, per
mollare un calcio all'avversario, perse un mocassino,
che prima volò sulla faccia di Roberto spaccandogli
gli occhiali, quindi finì nel Naviglio. Il mocassino si
allontanava galleggiando magicamente sull'acqua
fetida. Nino corse lungo la riva nella speranza di
riacchiapparlo se si fosse impigliato nei ciuffi di
canne che spuntavano qua e là nella corrente. Ma il
piede scalzo lo costringeva a un'andatura troppo
lenta. Così Roberto, mezzo cecato, lo sostituì nell'inseguimento.
E riuscì a ripescare la scarpa spenzolandosi
sull'acqua aggrappato a un palo. Si infradiciò,
ma riuscì.
Restituì il mocassino lasciandolo cadere davanti a
Nino, che sbanfava nel tentativo di recuperare il
fiato. Si incamminarono affiancati verso la macchina
(una patetica Dauphine), vicino alla quale mi ero
fermato ad aspettare la conclusione di quella lotta
dissennata.
14
Nino raccolse da terra gli occhiali di Roberto.
Reinfilò alla bellemeglio le lenti nella montatura
sghemba e la passò a Roberto che la inforcò. E insieme,
in silenzio, raggiunsero la Dauphine. Nino si
sistemò al posto di guida. Azionò le sicure impedendo
a Roberto di salire.
«Puzzi» gli disse. E partì. Mollandolo fradicio dell'orrenda
acqua del Naviglio.
Dopo cento metri bloccò l'auto. Scese. Tornò da
Roberto e gli consegnò le chiavi della macchina.
«Prendila tu».
Roberto dopo un attimo di indecisione si avviò
gocciolante verso l'auto. «Ti accompagno a casa»
propose a Nino.
«No. Con te in macchina non ci vengo. Puzzi».
Finì che ci sistemammo tutti e tre sulla Dauphine
lasciando i finestrini aperti perché l'odore defluisse
senza asfissiare nessuno.
«Puzzo sul serio?» mi chiese piano Roberto.
«Un po'».
«Ma è il sudore».
Non so quanto questo episodio, che mi torna in
mente ogni volta che a Milano passo per Porta
15
Ticinese, sia significativo per spigare...
Ci vuol altro.
Sempre per prendere di petto la città sfidandola per
esorcizzarla in base a quella sciocca tesi che non condividevo,
Nino affittò un appartamento alla Torre
Velasca, simbolo architettonico dell'opulenza arrogante.
C'erano solo uffici e locali di rappresentanza
in quel grattacielo che allora ancora stupiva (oggi
non più): costosissimi.
Nino ci abitava con Tosca e il bassotto Nikita.
Tosca era incinta. Anche se il suo fisico (era stata
una prima ballerina di successo) non suggerì mai
idee di maternità (il bambino lo perse al quinto
mese).
La sua attività professionale era abbastanza
ridotta: doveva essere sulla quarantina. Ma ballava
ancora. Soprattutto con la faccia, l'espressione del
viso. Ci sono danzatrici che riescono a esprimere
movimenti coreografici con gli sguardi: ballano da
ferme, si può dire. Ci sono, ci sono. Tosca eseguiva
fuettè con le palpebre, che ci crediate o no. Era
spiritosa. Molto.
16
Il suo passato da aristocratica e artista era più
denso di tutte le possibili biografie di noi figli spuri
di ceto medio illuminato (?), irrequieti e forse velleitari
prigionieri (complici) di un sistema che non ci
piaceva. Ma non eravamo in grado di cambiare: lo
sospettavamo ormai tutti.
La rivoluzione è scomoda. Meglio il riformismo.
Che magari ti concede dei momenti liberi per
distrarti.
Quando i discorsi prendevano questa piega, nel
gruppo c'era sempre qualcuno che offriva da bere o
suggeriva un film sperando di salvare la serata. Di
politica si parlava ormai solo per cause di forza maggiore,
perché pioveva e non era il caso di uscire, perché
qualcuna ci aveva dato buca, perché qualche
fastidio o piccolo- grande inghippo ci impediva una
qualunque rilassante soluzione serale.
La nostra situazione generale - mi rendo conto
raccontandolo - era sconcertante e gli atteggiamenti
di molti di noi si potevano definire patologici. I
miei amici, verso i quali involontariamente avevo un
atteggiamento gregario, stavano cercando di assorbire
un trauma generazionale. Che non era esattamen-
17
te il mio, che avevo diversi anni di meno, ma lo
capivo e condividevo solidarmente: dovevano ricaricarsi,
non so come dire. Qualcuno addirittura
immagino pensasse di dover essere risarcito, anche
se magari solo moralmente, per le delusioni che il
mondo («la società», dicevano con sempre minor
convinzione) gli aveva riversato addosso.
Roberto era stato partigiano. Era difficile farlo
parlare di quella sua esperienza. Solo con me si
lasciava andare a piccole confidenze, racconti che
troncava spesso con rabbia prima di una conclusione.
Con me si apriva perché ero lontano dalla sua
generazione, non mi sarei permesso contestazioni
ideologiche come alle volte succedeva in certi
momenti commemorativi con i coetanei.
A me diceva la verità perché ascoltavo senza contestare
le sue opinioni confrontandole con le mie:
Roberto parlava di anni in cui io ero ancora pì"" o
meno in fasce e lui già in Marina. Tra noi c'erano
quindici anni di differenza. Io, era l'inizio di un'estate
del secolo scorso, facevo gli esami di terza a casa
della maestra che la scuola era chiusa. Roberto era in
Grecia. Quando la maestra Binucci mi chiamò per
18
interrogarmi (eravamo in dieci: ero come sempre
l'ultimo) suonò la sirena. «Promosso» mi disse la
Binucci senza farmi nessuna domanda. E scendemmo
in cantina: cioè passammo in quarta.
Tornai a casa dopo il cessato allarme.
Anche Roberto decise di ritornare a casa, più o
meno in quei giorni. Disertò. Andò coi partigiani
greci. Poi coi commandos inglesi. E con loro sbarcò
in Italia, alle foci del Po. Aveva una specie di brevetto
partigiano scritto in inglese e firmato da un capitano
che diventò famoso negli anni Cinquanta
come produttore cinematografico. In poche righe
riassumeva un pezzo di storia della Resistenza ricostruito
poi da Rossellini in un celebre film. Che
Roberto non volle mai vedere.
«Non ho mai sparato un colpo» confessò. Ma un
tedesco sì, l'aveva ammazzato: questo uscì nel corso
di una sbronza in una di quelle serate storte che mi
facevano un po'"paura.
«Con una baionetta» disse senza spiegare oltre.
Poi gli diede di volta il cervello. E per un anno
passò da un ospedale militare a un altro, con nessuno
che poteva fare qualcosa per lui che non riu-
19
sciva a dormire e aveva dei mal di testa che lo facevano
urlare.
Finì a Terni. Strana destinazione per un tenente di
vascello. Poi di solito il racconto, più volte interrotto
nel tempo, si faceva convulso. C'era dentro anche
un matrimonio con una donna molto più grande di
lui. Della quale in seguito non seppe più nulla. Se
non che era viva e questo gli aveva impedito più
volte di risposarsi.
«Per fortuna» commentava.
Quindi, Roma. Ufficio Stampa del Ministero
della Marina. Da lì, i giornali: per quello del partito
fu utile il brevetto scritto in inglese.
«Mi devono restituire almeno vent'anni» diceva.
Ma chi?
20
II
La laurea vale tre anni
Nino aveva un atteggiamento un po'"diverso. Per
quanto anche lui a volte sembrava avere una specie
di conto in sospeso con qualcuno. Che poteva anche
essere lui stesso. O il destino.
Per la verità non gliel'ho mai sentito nominare,
il destino. No, non era da lui. Adesso che ci penso
neanche con la società ce l'aveva. Strano, no? Nino
l'intenzione di rimettersi in gioco non l'aveva mai
persa. Forse aveva perso delle certezze, come altri
della banda, ma non ce l'aveva con nessuno per
questo.
Mi fece prendere al giornale senza conoscermi
quasi. «Perché?» gli domandai una volta.
23
«Perché eri piaciuto al mio cane» disse.
Esperienza nel settore non l'avevo. Ero arrivato da
Roma un po'"frastornato. M'avevano tenuto alla
radio in via Asi, 70 per farmi impratichire. Chissà di
che, dato che lì, se volevo fare qualcosa di meno che
idiota, me lo dovevo inventare io. Se no i miei incarichi
erano una firma in calce ai verbali di trasmissione
prestampati: c'era solo da aggiungere la data.
Telefonate ai funzionari di servizio delle altre sedi
(allora si trasmetteva da diverse città e si confermava
al telefono il passaggio della linea), la gestione di
un branco di annunciatori, tantissimi, molti di più
di quanti ne servissero, vogliosi di esibirsi al microfono
anche per scarni comunicati. Avevano tutti il
contratto a tempo indeterminato e aspettavano di
venire in qualche modo utilizzati in uno stanzone
vicino all'ingresso.
Una quindicina: talmente caratterizzati da sembrare
involuti e, nel raccontarli, può sorgere il
sospetto che fossero inventati. Invece no. Su quindici
annunciatori, cinque erano affetti da zoppia.
Vederli muoversi in gruppo era spettacolare, grottesco.
24
C'era quello che aveva avuto la poliomielite,
quello con una gamba più corta dell'altra, uno con
una gamba di legno (aveva una voce bellissima).
Uno con le stampelle. E un altro che, appoggiandosi
a un bastone, riusciva a camminare velocissimo,
quasi a correre.
Perché tanti claudicanti tutti insieme non riuscii a
scoprirlo. I pochi altri con gli arti inferiori efficienti
avevano ognuno qualche particolarità incuriosente.
Uno speaker famoso aveva un buco sulla tempia
destra e un altro buco alla stessa altezza sulla tempia
sinistra che faceva pendant: s'era sparato un
colpo di pistola.
Il proiettile aveva girato attorno al cranio e se
n'era uscito dalla parte opposta. Come potesse essere
avvenuto questo fatto nessuno lo sapeva spiegare.
D'altronde, anche chiedere all'annunciatore particolari
sul suo mancato suicidio non era possibile.
Un paio avevano disturbi del sistema nervoso,
così dicevano gli altri senza perdersi in dettagli.
Uno praticava una specie di yoga. Stava ore con lo
sguardo fisso al soffitto. Si vedeva soprattutto il
bianco degli occhi.
25
Se fossi rimasto in quel posto più dei due mesi che
mi toccarono, forse sarei impazzito anche io.
Un amico pittore (che poi ebbe fortuna nel
tempo) mi consigliava di restare in quella gabbia di
matti perché li c'era la possibilità di scegliere l'orario
e quindi organizzare contemporaneamente un altro
lavoro, come faceva lui. Non me la sentivo.
Mi spostarono dalla comunità degli zoppi alle
onde corte: lì lavoravo al pomeriggio fino a notte.
Accompagnavo gli speaker delle ambasciate nei Riv
(le cabine di trasmissione) dove leggevano nelle loro
lingue notiziari generici quanto inutili trasmessi in
tutto il mondo.
Chissà che idea si facevano di noi gli eventuali
ascoltatori, ai quali fornivamo informazioni turistiche
e di costume di rara superficialità.
Capitò anche un incidente, chiamiamolo così,
legato a questi notiziari demenziali letti in tutte le
lingue. Compreso il tigrino e tigre (ci tenevamo ad
avere ancora velleitari rapporti con le nostre ex
colonie). A leggere questo notiziario per le zone
etiopi veniva un signore magrissimo, originario di
Salerno, che per anni era vissuto e aveva lavorato ad
26
Addis Abeba. Aveva anche l'incarico di tradurre in
tigrino e tigre quelle preziose notizie sul nostro
Paese dei campanelli.
Non conservò a lungo quel lavoro: qualche mese.
Perché alla direzione arrivarono delle lettere di protesta
che costrinsero i responsabili a intervenire.
Il magrissimo di Salerno, traduttore e interprete
non si sa da chi raccomandato, conosceva in effetti
pochissime parole della lingua che pretendeva di
parlare: cantilene di bambini, proverbi e soprattutto
parolacce, insulti e bestemmie. E proponeva nei suoi
notiziari questo materiale fonetico, contando sul
fatto che nessuno avrebbe mai ascoltato le trasmissioni
in quella lingua così particolare. Invece...
Lo cacciarono. L'azienda inviò una lettera di scuse
all'Ambasciata di Etiopia. Io riuscii a recuperare una
bobina del finto interprete di tigrino e tigre.
La traduzione era quasi impossibile, mi disse il
sostituto, un etiope- etiope. Parole messe in fila a
caso. Solo il saluto finale era (purtroppo) traducibile.
Diceva come congedo: «E adesso andate tutti a
fare in culo».
«Fino a quando reggerò?» mi chiedevo. Non
27
potevo domandarlo che a me stesso: ero isolato.
Non avevo più colleghi, non dico amici. Con quanti
avevano superato con me il concorso per quel
posto in Rai, avevo perso i contatti. Qualche raro
incontro alla mensa. La triste constatazione che eravamo
cambiati, ci stavano trasformando in funzionarietti
incravattati.
Qualcuno di noi aveva persino chiesto un ficus da
mettere in ufficio. E io, entrando nella stanza, mi
rivolgevo alla pianta invece che a quel mio ex amico
che stavo perdendo.
«Parli col ficus per sfottermi?» chiedeva.
«No. E che mi confondo. Ormai siete identici». E
uscivo dopo aver calorosamente stretto una foglia
nella mia mano destra. «Stammi bene».
Mi chiamò un direttore, un veneto con una gran
testa di capelli. Di quelli che camminano con tutto
il corpo, muovono inutilmente il movibile (braccia,
spalle, sopracciglia anche), danno l'impressione di
una globalità motoria inarrestabile. Voleva capire
che ci facevo nei corridoi in orari non tradizionali.
Raccontai con cupa ironia le mie giornate. Il
direttore ebbe un moto di solidarietà, disse che
28
capiva il mio disincanto, che era poi lo stesso da lui
provato in tanti anni. Gliene mancavano cinque per
la pensione.
E si perse in descrizioni di riscatti, anzianità, contributi.
Capì che mi stava perdendo. Con passo elastico
mi spinse nel suo ufficio. Aprì una cassettiera e
indicò dei pacchi di fogli.
«Ho scritto quattro romanzi» disse a bassa voce,
come se mi confessasse un brutto vizio. Poi, in un
accesso di vergogna, mi congedò. «Non lo dica in
giro». Sulla porta mi fermò con la frase: «La laurea
vale tre anni, per l'Enpals».
Di quel periodo ho ricordi inutilmente particolareggiati.
E delle foto fatte con macchine inefficienti
(Comet e Rondine Ferrania).
Perché mi ricordo i nomi e le marche di tempi
lontani e per il resto cancellati? Per quale stortura,
quale patologia?
Mi ricordo le racchette Maxima (e anche
Reanda),
gli attacchi da sci Kandar,
le penne Parker 51 e Aurora 88,
i tubolari Gardiol,
29
il cambio Campagnolo,
il Cucciolo Siata (col serbatoio che si sistemava
sulla canna e la bicicletta così sembrava una
moto),
le suole Vibram,
la Cisitalia,
l'Itala Pilsen,
l'auto Volugrafo a tre ruote,
il Doppio Kummel e il Triple Sec,
la Prunella Ballor,
il Liquore Galliano, giallo come lo Strega che
aveva copiato,
Kambusa (Uàn!) l'amaricante,
le Cremidea Beccaro,
la Tisana Kelemata,
la soluzione Schumm,
l'ischirogeno,
il Super Iride Benelli (Prato),
il dopobarba Floyd,
la Gomina Argentina (di papà),
il tabacco d'Harar,
la Colonia 4711,
la Limonina Rogé,
30
la Gi- vi- emme sul colle di Nava vicino alle stelle
le donne son belle le donne son belle,
Etrusca per uomini, Capriccio per le signore,
l'AutoUnion DKV,
il Resoldor Ah come respiro,
Allocchio Bacchini, Irradio, Geloso, Brionvega,
Leonora Ruffo,
Jenny Luna,
il Mago Bustellii,
l'attore Ermanno Randi (di Perugia) che fu ucciso
per gelosia da un amico,
Carlo Giustini che in Inghilterra era conosciuto e
in Italia me lo ricordavo solo io,
don Cippico,
Brusadelli, __^-^
l'ala Muccinelli,
i fratelli Sentimenti (il IV in porta),
Apò e Lucién Lazaridès,
Giordano Cottur e la Vilier Triestina,
Zaaf, ciclista di colore che vinse a un Tour de
France la tappa di Ginevra: io ero lì... e voi?
31
III
Molte si chiamavano Paola
Quasi tutte le mie ragazze si chiamavano Paola. No,
non è vero. Non quasi tutte. Molte. Chissà perché.
Poi ci sono state tre Marilena. Anche questo non è
normale. Ma neanche così significativo. Una
Marilena mi presentò una volta (era una presentazione,
come dire, ufficiale) chiamandomi Vittorio.
E come Vittorio figurai anche nei titoli di testa di un
mio lavoro. Ho chiamato Vittorio mio figlio.
Coincidenze.
Quando chiesero in Rai per non so più quali
ricerche chi era pratico di Milano, mi proposi. Bene.
Ero disposto anche ad andarci in trasferta per...? Sì.
Non vuoi sapere per quanto? No. Tra l'altro non ero
35
poi così pratico di Milano. Certe scelte sono quasi
casuali. Diventano quasi razionali col senno di poi.
Questa storia l'ho già raccontata. Forse più di una
volta. Se non si sta attenti si raccontano sempre le
stesse storie.
Quando decido di ricostruire un periodo della
mia vita (a pensarci, non faccio che ricostruire
periodi) parlo ogni volta del mio difficile impatto
con Milano (dopo i difficili impatti con Napoli e
Roma).
La scena iniziale (iniziale solo nella ricostruzione)
si svolge in piazza Beccaria. Spalle al locale di spogliarelli,
ti ritrovi di fronte a un grattacielino: un
edificio stretto tra due che stenta a innalzarsi ma ci
prova. Supera i due vecchi palazzi che lo fiancheggiano
comprimendolo e dopo un paio di piani si
ferma. All'ottavo. Forse erano finiti i soldi.
Ha (aveva, noi c'è più) vetri oscurati. L'avevano
pensato per farci degli uffici. Invece fu per qualche
anno un residence. Costoso e gelido come tutto
quello che si trova al centro della città, a un passo da
ovunque non devi andare se non eccezionalmente.
Comodo, sostengono. Non so per chi né perché.
36
Lì trovai un loft, come si dice. Con la sua parete
scorrevole per scoprire (o coprire) il letto a una piazza
e mezzo, misura classica per questi locali: la piazza
e mezza è quella pensata per le pratiche sessuali
non a lunga scadenza. Una coppia fissa chiede appena
possibile il formato matrimoniale. I fornicatori
invece preferiscono la monobranda abbondante
dove non si pensa tanto di dormire, ma solo riposarsi.
E non per molto.
Poi lei (o lui) se ne va. E l'altro si gode quella
mezza porzione di letto in più. Ah. In fondo anche
da soli non si sta male. Ah.
Sbaraccai dopo tre mesi, convinto che non avrei
più rimpianto quel posto che aveva il calore (e l'arredamento)
di una agenzia del Credito Italiano
(oggi Unicredit).
Invece mentre traslocavo (e mi aiutò Dolly, una
sana ragazza piemontese che s'era messa in testa di
fare grossomodo la puttana: lei diceva entreneuse,
sbagliando la pronuncia) il loft cominciò a mancarmi.
Ho sempre avuto la nostalgia precoce, mi mancano
persone e cose quando ancora ci sono.
Dolly aveva un modo di impattarsi coi problemi
37
pratici così tranquillizzante che, con la banale
scusa di un incontro in qualche modo sentimentale,
pensai di coinvolgerla nel trasbordo dal residence
all'attichetto di piazzale Giulio Cesare, che lei
riuscì a rendere abitabile in mezza giornata. Che
brava. Quando le manifestavo la mia ammirazione
per il suo essere organizzativa e razionale, Dolly si
incupiva: la sua aspirazione era un'altra. A lei (pur
non avendone le qualità) interessava diventare
antrenuse, ìntrenes, enternos, e via con altri tentativi
per dire "zoccola di lusso", mestiere improbabile
per una come lei.
Quando si litigava, più per scherzo che per ragioni
vere, io la spaventavo dicendole: «Sposerai un
commercialista e avrai cinque figli». Lei rispondeva:
«E tu diventerai frocio».
E" andata diversamente per tutti e due.
Scrivevo molto, in quel periodo. Cambiando stile,
genere e committenza. Ci fu anche qualche occasione
nel campo della pubblicità che, pur non
potendo permettermelo, suscitava spesso il mio
disgusto e perfino, eccezionalmente, qualche rifiu-
38
to: mai trovati tanti mediocri tutti insieme.
Mezzecalze e bilingui: non c'era cazzata che non
venisse protetta dalla versione inglese, non reperivi
incombenza della quale non si fornisse una definizione
di riscattante esotismo. Ogni tirapiedi si
definiva account, ogni suggeritore di poco più che
nulla era un copy. Io mi appoggiavo ad amici che
cercavano di placare certe mie furie critiche facendomi
lavorare senza comparire.
Le poche volte che fui costretto alla presenza a
dei brainstorming (accolita di cazzoni obbligati alla
creatività di gruppo) rischiai di far saltare progetti
di intere campagne per il gusto (o il vezzo, vah)
della battuta. Per stimolare il parto d'uno slogan di
lancio d'una maionese, si perse una mattina in
continui assaggi: il consumo del prodotto, sosteneva
uno dei committenti, avrebbe facilitato il guizzo
pubblicitario.
«Cosa vi viene in mente?» chiedeva il cretino
guardandoci deglutire tozzetti di pane sbaffati di
crema gialla. Suggerii, in preda a sfinimento:
«Pestatela: porta fortuna». L'allusione restò misteriosa
più a lungo del prevedibile.
39
Dopo mi evitarono nel giro delle proposte. Ero
già stato segnalato per analoghe provocazioni: per la
campagna promozionale "Panettone più Colomba"
il mio contributo, scartato sì ma sempre con una
preoccupante lentezza, era stato: «Le disgrazie non
vengono mai sole».
In un solo caso non subii alcuna provocazione
dolorosa. Quando un amico attore popolare pretese
la mia collaborazione, mi impose insomma. La cosa
mi spaventò oltre che lusingarmi. Perché il committente
pubblicitario mi trattava con timorosa reverenza
non lesinandomi occhiate che forse volevano
essere allusive: ero per caso l'amichetto di...?
Su quel mio amico circolavano voci maliziose:
troppo educato, troppo disponibile. Invece era solo
e spaventato. Perseguitato da un desiderio di intimità
familiare che non riusciva a ottenere legato patologicamente
alla propria madre e alle madri di tutti,
anche alla mia che aveva visto solo qualche volta a
Napoli. Religioso fino alla superstizione e viceversa.
La sua fragilità mi commuoveva.
Restò per anni a pensione (lui che guadagnava
cifre pazzesche) da una vecchia laida in zona Fiera.
40
«Per lei sono come un figlio» diceva. Infatti la
megera lo prevaricava, si faceva strapagare per una
stanza che era un buco, esigeva una deferenza che il
mio amico le concedeva arrivando a forme di
incomprensibile servilismo: le massaggiava i piedi
per lenirle certe artrosi secondo me inventate.
Presi, per due serie di Caroselli, delle cifre che
mai sarei riuscito a chiedere: mi furono offerte,
credo, per tranquillizzare il protagonista mio sponsor
sfegatato.
Il primo assegno che mi arrivò avventurosamente
(il portiere del residence aveva in un primo momento
respinto la busta) mi permise un salto a Venezia
dove avevo una ragazza (si chiamava Paola: già).
Al Festival del Cinema. Dovetti anche comprare
una giacca bianca da smoking, altrimenti non mi
avrebbero fatto entrare alla proiezione di Il giudizio
universale di De Sica.
Avevo intanto conosciuto, girando la seconda
serie di spot, un produttore esecutivo arrivato alla
pubblicità dal cinema vero.
Personaggio avventuroso come se ne incontravano
una volta, quando i vecchi affascinavano più dei
41
giovani: Leo era stato coinvolto in grandi film con
grandi maestri seppure con mansioni scarsamente
chiarite. Ma aveva questo passato che oscurava qualsiasi
palmarès di quei fregnoni dell'advertising che lo
circondavano spesso schernendolo. In quel trascorso
Leo si rifugiava per sfuggire a un presente di molteplici
difficoltà. Riusciva a sopravvivere con degli
espedienti dei quali si favoleggiava.
Forse attirò anche me in una delle sue complicate
combinazioni di fuga dai debiti. Ebbi questa
impressione: mi invitò al suo residence per un aperitivo.
Al bar mi sembrò avesse nei miei confronti uno
strano comportamento: ostentava deferenza, quasi si
sentisse lusingato del fatto che fossi lì. Mi indicava
sorridendo a dei signori che mi guardavano incuriositi.
Mi presentò al direttore aggiungendo un «il mio
amico del quale le ho parlato» di misteriosa e preoccupante
natura.
Ebbi la sensazione che mi avesse annunciato come
persona in grado di riscattare una sua più che probabile
morosità. Scoprii che era proprio così. Io
figuravo, nel suo fantasioso racconto, come rappre-
42
sentante di una mitica produzione che stava per partire:
con me sarebbero arrivati i danari di un saldo
lontano fin troppo promesso.
Quel Campari consumato sotto gli occhi incuriositi
e speranzosi di tutti riuscì a protrarre un credito
chissà quante volte rinnovato. Leo non mi
mollò per tutto il rito dell'aperitivo presentandomi
il presentabile e oltre. Mi accompagnò poi all'uscita.
Sulla porta del residence disse improvvisamente
ad altissima voce (era comparso il direttore):
«Allora si comincia tra poco... Bene!» Poi, piano:
«Forse lunedì vado in Colombia». Concluse in un
soffio: «E ci resto».
Mi abbracciò a sorpresa. «Ti voglio bene» disse.
Pensai che non l'avrei più visto.
Non andò in Colombia. Lasciò Milano e chissà
quanti creditori. Ricomparve sul «Corriere» sotto
forma di necrologio anni dopo: ringraziava tutti e si
scusava con quanti «si sarebbero aspettati di più da
lui». Capii a cosa si riferiva il vecchio.
In seguito ricostruii alcune delle sue ultime tortuose
vicende finanziarie. Era ridotto così male che
contattò un fratellastro col quale non aveva mai
43
intrattenuto rapporti: era un figlio avuto dal padre
fuori dal matrimonio. Portava infatti il cognome
della madre e il vero padre, il papà di Leo, non l'aveva
mai visto.
Leo gli propose l'acquisto del ritratto del genitore
comune, un olio conservato con devozione per tanti
anni. Era giusto che finisse nelle mani dell'altro
figlio. Che lo comprò commuovendosi.
Poi si scoprì che l'uomo del quadro non era il
padre di nessuno: era un signore qualunque davanti
al quale i fratellastri avevano però versato lacrime
vere. Persino Leo.
44
IV
Non si fa un provino a una contessa
Col secondo assegnone della cifra imprevista (fu
più l'imprevedibilità che la consistenza a stupirmi)
decisi di riparare a certe falle di relazione del recente
passato. Invitai anche, cedendo all'euforia del
momento, la banda di Nino (dalla quale per
incombenze professionali mi stavo allontanando: le
mie collaborazioni giornalistiche diventarono sporadiche),
al Biffi Scala. Mi accorsi che serpeggiava
uno strano rancore, una sorta di malessere di gruppo.
E la causa era Nino, una sua scelta giudicata
scorretta da quella comunità di moralisti libertini.
«Ci sono cose che non si possono fare» dicevano
all'incirca quando chiedevo la ragione del clima teso.
47
Nino s'era messo con la moglie di un amico
comune. Toccò a me, il meno coinvolto anche emotivamente
(forse), cercare di rimediare, chiarire, fare
da paciere.
Sbagliai tono fin dall'inizio: «... con la donna di
un amico!»
«Io le donne dei nemici non le conosco» rimandò
Nino. E non accettò alcuna obiezione. Anzi divenne
acido e aggressivo. Facevo obiezioni formali, difendevo
un concetto di amicizia da clan: e i sentimenti?
Anche l'amicizia è un sentimento. C'è una classifica
dei sentimenti. O no?
«Perché nessuno di voi parla di Tosca?»
Già, perché?
«Nessuno si preoccupa del suo dolore, dell'offesa
che ha ricevuto...»
«Da te».
«Sì, va bè. E allora? Tutti a preoccuparsi del povero
Ugo e basta...»
Ugo è un "amico".
«E se fosse uno stronzo?»
«Non mi dire che ti sei messo con Silvia perché
Ugo è uno stronzo...!»
48
«Sì» rispose. «Soprattutto per questo».
Ero tentato di credergli. Ma non lo ammisi se non
verso la fine di quel percorso indagatorio che stava
prendendo altre pieghe. Era vero che avevamo tutti
(Nino forse meno degli altri) un concetto quasi
mafioso dell'amicizia. Al punto che io, in un certo
senso portavoce del clan, ero lì con intenzioni padrinesche:
vediamo di rimediare, ricompattiamoci...
Finì che studiammo una serie di iniziative riparatone
di rara ipocrisia. Vinse ancora una volta la connivenza
generazionale.
Silvia tornò con Ugo che non s'era mai mosso,
disposta a subire per chissà quanti anni (forse per
sempre) quel sottile rancore così ben coltivato
soprattutto dagli stronzi (Nino purtroppo aveva
avuto ancora una volta ragione). Prevedibili, eterne
allusioni, continui sospetti degli insicuri, degli scottati,
quelli che non dimenticano perché non sanno
quanto è bello non ricordare. Il fascino discreto dell'amnesia
è degli eletti.
Forse anch'io un giorno...
Tosca tornò alla Torre Velasca. Suturò con l'ironia
e la scioltezza dei veri signori ogni ferita. Solo io
49
l'avevo vista piangere. Ma negai la circostanza
sapendo che avrebbe apprezzato.
L'aristocratica che ballava con i lineamenti veniva
da lontano e seguiva dei suoi ritmi immaginari. Gli
squarci del suo passato arrivavano a volte a illuminare
il mistero di quella carismatica leggerezza: racconti
riportati con la disinvoltura di chi non si scompone
e si aspetta di tutto perché in fondo non ha bisogno
di niente.
Il grande Totò, per dire, la volle nella sua compagnia
teatrale tanti anni prima («Ero minorenne»
spiegava Tosca per non preoccuparci), insieme al
cantante Basurto (barone) e all'attore Bentivoglio
(marchese come il costumista). La scritturò così,
senza approfondimenti professionali. Il Principe de
Curtis dichiarò: «Non si fa un provino a una contessa».
Erano cazzate che affascinavano. Non solo me.
Quando a Lugano con Nino partecipammo a un
programma tv semisperimentale da noi proposto e
organizzato (c'era anche Tosca) restammo un intero
pomeriggio in una sala prove a parlare. Come se non
avessimo avuto alternative logistiche per una chiacchierata
fra amici che quella specie di palestra spettrale.
50
Fiumi di ricordi, sfoghi, autobiografismo, paccottiglia
psicoanalitica, parole parole parole, bugie,
verità. Io e Nino riversammo uno sull'altro quello
che ci passava per la testa in quel tempo. Tosca ci
guardava come ci vedesse per la prima volta (forse
era così). Quindi, svuotati, aspettammo che anche
lei dilagasse, ci seguisse in quell'indefinibile esperimento
di parapsicologia inconsapevole. Tosca ci
guardò a lungo. In silenzio.
Poi si mise a ballare. Senza musica.
E ballando se ne andò dal salone dopo un inchino,
lasciandoci giustamente, disperatamente soli.
Anni e anni dopo, uscendo da un ristorante
romano vidi Nino. Lo riconobbi nonostante
un'enorme barba coltivata per coprire la faccia offesa
da una paresi. Mi fermai al suo tavolo.
All'improvviso, una frase: «Ti ricordi Lugano?»
«La sala prove...»
«Un pomeriggio sano a parlare...»
«Ma cosa ci siamo detti poi?»
«Io ricordo solo quello che disse Tosca».
Rise Nino. Con la bocca storta.
51
V
Incontrare Sandokan
Con Lucio Mastronardi mi mise in contatto Kezich,
che in quel periodo curava delle serie televisive.
C'eravamo già conosciuti, con Lucio, dopo il successo
del suo primo romanzo, quella storia del calzolaio
di Vigevano così lucida e crudele, così partecipata.
Così simile al suo autore, uomo complesso,
pieno di tormenti e giustificate insofferenze, assai
provato dalla volgarità dell'ambiente dal quale non
riusciva comunque a staccarsi.
Andammo insieme a Roma a parlare in direzione
del progetto che sembrava stesse per realizzarsi e
Lucio soffrì di nostalgia per quel suo paese appena
lasciato al quale faceva, senza volere, continuo rife-
55
rimento e dal quale era così condizionato.
Ammise che, come i suoi compaesani, la prima
cosa che guardava nel prossimo erano i piedi, le scarpe.
Aveva un'espressione stupita impressa nel volto e
parlava col tono basso di chi ha paura di disturbare
il prossimo che tanto lo spaventava e del quale aveva
così bisogno.
Aveva insegnato in una scuola della sua città per
diverso tempo, cercando di non far vedere il disagio
di quelle frequentazioni. I discorsi banali dei
colleghi lo offendevano quanto quelli degli allievi,
identici ai padri padroncini di fabbriche e fabbrichette.
Lucio cercava di reprimere l'orrore della banalità
di chi lo circondava. Ma poi finiva per sbottare.
Come quando assalì un collega che gli parlava
quotidianamente della sua auto Fiat 850 Deluxe
comparandola alle altre. Tutti i giorni, mi spiegò
Mastronardi. Che non riusciva a liberarsi dell'interlocutore
monotematico. Anzi, quasi era spinto a cercarlo
negli intervalli dedicati esclusivamente alla
meccanica e alle prestazioni della Deluxe. Finché un
giorno, senza alcun preavviso, al primo accenno non
56
so se al carburatore o che, Lucio gli saltò alla gola
tentando di strozzarlo.
Non era il primo episodio di insulto nervoso che
lo vedeva protagonista: aveva dato un'ombrellata a
un controllore delle ferrovie che gli era parso arrogante
(e certamente lo sarà stato, ma non fino al
punto da giustificare l'assalto, che a Lucio sembrò
quasi legittima difesa).
Anche a scuola aveva difficoltà a rimanere tranquillo,
spesso su provocazioni che non convincevano
mai gli inquisitori scattava. Poi cercava giustificazioni
che complicavano il superamento dell'episodio.
«Ma non ha visto che piedi piccoli c'ha il maestro
Martini?» urlò disperato al direttore che cercava
di venire a capo di una rissa, l'ennesima senza ragioni
apparenti, comprensibili.
«Perché devo incontrare tutti i giorni questi qui?!
Perché?!» si disperava Mastronardi
«E chi vorrebbe incontrare?» gli domandò il
direttore.
Lucio dopo un attimo di riflessione, rispose:
«Sandokan!»
Lo trasferirono a Milano, in una biblioteca comu-
57
naie dove non gli dettero alcun incarico, cercarono
sempre di evitarlo: lo stipendio glielo spedivano a
casa. Così Lucio non andò più.
E nessuno se ne accorse. Era sconvolto da questo
fatto.
Veniva da me, nelle ore di lavoro, e da lì telefonava
in biblioteca cercando di se stesso. Gli rispondevano
che non risultava nessuno con quel nome, che
non conoscevano nessun Mastronardi. «Eppure è un
cognome abbastanza conosciuto» rispondeva.
Fu in quel periodo di mobbing alla biblioteca scolastica
che incontrò, vicino a casa mia, un celebre
studioso di letteratura italiana (il più famoso) a passeggio
con la giovane figlia.
Il professore fu gentile, quasi affettuoso mi spiegò
Lucio. La figlia altrettanto, secondo lui.
L'incontrò informale diventò per il mio amico
una specie di segno del destino. Nel racconto, ripetuto
più e più volte, quello scambio di cordialità,
credo assolutamente normali, si trasformò in una
sorta di cerimonia solenne e suggestiva. Ormai era
diventato un evento quasi interminabile, che veniva
arricchito di particolari in ogni versione.
58
La figlia del letterato, man mano che si allontanavano
i fatti, aveva, secondo la delirante ricostruzione
di Lucio, manifestato per lui un interesse che
andava oltre la curiosità.
Elaborò nel ricordo ricchissimo di particolari
quello che credo avesse avuto nella realtà la durata di
un flash. E decise un'iniziativa della quale mi parlò
quando ormai era troppo tardi. Inviò allo studioso
una cassetta di liquori (eravamo sotto Natale)
accompagnata da una lettera nella quale chiedeva la
mano della figliola.
Il professore lo convocò a casa per chiarire quel
mistero. Sua figlia l'aveva intravista per pochi minuti:
come gli era venuto in mente addirittura un progetto
matrimoniale?
Lucio uscì da quell'incontro frastornato. Non
s'era reso conto di aver completamente inventato
una situazione inesistente. Il letterato lo trattò con
rude franchezza. Gli restituì la cassetta di liquori.
Alla quale Lucio attribuì parte dell'insuccesso:
«Forse ho sbagliato marca... Eppure in televisione
dicono che i prodotti Stock sono così buoni...»
Per un po'"non lo vidi. Lo chiamai al telefono per
59
invitarlo al congresso del Sindacato Scrittori a
Bologna. Era nervoso. Disse che non poteva, che
aveva un braccio ingessato e delle grane legali. Un
tizio voleva da lui il risarcimento di danni arrecati
alla sua auto. Lucio ci era caduto sopra buttandosi
dalla finestra del secondo piano, spiegò con naturalezza.
Ma la macchina era parcheggiata in divieto di
sosta. E allora...
Ecco forse perché scelse il Ticino qualche anno
dopo per...
60
VI
«Gaviraghi, ha finito con la signora?»
ci fu una parentesi romana molto piacevole. Tre
mesi in un albergo accogliente: un impegno televisivo
grosso, roba da sabato sera.
Naturalmente Nino e gli altri cercarono di calmare
il mio entusiasmo (lo avrei fatto anch'io al
loro posto). Ma in effetti era una grande occasione.
Nino finì per ammetterlo quando passai a salutarlo
prima di lasciare per un po'"Milano: anche per lui si
stava riaprendo il mercato. Aveva firmato un contratto
per un incarico di importanza inferiore
rispetto a quelli che aveva avuto fin lì. Ma la paga
era eccellente.
Da Roma tornavo saltuariamente a Milano, spes-
63
so insieme a Marcello, che raggiungeva appena possibile
la moglie, una donna ingombrante che lo trattava
con poco garbo. Lui sembrava averne paura.
La chiamava Aloha (il nome vero e più pertinente
era Olga) e davanti a lei cambiava perfino il tono
di voce, si intimidiva. Aveva fatto pazzie per conquistarla
e portarla via a un marito ricco e autorevole.
Si sentiva obbligato a garantirle una vita
altrettanto comoda rispetto a quella che, per
seguirlo, lei aveva lasciato: riusciva a mantenerla
nel lusso lavorando come una bestia. Lei non era
mai gentile, trattava Marcello in maniera brusca
davanti a tutti. Lo controllava nel cibo e gli rimproverava
il suo essere sovrappeso a ogni occasione,
spesso umiliandolo.
Lo mandava in giro a piedi (così avrebbe perso
chili): la Mercedes e l'autista li voleva a propria
disposizione. A volte lui telefonava timidamente per
farsi venire a prendere. La formula assai cauta era
questa: «Gaviraghi: ha finito con la signora?»
Solo la domenica mattina la macchina era tutta
per lui. Si faceva portare nei dintorni alle falde di
montagne accessibili e partiva marciando seguito a
64
passo d'uomo da Gaviraghi, che spesso lo salvava
dall'assalto di cani che inseguivano quel coso buffo
con uno zucchetto rosso in testa e la tuta di felpa.
Recuperato dall'auto, Marcello si faceva portare in
qualche bar dove, con uno sfilatino e una birra,
recuperava il peso perso nel footing.
L'ultimo di quell'anno ci sorprese sull'Appennino
una nevicata bestiale. La mia spyder non era l'ideale.
Dalla capote filtravano scoli di neve sciolta. Ma a
Marcello, raggomitolato nel posto a fianco, importava
solo che riuscissimo ad arrivare possibilmente
illesi ma soprattutto puntuali prima di mezzanotte,
come aveva promesso alla signora. Fu un viaggio terribile,
ci fermammo per tranquillizzare telefonicamente
Aloha (Marcello mentì: «Siamo a Lodi». Non
era vero, eravamo appena a Parma).
Non so come riuscii ad arrivare in corso Venezia
appena qualche minuto dopo l'ora stabilita: la
moglie di Marcello comparve, in un turbinio di
fiocchi di neve, in fondo alla via deserta, al centro di
piazza San Babila. Gaviraghi la proteggeva con un
ombrello. Lei, immobile e monumentale, era scesa
65
per controllare il nostro arrivo. Ci vide. Non fece
una piega. Girò su se stessa e risalì sulla Mercedes
seguita di lì a poco da Marcello, che cominciò già a
cento metri di distanza a profondersi in scuse. Sparì
inghiottito dal macchinone dove, dietro al finestrino,
vedevo la terribile Olga che parlava emettendo
delle nuvolette dalla bocca stratruccata. Marcello
mosse verso di me le dita di una mano in un malinconico
saluto.
La mia notte di San Silvestro fu movimentata.
Nel cabaret di Franco, un amico musicista, avevano
organizzato una festa complicata, un mix fra un
veglione di provincia con tanto di stelle filanti e un
evento culturale mitteleuropeo: musica da ballo di
un trio di jazzisti di classe e quartetto d'archi ("I
maestri obsolescenti", tanto per essere popolari) che
eseguiva musiche termali, da Il poeta e il contadino al
Valzer della trota. Ci furono anche un Erik Satie
{Composition en Forme de Poirè) e un paio di
Debussy che, pur eseguiti con una lancinante sega a
mano, non smossero un minimo di interesse.
Sembrava non si riuscissero a scalzare i maestri obsolescenti
dalla pedana: non era così. Il trio era scom-
66
parso. Li recuperai alla toilette in condizioni non
ottimali: il sassofonista aveva indossato una sottoveste
di pizzo. Non intendeva togliersela. Mi minacciò
con lo strumento.
Li riportai in sala ostentando un'imprevedibile
disinvoltura, che fece pensare al pubblico chissà
quale risvolto spettacolare. Invece il sax non si esibì
in nulla di trasgressivo o inconsueto. Suonava Mood
indigo con quell'intimo svolazzante, ma non offrì
risvolti diversi dalle pregevoli improvvisazioni
musicali.
Era quasi l'alba quando arrivò Luciano col poeta
negro Baldwin, ciucchi traditi. Il poeta recitò alcune
poesie in lingua originale. Forse. Nessuno capì niente
di quei farfugliamenti.
Luciano (che era il suo traduttore ufficiale)
applaudiva convinto, e tutti lo imitavano fidandosi
di lui. Dopo un giro di "penne da night" (terribile
primo piatto a base di peperoncino e tabasco per far
bere i clienti) se ne andò la luce. Urla e sghignazzi e
colpi sordi. Alla accensione delle luci di emergenza,
chissà come e perché, scoppiò una rissa.
Una scazzottata che diventò collettiva in un atti-
67
mo. Nessuno seppe mai spiegare cosa fosse successo,
quale fosse stato il motivo scatenante.
Il cabaret fu sconvolto da teppisti in smoking e
baldracche scollate: il gentile pubblico si trasformò
in breve in un'orda di vandali distruttori. Altre
volte li avevo visti all'opera, quei cretini. Franco, in
un angolo, guardava sconfortato: stavano spaccando
file di bottiglie di vino sistemate in quegli scaffali
a parete di legno scuro che fanno atmosfera.
Quando la furia si placò, erano rimaste intatte solo
quattro bottiglie (di Gattinara, ricordo). Franco si
alzò dal tavolo dove s'era sistemato ad aspettare la
fine dell'inferno.
Si avvicinò al ripiano con le bottiglie di
Gattinara. E le ruppe lui, con lentezza una per
volta, dopo averle guardate e soppesate con fare da
sommelier.
Un tempo (secoli fa) queste cose succedevano
con una certa frequenza. Per ragioni impalpabili,
di solito per iniziativa di alcuni che io chiamo per
semplificare cretini. Dei quali ricordo le facce: lisce
e tranquillizzanti e a volte anche allegre e ammiccanti.
Insospettabili e veloci a rientrare nella nor-
68
malità espressiva dopo qualche momentaneo tic:
un colpo a sistemare i capelli, una lisciata con l'indice
sul naso, una grattatina all'orecchio. Poi sgambavano
elastici verso le loro Bmw, sorridenti e consapevoli
di sé. Partivano a razzo dopo un paio di
sgassate.
E più difficile oggi riconoscere i cretini, quei cretini
lì. Hanno sempre la Bmw. Ma non sono più
quelli di una volta.
Rimasi a Milano fino all'Epifania. Sistemai alcune
faccende pratiche. Pagai delle bollette. Lasciai i soldi
al tizio della Einaudi (lo chiamavo così, ma
Giovanni non era più con l'editore torinese).
Vendeva a rate i libri di tutti. Eravamo amici. Anche
se la troppa confidenza rendeva interminabili gli
incontri. Giovanni parlava, parlava.
A lui interessava soprattutto farmi leggere certi
libri di un editore politico assolutamente periferico,
ma vicino alle sue idee rivoluzionarie deliranti.
Quei volumi semiclandestini erano improbabili
anche nei titoli: Dialogato coi morti. Dialogato
con Stalin. Erano saggi di movimenti marxisti-
69
leninisti, che si riunivano mensilmente in una sala
biliardo di via Poliziano («Al piano di sopra c'è
una stanza. Non lo sa nessuno che c'è»). Lì parlavano
soprattutto di Amadeo Bordiga e di come il
movimento operaio aveva frainteso quanto l'ideologo
aveva elaborato per il riscatto di quella classe
fuorviata dalla socialdemocrazia. Per un po'"reggevo.
Mi commuoveva l'entusiasmo di Giovanni che
aspettava l'inaspettabile, accettava quella vita infame
(dava al movimento la metà dei suoi guadagni:
diciamo meglio incassi. I guadagni non c'erano).
Era stato capoofficina all'Alfa Romeo. Ma s'era
dimesso il giorno dell'attentato a Togliatti. I
tempi, aveva pensato, erano maturi. Non era così:
riuscì persino a farsi arrestare per una manifestazione
che non si trasformò in quello che lui e una
ventina di altri visionari pensavano. Lo stesso
Palmiro aveva invitato tutti alla calma. Ci fu poi
anche la vittoria di Bartali al Tour de France che
dissuase la massa, anche se Giovanni non voleva
riconoscere questo motivo come preponderante.
Era il virus socialdemocratico: possibile che non
capivo? Ma d'altronde i più la pensavano come me
70
e come tanti che non sarebbero mai andati al
piano di sopra del biliardo di via Poliziano a parlare
del povero Bordiga tradito da quelle merde
della Terza Internazionale.
71
Vii
Operine buffe
... Proprio stamani ho avuto, inaspettatissima, una lettera del
Tenente Weimer, quello che per sfortuna o miracolo non
ammazzai sulla strada di Villafranca. In un esatto italiano,
dopo avermi infinite volte ringraziato ch'io non lo levai dal
mondo (ma veramente l'intenzione c'era), m'annunzia che non
tornò più mai a Vienna, che liberato dalle prigioni scelse di
rimanere in Italia, e ora sta a Milano dove si guadagna il pane
scrivendo i libretti per le Operine Buffe.
Luciano Bianciardi
La battaglia soda, Rizzoli
Ormai quello facevo a tempo pieno: l'estensore di
libretti per Operine Buffe, come aveva raccontato
Bianciardi nella sua trasposizione fantastica del
romanzo La battaglia soda.
Dai miei grandi maestri, ammettevo con un po'"di
imbarazzo, avevo preso furbescamente quanto di più
facile e immediato poteva servirmi. Avevo ancora
molto da imparare.
Lavoravo a volte su commissione, ma più spesso
senza alcun incarico preciso. Proposte eventuali da
piazzare chissà quando e chissà a chi si accumulavano
in attesa di occasioni che non sapevo procurarmi.
Mi risultava difficile prendere certe iniziative, anda-
75
re io a cercare i possibili interessati ai miei progetti.
Anche perché, una volta estesi, quei progetti non mi
incuriosivano più. Spesso la rilettura mi deludeva.
E comunque era sempre l'idea prossima ventura,
magari appena abbozzata, ad interessarmi maggiormente.
Riuscii solo una volta ad andare da un
impresario teatrale su insistenza di un amico che
volle fare da tramite: dovevo conoscere e farmi
conoscere.
Il grande produttore era estroverso e colorito,
somigliante alla propria leggenda. Ma anche mutevole
e a volte spiazzante. Sulle pareti della platea del
suo teatro aveva fatto mettere una scritta luminosa:
«Vietato fumare». E a quella scritta ne aveva fatta
aggiungere un'altra (non c'erano ancora i drastici
divieti attuali, ma generiche e inapplicate proibizioni)
a caratteri leggermente più piccoli: «Servirsi dei
portacenere. Grazie».
Lui indicava con un sorriso quell'invito così garbato
che rappresentava forse meglio di tutto la sua
filosofia, la sua tolleranza solidale ammiccante. Mi
fece aspettare a teatro. Forse faceva così con tutti
che, in quel tempio silenzioso, si sentivano ancora
76
più piccoli e insignificanti. Mi ricevette nello studio
all'ammezzato. Lo studio somigliava al teatro e al
suo padrone: tendeva al soverchio. Troppi marmi e
velluti e lampade e ninnoli. Troppo personale discreto
ed efficiente che parlava bisbigliando in un'atmosfera
tra il sacrario e la casa di tolleranza. Il grande
produttore risultava (non so quanto spontaneamente)
burbero e simpatico. Rappresentava con indubbia
efficacia la parte dell'ultimo erede di una categoria
in estinzione: meridionale, agiva da nordico
quando era il caso, virando all'improvviso nei comportamenti:
da sentimentale sapeva diventare il più
pratico e razionale degli imprenditori.
Mi fece sedere su un pouf più basso della scrivania:
vecchia tecnica per intimorire l'interlocutore. Sì
e no che riuscivo a vederlo, il mitico. Lo inquadravo
di sguincio schivando con lo sguardo un paio di
grosse foto incorniciate che vedevano l'uomo affiancato
da mostri sacri: l'attrice più famosa del mondo
alla quale baciava la mano con atteggiamento più
avido che ammirato. E il più grande attore di tutti i
tempi che aveva, certo volutamente, vergato sulla
foto una dedica ridondante a coprire quasi comple-
77
tamente la figura del produttore con svolazzi. Ma
sotto le frasi sussiegose e solenni, il mio ospite riusciva
a farsi riconoscere per la posa, che sembrava
avesse assunto prevedendo la possibile successiva
invasione grafica dell'immagine. Il produttore, di
profilo, aveva quasi poggiato il naso sulla spalla del
più grande attore di tutti i tempi che, per salvare il
proprio busto, risparmiò quell'angolo dai ghirigori
della stilografica dando così modo ai posteri di prendere
atto di quell'incontro lontano e quindi, più che
altro per questo, storico: quel naso era il suo, vede?
(anzi disse, indicando il naso: «Questo sono io»).
«Questa è l'ultima immagine del povero...» disse
per aumentare il valore dell'icona.
A quel punto avrei dovuto, rompendo l'atmosfera
nostalgica ed evocativa, propormi come argomento,
parlare di un progetto che avevo elaborato con un
attore che, in confronto al genio che reggeva prestigiosamente
il naso dell'ospite nella foto, era poco
più del nulla (cioè poco più di me).
Mi persi in un antefatto depistante che non mi
avrebbe portato a niente, non al racconto di una
trama che a quel punto avevo il terrore di svelare:
78
Dio mio, stavo precipitando nell'abisso della pretenziosità.
Perché il mostro sacro il cui naso sfiorò la spalla
dell'altro mostro, avrebbe dovuto incuriosirsi o
anche solo interessarsi a quel mio ipotetico spettacolo
destinato, nella migliore delle ipotesi, a figurare
per poche sere nel cartellone di una compagnia di
giro indicato come (una qualifica dal sapore di delazione)
«novità italiana»?
Mi salvò in un certo senso il mio prestigioso interlocutore
che evidentemente, come e più di me, si
stava rompendo le palle.
«Io ho un'idea» rivelò.
Quando un discorso comincia con questa premessa
è consigliabile chiudersi in difesa. Andarsene,
se è possibile. O acquisire un distacco da ciò che può
avvenire.
L'esperienza mi ha insegnato che «ho un'idea» lo
dice soprattutto chi non ne ha e scambia un'intenzione
per un'invenzione. Le idee riconoscibili (e utilizzabili)
come tali ce l'hanno soprattutto i plagiari,
quelli che copiano, ricalcano. O almeno si ispirano.
Che propongono il già proposto che è sempre
79
meglio accetto del nuovo. La novità è il difetto più
difficile da superare in un'idea. L'originalità è spesso
un handicap, se volete credere all'esperienza. E" questo
concetto che salva i creativi troppo sensibili dal
suicidio. L'eccesso di originalità, l'essere troppo
avanti, troppo innovativi, è portato come causa di
un mancato riscontro positivo. E un discorso lungo.
Per tornare allo studio del grande produttore e a
quel giorno interlocutorio che avrebbe potuto cambiare
il corso di un'esistenza (ma non riuscì) e alla
frase fatale («io ho un'idea»), la situazione comunque
si sbloccò. Il mitico che sapeva tante cose (anche
dove appoggiare il naso) risolse quell'incontro così
difficile per tutti (ma per me di più).
«Io ho un'idea» fu l'incipit che sbloccò una situazione
per me irrisolvibile: qualcuno mi sostituiva
come protagonista di un'iniziativa della quale ero già
stufo prima di promuoverla. Mi accorsi di odiare
quella proposta che avrei dovuto esporre: una commedia
su un gruppo di amici che si incontrano dopo
un periodo di separazione, al funerale di uno di loro.
Lo so che non è originale, che nel frattempo ci sono
stati commedie e film che hanno proposto la stessa
80
situazione. Ma all'epoca la situazione non era stata
ancora sfruttata.
E io l'avevo vissuta. E sofferta. Perché c'era Paolo
nella cassa sistemata nella chiesa sul lago. E pioveva.
Ero arrivato come sempre in anticipo. E non
c'era ancora nessuno. E li ho visti arrivare. Tutti.
Tutti quelli che sarebbero venuti anche al mio funerale,
con la stessa faccia, la stessa espressione storta
ma anche provvisoria, perché sarebbe bastato un
niente per scoppiare a ridere, e quella era la nostra
specialità di coglioncioni. Con dentro ancora (non
per molto) quella voglia di ruzza che ti fa passare
dal pianto al riso, quello forte, irrefrenabile, a volte
convulso, che può anche concludersi di nuovo con
le lacrime.
Gocciolanti e confusi. Con gli sguardi preoccupati
nella ricerca di qualche amico al quale aggrapparsi
perché i dispiaceri (come i piaceri) si affrontano
meglio in compagnia.
E arrivò Tito, grande e grosso, con la testa protetta
da un cappelletto ridicolo del quale s'era scordato
e lo tenne anche in chiesa tutto il tempo. Scese
verso il centro, verso la bara. Non vide dei perfidi
81
scalini e per non cadere fu costretto a spiccare una
corsa che si concluse contro una corona. Gli partì
un moccolo che rimbombò nella chiesa ancora
semivuota (un paio di donne di quelle che vanno a
tutti i funerali, e sono sempre quelle, si girarono a
guardarlo).
Poi gli altri: l'altro Paolo che si piazzò sul fondo
seminascosto da una colonna che non riusciva a
stare fermo, compariva e scompariva un po'"da un
lato un po'"dall'altro. Finché non arrivò la sua ex
moglie con la quale iniziò un discorso fitto e probabilmente
sgradevole: chissà da quanto tempo non
litigavano, c'era un arretrato da smaltire.
Poi Bruno che salutò tutti stringendo mani e
distribuendo abbracci come si fa alle feste. Ai funerali
no. Si fanno cenni col capo, ai funerali. Poco più.
Giorgio arrivò in carrozzina, giustamente incazzato.
Il badante filippino stentava a manovrare e lui gli
si rivolgeva dandogli dello stronzo a bassa voce.
La vedova arrivò tardi. Sergio si precipitò ad aprirle
lo sportello dell'auto, ma Giovanna, infastidita,
scese dalla parte opposta rifiutando quella pietà formale.
Scivolò sul fango e si appoggiò alla macchina
82
per non cadere proprio nel momento in cui l'auto,
guidata dalla figlia, si muoveva per andare al parcheggio.
Giovanna cadde con una lentezza spettacolare
con tutti che la guardavano senza poter fare nulla.
Si rialzò inviperita con Sergio, con la figlia, con me
che l'avevo aiutata a recuperare la borsa che era finita
sotto la ruota dell'auto, ma nel tirarla fuori mi si
era staccato il manico. Era furiosa. Con tutti quelli
che guardavano il suo imbarazzo e il suo dolore. Con
la madre di Paolo, la suocera, famosa per parlare a
vanvera in ogni occasione. Abbracciandola la vecchia
riuscì a dirle: «Eh: oggi non ne va dritta una!»
Come avrei potuto raccontare questa situazione e
il successivo pranzo e quella rimpatriata generazionale
così, a freddo, a un signore che mi intravedeva
ai piedi della sua scrivania, così insignificante in
mezzo a quei reperti da museo del teatro mondiale,
mal protetto da un curriculum che si poteva trascrivere
sul retro di una bustina di Minerva e avanzava
forse anche un po'"di spazio.
«Io ho un'idea»: l'avrei abbracciato.
Me la raccontò. La storia di un alieno che arrivava
in una città italiana e veniva accolto con l'affet-
83
tuosa curiosità nostra tipica. Col protrarsi della permanenza,
l'alieno diventava sempre meno interessante
per gli altri che pian piano...
Mi snocciolò Un marziano a Roma di Ennio
Flaiano, adorato mio maestro e amico. Ero persino
andato alla catastrofica indimenticabile prima.
Accennai alla singolare coincidenza della storia che
mi andava raccontando con quella della commedia
rappresentata la stagione precedente. Ah sì. Due o
tre sere... Non nel suo teatro.
Tutto quanto veniva rappresentato altrove non gli
risultava, evidentemente secondo lui non lasciava
traccia.
«Forse la partenza può assomigliare. Ma lo svolgimento...»
Pensai mi stesse prendendo in giro. No. Lui aveva
avuto, un anno dopo, un'idea già realizzata (e con
clamore). Si poteva rifare tranquillamente. Perché lo
svolgimento...
«Si potrebbe ambientare a Napoli» dissi provocatoriamente.
«Vede che per forza viene fuori tutta un'altra
cosa?!»
84
Quando glielo raccontai, Flaiano si divertì molto,
non si meravigliò. Anzi: un alieno a Napoli era certamente
un'altra commedia, che non avrebbe richiamato
il suo marziano a Roma. Nessuno avrebbe
notato delle somiglianze, perché sarebbe stato un
successo. E un successo non somiglia mai a un
tonfo. Grande.
85
VIII
"E solite fessane
Non bisognerebbe mai accettare lavori anonimi. Di
solito sono degradanti (per questo si preferisce
l'anonimato) o poco chiari. Quello che accettai era
degradante e poco chiaro: un editore tenta di acquistare
le memorie di una principessa (stronza come
solo le principesse riescono a essere). Non si accorda
sulla cifra e allora chiama un disoccupato momentaneo
(i disoccupati momentanei vengono via a meno
e sono disposti a tutto perché non sono abituati alla
disoccupazione che li getta nel panico), gli offre una
cifra solitamente modesta per scrivere una biografia
non autorizzata ispirata, diciamo così, a quella ufficiale
che non si è riusciti ad acquistare.
89
Il rischio effettivo è cadere nel plagio, rivelare la
fasullaggine dell'operazione o lasciarsi andare a illazioni
di fantasia che possano risultare lesive della
reputazione delle sputtanatissime protagoniste che
han venduto l'esclusiva (oltre al resto).
Raccontai a puntate la vita di questa imbecille
attribuendole sentimenti umani e capacità che il
biografo ufficiale non era riuscito a evidenziare con
quella stupida mania di autenticità che serve in ben
altre occasioni.
Uscì a puntate su un settimanale di modesto livello.
Un trionfo. Gli avevo dato giù di fantasia. E
quando mi incagliavo nella ripetitività di certi snodi
obbligati (c'erano eventi storici che non si potevano
modificare), vigliaccamente attribuivo alla principessa
un sogno nel quale la scimunita immaginava
(senza assumersi alcuna responsabilità) soluzioni
spettacolari che, dichiarate come d'origine onirica,
permettevano sforamenri e arricchimenti sfrenati.
Dopo l'euforia dei primi riscontri, arrivarono le
prime grane: la principessa cercò di fermare la pubblicazione.
Non ci riuscì: la dicitura «biografia non
autorizzata» concedeva a chiunque l'esposizione di
90
tesi le più ardite. E intanto l'editore tedesco, detentore
dei diritti del memoriale, cercò di bloccare
tutto aggrappandosi al titolo (dalla *rivistaccia italiana
non sufficientemente mascherato rispetto
all'originale).
Ci fu una sospensione di due settimane. Poi, con
qualche accomodamento, la cosa si aggiustò. Ma le
noie non finirono lì.
I legali della principessa intervennero chiedendo
la visione preventiva delle puntate future e relativa
approvazione delle stesse da parte di quella scimunita
che stava vivendo, grazie a quel chiasso pacchiano,
una sorta di rilancio.
Chiesi di venire sostituito. Subentrò un vecchio
cronista che pensò bene di dare sfogo alla sua fantasia
repressa concedendosi delle invenzioni obiettivamente
esasperate.
Successe che partì una querela. Che arrivò a me
che risultavo ancora per contratto l'estensore di
quella travagliata (e non autorizzata) biografia.
II vecchio cronista si defilò come una carogna, io
fui costretto a riparare, pur innocente, con una vergognosa
ammissione di colpa.
91
Mi liberai dall'incarico rimettendoci parecchi soldi.
Per documentarmi almeno un minimo sulla storia
recente attraversata dalla principessa con l'eleganza
stolida di un'oca, avevo frequentato uno scrittore
esperto, specialista di vicende del Novecento,
autore di libri ricchi di particolari su avvenimenti
decisivi per il nostro continente.
Era un parlatore affascinante seppur tendente alla
logorrea: era difficilissimo interrompere il suo eloquio
napoletano. Tendeva a dilatare le conversazioni
costringendo gli interlocutori a orari gravosi. Non
riuscivo a liberarmi che a tarda sera dopo averlo
accompagnato a casa. Ero riuscito a evitare gli inviti
per un bicchiere.
Il professore aveva spesso insistito per una visita al
suo appartamento che condivideva con Irina, una
donna russa descritta come «superiore» senza altri
particolari che comunque sarebbero risultati sminuenti.
Ressi a lungo, ma dovetti cedere una sera:
non era poi così tardi. Un bicchiere ci stava.
Il professore aprì la porta ed entrò cercando la
donna superiore che evidentemente non lo aspettava
così presto.
92
La trovammo sul divano del soggiorno in atteggiamento
ginecologico con sopra un tizio del quale
riuscii a vedere solo le chiappe, ma bastarono per
mettermi a disagio.
«Noi andiamo a cena fuori» disse il professore
indicandomi alla superiore momentaneamente collocata
in posizione inferiore.
Mi spinse quindi dolcemente fuori dall'appartamento
tentando un'operazione di alleggerimento
formale. Disse, nel suo napoletano rassicurante: «Ih!
Sempre "e solite fessane!»
Ci fermammo in una pizzeria sotto casa. «Qui
fanno un calzone... lo devi assaggiare».
93
IX
Roncobilaccio e Berliner ensemble
In quell'andirivieni Milano- Roma trovai però il
tempo per completare con Raffaele Crovi la riduzione
teatrale di Uomini e no di Elio Vittorini, personaggio
mitico per molti di noi. Raffaele aveva collaborato
a lungo con Vittorini, lo conosceva benissimo
ed era in rapporti di amicizia e stima.
Mi portò a casa sua: un'abitazione straordinariamente
somigliante allo scrittore, elegante come lui e
un po'"scomoda, raggiungibile dopo rampe di scale
impervie.
Guardavo Vittorini come si guarda una specie di
divinità. Dovevo a lui tante scoperte letterarie che
avevo acquisito e adottato come parametri. In
97
mezzo c'erano anche un paio di bufale, certo. Ma
anche gli errori di valutazione di quel grande (ahi,
il Gattopardo^) erano giustificabili anche se non
condivisi.
Lesse il lavoro che con Crovi avevamo composto
nel più grande rispetto possibile. Uomini e no, non
si discuteva sulla sua importanza. Semmai sulla
forma. Come qualcuno malignamente sosteneva,
era scritto in una lingua a volte faticosa. Sembrava
tradotto dal polacco, per dire. Ma era solo una ricerca
di stile per un'epica che nella nostra tradizione
non aveva precedenti.
Vittorini dopo pochi giorni disse che la lettura
l'aveva soddisfatto, il progetto gli sembrava riuscito.
S'era permesso di apportare una modifica.
Tremando andai a cercare l'appunto del maestro.
Aveva solo aggiunto una didascalia, un'appendice
non così fondamentale per un'opera di teatro.
Chissà perché sentì il bisogno di dilatare una descrizione
scenografica che probabilmente (come succede
in palcoscenico) sarebbe stata disattesa dagli esecutori.
So che Uomini e no l'hanno rappresentata
98
all'estero. In Italia, una compagnia minore.
Conosco poi due edizioni radiofoniche: una svizzera
e una italiana.
Ero felice per quel lavoro così diverso dal mio abituale,
una specie di omaggio doveroso a chi aveva
vissuto da protagonista un periodo fondamentale
per il nostro Paese. Così la pensavo, anche se non
avrei mai trovato il coraggio per un'ammissione in
fondo un po'"retorica come questa.
Per ciò riuscii a proporre quel testo al più prestigioso
(e storico) teatro stabile italiano.
Il suo direttore- fondatore mi rispose con una
franchezza per certi versi ammirevole: il prestigio
dell'autore del romanzo lo lasciava indifferente.
Non capiva il perché dell'operazione. E si stupiva
che uno come me, così caustico nella scrittura, si
fosse interessato a una trascrizione inutilmente
fedele e pedante.
«La preferisco» disse, «quando esercita la sua irriverenza
in cabaret».
Già, me l'ero dimenticato: avevo scritto un
monologo parodiando il suo modo di parlare, la sua
erre praticamente inesistente, la sua facondia ridon-
99
dante. Una cosa che, fra addetti ai lavori, aveva
divertito amici e nemici. Il pezzo era delirante, ma
partiva da un'inspiegabile intervista che il fondatore- direttore
aveva rilasciato in tv. S'era imbarcato
chissà perché in un paragone improponibile tra il
progetto del suo teatro e quello dell'Autostrada del
Sole, ambedue tendenti a unire luoghi (geografici e
culturali) fino ad allora lontani: una similitudine
che poteva degenerare in catastrofe e che sfruttai da
mascalzone mescolando corsie, palchi, caselli, camerini,
Roncobilaccio e Berliner Ensemble.
Si tormentò il baffo e sorrise: «Non sia troppo di
sinistra se vuole essere spiritoso» mi raccomandò.
«Per non perdere la verve, posso diventare al massimo
socialista» risposi.
Non sorrise restituendomi il testo che non gli era
piaciuto quasi quanto non gli ero piaciuto io.
100
X
Para Celestino
Un paio di commedie musicali contribuirono a
tranquillizzare quanti seguivano con una certa angoscia
le mie vicissitudini finanziarie. Guadagnavo
moltissimo in certi periodi. Poi, quando m'ero
assuefatto alle vacche grasse, intorno a me scompariva
all'improvviso ogni genere di armenti.
Mi ritrovavo al centro di un deserto avendo perso
l'abitudine all'ordine e alla morigeratezza: è brutto
riconoscersi come il povero più elegante, lo scannato
con la macchina più bella, l'indigente con le abitudini
più costose del quartiere.
Perché ogni volta rischiavo la fame senza poter
onestamente contare su un briciolo di solidarietà?
103
Chi solidarizza con un pirla che si fa tagliare il telefono
per morosità e lo scopre tornando da un weekend
all'hotel Nazionale di Portofino (la solita
camera con le finestre sulla piazzetta)?
Non potevo più neanche meravigliarmi. Dovevo
acchiappare qualunque incombenza lavorativa da
chiunque mi venisse offerta. Così mi capitò un'avventura
singolare: tramite amici napoletani che
avevano del mio curriculum professionale un'idea
esaltata ed esaltante, ricevetti un'offerta senz'altro
strana.
Avrei dovuto (per una cifra esagerata sulla quale
ottenni un anticipo che mi salvò la vita) scrivere la
biografia di un miliardario campano, un personaggio
misterioso che aveva lasciato in fretta l'America
Latina per tornare al paese d'origine: un orrendo
agglomerato di catapecchie sulle pendici di un
monte di rara bruttezza.
Lì era nato il Cele che intendeva rifondare la cittadina,
ricostruire la catapecchia avita, vivere gli
anni della maturità nella pace agreste.
Cele (diminutivo di Celestino) era scapolo. Era lo
scapolo più pieno di figli mai esistito nella zona:
104
aveva ingravidato quasi tutte le donne che aveva
incontrato, mi dissero. Riconoscendo però i figli,
frutto di relazioni tutte assai brevi dati i viaggi che
Cele intraprendeva continuamente verso le
Americhe, dove restava a lungo.
L'uomo era rozzo, ma non antipatico. Aveva delle
debolezze (a parte quella riproduttiva) molto particolari.
Voleva essere commemorato da vivo: ecco la
ragione per cui pretendeva che l'aiutassi a scrivere le
sue memorie. Intendeva poi trasformare la casa dei
suoi vecchi in un mausoleo e per questo aveva ordinato,
a un'azienda di sviluppo e stampa cinematografica
di Roma, dei costosissimi pannelli plastificati
di foto ingrandite da attaccare alle pareti fino a
coprirle completamente.
Le foto erano quelle dell'album di famiglia: battesimi,
cresime, bambini (soprattutto suoi) nudi su
pelli d'orso, madre e padre il giorno delle nozze, lo
zio in divisa fascista col braccio teso, una serie interminabile
di mostri con gli occhi sbarrati per il
lampo di magnesio.
Una stanza era dedicata alla vecchia madre morta,
105
immortalata nei pannelli fino a ricostruire l'arco
della sua esistenza, dalla culla all'altare, alla bara:
c'era anche un servizio professionale (plastificato)
del funerale.
La madre di Celestino, la povera Matilde, era
ricordata anche sul cancello (la scritta «Villa Matilde»
era completata da una foto, sicché sembrava l'ingresso
di una cappella più che di un'abitazione).
Cele aveva tanti di quei soldi che bastò far sapere
alla direzione di una banca nazionale che aveva
intenzione di trasferire il suo denaro, che la banca
si disse disposta ad aprire un'agenzia sul posto.
Cele pretese (e, incredibile, ottenne) che l'agenzia
venisse (mai successo) dedicata a mammà.
Sull'ingresso della sede nella piazzetta del paese,
sotto la scritta, «Banca ecc.», più in piccolo un'aggiunta:
«Agenzia Mamma Matilde»: Cele mi informò
che era l'unico caso in Italia di sede bancaria
intitolata a qualcuno.
Per evitare di raccontare solo le vicende fornite
dall'interessato, pensai di girare un po'"fra i parenti,
gli amici, i compaesani, e conoscere anche i loro
pareri sul conterraneo conosciuto in due continen-
106
ti. Gli intervistati (dai quali venivo accompagnato
sempre da scagnozzi del Cele) avevano il terrore di
dire qualcosa di sbagliato e di non agiografico. Un
disastro.
Finché decisi di andare da solo a parlare con gli
abitanti del paese. E vennero fuori anche storie che
certamente non avrei potuto trasferire nell'agiografia
che mi accingevo a stendere a pagamento.
Cele era emigrato mezzo secolo prima, poco più
che ragazzo. Per non andare militare. Si imbarcò
clandestinamente (come era usanza di tutti laggiù) e
dopo qualche esperienza imprenditoriale della quale
poco si sapeva, aprì un'impresa di costruzioni italoamericana.
Intorno alla quale, in rapida successione,
dette vita ad altre attività indotte: fabbriche di laterizi,
aziende di trasporti. In società, riferivano con
aria furbesca, con persone importanti.
Manodopera soprattutto italiana, anche se negli
ultimi tempi non era più così. Di recente gli emigrati
italiani, che nell'immediato dopoguerra erano
tantissimi, s'erano ridotti di numero.
Molti viaggi, pare organizzati da uomini del
Celestino, non erano andati a buon fine. Gli emi-
107
granti non avevano passaporti, non li chiedevano,
molti poi non potevano espatriare per comprensibili
motivi. Scomparivano dopo essersi imbarcati su
bastimenti clandestini predisposti da amici o emissari
del Cele.
Di molti di loro non si seppe più nulla. Poi qualcuno
fortunosamente riusciva a tornare a casa e a
raccontare (con cautela, certo) l'avventura.
I clandestini venivano imbarcati segretamente e
per giorni e notti vagavano in mare diretti (credevano)
in America Latina verso un lavoro sicuro presso
un compaesano. La cifra richiesta per il viaggio era
alta, ma tutto considerato ne valeva la pena. I passeggeri
(clandestini) dovevano stare giorni e giorni
sotto coperta per non farsi vedere. Uscivano di notte
sulla tolda.
La nave, dopo un viaggio di due settimane, si fermava
a un attracco naturale. «Via, giù tutti: siete in
America! Sistematevi sulla spiaggia che all'alba vi
verranno a prendere». E la nave ripartiva.
All'alba, mi confessò uno facendomi promettere il
silenzio sulla fonte, non arrivava nessuno. E così per
giorni. Finché la guardia costiera non individuava
108
quel gruppo di disperati e li arrestava perché si trovavano
in Marocco e senza passaporto.
I giorni di sballottamento in mare servivano a
dare l'idea del viaggio verso l'America. Che molti di
loro non videro mai. Qualcuno rimase in Marocco.
Qualcuno vagò non sapendo cosa tornare a fare al
paese dove non aveva più niente.
C'era qualcosa di molto losco dietro queste storie,
che non utilizzai. Come, d'altronde, non utilizzai
niente di quello che raccolsi in quel mese dedicato al
reperimento e alla stesura della vita (assolutamente
inventata) di Celestino.
Per l'attività in Sudamerica dovevo basarmi sui
racconti del protagonista, entusiasta di sé e del suo
passato del quale sembrava ricordare solo gesta
memorabili che mi raccontava a ogni fine pasto
quando, tra il fumo di sigari enormi sulla cui etichetta
si leggeva «Expeciales para Celestino», si ricostruiva
tutto il bello di quell'uomo banale e spaventoso
nello stesso tempo.
Due settimane passarono così. Quindi tornai a
casa promettendo un primo elaborato a breve. Che
arrivò insieme a un mio assegno col quale restituivo
109
quel maltolto che m'aveva salvato dalla meritata
indigenza ritornante quasi a scadenze fisse.
Suggerii per la mia sostituzione il vecchio cronista
della biografia della principessa. Non serbo rancore.
110
XI
Un buco nel muro
Mi capitò la fortuna di partecipare alla stesura di
uno spettacolo teatrale prestigioso: grande produzione,
cast ricco, impegno a tempo pieno.
Giornate intere passate in un ufficio angusto (e
storico) ricavato nell'ex guardaroba del teatro più
importante di Roma. In quel buco nel muro passai
mesi (e poi anni) ad ascoltare e proporre. E discutere
e difendere idee che non fu mai facile far
accettare: avevo il difetto di essere il più giovane
del gruppo, non avevo referenze indiscutibili: la tv
e il cabaret erano un'anticamera, non una provenienza
sicura.
Quando proponevo qualche idea non già pratica-
113
ta nel settore incontravo diffidenza. Così mentivo:
dicevo di aver visto quanto suggerivo in spettacoli
all'estero. Garantivo la validità dell'idea presentandola
come già fatta, come plagio. Questo la rendeva
accettabile. Non era il "fare" lo scopo, ma il "rifare"
senza rischio.
Appena possibile tornavo in cabaret, dove sfogavo
certe mie velleità. Sceneggiai un capitolo del
Capitale di Marx (quello del plusvalore) facendolo
recitare dagli attori col birignao dei classici della tv.
Tentai una parodia di 77 vicario che tanto aveva preoccupato
la censura del tempo. Sostenevo che il
papa, durante gli anni spaventosi del nazifascismo,
era stato sostituito da un robot, un umanoide plagiato
e gestito dai politici.
Avemmo qualche grana, fummo chiamati in
Procura, ci sentimmo quasi importanti quando
minacciarono di chiudere il locale con la scusa dell'inefficienza
delle uscite di sicurezza.
Di giorno il cabaret diventava ristorante frequentato
da personaggi della zona di via Canonica.
Spesso pranzavo con Cremonesi, un vecchio anarchico
che viveva vendendo oggettistica d'epoca.
114
Vendeva un oggetto per volta. Mai più di uno. Te lo
proponeva fino allo sfinimento. Ricordo che fui
costretto a comprare un orrendo calamaio di bronzo
che l'anarchico non riusciva a sbolognare.
Cremonesi raccontava di Errico Malatesta, di cariche
di guardie regie, di segregazioni a Palazzo
Marino (?) e mi fornì decine di versioni sull'attentato
del teatro Diana, una diversa dall'altra.
La sera mangiavo con Alvaro, l'uomo delle luci.
Di giorno Alvaro lavorava in un'impresa di pompe
funebri (sempre reparto elettrico). Poi prendeva il
suo Galletto Guzzi e veniva al cabaret: era gobbo
come pochi altri. Ma riusciva ad armonizzare il suo
fisico scoliotico con l'ambiente. Si piazzava durante
lo spettacolo in una rientranza del muro di fondo,
che sembrava pensata per ospitare la sua spalla
sghemba. Anche il motorino che usava sembrava
pensato per i gobbi. Alvaro era discreto ed educato.
Spesso cupo perché avvilito, spiegava a voce bassa,
da un handicap che confessava come una rivelazione:
sono un po'"sordo, diceva disperato.
115
XII
La ultima vez
Tornare nei posti dell'adolescenza è struggente. E
utile. Per capire se l'adolescenza è veramente finita.
Perché qualche dubbio ognuno di noi ce l'ha che ci
possa essere, non dico un prolungamento, ma un
ritorno, un rewind magari procurato artificialmente:
come era diventata Elena? Come ero diventato io
per lei (bè, questo mi faceva un po'"paura)?
Elena non la vidi. Incontrai per caso la sorella in
corso Vannucci. La sorellina piccola era una grassa
signora che di quegli anni da patetica recherche era
riuscita a mantenere il colore dei capelli biondi
(naturali?). Il negozio della nonna non c'era più.
Ebbi il terrore di incontrarla, Elena. Alla quale
119
non ero mai riuscito a dire niente di quanto avrei
voluto. E che avrebbe forse voluto anche lei, che
arrossiva quando ci incontravamo: niente altro.
Proprio niente.
Può un niente spingere un uomo a puntare verso
un passato a trecento chilometri nella speranza che
una ragazza che chissà come era diventata potesse
ancora arrossire vedendo come era diventato lui?
C'era un profumo di tigli che sapeva di scrutinii e
di esami.
C'erano le rondini che si abbassano a stormi
squittendo: ormai lo fanno raramente. Forse solo
nella mia città.
Seduto al caffè dove andava mio padre, guardavo
il passeggio con un senso di sgomento. Fino a qualche
tempo prima avrei dovuto salutare chissà quante
persone. Adesso no: facce nuove per me.
Erano di fuori? No. Di fuori ero io che non avevo
calcolato che vent'anni sono tanti, anche per chi ha
una gran memoria. Come me che ricordavo anche e
soprattutto le fregnacce. Per esempio...
... Sandra Dee
il banchiere Giuffré
120
il fungo cinese
Amru Sani
la decapitata di Castel Gandolfo
Siamo Febo Liliana e Grancassa
Dici Decio? Dico Lucio. O, Cacio
il travaso delle idee i
la tricofilina
la polvere Mom
i preservativi Olla
Bianco Padre che da Roma
ci sei meta luce e guida
In ciascun di noi confida
Su noi tutti puoi contar
Siamo arditi della fede
Siamo araldi della croce
a un tuo cenno alla tua voce
un esercito all'altar
Son prodotti di Alemagna: Ullalà è una cuccagna!
Akela: del nostro meglio!
Taciun taciun popò", taciun taciun popò", arriva la
corriera Gallarate- Rho
Oh oh only you
il colluttorio Botot (c'era in tutti i casini)
121
il caso Montesi
Bril Cream, splendore nei Capelli ti dà la personalità
Formitrol
Dura minga: non può durare
Una buona cera? Ottima direi: è Cera Gray
il Popelin Capri
Domani è troppo tardi
Tolon tolon tolon tolon
Brigitte Fossey
Va serenata celeste, celeste come gli occhi di una
donna
Yma Sumac, l'usignolo delle Ande
via Arsenale 21 Torino (o anche casella postale 400)
il nodo scapino
le mutande Enea
il quartetto Radar
Franco e i G5
Stramilano: essetierreaemmeielleaenneo
il maestro Graziosi
E mo, e mo: Moplen!
Pallante che sparò a Togliatti
Pastiglie Valda
122
Un uomo solo al comando: la sua maglia è biancoceleste...
Mamma mamma voglio il formaggino Mio
Besame, besame mucho...
... L'ho cantata tornando a Milano con grande
passione: como si fuere està noche la ultima vez.
Era un momentaccio. No, non professionale.
Sentimentale.
Nel senso che ero solo, avevo mollato qualsiasi
legame, qualsiasi impiccio. A Marica non avevo
risposto al telefono per tre giorni. E anche quando
venne a cercarmi a casa (vedevo la sua macchina dalla
finestra) feci finta di non esserci. «Dobbiamo parlare»:
ecco cosa mi faceva scappare via. Il «dobbiamo».
Andai a Roma dove non mi avrebbero trovato.
Andai da Ennio. Parlare con lui mi faceva sentire
intelligente. Di riflesso: l'intelligente era lui. Io
assorbivo.
Mi raccontò una storia per il cinema che non
aveva scritto né, a quanto ne so, scrisse mai.
Si svolgeva a Pescara alla fine dell'Ottocento. La
storia dell'amicizia tra un farmacista e un fotografo:
123
lo studio e la farmacia affacciavano sulla stessa piazza.
La noia delle lunghe giornate d'inverno li spingeva
a socializzare. Pescara d'inverno era insopportabilmente
noiosa. Ah, potersene andare! Si ritrovavano
ora nel negozio dell'uno, ora nel laboratorio dell'altro
a parlare e sognare. Era il 1894. La curiosità li
spingeva a sondare le conoscenze tecniche dell'altro:
il fotografo si informava su certi acidi, il farmacista
sul mistero delle immagini riprodotte da una camera
oscura. Peccato che fossero immobili. Forse si
sarebbe potuto inventare qualcosa che le animasse.
Cominciarono a studiare il mistero delle immagini
in movimento. Tentarono fino a che riuscirono:
arrivarono alla cinepresa (primordiale) e alla pellicola.
Girarono i primi filmetti: l'arrivo del treno alla
stazione di Chieti, l'uscita degli operai dalla manifattura
tabacchi di Pescara, il giardiniere distratto
(che finisce per innaffiare se stesso).
Di corsa a brevettare quella invenzione: era il 14
febbraio 1895. Sogno realizzato. Adesso via verso la
grande avventura: una scoperta così bisognava presentarla
in una capitale importante. Parigi!
E partirono per la Ville Lumière con le valige
124
piene di macchinari e di sogni. Felici.
E felici arrivano a Parigi: è il 28 dicembre del '95.
Passano senza farci caso per boulevard des
Capucines e non si fermano a leggere il cartellone
appeso davanti al Grand Cafè: quella sera, primo
spettacolo cinematografico offerto dai fratelli Louis
e August Lumière (che avevano brevettato la loro
invenzione il 13 febbraio, un giorno prima degli
abruzzesi).
Il farmacista e il fotografo passano senza accorgersi
di nulla. Felici proseguono per la loro strada.
«Ma è una storia tristissima!» obiettai.
«No. Finisce prima. La tristezza semmai viene
dopo».
Era vero. Come quasi sempre.
125
XIII
Viva gli sposi
A Milano rientrai nel clan di Nino, dove le novità
erano poche. Tre: Roberto s'era innamorato, aveva
avuto un attacco ischemico e si voleva sposare.
Tre eventi contemporanei e imprevisti. «L'unico
grave è il matrimonio» commentò Nino. Che organizzò
una finta cerimonia per ingannare (ma questo
termine allora non venne usato) la famiglia della
ragazza, dei friulani bonaccioni a casa dei quali noi
farabutti arrivammo tutti insieme fingendo di essere
appena andati in municipio per le nozze. Balle:
Roberto aveva un vecchio conto con l'istituto matrimoniale.
Ma la recita era perfetta: Tosca arrivò persino
con un mazzolino di mughetti che figuravano
129
essere i fiori lanciati dalla sposa a fine cerimonia.
La madre fu colta da malore, il padre (un omone
forte come una quercia che se avesse saputo ci avrebbe
stritolati) non trattenne il pianto. Io avevo invitato
per movimentare un amico cabarettista, un irresistibile
omosessuale che impedì, animando l'atmosfera
sopra le righe, qualsiasi cedimento patetico.
Ci fu persino un lancio di confetti: fummo dei
perfetti mistificatori. Anche l'attacco di moralismo
arrivò al momento giusto, quando ormai eravamo
lontani dalla casa della sposa.
E Nino poté finalmente dire: «Siamo delle autentiche
merde».
130
XIV
Che fine ha fatto quel cavallo...
Altre avventure, altri incontri: a Roma, un periodo
di cinema.
Non grande cinema, supervisioni di sceneggiature
altrui, collaborazioni a copioni collettivi. Un
western italiano dove ogni sceneggiatore si scatenò
nel suggerire follie: io arrivai a ipotizzare un ruolo
primario per un cavallo. Addestrato per sparare
muovendo la coda: agitandola azionava un marchingegno
che agiva sui grilletti di un fucile che sparava
alle spalle del cavaliere contro eventuali inseguitori.
Era un'idea assolutamente demenziale, ma ormai
si cercava di superare il livello di credibilità in qualunque
modo. Avevo dimenticato, per fortuna,
133
quella pensata improponibile. E non la trascrissi
nella versione definitiva.
Il produttore mi rimandò il copione con una nota
di suo pugno: «Che fine ha fatto il cavallo che sparava
col culo?»
Qualche sera andavo a cena da Adolfo, grande
esperto di giochi televisivi. Persona generosa quanto
poco fortunata con le donne. Secondo me se le cercava
certe situazioni sentimentali che lo vedevano
sempre perdente. Era l'uomo più abbandonato dalle
donne che avessi mai conosciuto. L'avevano mollato
tutte. Ma non c'era una ragione specifica, o almeno
io non l'ho mai trovata.
Lui si consolava dicendo: «Per essere abbandonato
da tante, bisogna averle avute queste tante, no?»
Giusto.
Forse c'era, da parte sua, un atteggiamento di rassegnazione
già in partenza. Si metteva con qualcuna
preparandosi alla fine della relazione, che immancabilmente
arrivava ogni volta, come evocata.
134
XV
Gnagnera finale
Tornai a Milano per sbaraccare tutto. Il mio mestiere
(o quello che più mi interessava del mio lavoro) si
faceva a Roma.
L'addio non fu facile. In fondo quel posto così
difficile e a volte sgradevole era anche un po'"mio.
Il congedo fu più lungo del previsto.
Rimandavo il trasferimento inventandomi delle
difficoltà.
La sera d'addio la organizzò Gracco, un personaggio
indefinibile che odiava la sua città, dalla quale
non riuscì mai ad allontanarsi definitivamente.
Detestava tutto quello che veniva imposto orgogliosamente
come meneghino. Ricordo i suoi litigi con
137
i difensori della milanesità, che lui non sopportava.
Arrivava alle risse verbali con chiunque cercasse di
difendere la tradizione lombarda.
Gracco odiava persino la cotoletta alla milanese,
piatto copiato dalla gastronomia austriaca. Ordinava
la cotoletta. Si faceva spiegare dal maitre la liturgia
preparatoria. Poi chiedeva del limone. E spremeva la
cotoletta sull'agrume che mangiava fingendo golosità.
Feci il trasferimento del conto bancario alla Comit
dei Parioli. Era una banca piacevole, frequentata
soprattutto da persone anziane, militari in pensione,
diplomatici, contesse.
Sembravano finti, sembrava una recita:
«Buongiorno baronessa... buongiorno generale...
ambasciatore...!» Le porte d'accesso erano controllate
da un vigilante in tutto.
Andai col cane. Non c'erano ancora quei cacacazzo
che oggi ti chiedono di lasciarlo fuori, attaccato
al moschettone sotto la scritta «Io devo restare qui».
Ancora ci si muoveva con relativa scioltezza.
Entrai con Holden al guinzaglio vezzeggiato da
aristocratiche, ufficiali, corpo consolare. Una vec-
138
chia contessa entrò sfarfallando e scomparve al
piano di sotto, alle cassette di sicurezza.
Fu un attimo: un giovane saltò il bancone urlando
«tutti a terra: è una rapina!»
Holden cominciò ad abbaiare. Io lo tenevo sotto
di me, ma lui abbaiava verso un tizio con una pistola
che mi si avvicinò puntandomela alla tempia.
«Fallo stare zitto».
E io tentai di prendergli il muso, al mio terrier,
che mi leccò la mano, ma ricominciò ad abbaiare.
Sentivo qualcuno che piangeva. Il bandito con la
pistola era nervoso: gli vedevo i piedi che andavano
avanti e indietro.
Holden aveva deciso di farmi ammazzare. Adesso
ringhiava sfuggendomi da sotto il corpo.
Mi sembrava di essere lì da un'ora. Addirittura
avvertii un attimo di noia. Io sono uno che non ha
paura: non ho alcun merito. Non sono coraggioso:
solo non provo paura. E un'altra cosa.
Mi misi a pensare ai fatti miei. Holden si era calmato.
Non sentivo più alcun rumore. Mi misi a
pensare al mare, a quando (la stagione era quella) si
partiva per Riccione. A quando si arrivava, all'ecci-
139
tazione di andare subito alla spiaggia. All'emozione
nel rivedere gli amichetti di quegli anni: Nello, che
sapeva imitare le voci di Sandrone e Fagiolino,
Checco che imitava il cantante Bacilieri dell'orchestra
di Corrado Bezzi che suonava al Florida,
Mariolino con la faccia buffa che poi diventò un
fanatico nazifascista, spia dei servizi: come si fa con
quei denti in fuori, gli occhiali da cecato e le guance
pienotte da bamboccio?
Come era tutto più facile allora. Come ci si capiva
in fretta. Si parlava la stessa lingua che ora non
conosciamo più.
Si cresce e si peggiora. Sempre. E non si comunica
più, non ci si capisce. Mentre una volta era tutto
facile. Mi piacerebbe parlarne con qualcuno. Ma
parlarne non come si fa oggi con la consecutio, la
corretta dizione, che noia.
Come una volta... Come quand'erme freghi,
cinini cinini. Guaglioni, bagai, pischelli, alti un
cazzo e un barattolo, che ce pijava la ruzza, si montava
tuttambotto un rebelot, non c'erano madonne
che ce potessero fermà, marampeti quant'erme, «sta
bono che te do un sochè»: e sti cazzi? Se capis "na
140
gotta, giusto? Scrivere come si parlava poi: figuress!
La lingua cambiava come il panorama. Come
noi. Nisciuno s'arrecuorda bene il perché di tante
parole: perché "arimorta" si diceva ovunque?
Perché nessuno, neanche qualche pirla di semantico,
ha mai organizzato un frenzola di seminario sul
linguaggio di quando eravamo felici (famo più felici,
vah)? Perché parliamo del passato dimenticandone
la lingua?
Ciapa el tram balorda: ciapa el tram che mi son
sórda: cosa voleva dire? Nessuno se la ricorda più.
Né "chiove chiove jesce "o sole, tutt'e vecchie
fanno ammore, fanno ammore in t'o tiane, tutte "e
vecchie ruffiane".
O "ponte ponente pontepi tappe tapperugia".
Finimola co "sta gnagnera, alora (pron: alùra).
Parliamo l'asettico linguaggio della comunicazione
mediatica.
O magara l'è mej parlà ingles. Okay?
Okay "n par de cojoni.
141
Indice
p. 9 La rivoluzione è scomoda
21 La laurea vale tre anni
33 Molte si chiamavano Paola
45 Non si fa un provino a una contessa
53 Incontrare Sandokan
61 «Gaviraghi, ha finito con la signora?)
73 Operine buffe
87 "E solite fessane
95 Roncobilaccio e Berliner ensemble
101 Para Celestino
111 Un buco nel muro
117 La ultima vez
127 Viva gli sposi
131 Che fine ha fatto quel cavallo...
135 Gnagnera finale
Potrebbero piacerti anche
- Portanova e il cadavere del prete: Siracusa 1964Da EverandPortanova e il cadavere del prete: Siracusa 1964Nessuna valutazione finora
- Tradizioni e Speranze: Anime brulicanti vol. 3Da EverandTradizioni e Speranze: Anime brulicanti vol. 3Nessuna valutazione finora
- E anche questo Natale...: Interviste a Enrico Vanzina, Christian De Sica, Jerry Calà e a tanti altri personaggi di uno tra i maggiori cult degli anni '80Da EverandE anche questo Natale...: Interviste a Enrico Vanzina, Christian De Sica, Jerry Calà e a tanti altri personaggi di uno tra i maggiori cult degli anni '80Nessuna valutazione finora
- Io lo conoscevo bene: Storia semiseria di Gianfranco D'Angelo, eterno fanciulloDa EverandIo lo conoscevo bene: Storia semiseria di Gianfranco D'Angelo, eterno fanciulloNessuna valutazione finora
- Giallo Piombino: Tutto il thriller di Gordiano Lupi 2000-2020Da EverandGiallo Piombino: Tutto il thriller di Gordiano Lupi 2000-2020Nessuna valutazione finora
- Tanti volti nella memoria: Ricordi di un medicoDa EverandTanti volti nella memoria: Ricordi di un medicoNessuna valutazione finora
- Le Veglie Di Giovanni: MAREMMA Storie davanti al caminettoDa EverandLe Veglie Di Giovanni: MAREMMA Storie davanti al caminettoNessuna valutazione finora
- Nati in via Madre di Dio: Un'indagine per Pagani e MarinoDa EverandNati in via Madre di Dio: Un'indagine per Pagani e MarinoNessuna valutazione finora
- Barnaba Zago e la chiavetta del male: Una storia di ladri, bambini e canaglieDa EverandBarnaba Zago e la chiavetta del male: Una storia di ladri, bambini e canaglieNessuna valutazione finora
- Nelle viscere di Bologna: Un'indagine di Galeazzo TrebbiDa EverandNelle viscere di Bologna: Un'indagine di Galeazzo TrebbiNessuna valutazione finora
- Paolo Villaggio - 1971 - FantozziDocumento140 paginePaolo Villaggio - 1971 - FantozziMarco Sanità100% (1)
- (E-Book ITA) - Paolo Villaggio - FantozziDocumento67 pagine(E-Book ITA) - Paolo Villaggio - FantozziValeri Rider100% (2)
- Motorola Wilder Gsgitalian68004150007 - v3Documento2 pagineMotorola Wilder Gsgitalian68004150007 - v3Alex MiròNessuna valutazione finora
- SpecialeGiulia 05Documento4 pagineSpecialeGiulia 05Alex MiròNessuna valutazione finora
- Elio Vittorini Il Garofano RossoDocumento102 pagineElio Vittorini Il Garofano RossoAlex Mirò100% (1)
- Produzione Delle Vetture Alfa RomeoDocumento13 pagineProduzione Delle Vetture Alfa RomeoDomenico Bevilacqua100% (1)
- Ricetta AmarettiDocumento2 pagineRicetta Amarettimilian__tNessuna valutazione finora
- LIDL Volantino On Line KW49Documento36 pagineLIDL Volantino On Line KW49meditansNessuna valutazione finora
- Nu Brutto DifettoDocumento29 pagineNu Brutto DifettoFranco MarascoNessuna valutazione finora
- Receitas 4Documento205 pagineReceitas 4Nadia LamasNessuna valutazione finora
- Esercizio Di Correzione ErroriDocumento2 pagineEsercizio Di Correzione ErroridomteachNessuna valutazione finora
- Catalogo Renzini COMPLETODocumento84 pagineCatalogo Renzini COMPLETOPaolo AnzilNessuna valutazione finora
- Triptico - Prima de SunyDocumento2 pagineTriptico - Prima de SunyJuan Rojas100% (3)
- Catalogo SANREMO LineaDocumento38 pagineCatalogo SANREMO LineaJulianNessuna valutazione finora
- DistillatiDocumento39 pagineDistillatiamaranto86Nessuna valutazione finora
- Torrone in CasaDocumento13 pagineTorrone in CasaHolli CarpenterNessuna valutazione finora