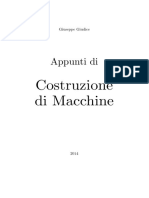Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Gestione Della Produzione Industriale - Armando Brandolese, Alessandro Pozzetti, Andrea Sianesi PDF
Gestione Della Produzione Industriale - Armando Brandolese, Alessandro Pozzetti, Andrea Sianesi PDF
Caricato da
PaoloPetraglia0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2K visualizzazioni320 pagineTitolo originale
Gestione Della Produzione Industriale - Armando Brandolese, Alessandro Pozzetti, Andrea Sianesi.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2K visualizzazioni320 pagineGestione Della Produzione Industriale - Armando Brandolese, Alessandro Pozzetti, Andrea Sianesi PDF
Gestione Della Produzione Industriale - Armando Brandolese, Alessandro Pozzetti, Andrea Sianesi PDF
Caricato da
PaoloPetragliaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 320
ARMANDO BRANDOLESE = ALESSANDRO POZZETTI
ANDREA SIANESI
GESTIONE DELLA
PRODUZIONE INDUSTRIALE
Principi, metodologie, applicazioni ¢
misure di prestazione
CAMERA. BI ‘COMMERCIO. como:
“BIBLIOTECA
Sede Universitaria Lecco
000617
Copyright ©-Uirico Hoeplt-Editore’.
via Hoepli 5, 20121 Milano (Italy)
‘Tutti i diritti sono riservati a norma di legge
€ a norma delle convenzioni internazionali
ISBN 88-203-1902-0
Ristampa:
43°21 0. 199 1992
Copertina di Lamberto Menghi
Composto da Pragma See!
Rimini-Milano
‘Stampato dalla Lito Velox
‘Trento - via degli Orbi, 6
Printed in Italy
Introduzione 1
1 Introduzione ai sistemi produttivi os
1,1 Introduzione 5
1.2 Classificazione delle tipologie di produzione manifatturiera 9
1.2.1 Fabbricazioni q 9
1.2.2. Montaggi Ww
1.2.3 -Classificazione in’ funzione™ del” grado’ di: witoy
mazione 13
1,3. Caratteristiche e problemi delle produzioni ‘manifatturiere 14,
13.1 Fabbricazioni 14
1.3.2. Montaggi 20
1.3.2.1 “ Montaggi:prevalentemente: manuali 20
1,3,2,2 “Montaggi‘automatici : 23
Bibliografia tes 24
2° Misure di prestazione dei sistemi produttivi 27
2.1. Potenzialit& produttiva 27
2.1.1 Premessa 27
2.1.2 La potenzialita di una macchina‘o di un impianto 29
2.1.2.1: Stati possibili é 30
2.1.2.2 Le definizioni della potenzialita 33.
2.1.2:3, . Collegamenti con-altri stramenti di-analisi 39.
2.1.3 La potenzialita di reparti complessi 40
2.1.4 La potenzialita produttiva e |’automazioné!
flessibile 4B
2.1.5 Conclusioni r 44
2.2 Flessibilita ¢ versatilita neisistemi produttivi i 45
2.21 Premessa AS
2.2.2 Flessibilitd e. versatilita: 46
2.2.3 Le dimensioni‘della flessibilita 41
2.2.4” Le dimensioni della versatilita 51
2.2.5 La misura della riconfigurabilitt 52
2.2.6, La misura della convertibilita 56
22.7 Conclusioni 57
Bibliografia 59
3¥ introduzione alta gestione della produzione industitaté 61
3.1 Fasi della programmazione della produzione 62
3.2 Pattori critici per la pianificazione di Iungo periodo della
produzione mplsasiie68
3.3. Fattori critici per la programmazione aggregata n
3.3.1 Domanda pict ied sini saeent 72
3.3.2 Tipologie di Prodotti , 76
3.3.3... Costi 2 allat Bey 79
Bibliografia 85
4. La programmazione aggregata della, produzione 87
Classificazione delle metodologie in funzione delle tipolo-
igie di-prodotti,.della. domanda, dei costi e dei vincolindi.cui
Si tiené conto tet 87
4.2. Modelli di programmazione aggregata. monoprodottos, 92
4.2Aiell:modello di programmazione lineare semplice 92
4.2.2: Il modello di Wagner-Whitin 95
4.3 Modelli di programmazione aggregata pluriprodatto--::« 101
43.1 Imodellodi Programmazione lineare-a numeri in-
teri é 2 ty 102
Tl modello di Karni-Roll 2H 103
Il modello di Aucamp 114,
4.3.3.1 Introduzione: 4 14
43.3.2 ‘Trattazione matematica del modello 115
43.3.3 .Conclusione 124
4.4 © Confronti tra'i-modelli di Programinazione aggregata ¢ i-
nee di evoluzione oad 125
Bibliografia f 132
5 ianificazione dei fabbisogni. 133
Tecniche di gestione a scorta 133
5.1.1 Modelli 136
5.1.1.1 Modelli’switch 136
5.1.1.2. “Il modello OP-EOQ 138
5.1.1.3 _ Il modelo a intervallo di riordino fisso
5.1.1.4 Il modello di Magee-Boodman
La pianificazione dei fabbisogni
5.2.1 Problemi dei modelli di gestione a scorta
5.2.2, Intreduzione alle tecniche di gestione a fabbi-
sogno
S¥s° La tecnica MRP-Material Requirements Planning
5.2.3.1 — Introduzione
5.2.3.2 I dati di ingresso del sistema
5.2.3.3 Le fasi della proceduta MRP
5.2.3.4 Approfondimenti sul concetto di distinta
base € sulla loro gestione a calcolatore
5.2.3.5 Profili di immesso
5.2.3.6 Conclusioni
5.3. Le tecniche Just In Time-J/T
5.3.1. Introduzione
5.3.2. Programmazione.della produzione Just In Time
5.3.3 Trattazione analitica di Kimura-Terada
5.3.4 Conclusioni
Bibliografia
La programmazione operativa
6.1. Introduzione :
6.2 Ipotesi valide nell'ambito della programmazione operativa
63 Classificazione dei modelli utilizzabili: per la programma-
zione operativa
6.3.1 Classificazione in base al sistema produttivo con-
siderato
6.3.2 Classificazione in base agli obiettivi della program-
mazione
6.3.3 Classificazione in base al tipo di tecnica utilizzata
6.4. Modelli per la programmazione operativa
6.4.1. Macchina singola
6.4.1.1 Il modello di Karg e Thompson
6.4.1.2 I modello di Hodgson
6.4.1.3 La minimizzazione del medio flowtime
6.4.1.4 La minimizzazione del medio lateness
6.4.1.5 La minimizzazione del medio tardiness
64.2. Macchine parallele
6.4.2.1 Tl modello di McNaughton
144
145
149
149
153
158
158
160
162
171
187
197
197
200
207
212
215
217
217
221
223
224
231
240
247
247
247
248
250
250
250
251
251
6.4.5
6.4.6
La ‘minimizzazione del makespan in
assénza di|preemption :
La minimizzazione del inedio flowtime
I modello'di Nunnikhovene Emmons
Il modelo di'Parker, Deane e Holmes
Open shop
6.4.3.1" ~ 11 modelo di Kitémia ¢-Gerstiwin
Flow shop : 2
6.4.4.1 Il modello di Johnson
Il modello di Palmer
IW inodéllo di Gupta
6.4.4.4 — Il modello di Campbell, Dudek e Smith
Job shop :
6.4.5.1 La minimizzazione dél makespan
6.4.5.2. Le regole di carico
6.4.5.3 Il thodello di Bechte (Ldad-Oriented
‘Manufacturing Contfol)
6.4.5.4 Il sistema ésperto ISIS
Job shop con magazzino a valle
6.4.6.1 Il modello di Berry
6.5 Cenni allo-scheduling stocastico
Bibliografia
Indice analitico:
252
253
254
255
257
258
260
260
265
266
268
270
271
274
282
296
298
298
300
303
307
Introduzione
La criticita delle sfide sui fronti della qualita del servizio logistico per la so-
pravvivenza la competitivitd delle imprese industriali ha rinnovato in questi an-
ni, sia nella prassi manageriale quotidiana, sia nell’ambito delle discipline che
hanno per oggetto di studio la gestione d’impresa, l’interesse per le tematiche di
Progettazione ¢ gestioné dei sistemi produitivi, visti come elemento essenziale,
anche se certo non unico, per poter-rispondere efficacemente alle sfide predette.
Partendo, come é-giusto, da questa premessa, evidente che la “progettazione”
e la “gestione dei sistemi di produzione industriale” comprendono uno spettro
molto ampio di tematiche di non agevole delimitazione. Pid che un insieme di
tecniche elo metodologie, si tratta infatti di un insieme di problemi che,una qual-
siasi impresa industriale si ova a dover affrontare lungo I’arco di tutte le at-
tivita che, partendo da progetti ¢/o prototipi, materie prime e componenti, per-
mettono di ottenere flussi di prodotti “vendibili”, cio’ disponibili. in quantita
prefissate a scadenze prefissate e con determinati livelli qualitativie di.costo.
Per inserire in un quadro unificante i numerosi problemi di varia natura che
nello svolgimento di tali attivita occorre affrontare, & conveniente riferirsi 4 tre
momenti fondamentali, che si collocano in successione logica:
1. creazione elo adeguamento della capacitd produttiva, ovvero progettazio-
ne (0 riprogettazione) e realizzazione del sistema produttivo:
2. predisposizione del sistema produttivo a nuove produzioni (spesso indica-
ta con il termine “industrializzazione”), ovvero messaa punto dei cicli di
lavorazione necessari, delle attrezzature, delle procedure di collaudo e con-
trollo della qualita, ecc.
3. formulazione e gestione dei piani di produzione; ovvero utilizzo delle ri-
sorse-del sistema produttivo predisposte nelle fasi precedenti per realizzax
re i prodotti desiderati.
In‘un contesto cosi ampio, scartata a priori Villusione di realizzare un trat-
tato completo, si imponeva una scelta di argomenti e di temi. E nato cosi que-
sto volume, focalizzato prevalentemente sul terzo “momento logico fondamen:
tale”, la formulazione ¢ gestione dei piani di produzione o “Programmazione
délla produzione”, anche se neiiprimi-capitoli Pottica si allarga.a proporre un
quadro di riferimento per il posizionamento delle leve di progettazione dei si-
1
j
q
i
2 yNTRODUZIONE: ¥
stemi produttivi e per la misura delle principali prestazioni di tali
un’altra angolazione, il libro pud essere visto come incentrato prevalentemen-
te sugli aspetti gestionali necessari per garantire un’efficace servizio logistico.
IT motivi che hanno portato a tale. scelta sono in sostanza due. II primo & es-
senzialmente pragmatico: gli argomenti trattati corrispondono in larga misura
4 quelli dellinsegnamento “Gestione della produzione industriale” del Corso
di laurea in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, tenendo conto
che in tale Corso di laurea V’intero spettro delle problematiche relative’ ai’ si-
stemi produttivi trova rispondenza in un_pacchétto coordinato"di inseghiamen:
ti, di cui I"insegnamento predetto fa parte. Il secondo motive risiede nel fatto
ché,’a giudizio degli autori, le opere che trattano in mnaniera equilibrata & come
pleta i temi relativi alla prima delle due sfide competitive (la qualita) sono ad
oggi assai pili numerose ‘di quelle relative alla secorida di esse (il servizio lo-
gistico). ; z
* Su'tale tema, infatti; anche nella letteraura internazionale} prevalgono 0 ope-
1é'di Yaglio strategico-manageriale, orientate all’analisi qualitativa'delle macto-
variabili di progetto del sistema ¢ delle loro interazioni, ovveto, all’altro estre-
mo, opere di natura matematico-quantitativa, derivanti dalla matrice:algoritmi=
ca della Ricetca operativa. ‘
La tendenza a “rifuggite” verso uno di questi due estremi 2 in'qualche mo-
do da far risalire-al fatto che, da un lato, l’area della gestione della’ produzio-
ne @una di quelle in cui, per la numerosita dei vincoli ¢ det dati da ‘rattare-e
pér la foro: muteyolézza nel tempo, l’utilizzo di tecniche quantitative risulta pid
difficile, talché in molti prevale la sfiducia nell’efficacia:debloro impiego, men-
tre, dall’altro, per gli stessi motivi di numerosita ¢ mutevolezza, un impiego di
tecniche & metodologie adeguate appare pid conveniente, donde l’enfasi, spes-
50 eccessiva, nei riguardi degli approcci quantitativi.
IL tentativo che anima questo libro & appunto quello di ricercare un. giusto
equilibrio fra l'inquadramento concettuale dei vari problemive delle tecniche
pid adatte:alla loro soluzione, la trattazione quantitativa, ¢ quindi rigotosa,
dei vari modelli e, infine, la valutazione, trata sia dall”esperieiiza industria-
Ie sia dal lavoro di ricerca, sulla pratica applicabilita: delle varie: teeniche é
sui loro limiti. In presenza di sistemi.produttivi sempre pid: complessi¢ co-
stosi, chiamati a far fronte a esigenze di mercato sempre pill pressanti, le im-
prese pitt attente avyertono del resto l’esigenza di introdurre in. misura ¢re-
scente, in un’area finora affidata a notevoli dosi di empirismo, tecniche di-ge-
stione rigorose e quantitative, in grado di garantire con-continuita un utilizzo
efficiente delle risorse produttive, indipendentemente, per quanto possibile, dal-
la capacitd e dall’esperienza dei singoli addetti alla programmazione della pro-
duzione.
INTRODUZIONE 3
Nelle-intenzioni degli autori, quest'opera vuole anche costituire un contribu-
to di ampio respiro alla.sistematizzazione ¢ tazionalizzazione di concetti, tec-
niche e metodologie in qualche modo collegabili alla Gestione della produzione.
I destinatari possono pertanto essere sia studenti di corsi, universitari 0 po-
stuniversitari, che debbano acquisire: conoscenza delle tecniche di gestione dei
sistemi produttivi e dei loro limiti di applicabilita, sia “‘uomini di azienda” de-
siderosi di individuare nuovi spunti di soluzione ai problemi reali con i quali
si confrontano, quotidianamente.
Il lavoro é frutto-della: collaborazione fra gli autori, essendo la sintesi di
un’esperienza quasi ventennale ¢ di un lungo lavoro di ricerca svolto congiun-
tamente presso il Politecnico di Milano.
Il primo capitoio, di carattere introduttivo, propone un quadro di riferimen-
to per I’esaime dei differenti sistemi produttivi; i contenuti del capitolo sono
frutto di una rielaborazione (curata da A. Sianesi), del lavoro “Analisi dei s
stemi di produzione manifatturiera” di A, BRANDOLESE, G. BRUGGER, M.
Garerti, M, Misut; Finanza Marketing & Produzione, Milano, Anno TIl, n. 1,
1985. =
Il secondo capitolo presenta'con maggior ampiezza alcune caratteristiche dei
sistemi produttivi che costituiscono dei prerequi fondamentali pér I’analis
quantitativa dei sistemi stessi; in particolare in questo capitolo sono stati Tac-
colti i due articoli di A. BRANDOLESE “Flessibilith e versatilita nei sistemi pro-
duttivi” e “La misura della potenzialita produttiva: una prospettiva gestionale”,
Economia & Management, Milano, vol. 16, 1990, e val. 18, 1991,
Nel terzo capitolo (a cura di A. Sianesi) sono classificate le differenti fasi
del processo di pianificazione, programmazione e controllo della produzione e
vengono quindi analizzati i fattori critici per la pianificazione e per la
programmazione aggregata della produzione.
Il quarto capitolo (a cura di A, Sianesi) contiene l’esposizione dettagliata dei
pid importanti modelli’ per la formulazione del piano principale di produzione
dei prodotti finiti, presenta i risultati di confronti sperimentali tra i modelli stes-
traccia uno “stato dell'arte” sulle ricerche in corso (quest’ultima parte &
tratta da: A. SIANEsI, “La formulazione del piano principale di produzione:
considerazioni sui risultati di sperimentazioni effettuate ¢ possibili evoluzioni”,
Convegno nazionale ANtMP-OIcE-UAMi, Palermo, 1990).
Tl quinto capitolo (a cura di A. Brandolese e A, Sianesi) analizza e confron-
tale tecniche che permettono, una volta elaborato il Piano principale di produ-
Zione, la gestione di tutte le operazioni di pianificazione — programmazione
= Produzione dei fabbisogni di sottoassiemi, componenti ¢ materie prime che
compongono il prodotto finito stesso. Vengono pertanto presentate le tecitiche
di gestione “a scorta”, le tecniche MRP di gestione “a fabbisogno” e vengono
4 INTRODUZIONE:
analizzati gli aspetti pid direttamente legati alle tematiche della gestione della
produzione industriale presenti nelle tecniche giapponesi Just In Time:(J/T).
Il sesto capitolo (a cura di A: Pozzetti) analizza le metodologie utilizzabili
Per la programmazione operativa, classificandole:in telazioneial. contesto: pro-
duttivo, agli obiettivi della programmazione-e alla tecnica‘risolutiva adottata,
‘Vengono infine presentati alcunisesempi di modelli per lo. scheduling, colloca-
ti all'interno dei tre profili di classificazione sopracitati,
Sulla base dell’esperienza maturata in quest’ oceasione, @ intenzione degli au-
tori estendere in futuro l’impostazione adottata:a altri importanti aspetti della
gestione industriale, primo fra tutti'la gestione della qualita.
Marzo 1991 ‘> ARMANDO BRANDOLESE,
z ALESSANDRO PQZzZETTI
ANDREA SIANESI
Politecnico di Milano
Dipartimento di Economia eProduzione
Questo volume @ stato scritto nell’ ambito delle attivita di Autofaber, un consorzio
di ricerca nel settore dell’automazione industriale costituito da IBM-Semea, Mandelli,
Milano Ricerche ¢ Italtel. z
1
Introduzione ai sistemi produttivi
1.1 Introduzione
In questo capitolo introduttivo viene proposto’un quadro di riferimento com-
pleto, pur senza entrare in dettagli tecnici, per l’esame.dei diversi sistemi pro-
duttivi. Cid al fine di facilitare la comprensione di una reali sufficientemente
complessa ¢ articolata, oltre che soggetta a rapidissima evoluzione.
E opportuno iniziare I’analisi con una classificazione dei profili esogeni (con
il termine “esogeno” si yuole qui enfatizzare il fatto che.tali profili determina-
no ‘dall’esterno” la tipologia del sistema produttivo pid’ opportuna) mediante
i quali @ possibile catalogare i sistemi di produzione- Purtroppo non esiste uno
schema di inquadramento largamente accettato che tenga conto di tutti i diver-
si profili secondo i quali @ possibile analizzare i sistemi produttivi. Ci si atter-
TA pertanto al tentativo di classificazione proposto in [3], che aggiunge ai-due
Profili fondamentali delle modalita di manifestazione della domanda ¢ delle
modalita di predisposizione det? offérta, gid indicati in [5], una terza importan-
te dimensione: le caratteristiche intrinseche del prodotto. Nella fig. 1.1 @ illu-
strato il quadfo di riferimento utilizzato.
Alla luce delle modalita con le quali la domanda si forma (€ trova tisposta
da parte dell’impresa) possono’éssere individuati i tre casi “‘tipici”:
— produzioni su commesse'singole,
— produzioni su commesse ripetitive,
— produzioni per i magazzino (su previsione).
Nel primo caso I’azienda riceve una serie di ordini diversi per singolipro-
dotti (9 per partite di modesta consistenza), differenziati anche in misura note-
vole; per i quali Solitamenite occorre'elaborare il progetto (totalé 0 parziale), il
ciclo di lavorazione ecc. ‘
Nel secondo caso rientrano invece sia le imprese (subfornitrici) che realiz-
zano'una gamma‘di prodotti dalle caratteristiche definite per un gruppo di clien-
ti abbastanza stabile, che richiede delle forniture Scaglionate nel tempo; sia le
aziende che producono"‘sw catalogo”, ma solo dopo il maniféstarsi dell ordi:
iicazione‘secondo il
di ispondere alla dofnanda
Classificazioné's
ikmodo oi reaizzare
il prodotto
Fig.1.1° Profil tilevanti per Panalisi dei sistem produttivi.
ne, per una clientela assai varia una gamma spesso ampia di prodotti, di-cui so-
no definiti in anticipo progetto, cicli, attrezzature, materiali.
Nel terzo caso infine I'impresa realizza, prima del manifestarsi degli ordini,
volumi abbastanza elevati di prodotti, che affluiscono attrayerso.una rete di di-
stribuzione ad un gran numeo di clienti anonimi. eesheeis this
In base alle modalita secondo le quali viene realizzato I’ output, le produzio-
ni possono invece essere classificate come:
— produzioni unitarie,
— produzioni intermittenti (o a lout),
— produzioni continue. ihe sf i:
Nel primo caso la variabilita-dei cicli di produzione @ assai spinta; cosieché
Vattivita produttiva @ organizzata in funzione dell’ottenimento delle quantita
richieste dai singoli ordini.
Nel secondo caso i cieli sono meno variabili nel tempo ed il loro impiego ha
luogo con criteri di alternanzai i prodotti sono realizzati in loti di entita supe-
riore ai fabbisogni immediati, in modo da formare delle scorte.destinate ades-
Tees hrs
INTRODUZIONE AI SISTEMI PRODUTTIVI 7
sere utilizzate in seguito, quando i centri operativi saranno impegnati in altre
attivita produttive.
Nel .terzo caso i cicli restano costanti anche: per periodi notevolmente este-
si, dando luogo.ad un flusso ininterrotto di prodotti dalle caratteristiche omo-
genee nel. tempo.
Nello schema della fig. 1.1 riveste un particolare rilievo, come si é detto, il
profilo rappresentato dalla natura intrinseca del prodotto. A volte gli elementi
che costituiscono il bene: finale non possono essere facilmente identificati; il
prodotto non pud pertanto essere scomposto a ritroso, poiché i componenti ori-
ginari non sono pid distinguibili 0 hanno cambiato natura. In questi casi si par-
Ja di produzioni per processo: ne sono esempio i procedimenti utilizzati per -ot-
tenere acciaio, carta, cemento, prodotti chimici, filati, prodotti-farmaceutici ecc.
Altre volte il'bene ottenuto & costituito. da un certo:aumero di component di-
screti, © parti, in genere di diversa natura. Si pud allora:parlare di produzioni
per parti 0 manifatturiere: si pensi per:esempio a prodotti quali le-automobili,
gli elettrodomestici, le apparecchiature:elettroniche, le Scarpe, i giovattoli ecc.
Una caratteristica ovvia di questo tipo di:produzigne'e che un prodetto pudies-
Sere montato-e smontato (tale: condizione pud anghe venire a cadere,:senza tut-
tavia perdita di generalita,, nel-caso:di assiemaggio mediante:saldaturay incol-
laggio, forzatura, cucitura ecc.), Il processo produttivo, di massiina, compren-
der pertanto sia le fasi di fabbricazione (da intendere.come insieme. di lavo-
tazioni:che:modificano la forma, le‘dimensioni.o lo.stato superficiale: di-parti
singole), sia Je, fasi di montaggio (da intendere,come complesso delle opera-
zioni di.giustapposizione di parti.singole per formare un assieme).
In genere, il primo tipo di produzione.(per proceso) 2 anche’ caratterizzato
da un, ciclo tecnologico ben definito-e vincolante (spesso il. processo:-produtti-
vo non fa-altro che riprodurre le condizioni opportune per realizzare’ una’serie
di,trasformazioni fisico-chimiche, come avviene per esempio.nel-caso della si~
derurgia): si parla percid in termini equivalenti anche diproduaioni a:ciclo téc=
nologico obbligato. 1 procedimenti-del, secondo tipo. sono inyece-caratterizza
da una grande varieta nei. cicli tecnologici delle parti componenti, cicli:che spes-
so.amméttono numerose ‘varianti:, possono pertanto anche essere definiti come
produzioni a ciclo tecnologico non obligato. :
La distinzione sulla base della natura (caratteristiche.intrinseche) del: prodot-
to,corrisponde ad.uno dei profili di:inquadramento proposti in:{7], con'l’obiet-
tivodi individuare i criteri di programmazione e-controllo della produzione pit
adatti, alle. diverse situazioni, produttive, “Tale classificazione:8-infatti costruita
secondo due dimensioni:,. i ‘
all volume. di, produzione (che &-uno dei profili-della fig. 11);
= AL grado.di,complicanza (complicacy) del prodotto.da, realizzare, che & cre-
8 CAPITOLO 1
scente pasando dai:materiali ‘semplici" (produzioni per processo della fig.
1.1) via via ai sistemi complessi (per esempio una centrale telefonica) incor-
Poranti: numerosi processi ed in genere costituiti da un gran numero:di part,
In tale schema il livello minimo di complicanza Civello 0): corrisponde alla
Produzione per proceso; i livelli successivi (dal grado 1 in poi) coprono I’a-
Tea delle produzioni per parti, suddivise in stadi successivi'di integrazione (spes-
so esprimibili con i termini: parte singola, sottoassieme;‘assieme;-gruppo,com-
Plessivo ece.). Il concetto di grado di complicanza erescente passando'da pro-
uzioni. per: processo a produzioni per parti 2 riferito esclusivamente al prodot-
to che viene realizzato, e non allo specifico processo utilizzato: Infattiy:mentre
® innegabile che il grado di-complicanza:di tn’ ptodotto -cresceall’iumentare
del numero di processi che in esso:sono incorporati:(poiché questi ‘si-aecumu-
lano:nel'prodotto), non-necessariamente\in ‘un prodotto complicato &¢omples-
sa la-tecnologia del singolo processo’ di ‘produzioné)utilizzato: Cid" che. si ri-
Scontra in genere & che, al:crescere del grado di omplicanzaidelprodotto? si
ha un trasferimento di prevalenza'dai problemi strettatriente tétnologici a quel-
li impiantistici'e*gestionali. \La‘dircostanza @ dovuta all’aumento' dei ‘gradi di
liberta nei. modi-di:syelgimentodei ‘cicli di produzione,*¢ quindi‘alf’aumento
delle opzioni progettuali e:dei problemi di coordinamento: Menire ‘quindi-nel-
le produzioni per processo si incontrano rilevanti problemi tecnolagici e stru-
mentistici; i maggiori problemi di progettaziowie'e i gestione del sistema pro-
duttivo si incontrano nelle produzioni per parti: Ad esse’ sono-destinati: i suc-
cessivi paragrafi di questa introduzione; verranno infatti descritte'le tipologie
Produttive che si incontrano'con maggior frequenza nelle produzioni- manifat-
turiere’per parti e, successivamente, saranno discussi i campi di applicazione,
i limiti‘ed i pregi di ogni tipologia.
Merita di essere menzionato un altro studio [11], volto alla classificazione
dei sistemi produttivi, che individua le’seguenti “categorie”. di'sistemnivai pro-
duzione, con riferimento: alle caratteristiche dei prodotti‘lavorati edralle-relati-
ve modalita con le quali’ la domanda si forma e trova rispesta da parte ‘@ell"im:
Presa (primo profilo d'analisi disctisso precedentemente).
— Make to stock: produzione di prodotti Standard; gli item Considerati a livel-
lo di formulazione di un piano principale di produtione (vedi capitold:4)
coincidono con gli end-item della distinta base: (Con accezione ‘aniglosasso-
ne BOM-Bill Of Material — vedi capitol 5) 0, even tualinente, con famiglie
di tali item nel caso il loro numero penalizzasse eccessivamente I’elabora-
tione dei piano di produzione; questa categoria corrisponde’ pertanto.alle
produzioni su previsione di prodotti a limitata complicanza, ‘
— Assemble to order: prevede due modalith gestionali distinte: la produzione
Su previsione di sottogruppi standard e la successiva personalizzazioné del
eee
INTRODUZIONE AI SISTEME PRODUTTIVI 9
prodotto finito in fase di assemblaggio finale (effettuata non pid su previ-
sione ma solamente a.fronte di ordini acquisiti); in questa categoria sono
presenti-pertanto le produzioni-a elevata ampiezza di mix di codici prodot-
to finito, caratterizzati perd dalla comunanza di alcuni sottogruppi standard
(vedi paragrafo 5.2.3.4). Rispetto al profilo dei rapporti fra-produzione e
modalita con cui la‘\demanda si forma, questa categoria & pertanto un mi-
sto fra la produzione su previsione (per i sottogruppi standard) ¢ su com-
messa (per I’assemblaggio finale).
— Engineer to order: i prodotti considerati sono tali per cui la,loro produzio-
né-non pud iniziare ‘fino a che l’ordine del committente non sia stato ‘ac-
quisito; solo al momento dell’ordine possono essere attivate le operazioni
di progettazione/ingegnerizzazione (per esempio.per il fatto che i-disegni
del prodotto ole specifiche di qualita di produzione sono fornite dal clien-
teal momento dell”ordine); si riconoscono qui gli elementi-tipici delle pro-
duzioni: per-commesse singole.
— Make to order; analoga alla precedente con la sola differenza che-le attivi-
1a di -progettazione/ingegnerizzazione: possonojesseie anticipate” spello ee
momento dell acquisizione dell’ordine: (commesse'wipetitive) x
Dopo aver presentato brevemente quali sono i fattori esogeni che. pid.diret-
tamente hanno influenza sui sistemi produttivi-e sulle:loro: modalita:di-utilizzo
¢ di funzionamento, si-illustrano le principali tipologie produttive con partico-
lare.riferimento-alle produzioni manifatturiere.
1.2: Classificazione delle tipologie di produzione manifat-
diizionie ‘a Seconda essenzialmente:
dei volumif uinitari da realizzare;
— Wella ripetitivita,
= del valore unitario dai’pezzi.. -
Le:principalisoluzioni’sono descritte nel seguito- Ee
Jayout funzionale’ o per proceso} /4b Shop \nella
pi diffusa termmologia anglosassone). In essa ogni unit dilavoro,jo or-
dine di'lavorazione: (costituito da un’ unico pezzo-o da‘un-certo
pezzi lotto'o batch — che si :muovono assieme, ‘per esempio in un'con-
tenitore © pallet), richiede l"esecuzione di una ‘série di-operazioni:da-parte
10 CAPITOLO 1
‘di un gruppo di centri di lavoro (machine, stazioni, gruppi di-operatori) in
‘una ‘sequenza preassegnata (ciclo tecnologico) che eventualmente pud
ammettere alternative. In-queste organizzazioni produttive la varieta dei ci-
cli da realizzare'8 tale:che'l' unica forma:di ordinamento’ péssibilei® quel-
Ja di aggregare i macchinari in’reparti omogenei'perstipo di: lavorazione re-
alizzabile. T flussi produttivi tendono ‘pertanto ad essere via via pit) intrec-
‘ ‘Giati pasando da job shop impiegati:per-produzioni in.qualche misura ri-
Petitive (cicli'con qualche interferenza) all’impiego in: produzioni su com-
Miesse singole (possibilita di cicli con sensibili-interferenze). La.creazione
di reparti dotati di omogeneitd techologica, oltre’a facilitare-lo scambio di
Competenze fra operatori ela supervision da parte dei capi di’ primo:livel-
1o, mette a disposizione una potenzialitiproduttiva (espressa’per‘esempio
“in termini di ore miatcchina disponibili ‘per Msecuzione di-una data‘classe
di operazioni tipiche del reparto) variamente*atilizzabile per le produzioni
che Ia richiedono, a tutto Vantaggio della fléssibilitaoperativa (tipica dique-
ta'soluizione). ‘
lavorazione sufficientemente omogenéi (sec SHURINMecnologia
“PUGS CSIP TecinatoRyy aT poLsiho create SURG GeMM) i ne
chine (questa volta di natura divérsa) adibite ale TavorantOM Tecessaric per
GCS TT MET produtiy rispetio alle ‘soluzioni del tipo job shop (con
Vantaggi in termini di sémplificazione dei trasporti ¢ della gestione della
Pproduzione); in parallelo diminuisce pero la flessibilita dell’impianto (ogni
cella @ infatti‘dedicata alla lavorazione di una sola famiglia):Pervun’anali-
sidettagliata di questa tematica, che non pud aver'luogo nella presente in-
troduzione, si veda [9]. sai
—P. inee di producone-per prodoito 0 # Waslerimento del prodotto Mrasyferte,
‘iansfer lines 0 linee di fabbricaztone). Queste satel PS'SON0 CO-
stituite da ‘un inst gettato (0 comunque utilizzato) per
Tealizzare rigidamente una sequenzaprefissata di’ lavorazioni, per prodotti
da ottenere in grandi quantita econ varianti limitate. In questo: caso:il:flus-
poi materiali & lineare g
Le soluziont impiantistiche, nell’ordine in éui sono state’ésposte, sono-adat-
te per valori crescenti dei volumi unitari di produizione-e quindi del grado di
Tipetitivita; il Hivello di flessibilita del sistema produttivo &-invece ovviamente
decrescente passando dalla prima alla terza.
INTRODUZIONE AI SISTEM PRODUTTIVI 11
mentaiggi (0 assiemaggi), sempre in dipendenza di vari fattori (comples-
sitd e durata delle operazioni, esigenze di organizzazione del lavoro, volumi da
realizzare, valore unitario dei | pezzi ecc.), si possono presentare di massima i
procedimenti
pLquesto caso l’oggetto da realizzare non si tra-
tazione) all’altra; 8 invece l’operatore che com-
pie'l'intero ciclo di assiemaggio (ed eventualmente di collaudo) del: pro-
dotto avendo a disposizione le parti e le attrezzature necessarie (come per
esempio avviene nel caso del montaggio di machine utensili di medie-gran-
di dimensiogs
‘baat da urlsiste trasporto eventualnien te-alieceanizrato (per *
esempio un convogliatore a nastro oa rulli, a lato-dél-quale: sono: po-
ste le varie'stazioni dotate di un sistema Gsingrono di prelievo-invio au-
tomatico delle parti). Sotto il profilo dei vincoli di ritmo e dei modi di
esecuzione dell'attivitd da parte, degli operatori, queste soluzioni pos-
Sono essere considerate come un insieme di posti fissi, per i.quali la
nea rappresenta a’seconda ‘dei casi il sistema meccanico che-agevola'i
trasferimenti-dell’assieme in. crescita da un’posto di lavoro al successi-
vo (montaggio sequenziale), ovvero il mezzo di adduzione.di-sottoas-
siemi-montati in:posti diversi al medesimo punto di assiemaggio fina-
Je (montaggio’stellare). 2
+ Le linge con ripnasis g.cadenza — paced lines — 0.a trasfe-
fla cadenza di avanzamentosé fissata dal-siste-
ma di trasporto:dei pezzi, e-risulta pertanto. uguale per tutte le ‘stazio-
ni. Spesso la linea viene suddivisa in una serie di sezioni diverse, tra
Je quali possono essere: presenti “polmoni di: disaccoppiamento”: (buf
fer) per.dare-maggiore elasticita operativa in caso di arrestio di'rallen-
tamenti.in-alcune aree.'Le linee a trasferimento contiiiuo.possono es-
Sere corisiderate‘come'un caso particolare di linea a ritmo imposto. Esse
sono essenzialmente costituite da una serie di stazioni disposte Iungo
un convogliatore in moto continuo (aereo.o.a pavimento), recante ipro=
dotti da:assiemare intervallati fra loro adistanza’costante. Il tempo im+
Piegato dal prodotto per attraversare la stazione — di fatto-fisso (in quan:
12, ‘CAPITOLO 4
to imposto dal convogliatore) salvo piccole variazioni possibili se lo spa-
zio assegnato alla singola stazione non é rigorosamente limitato — vie-
ne utilizzato per le operazioni di assiemaggio assegnate alla:medesima.
La soluzione in esame 2 utilizzata per prodotti voluminosi da: montare
in grande serie, quali automobili, lavatrici,domestiche ecc.
La classificazione che precede fa riferimento alytipo di impianto utilizzato
per-il montaggio. Considerando invece gli aspetti di of gahizzazione del lavo-
To, Si possono presentare, di massima, le alternativesdescritte di- seguito.
; controllo, collaudo ¢ riparazione; inoltre ogni addetto
segmento.del ciclo. produttine..
Sonerpossihili quando; realizzando forme di.arricchi-
ob enrichment), aegni laVoratore® assegnata una fra-
STlaudo e riparazione.
Gli isola dipende normalmente dal v di produzione, dal-
la complessita del prodotto ¢ dai vincoli tecnici ed economici derivanti dal-
V'impianto..Nei‘montaggi ad isola possono quindi teoricamente ritrovarsi
> izioni_viste nei montaggi parcellr fos Ts
In questo, caso esiste ung.chiarg.divisione traattis
questo. caso. un erapaedlaunoasositasscenta
Ponsabilitk di realizzare unisepmiento apprezzabile del
= -
meno significativa, quelle indicate per i monlaggl ricomposp. i
east possono presentarsi anche forme di rotazione Gel Tavore~Giek-zoia-
tion). Dal punto di vista impiantistico, con riguardo all’entita del segmen-
to di produzione assegnato e alle modalita di ripartizione dei’ compiti, il mon-
taggio a isole pud accostarsi alle soluzioni a posto fisso 0 a.trasferimento.
‘Anche ‘se dal punito-di vista dell’organizzazione del iavoro € della gestione
delle attivitd- (si. pensi all’intercambiabiliti degli addetti, alla possibilitA di at-
tuare forme di-incentivazione di gruppoy.alle modaliti di programmazione del-
Ja produzione di breve periodo ecc.) le cellule-di fabbricazione ¢-leisole di mon-
taggio risultano in definitiva analoghe, le motivazioni:ehe: stanno: alla base di
queste due soluzioni produttive sono assai differenti. Per le:prime-il fine ulti-
mo & da riceréare nel tentativo di ottenere i vantaggi della: produzione di gran-
de-serie anche per le piccole e medie serie; mentre per le seconde la tagione
di fondo consiste essenzialmente nel tentativo di fornire-una risposta alla ri-
chiesta degli operatori di compiere mansioni pid’ complete e significative. Di
solito, fra altro, per tale via si ottiene anche un aumento della flessibilita
INTRODUZIONE AI SISTEMI PRODUTTIVI 13.
dell’elasticita: dell’ organizzazione produttiva (grazie-alla maggiore capacita di
fare fronte a microconflittualita, assenteismo ecc.), nonché una qualita del pro-
dotto ‘pid elevata ¢/o pid costante:
1.2.3: Clas
icazione in funzione del grado di automa’
ne
Accanto ai profili‘di classificazione delle-fabbricazioni ¢ dei, montaggi in pre-
cedenza illustrati, che prendono prevalentemiente in considerazione-gli:aspetti
impiantistici; gestionali e organizzativi, pud essere interessante considerare il
profilo del grado di automazione, cio’ del livello. di autosufficienza'degli:im-
pianti nello svolgere le attivita-produttive. Si possono cost avere soluzioni ma-
nuali, semiautomatiche, automatiche: f
Pevidente che nella realt’'i profili di-classificazione non-sono indipenden-
tie che-in molti casita scelta di-unassetto per Morganizzazione- del proceso
& strettamente legata al grado di automazione adoitato.
‘Nel campo della fabbricazione, per esempio, 1’ utilizzo di linee transfer & spes-
so legato alla facilita di meccanizzare per intero il processo. In questo stesso
ambito, l"elemento ‘di maggiore novitd & costituito’dai Flexible Manufacturing
System 0 FMS{10}. Essi non sono concettualmenié diversi dallé cellule ma} in
pratica, mediante la presenza di un sistema di trasporto automatico’edi-un cal-
colatore che controlla l’intero processo produttivo, aumentano notevolmente le
prestazioni ottenibili. Gli FMS possono essere pertanto visti sia come, lo. svi-
luppo ‘naturale ‘déi'sistemi di fabbricazione a maggiore flessibilit’, nel momen-
to-in cui si voglia aumentare il loro grado di automazione, sia Come to svilup-
po dei sistemi transfer, quando si desideri aumentare il loro grado di flessibilita.
‘Nel-campo dei montaggi, le linee a trasferimento.possono. essere, classifica
te, sulla base:del grado.di automazione, nelle’ categorie descritte di seguito:
— Binee,gemiautomatiche: Sond frequenti nel montaggio di prodotti dimedia-
alta serie (per esempio motori, duto, machine per-ufficio, confezionamen-
to'di prodotti di largo consumo ece.). In questi casi, a fianco di fasi ma-
nuali per-I"esecuzione di‘operazioni particolarmente complesse & presente
un largo numero di fasi automatizzate (inserzioni, dosaggi; tappature ecc.).
— . Linee_automatiche (transfer 0 a trasferta). Utilizzate per l’assiemaggio au-
tomatico ii produzioni di altissima:serie, sono:analoghe alle linee transfer
di“fabbricazione; tanto. che a volte sulla stessa linea avyvengono siaxopera-
zionii'di'fabbricazione sia operazioni di montaggio. In-esse I’ uomoha eschi-
sivamente funzioni di-controllo-e di alimentazione periodica dei componen-
ti (@sempi'di sitaazioni'di questo tipo si hanno-nella»produzione di tampa:
dine; ‘siringhe'a’perdere, schede elettroniche ece.).
14 CAPITOEO.1
A-quadro. dei. processi automatizzati’ di-fabbricazione : di: montaggio ®in-rapida
evoluzione, per effetto dei veloc progress: tecnologici:relativiai:sistemi di. traspor-
to intemo, ai sistemi di,manipolazione, ai calcolatori utilizzati per-il-controllo.e la
gestione delle attivitA produttive. Un notevole contributo a questi progressi @ dato
anche dagli sforzi di concettualizzazionee di razionalizzazione compiuti al fine di
mettere in luce i fattori chiave del funzionamento dei sistemi produttivi: Oggi'infat-
4, sfruttando le possibilita offerte dall’automazione programmabile, un sistema di pro-
duzione opportunamente progettato ¢ realizzato.pud presefitate earatteristiche inter-
medie rispetto a quelle dei.tipi descritti in precedenza,.con-il-vantaggio di-gonsegui-
Te i benefici offerti da-ciascuna soluzione.di base senza doverne-sopportare ji limiti,
Eda notare come anche per i processi-di assemblaggio, analogamente.a quanto det-
to peri processi-di fabbricazione, anghe se.con maggior ritardo rispetto a.questi ul-
timi, si vanno diffondendo installazioni di sistemi flessibili.(FAS-Flexible. Assembly
System) caratterizzate da un elevato,grado ‘di automazione (soprattiitte. come softwa-
re di gestione ¢.controllo della produzione) applicato a produzioni:non di,grandissi-
ma serie (il mix che viene prodotto sui FAS 2 molto pid ampio.di quello prodotto
sulle linee completamente automatiche). Prerequisito fondamentale per l'adozione di
sisterni FAS & in ogni,caso lo sforzo di-razionalizzazione delle attrezrature produt-
tive e dei prodotti (che devono essere progettati espressamente.con riferimento al si-
stema di produzione sul. quale doyranno essere assiemati) il che permette di dimi-
nuire Ia durata (éd i costi) dei cambi di produzione da un modello all’altro,
13 Caratteristiche e.problemi delle :produzioni manifat-
turiere
Verranno ota esaminati con qualche dettaglio gli aspetti -fondamentali di:pro-
gettazione e di gestione, i campi di applicazione, i limitived i pregi-di ogni ti-
pologia di sistema produttivo riscontrabile nelle produzioni manifatturiere: Per
maggiori approfondimenti:si veda (3). “oh :
1.3.1 Fabbricazione
Ponendo a confronto le soluzioni estreme, fra quelle possibili per i processi di
fabbricazione manifatturiera, la tab. 1.1 permette di-definire + principal punti
di forza e di debolezza della produzione per teparti (job:shop) ed’in linea. A
commento della tabella, si noti che molti punti di forza di una. soluzioné Tap-
Presentano punti di debolezza dell’altra, secondo un rapporto di antitesi. Altri
aspetti sono influenzati anche dal volume di-produzione realizzato, per cui al
INTRODUZIONE Al SISTEME PRODUTTIVI 15
‘Tab. 1.1 Contronto punti di torza-debolezza Linea/Job Shop
Punti di forza Punti di debolezza
Job Shop
Investimento ridotto Ati tempi di attraversamento
Alta flessibilita Elevate WIP
Elevata elasticita Scarsa saturazione
‘Scarsa obsolescenza > ‘Alti costi di manodopera
Rapido avvio di nuove. precuzioni Qualita non omogenea
‘Scarsa prevedibiita tempi di consegna
Difficte reperibilita manodopera specializzata
Linea
Ridotti tempi di cicio Notevole rigidita
Ridotto WIP Investimenti elevati
Elevata saturazione Rischi di rapida‘obsolgscenza
Ridotto fabbisogno di manodopera —...-.-... Wulnerabilité ai-guasti
Qualia uniforme Elevato tempo di avvio dhnuove produzioni
variare della scala operativa una. caratteristica pud.tramutarsi.da positiva.in ne-~
gativa, e viceversa. Per esempio, il fattore “riduzione dell *investimento”, che
generalmente gioca a favore del job shop, pud invertire il suo effetto qualora
si debba ottenere un elevato volume di prodotto. Infatti la mag gior produttivi-
12 della linea pud consentire di realizzare un imptanto pid’ piccolo ¢ di ininor
costo rispetto ad una soluzione equivalente per reparto. :
La progettazione dei sistemi di fabbricazione basati sul concetto di job shop
richiede una‘stima dell’entitd dei fabbisogni, netti (per esemipio in‘ termini di
‘ore/anno) per'ogni tipo di lavorazione richiesta (per esempio tornitura’ frésa-
tura, ricottura ecc., con un’eventuale ulteriore suddivisione in base a Classi di-
mensionali,‘di lavorabilitd ece.) nonché dell’ammontare dei tempi, morti, con-
seguenti ai riattrezzaggi (setup).per i:cambi di produzione (dipendenti’anche
dalle-modalita di gestione dell*impianto), al fine di calcolare il fabbisogno lor~
do (espresso-in ore/anno) per ogni ifunzione, L’analisi di tale-fabbisogno; tenu-~
to conto della disponibilita-annua delle varie macchine:(che't:funzione del:nu-
mero di turni, dei-tempi-di manutenzioné éce.), porta alla,determinazione’del»
parco. machine necessario: Risolto.in\tal:modo, anche:se in maniera approssi-.
mata, il problema della fissazione della, potenzialita.dei centri di lavoro, restax;
no.da, dimensionare. le, aree-di stoccaggio necessarie per.contenere.i, pezzi.in
corso: di-lavorazione. (Work. In Progress-WIP)..
Ben pid:complessi, anche: sul piano concettuale, sono gli aspetti di gestione
di questo tipo di sistema, con particolare riferimento alla programmazione del.
Ja produzione.. Si tratta:infatti di risolvere il. problema dell’allocazione‘divuna:
—PFlusse delle parti
VV Magazzino j
Fig. 1.2” Schema dei tlassi produttiv’ in sistemi di fabbricazione di tipo job-shop.
Setie di tisorse limitate (le machine) ad un insieme di impieghi (1 prodotti) i
Gui cicli (suecessione di utilizzo delle machine) sono parzialmente sovtappo-
sti fra loro € non necessariamente: unidirezionali (fig, 1.2). Il quadro é reso an-
cor pid complesso dalla variabilita nel tempo del mix dei prodotti (insieme de-
gli impieghi) e dalla influenza degli effetti casuali tipici delle situazioni in cui
il job shop opera (modifiche nelle richieste dei clienti, variabilita delle carat-
teristiche delle materie prime ecc.).
La complessita dei problemi di gestione della produzione per reparti porta
ad acceitare nella pratica soluzioni empiriche presumibilmente:abbastanza lon-
‘ane dall’ottimo. Cid, spinge di regola, in fase di dimensionamento dell'impian-
to,.a rieorrere a cocfficienti cautelativi che di fatto.danno: luogo a¢- un. sovra-
dimensionamento della.capaciti. Per-tale motivo i tassi di saturazione netta (1)
delle machine nei job shop sono tipicamente sidotti a valori sion. superiori ab
15-20% nel caso. di produzioni su:commesse singole,’ed al'60-70% nel caso di
Produzioni di natura ripetitiva (in-genere realizzate a lott)
J. Per tasso di saturazione si pud in generale intendere:il rapporto ta iD ténipovin‘éul uti data Pi8orsa
roduttiva & impegnata in attvita connesse con la produzione éd il tempo totale di dispontbilita della risorca
lesen; Per saturazione netia si intende lo stesso rapporio, solo che al numeraiore & presente sola I'effetivo
tempo di Ievorazione, depurato quindi da tui gli alr tempi quali arezzaggi,preparazioni ecc. Pet maggios!
‘pprofondimenti si veda comanque il paragrato dedicato alla potcnzialita produtliva nel eapitolo 2.
INTRODUZIONE Al SISTEMI PRODUTTIVI 1
V-O-E-E--
Macchina
—> Fuusso delle pant
YV Magazzino
Fig..1.8 Schema del flusso produttivo in sistemi di fabbricaztone i tipo transfer.
Problemi tipici della programmazione della produzione nei job shop sono la
scelta dell’entita dei loti di produzione e la determinazione delle sequenze di
inoltro dei singoli lavori all’interno dell’impianto (loading) e sulle sitigole mac?
chiné (dispatching), tenendo conto per esempio deiterinini diconsegha nonché
di varie esigenze operative: la saturazione del macchinario, la limitazione dei
lavori in corso, il contenimento dei tempi di attrezzagio.ecc. (vedi capitolo 6).
Passando dalle strutture per reparti ai sistemi di-fabbricazione -in linea (fig.
1.3), i maggiori problemi si spostario dalla fase di gestione a quella di proget-
tazione. Questi sistemi richiedofo infatti una progettazione accurata dak punto
di vista del bilanciamento e della disponibilita, poiché tali parametri-condizio-
nano fortemente il livello delle prestazioni. E importante in particolaré che non
vi sia una stazione pit: lenta di altre ad influenzare negativamente la cadenza
dell’intera linea‘e che 1a disponibilit& (cioe la frazione del tempo totale in cui
Fimpianto noné guasto) sia alta, al fine'di garantire Ia realizzazione degli éle-
vati volumi:di produzione ‘che hanno giustficato la scelta di questo tipo di si-
stema, nonostanite il’ notevole costo di impianto.
‘Prima diprocedere-alla realizzazione di una linea transfer & necessario inol+
tre.compiere un’analisi approfondita dei rischi-di: mercato ‘ab-quali'si-va incon=
tto dotandosi di una certa capacita produttiva per uno specificorprodotto.. Una
volta realizzato:”impianto} se il mercato non assorbe il volume:di’produzione.
che.é stato utilizzato. per il dimensionamento, si-determitiano-dei: fenomenidi
insaturazione che elevano in modo spesso notevole i costi, compromettendo:la
capacit). dellimpresa.di remunerare adeguatamente il capitale.investito, o°ad-
dirittura di raggiungere l’equilibrio-economico.
Si'deve.ticordare’ che il rischio, di mercato non & comunque assente nel. ¢a-
so in cui si, scelga-un sistema di tipo. job shop, alla luce: delle sue pidelevate
18 ‘CAPITOLO:1 ‘
caratteristi¢he di flessibilitd e di elasticita, Una volta realizzato Timpianto, se
il mercato’si espande vi & infatti la possibilita che un altro produttore, dotato
di una linea transfer, consegua dei vantaggi competitivi sia sull piano dei costi,
sia anche sul piano dei tempi di risposta ¢ della qualita del prodotto, tendendo
precaria la condizione dell’impresa concorrente.
Completando da un punto di vista generale il confronto tra le due soluzioni
esaminate, la differenza pid significativa sembra essere Ta seguenté:
— il job shop @ un sistema produttivo che mette a disposizione una “capacita
tecnologica” (in termini di gamma di lavorazioni);
— la linea transfer 2 un sistema produttivo che mette a disposizione una
“capacita di produzione” (in termini di volumi lavorati).
Esiste pertanto un differenziale di livello fra le due soluzioni: nella seconda
vi & pure della capacita*tecnologica, che peraltié’theorporata nell’impianto
diretto alla realizzazione di uno specifico prodotto (0 di.una gamma ristretta di
prodotti);.nella prima invece la definizione del cigig,di proguzione non snep-
Pure accennata € deyono essere prese di volta in. volta le mistre necessarie
all’adeguamento delle machine alle aperazioni (attrezzaggio):sia al reperimen-
to, fra quelle possibili, delle particolari capaciti teenglogiche richieste nei. di,
versi casi (routing).
Lo. stesso tipo di analisi pud essere compiuto-con.siferimento.al ciclo di
fabbricazione di un generico prodotto realizzato con una delle diverse solu:
zioni produttive esaminate. Se, come & mostrato nella fig. 1.4, siindicano con
dei, grafi le alternative di fabbricazione di ogni parte componente, si avra in
generale un andamento di tipo vario (in parte lineare, in parte sintetico 0 ana-
Titieo): 2
Fabbricare un particolare vuol dire in pratica ordinare in sequenza le‘ope=
razioni-in uno dei-tanti modi che rispettano i vincoli di precedenza del grafo
di base, e approntare poi le attrezzature necessarie per ogni operazione (cre=
azione del ciclo). ‘Cid pud essere fatto una volta per tutte realizzando una li-
nea di produzione (sari importante allora aver scelto ¢ bilancidto'bene la se-
quenza) oppure decidendo caso per caso le unit dei diversi reparti'da-utiliz-
zare (considerando magari anche le alternative per/poter superare le momen:
tanee indisponibilita di qualche machina); Anche. sotto questo iprofilovil: sie
Stema a cellule si presenta come una soluzione inteftiedia) poiché rende’di-
sponibile una capacith per un numero limitato di parti (famiglia) e richiede
riattrezzaggi contenuti.
Da ultimo, & necessario considerare le differenze che si ravvisano fra i due
Sistemi produttivi in esame dal punto di vista dei tempi di preparazione per
la produzione (virtualmente nulli nel caso della linea una volta terminata la
fase di industrializzazione dei prodotti) e dei tempi mediamente necessari per
INTRODUZIONE Al SISTEMI PRODUTTIVI 19
af altemativo A-A
1.4 Rappresentazione mediante grato di un ciclo di lavorazione:
ottenere in ogni fase del ciclo la capacita tecnologica necessaria (disponibi-
le per scelta progettuale nel sistema transfer; da reperire, invece nel,caso:del
job.shop,.a fronte di una capacita finita, spesso gia allocata ad altri Javori).
Cid si traduce in tempi di permanenza del prodotto nei circuiti-produttivi, ¢
quindi in tempi di risposta (lead time) del sistema, diversi in termini di ordi-
ni-di grandezza, a parita di tempo tecnico. necessario’ per-le lavorazionin‘B
usuale, in: proposito definire la. cosiddetta Manufacturing Cycle Efficiency
(MCE).come rapporto fra-il-tempo.tecnico..e il-lead time. del-sistema,
esprimendo il lead time come somma dei tempi tecnici + i tempi.di ispezione
¢ controllo + i tempi di movimentazione + i-tempi di attesa.
Per‘un job shop'non’sono infrequenté valori di. MCE compresifral/25 # 1/30;
per una linea il rapporto sale‘a valori dell’ ordine dell unita. Nel secondo'caso, vi
@ naturalmente la contropartita rappresentata dalla rigidita propria di-un sistema.
produttivo ‘che pér sua natura presenta un clevato livello di-specializzazione.
Gli FMS costituiscono anche da questo punto di vista una significativa evo-
luzione dei metodi produttivi: essi infatti, riducendo a valori trascurabili i tem-
pi assorbiti dai cambi di: produzione, éliminano uno dei pit seri'limiti dei job
shop, estendendo cost il campo di applicazione delle soluzioni fondate sul.con-
cetto di “‘capacita tecnologica’’. Poiché nella pratica non sempre é facile o pos-
20
sibile [2]-realizzare un FMS ad
CAPITOLO 1
amplissima ‘gamma’ produttiva (I"equivalente
automatico del job shop) i sistemi di questo tipo finora installati'réalizzano di
Solito famiglie ben determinate (anche.se sufficientemente-ampie) di pezzi. Cid
che cotita, in ogni: caso, & rilevare’che I’ FMS non ‘tappreSerita un diverso mo-
do‘ di fabbticiire, ma una realizza:
Stema-produttivo per “capacit’ té
ti fra i vari tempi di esecuzione e di prepar
I'FMS modifica anche 1’;
1.3.2: Montaggio
1.3.2.1 Motitaggi prevalentemente'manuali isis
In generale, mentre per il montag;
corte alla soluzione a posto fisso,
volumi® prassi comune adottare
zione per via largamente-automatica di un
cnologica” {6}. Di-faité ped; poiché i tappor-
azioné cambiano 8ignificatamente,
area di convenienza applicativa ‘di questa soluzione.
shim
gio di impianti ¢ grandi apparecchiawitelsive
hei processi di montaggio per medio-geandi*
il sistema della linea. Cid a motivo dellatini
nor rilevanza degli investimenti in.attrezzature e del ‘numero inferiore di unite
produttive da gestire: mentre infatti nella fabbric:
te sonole diverse parti realizzate,
queste-ultime nell’assieme finale.
L’attenzione’si concentra percid sulle diverse vie
Te ciclo di'un prodotto}:piuttosto cl
ione-si hanno. tanti cicli quaii=
& solitamente-unico il ciclo di montaggio di
per réalizzare-if particola:
he sul modo di rendere possibili pid cicli sul:
lo ‘stesso: impianto, come: nel caso della fabbricazione. dunque consideratd
Tab. 1.2-Caratteristiche: delle, soluzioni di
Punti di forza
s
{Posto fisso
Investimento ridotto
Lavoro vario
Controllo qualita sernpiificato:
Rapido. avvio di nuove produzioni
Linea
Ridotti tempi ai ciclo
Ridotto wi
Ingombro timitato
Ridotto costo ci manodopera
Flusso delle parti pid razionale
Hi montaggio manuale
Punti di debolezza
Alto tempo di ciclo
Elevato WIP
Flusso.delle parti intrecciato. &
Notevole. ingombro
Maggiori costi di manodopera
Difficile addestramesite mariodopera
Notevole rigicita
Investimenti elevati
Ditficile bitanciamento
Lavoro ripetitivo S
Maggior tempo di awio di nuove produzioni
INTRODUZIONE Al SISTEME PRODUTTIVI 21
prevalente il problema di progettare accuratamente il
ottenere un efficiente utilizzo delle attrezzature.
Nel caso di montaggio di un solo tipo di assieme (0 di una gamma con varian-
ti limitate) che richieda un prevalente intervento manuale come, per esempio, pet
Vassemblaggio finale nell’industria automobilistica, ponende anche in questo ca-
$0 a confronto le situazioni estreme, la tab. 1.2 mette in luce i prineipali punti di
forza e di debolezza del montaggio, rispettivamente, a posto fisso o.in-linea.
Caratteristica dei sistemi di montaggio a posto fisso 2 la necesita di dispor-
te in ogni posizione di lavoro di tutte le parti e le attrezzature necessarie per
arrivare al completamento dell’assieme finale. Di conseguenza, se il numero di
posti di montaggio 2 alto (come avviene per esempio se il tempo. di-montaggio
& abbastanza elevato ¢ se il volume di produzione di assiemi non @ piccolo), il
flusso delle parti risulta molto intreceiato. Per contro ogni operatore ha sotto
controllo l’intero processo di montaggio; inoltre pud compiere la verifica di fun-
zionalita e l’eventuale riparazione dei difetti di prodotti anche complessi (si pen-
si per esempio al montaggio di macchine utensili, quadri elettrici ecc.).
Una soluzione in grado di migliorare 1a-gestione-del flusso dei componenti,
ma che peraltro non: tisolve il problema. dell’eleyato numero di;postazioni: di
lavoro e delle relative attrezzature, quella di avviare al posto di-montaggio
set completi (kit), comprendenti tutte le parti. necessarie per realizzare un.dato
assiéme.’ Questa soluzione diviene pressoché indispensabile qualora ‘i voglia
utilizzare un sistema’a posto fisso per il miontaggio di assiemi diverst (varian-
ti), comsequenze e mix di produzione variabili nel tempo. Si noti’ infine che,
nella-thaggior parte ‘dei settori industriali, la divetsificazione del:prédétto fini-
to & ormai*titenuta.un--fattore critico di successo; ‘si assiste’ pertanto~alla
“proliferazione” di varianti che, partendo dalla stessa struttura di prodotto} dif-
feriscono per un numero telativamente’limitato di’ particolari at
Il montaggio a trasferimento (0 in linea) trova applicazione soprattutto in pre-
senza ‘di elevati volumi produttivi edi assiemi-di dimensioni' ¢onsiderevoli (&
da notare che anche il costo delle attrezzature di montaggio; se rilevante, pud
far preferire questa soluzione al sistema a posto fisso).
‘Un:esempio @ fornito dalla fig. 1-5: (si ticorda che con il’términe di stazione
si indica una postazione di lavoro dove @ svolto un segmento ben definito-del
processo:di montaggio'— una‘o:pid operazioni— denominato fase).-Ogni fa:
se pud essere assegnata ad una © pil stazioni: ilsnumero di queste ultitrie:indi-
ca allora il grado: di “parallelizzazione” dell’attivita produttiva. Di, regola, al
termine di-un certo numero di fasi successive 2 possibile eseguife' uit/control-
lo. (funzionale, geometrico:ece.). ath
Con-questa soluzione impiantistica il flusso delle parti damontare' molto pit:
razionale, poiché ogni postazione deve essere alimentata solo con una quota‘dei’
lo rispetto. a quello di
Te boa
Gentro ai lavoro (stazione)
1 Fase
“oP Flusso delle pani
Fig: :5°"Schema dei Tissi produit’ nei sistemi ai montaggi'd trasteriiento (in linea).*'
Particolari.costituenti il prodotto. Inoltre, ogni postazione richiede un minor. nu-
mero.di, attrezzanure, consentendo cosi di ottenere una.miglior saturazione.com-
Plessiva, che pud permettere a sua volta I’utilizzo di mezzi pid sofisticati ed a pid
clevata produttivita..Si deve in ogni caso osservare.che la potenzialita produttiva
della linea, dipende tipicamente solo dal tempo di completamento:del. lavoro da
Parte della stazione (0 del gruppo di stazioni) che,procede con maggior.lentezza,
Anche nel caso.di montaggio a trasferimento & possibile migliorare. la gestione
del. flusso dei componenti ricorrendo ai kit: Per esempio, nel.settore degli elettro-
domestici,, uno.stesso.modello base di, frigorifero. viene; generalmente. addobbato
con differenti “gadget”, personalizzati per canale di distribuzione, quali differenti
Portabottiglie, vassoi supplementari ecc.,.che possono essere movimentati in kit.
[pid rilevanti problemi di progettazione nei sistemi-di, montaggio manuali
sono legati: {
— alla progettazione det posto ¢ del ciclo di lavoro dell’ operatore (con le'so-
-luzioni sia a posto-fisso sia in linea);
7 al Bilanciamento fra i diversi stadi del processo (con i sistemi in linea).
Per-dare una risposta al. prima problema possono essere iutilizzate, fra l’al-
To, molte delle tecniche di analisi de! lavoro sviluppate negli ultimi-decenni
(MTM, cronometrageio, ergonomia ecc.). Il secondo. problema consiste nel de.
terminare quali, fra tutte le operazioni necessarie al montaggio completo. del
INTRODUZIONE AI SISTEMI PRODUTTIVI 23
prodotté finité,-assegnare ad ogni staziorie, in modo “bilanciato” e nel rispet-
to dei vincoli tecnologici di precedenza e di massimo carico di lavoro assegna
bile alla singola postazione. Nel caso.delle linee manuali, tale ricerca & resa’
particolarmente complessa dalla variabilitA intrinseca dei tempi di montaggio
degli operatori (il tempo. di montaggio dipende: infatti dalla’ predisposizio-
ne/abilit& dell"operatore, dall’affaticamento ecc.).In ogni caso, l’interdipenden=
za fra stadi derivante dalla soluzione in linea pone, pur con il ricorso a meto-
di di bilanciamento sofisticati, un limite superiore di.convenienzavalla satura-
zione degli operatori addetti al montaggio. Tale situazione pud essere supera-
ta solo riducendo la rigidita del vincolo di dipendenza fra i diversi stadi (per
esempio con la creazione di polmoni di disaccoppiamento statici o circolanti).
1.3.2.2 Montaggi automatic:
Liimpiego di linee di montaggio automatiche @ stato finora in prevalenza basato
su sistemi a trasferimento fisso, realizzati ad hoc, perl’assiemaggio in:grandi yo-
lumi di prodotti relativamente poco complicati. Con.questa soluzione vengono:
meno i vantaggi in. termini di flessibilita:e di riduzione: degli investimenticfissi
del montaggio manuale, mentre si presentano i problemi di rigidit e di rischio
di obsolescenza delle linee transfer di fabbricazione. Anche i robot industriali so-
no stati finora utilizzati prevalentemente in linee di, montaggio del. tipo transfer
(anche se con cicli’di stazione complessi, consentiti:dal particolare tipo.diim-
pianto considerato), sfruttando principalmente Ja loro capacita di operare in.con-
tinuo_senza-decadimento di-prestazioni anche in ambienti insalubri (si,pensi ai
robot di saldatura e-verniciatura). Assai meno sfruttate.sono state, invece. finora
le notevoli caratteristiche di programmabilita, ¢ quindi di versatilita, di queste
macchine, Cid: in gran parte. dovuto. alla dotazione.assai- ampia-di attrezzature
che sarebbe necessario fornire all’organo di manipolazione del robot per render=
lo effettivamente flessibile; questo di fatto conduce, quando si sceglie.una parti-
colare organizzazione del posto di lavoro, a conferirgli un assetto rigido.
Nei casi in‘cui l'aumento'del rapporto costo delle attrezzaturelvalore-del
prodotto, oppure l’ampliamento della gamma da realizzare, rende interessan-
te la possibilita di montare prodotti diversi sullo stesso impianto, si sta,affer-
mando la tendenza ad abbandonare la tradizionale impostazione “verticale”
del processo, che prevedeva impianti orientati alla realizzazione dell'intero
prodotto, ed.a creare invece, con un criterio “orizzontale”, dei sistemi di mon:
taggio per classi di opérazioni. Questi ultimi consistono in cellule di’ montag-
gio, costituite da robot industriali eventualmente integrati con machine spe-
cifiche (per esempio: piccole presse per ribadire 0 forzare, avvitatori, calibri
ece.) in: grado di‘ realizzaré unia. gamma di operazioni di-assiemaggio peruna
Potrebbero piacerti anche
- Progetto Corso 2 RiassuntiDocumento208 pagineProgetto Corso 2 RiassuntiPaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- Esercitazione Deformazione TermicheDocumento9 pagineEsercitazione Deformazione TermichePaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- Procedure Approvvigionamento InputDocumento6 pagineProcedure Approvvigionamento InputPaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- Meccanica Razionale PDFDocumento70 pagineMeccanica Razionale PDFPaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- 02-Gestione Colli Di Bottiglia-1Documento8 pagine02-Gestione Colli Di Bottiglia-1PaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- Appunti 2018Documento269 pagineAppunti 2018PaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- Dischi in RotazioneDocumento14 pagineDischi in RotazionePaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- Dispense Lo GiudiceDocumento252 pagineDispense Lo GiudiceFerruccio RossiNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di Meccanica Strutturale - Temi D'esame SvoltiDocumento33 pagineFondamenti Di Meccanica Strutturale - Temi D'esame SvoltiPaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- Esercizi Matlab Su MatriciDocumento6 pagineEsercizi Matlab Su MatriciPaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- Esercizi e Programmi (l9 Prima Parte)Documento16 pagineEsercizi e Programmi (l9 Prima Parte)PaoloPetragliaNessuna valutazione finora
- Esercizi Matlab Su MatriciDocumento6 pagineEsercizi Matlab Su MatriciPaoloPetragliaNessuna valutazione finora