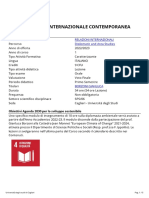Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Report GEOGRAFIA DELLE RISORSE
Report GEOGRAFIA DELLE RISORSE
Caricato da
Volevo fare l'artisticoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Report GEOGRAFIA DELLE RISORSE
Report GEOGRAFIA DELLE RISORSE
Caricato da
Volevo fare l'artisticoCopyright:
Formati disponibili
[SP/0070] GEOGRAFIA DELLE RISORSE
Informazioni generali
Corso di studi RELAZIONI INTERNAZIONALI
Percorso Diplomatic and Area Studies
Anno di offerta 2022/2023
Anno di corso 1
Tipo Attività Formativa Caratterizzante
Lingua ITALIANO
Crediti 9 CFU
Tipo attività didattica Lezione
Tipo esame Scritto
Valutazione Voto Finale
Periodo didattico Primo Semestre
Titolari SISTU GIOVANNI
Durata 54 ore (54 ore Lezione)
Frequenza Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare M-GGR/02
Sede Cagliari - Università degli Studi
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
I contenuti del corso sono coerenti con i seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU
Università degli studi di Cagliari Pag. 1 / 5
Obiettivi formativi
Il corso si prefigge di fornire agli studenti i principali strumenti conoscitivi e interpretativi
della geografia delle risorse e delle politiche dell'ambiente, nella loro sistemica e territoriale.
Conformemente a quanto previsto dai Descrittori di Dublino (I-V), alla fine del corso lo
studente avrà acquisito le seguenti conoscenze e abilità:
I. Conoscenza e comprensione: lo studente acquisirà la conoscenza dei principali modelli
interpretativi del rapporto uomo-ambiente, delle principali criticità ambientali esistenti alle
diverse scale di osservazione e delle politiche volte alla salvaguardia delle risorse del pianeta.
II. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: grazie alle nozioni apprese, lo studente
saprà analizzare la geografia delle risorse del sistema mondo e comprendere le strategie di
gestione delle risorse naturali attuate dai vari decisori politici.
III. Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di formare un giudizio indipendente e
critico sulle politiche di gestione delle risorse del sistema Terra.
IV. Abilità comunicative: lo studente acquisirà la capacità di comunicare le competenze
acquisite, nonché le proprie opinioni in merito alle questioni più controverse legate al
rapporto fra uomo e ambiente naturale.
V. Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di poter applicare conoscenza e
comprensione acquisite agli ambiti professionali e di ricerca attinenti alle politiche di
governo dell'ambiente.
Prerequisiti
I prerequisiti per la comprensione dei contenuti del corso sono:
Conoscenza di base della geografia umana ed economica;
Sufficiente dimestichezza con l'uso delle carte geografiche e tematiche;
Capacità di interpretazione dei dati statistici e dei cartogrammi;
Praticità nell'uso di internet.
Università degli studi di Cagliari Pag. 2 / 5
Contenuti
Il corso sarà articolato in due parti.
Nella prima parte verranno approfonditi il significato e i contenuti dell'analisi geografica nella
rappresentazione dell'ambiente e nella definizione delle risorse naturali, rinnovabili e non
rinnovabili, con uno specifico approfondimento sull’approccio geografico al cambiamento
climatico
Argomenti della prima parte (30 ore):
Introduzione all'analisi geografica;
Dalla natura al territorio;
Le rappresentazioni dell'ambiente e la classificazione delle risorse
Il governo delle risorse comuni e dei beni collettivi
Le conseguenze e le risposte al cambiamento climatico in una prospettiva geografica
Una chiave di lettura della geografia delle risorse: la risorsa cibo nel sistema globale
Argomenti della seconda parte (24 ore)
Una seconda chiave di lettura della geografia delle risorse: l'acqua, un bene comune della
Terra:
- La rarefazione della risorsa: risorsa abbondante spesso insufficiente;
- Gli usi dell'acqua;
- Water Grabbing. Le guerre per l'acqua?
Una terza chiave di lettura della geografia delle risorse: Land Grabbing, il processo globale di
acquisizione di terre su vasta scala.
- Obiettivi, attori e conseguenze della corsa alla terra.
Una quarta chiave di lettura della geografia delle risorse: geografia politica delle risorse
minerarie ed energetiche
Metodi didattici
Il corso è articolato in 54 lezioni frontali complessive con moduli della durata di 2 ore
ciascuno. All'attività didattica parteciperanno esperti in tema di risorse e politiche
ambientali. Verranno utilizzati strumenti audio-visivi, in particolare la proiezione di
documentari sui temi trattati.
Si ricorda che il Manifesto Generale degli Studi stabilisce che “La didattica verrà erogata
prevalentemente in presenza, integrata e “aumentata” con strategie online, allo scopo di
garantirne la fruizione in modo innovativo e inclusivo.”.
Università degli studi di Cagliari Pag. 3 / 5
Verifica dell'apprendimento
La valutazione consiste in una prova scritta comprendente domande a risposta aperta sugli
argomenti svolti a lezione (per es.: Il concetto di ecosistema e la sua utilità per i sistemi
antropici; I differenti valori, anche politici, della biodiversità; Il ruolo della risorsa idrica nel
conflitto arabo-israeliano; Le migrazioni di massa e i rifugiati ambientali).
Per gli studenti frequentanti è previsto un esame intermedio, con le stesse modalità, alla fine
della prima parte del corso.
Gli esiti saranno pubblicati e verbalizzati tramite il sistema Esse3.
Modalità di determinazione del voto:
Nella valutazione dell'esame, la determinazione del voto finale tiene conto dei seguenti
elementi:
1. La capacità dello studente di utilizzare argomenti appresi coerentemente alla risoluzione
del quesito proposto;
2. La capacità di aver colto i nessi che intercorrono tra i temi trattati, in una visione di sintesi;
3. La conoscenza degli argomenti del corso;
4. L'utilizzo di un linguaggio appropriato.
Per superare l'esame, e riportare quindi un voto non inferiore a 18/30, lo studente deve
dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati nel corso
(punto 3) e di essere in grado di esprimerli in una visione di sintesi e con spirito critico
(punto 2), con una argomentazione almeno accettabile (punto 1) e un linguaggio privo di
errori gravi (punto 4).
Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece dimostrare di aver
acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso (punto 3),
con una elevata capacità argomentativa (punto 1), un'ottima capacità di sintesi (punto 2) e
un linguaggio corretto e appropriato (punto 4).
Università degli studi di Cagliari Pag. 4 / 5
Testi
Per la prima parte:
M. Bagliani, E. Dansero, Politiche per l'ambiente. Dalla natura al territorio, UTET Università,
2011, pp. 1-106 (escluse schede)
M. Bagliani, A. Pietta, S. Bonati, Il cambiamento climatico in prospettiva geografica. Aspetti
fisici, impatti, politiche, il Mulino, 2019, capp. 4 (da p. 130 a p. 174), 5 e 6
S. Bonati, Dal climate denial alla natura da salvare: il riduzionismo nella narrazione dei
cambiamenti climatici, Rivista geografica Italiana, 2021, CXXVIII, 2, pp.53-68
M. Lazzeroni, Bounce-Back o nuove traiettorie di sviluppo? Alcune riflessioni sul concetto di
Resilienza Generativa nella fase post-pandemica, Documenti Geografici, 2022,1, 11-21
(https://www.documentigeografici.it/index.php/docugeo/article/view/340)
G. Pettenati, A. Toldo, Il cibo tra azione locale e sistemi globali. Spunti per una geografia dello
sviluppo, FrancoAngeli, Milano, 2018, (capitoli 1-4-6).
Per la seconda parte:
F. Lasserre, Acqua. Spartizione di una risorsa, Ponte alle Grazie, 2004, pp. 11-65.
E. Bompan, M. Iannelli, Water Grabbing. Le guerre nascoste per l’acqua nel XXI secolo, EMI,
2018 (RCS Media Group, 2020)
A.C. Mauceri (a cura di), Guerra all'acqua, Rosenberg e Sellier, 2016, pp. 76-122, 148-153
M.G. Grillotti Di Giacomo, P. De Felice, Land grabbing e land concentration. I predatori della
terra tra neocolonialismo e crisi migratorie, FrancoAngeli, Milano, 2018, (pp. pp. 15-53, 69-80,
113-132, 147-162).
M.G. Grillotti Di Giacomo, P. De Felice. L’agroalimentare italiano tra globale e locale: le
abitudini alimentari prima e durante la pandemia virus Covid-19. Documenti Geografici, [s.l.],
n. 1, p. 245-259, giu. 2020.
(https://www.documentigeografici.it/index.php/docugeo/article/view/202)
S. Conti, G. Dematteis, F. Nano, A Vanolo, Geografia dell'economia mondiale, Cap. sesto: La
produzione mineraria ed energetica, Utet Università, 2022, pp.124-157
Altro
Materiali di approfondimento verranno forniti nel sito del docente.
Università degli studi di Cagliari Pag. 5 / 5
Potrebbero piacerti anche
- Report STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALIDocumento5 pagineReport STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALIVolevo fare l'artisticoNessuna valutazione finora
- Report STORIA INTERNAZIONALE CONTEMPORANEADocumento5 pagineReport STORIA INTERNAZIONALE CONTEMPORANEAVolevo fare l'artisticoNessuna valutazione finora
- Report SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPODocumento3 pagineReport SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPOVolevo fare l'artisticoNessuna valutazione finora
- Basi Di Geografia Umana Ed EconomicaDocumento9 pagineBasi Di Geografia Umana Ed EconomicaVolevo fare l'artisticoNessuna valutazione finora