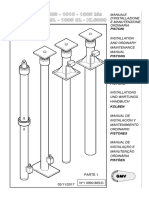Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
La Rete Delle Categorie
Caricato da
Stoyan Ivanov Furdzhev0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
5 visualizzazioni3 pagineTitolo originale
La Rete Delle Categorie.rtf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
5 visualizzazioni3 pagineLa Rete Delle Categorie
Caricato da
Stoyan Ivanov FurdzhevCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 3
Non essere
"Il non essere è la categoria che esprime la rappresentazione del nesso
- come unione interna all'oggetto semplice o composto - in quanto
mancante di un riferimento al contatto metafisico. La distinzione tra essere
e non essere si riconduce quindi a quella tra un possesso (hexis) e una
privazione. Nulla di strano in questo, purché si intenda possesso e
privazione rapporto non già a un soggetto sostanziale, bensì soltanto a un
soggetto relativo e comprimibile. Si è detto infatti che l''è' esprime il nesso
corrispondente a una parte del soggetto, cioè alla differenza tra il soggetto
presente nel contatto e quello rimanente nella rappresentazione del dato
oggetto. Esprimendo qualcosa che 'apparteneva' al soggetto, bene si può
dunque dire che l''è' esprima un possesso. Ed è proprio quella parte di
soggetto, su cui si fonda il richiamo all'immediatezza, che il non essere
dichiara mancante, o comunque non identificabile, nella rappresentazione
del dato oggetto. In altre parole, l'unione dell'oggetto non vi e colta come
riproduzione di un'anteriore unità nell'immediato: manca quest'istantanea
verifica.
Poiché qui non viene preso in considerazione l'errore, in quanto
connesso alle rappresentazioni individuali (cui si darà il nome di logos
spurio), rimane da spiegare perché il nesso che si esprime nella categoria
del non essere affiori nelle serie di rappresentazioni astratte. Se ogni
espressione esprime quella che la precede nella serie, giù sino al contatto,
allora in ogni rappresentazione di un oggetto costituito dal legame della
necessità dovrebbe trovarsi un richiamo all'immediatezza, ossia
nell'espressione verbale di tale oggetto dovrebbe venir incluso l''è'. Questo
punto di vista tuttavia dimentica uno dei due caratteri essenziali
dell'espressione: l'aspetto dell'insufficienza, dello scadimento. Se
l'espressione è inadeguata rispetto all'immediatezza, quasi una sua
degradazione, non c'è da stupirsi che la rappresentazione di un oggetto
semplice o composto non riconosca in esso l'espressione di una lontana
immediatezza. Questa mancanza di riconoscimento si esprime appunto nel
non essere. Già si è parlato della categoria di totalità come di un elemento
riparatore, che mediante il carattere contrapposto dell'estensione fornisce
un equilibrio, un compenso alla suddetta insufficienza dell'espressione.
L'antitesi tra essere e non essere esemplifica questa funzione equilibratrice:
congiunti, essere e non essere costituiscono una totalità, un compenso
estensivo appunto all'insufficienza espressiva denunciata dal non essere e
inerente anche all'essere, nell'identificazione dell''è' con l''era' (mentre l''è'
in quanto espressione, non può richiamare 'proprio ciò che era'
l'immediatezza), un equilibrio allo scadimento espressivo delle due
categorie prese singolarmente."
"Filosofia dell'espressione"... " La rete delle categorie"
Si può avanzare l'ipotesi, che durante l'esposizione Giorgio Colli non
aveva immediata sensazione della mancanza di non essere in un contesto
che esprime la totalità delle repressioni. Meno arrischiata mi sembra invece
l'affermazione che una delle ultime affermazioni si presta all'interpretazione
che essere e non essere fanno parte del carattere totemico
dell'immediatezza. Inoltre con la tirata in ballo del contatto metafisico,
riferendosi all'antitesi tra la presenza e l'assenza (il possesso e la privazione)
ha snaturato l'argomento.
È possibile che l'essere sia assente, e che il non essere sia presente? O
l'assenza di predicazione, così come di un predicato adeguato, sostituisce la
presenza di uno inadeguato?
Si tratta semplicemente di un'altro esempio del supposto superamento
dei sapienti da parte di Aristotele a cui Giorgio Colli aderisce per affinità
dottrinale.
Tutt'all più, la mancanza è il possesso si possono ricondurre
all'opportunità o meno di un'azione, o in un contesto strettamente formale,
all'eseguibilità o meno di un'operazione. Ci si può accorgere della mancanza
di certi stimoli, come la mancanza di appetito o di uno dei laici delle mie
scarpe. In ogni caso, che qualcosa di cui si ha nozione sia manifesto o meno,
in un determinato senso non ci vuole particolari doti per accorgersene,
mentre in un altro ce ne vuole più di una, e ardua esercitazione per giunta.
Per quel che mi concerne, io ammetterei volentieri che non sono molto
adatto ad occuparmi di dialettica, se qualcuno più versato di me nella
materia si prendesse la briga a dimostrare che l'antitesi tra il possesso e la
mancanza abbia la stessa natura di quella tra essere e non essere, e una
relazione tra i termini diversa da quella tra il movimento e la quiete;
determinata da una necessità inflessibile, come l'ha definito Platone
durante la sua spiegazione di un potenziale significato del concetto di non
essere.
Per quanto ammiro Platone e la sua interpretazione della nozione di
giustizia, a me non sembra dire me non che con la tirata in ballo del
comportamento dello strano Euricle abbia reso molto giustizia alle tecniche
utilizzate da un povero artista. A dirla tutta, con la mia interpretazione del
metodo dialettico, non mi sembra per niente che il buio sia meno presente
dalla capacità di intendere. Almeno finché l'intera installazione, burattinaio
e burattini compresi, non raggiunge una formale coincidenza con l'originale,
diventata una volta per tutte completamente immedesimata.
Potrebbero piacerti anche
- DEMARTIS, Lucia. L'estetica Simbolica Di Susanne LangerDocumento81 pagineDEMARTIS, Lucia. L'estetica Simbolica Di Susanne LangerAngela María Gómez OspinaNessuna valutazione finora
- Francese - Verbi Coniugaz.Documento19 pagineFrancese - Verbi Coniugaz.veneziaasdfNessuna valutazione finora
- Ossola - Dal Cortegiano All'Uomo Di MondoDocumento98 pagineOssola - Dal Cortegiano All'Uomo Di MondoEdoardo SpinazzolaNessuna valutazione finora
- Le Catilinarie Di CiceroneDocumento3 pagineLe Catilinarie Di CiceronejulietNessuna valutazione finora
- Parte - 1 Cilindros HidraulicosDocumento64 pagineParte - 1 Cilindros HidraulicosJosé SalazarNessuna valutazione finora
- Quaderno Assimil 4Documento1 paginaQuaderno Assimil 4P.Nessuna valutazione finora
- Peruzzi DefinizioneDocumento2 paginePeruzzi DefinizioneRoberto SiriguNessuna valutazione finora
- 15 Esercizi Equazioni LogaritmicheDocumento6 pagine15 Esercizi Equazioni Logaritmichedarelle keunouNessuna valutazione finora