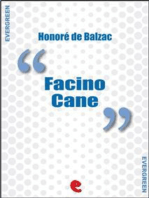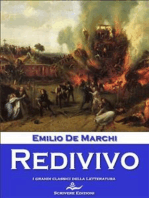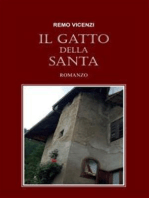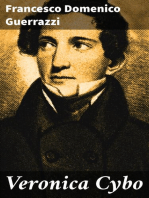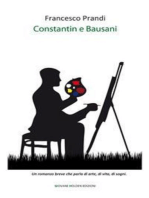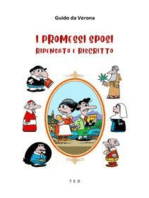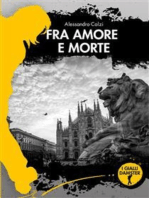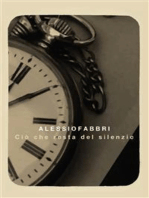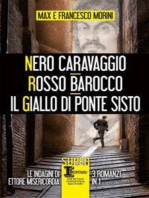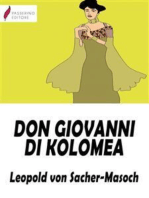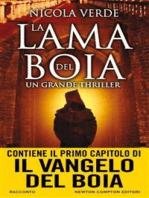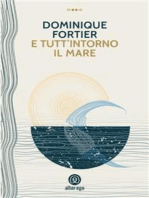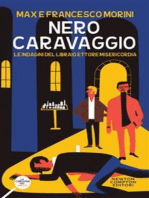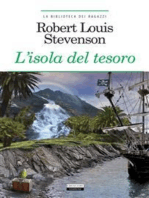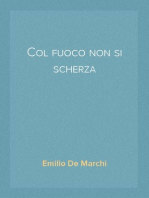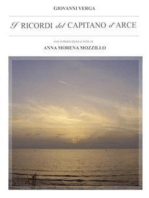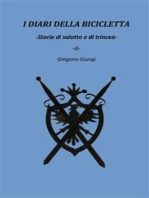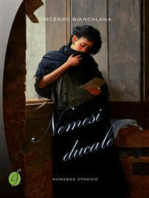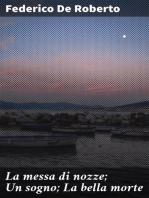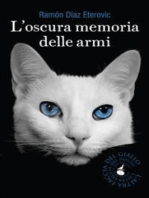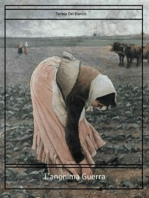Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Lo Scriba Di Casole
Caricato da
Φάβιος Πανταῤῥέων ΤειχομελήςTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Lo Scriba Di Casole
Caricato da
Φάβιος Πανταῤῥέων ΤειχομελήςCopyright:
Formati disponibili
R A F F A E L E G O R G O N I
Lo scriba di Csole
Il segreto di Otranto
R O M A N Z O
Redazione Lorenzo Velle
Impaginazione Ettore Ronzino
Art Director Nino Perrone
BESA Editrice
via Duca degli Abruzzi, 13/15
73048 Nard (LE)
tel./fax +39.0833.871608
redazione@besaeditrice.it
www.besaeditrice.it
INDICE
PROLOGO
CAPITOLO I
CAPITOLO II
CAPITOLO III
CAPITOLO IV
CAPITOLO V
CAPITOLO VI
CAPITOLO VII
CAPITOLO VIII
CAPITOLO IX
CAPITOLO X
CAPITOLO XI
CAPITOLO XII
CAPITOLO XIII
CAPITOLO XIV
CAPITOLO XV
CAPITOLO XVI
CAPITOLO XVII
CAPITOLO XVIII
CAPITOLO XIX
CAPITOLO XX
CAPITOLO XXI
CAPITOLO XXII
CAPITOLO XXIII
CAPITOLO XXIV
CAPITOLO XXV
CAPITOLO XXVI
EPILOGO
9
11
15
22
30
34
39
49
53
59
65
77
84
94
100
106
111
118
126
131
139
143
150
157
166
178
183
185
ad Alessandro
PROLOGO
Non mi sono mai abituato a questo mare che non un
mare. A questacqua bastarda di tante acque, alle velme, alla pa-
lude dove terra e mare si confondono nel torbido della laguna.
Le lune e i venti subdolamente spingono le onde che ora ri-
salgono oltre le foci dei fiumi, ora si ritirano, lasciando le erbe
del fondo a seccare tra nuvole di mosche e zanzare.
Anche lindolente carnalit della sabbia che si intride tanto
del fiume che del mare mi appare uninfedelt senza passione.
LAdriatico sotto lo scirocco frange lontano, sulle secche e
alla costa arriva una maretta corta e nervosa, cos, quando scen-
de la bora, la laguna frigge insidiando di correnti maligne i ca-
nali.
Tra la solidit della terra e la mutevolezza dellacqua, tra
fondamenta e canali, questa citt si consuma in una rissa este-
nuante.
Dove io nacqui, terra e mare conoscono solo la pace o la
guerra. Nelluna restano a confrontarsi immobili e vigili, nel-
laltra si scontrano con accanita ferocia e la roccia strappa nu-
vole di polvere allonda e londa schegge di calcare agli scogli.
Dove per la prima volta ho visto la luce essa ha la nettezza
del filo di una spada. Qui, dove vado invecchiando, ha la cru-
delt del riflesso. Per fortuna i miei occhi non hanno dovuto
patire molto questa crudelt.
Da anni preferisco vivere nella penombra delle stanze e mi
avventuro per calli e campielli solo alle prime luci dellalba o al
calare della sera. Durante il giorno le tende oscurano la mia ca-
mera e la luce solo limmutabile crepuscolo del lume sul mio
scrittoio.
,
Questa mattina bene che lo accenda per lultima volta e
per lultima volta torner a scrivere, poi penne, inchiostri, carte
e pergamene resteranno solo cari oggetti restituiti alla loro na-
tura inanimata.
Cose morte con le quali, alle volte, mi sono illuso di rende-
re cose vive.
:c
I
AllIllustrissimo Aldo Manuzio,
Stampatore e Editore in Venezia
Eccellentissimo Maestro
Ti rendo, accluso a questa lettera, lultimo volume che mi
hai inviato per la traduzione. Si tratta, come sai bene, del Libro
Settimo di Tevarih-i Al-i Osman. Nonostante le tue raccoman-
dazioni per la nobilt del suo autore, lo stimatissimo Ibn
Kemal, e per il gran pregio della sua scrittura, questa non tro-
ver pi le sue corrispondenti parole italiane per mia mano.
Non sono soltanto let, la stanchezza e la vista affaticata che
mi inducono a interrompere per sempre il lavoro.
Mi bastato scorrere alcune pagine per provare un dolore
che non pensavo certo di avere dimenticato, ma almeno di
avere relegato in una regione morta della mia anima dove la-
sciarlo assopire.
Impara soffrendo! Pathei mathos! era linsegnamento dei
miei maestri nella Santa Abbazia di San Nicola di Csole e
molto, nella mia vita, ho appreso nel dolore ma non ho moti-
vo di apprendere da altri ci che nessuno meglio di me ha co-
nosciuto. In vero temevo che sarei arrivato un giorno a questo
punto.
passato quasi un anno da quando mi hai affidato lincari-
co per la traduzione delle Storie della Casa di Osman. Lungo i
primi sei libri il lavoro stato veloce e la mia scrittura ha ga-
reggiato in leggerezza con quella di Kemal che scorre come un
ruscello in lode e per la delizia del suo committente e signore,
il Gran Sultano Bayezid.
::
Avanzando nelle pagine sono arrivato alla magnificazione
delle gesta di Mehmet II Fatih e il mio sangue ha cominciato
a pulsare pi forte e le tempie mi dolevano e le mani erano
prese dal tremito e pi andavo avanti e pi il respiro si faceva
pesante.
Per dare ragione del mio rifiuto devo svelare a te, mio be-
nefattore e amico, quanto avrei preferito lasciare dormire nei
recessi del passato.
Una storia che in molti si provano gi oggi a raccontare e
temo della quale molti si approprieranno in futuro perch
essa sembra ben prestarsi a essere avvolta dal velo delleroica
leggenda e illuminata dalle edificanti aureole del martirio. E
storia di eroi e di martiri fu, ma un freddo calcolo e una gelida
macchinazione la gener.
Ho grandissima considerazione per la scrittura lucente di
Ibn Kemal ma non posso leggere le sue adulanti parole in me-
moria di Maometto II.
Egli fu per me una maledizione devastante e io per lui meno
del filo derba che lo zoccolo del cavallo calpesta nella sua corsa.
Per tutta la vita ho odiato un uomo che non ho mai visto di
persona. Di lui conosco solo unimmagine e quando cadde
sotto i miei occhi una vertigine di rancore mi colse.
Avvenne una sera nella bottega dei Bellini. Amavo, di tanto
in tanto, frequentare Gentile e Giovanni. In quellambiente di
pittori, sempre frequentato da artisti di passaggio, trovavo
qualche ora lieta di piacevole conversazione.
Una sera si disputava di ritratti. Era appena giunto da
Treviso messer Lorenzo Lotto, antico allievo di Giovanni.
Ancora sporchi di colori erano arrivati, per un bicchiere di
vino, Giorgione e quel Tiziano che allora lo aiutava per le pit-
ture al Fondaco dei Tedeschi.
Forse fu il vino o il cattivo umore ma tant che nel bel
mezzo delle cicole il Lotto, che era giovane di brusco caratte-
re, dette sulla voce a Gentile.
Taci tu, che dipingesti per gli infedeli! Facci vedere come
hai ritratto la rovina della fede e di Venezia!
::
Fu cos che per la prima volta io vidi la faccia delluomo a
causa del quale avevo perduto la famiglia, i confratelli, gli
amici, la mia citt, le mie fatiche e la fede in Dio.
Eccotelo il pi grande degli infedeli, Lotto, che noi Bellini
si dipinge di tutto: vescovi, santi e pure infedeli!
Era la copia di un ritratto che Gentile aveva fatto al
Conquistatore. Un naso adunco sovrastava la bocca e il mento
sfuggente, appena dissimulato da una barba leggera. Gli occhi
erano spenti sotto un grande turbante. Stentavo a credere che
quella fosse limmagine del formidabile stratega, del guerriero
spietato che, a soli ventuno anni, aveva colpito a morte
Bisanzio e fatta sua Costantinopoli.
Le mie mani tremavano al punto che gli amici mi tennero
per ubriaco e Gentile disse al Piombo di accompagnarmi a
casa. Al primo campiello mi appoggiai a una vera di pozzo per
respirare.
Marco, stai male?
Niente, Sebastiano, niente, stato come un velo nero che
m passato davanti agli occhi.
Avrei voluto bruciare quel ritratto cos come avrei voluto
bruciare le pagine di Kemal che accoglievano le descrizioni
delle gesta del Conquistatore di Costantinopoli, del
Governatore di Amasia, delle sue vittoriose campagne contro
gli ungheresi, gli albanesi, della presa del Principato di
Qaraman e del trionfante dilagare in Serbia, Morea e Bosnia.
S, avrei voluto bruciare la magnificazione della sua gloria cos
come la sua volont aveva bruciato tanta parte della mia vita.
Eppure ho continuato il lavoro di traduzione. La penna scric-
chiolava per la rabbia della mano ma dominavo abbastanza la
mia furia. Lo scriba, secondo lantico canone, non deve avere
cuore e passione. Egli solo strumento.
Temevo che Ibn Kemal sarebbe arrivato, nella sua narrazio-
ne, a un punto che non mi avrebbe pi consentito di domina-
re la mia anima e, al voltare di ogni pagina, paventavo di legge-
re parole e nomi e vicende sepolte da tempo nel pozzo della me-
moria. Temevo che in quel momento non sarei pi stato scriba.
:+
stato nel Settimo Libro, con angoscia montante sfogliato,
che i miei occhi si sono impigliati in queste righe:
Qui si parla dellandata del famoso Comandante Ghedik
Ahmed Pasci in Puglia, a capo della flotta, e della sua conqui-
sta, nel luogo suddetto, della famosa fortezza chiamata
Otranto
E fu strage, ma pi feroce delle scimitarre, dei pugnali e
delle bombarde e lance e frecce fu lo spietato calcolo tracciato
dai disegni di tanti e diversi mondi contrapposti. Per troppo
tempo ho cercato di scomporre quel calcolo, di studiarne ogni
singolo elemento, di ordire linsano disegno di trovare regioni
e motivi e cause per lo scatenamento di tanta crudelt, per le-
pifania di tanto orrore.
:
II
Aheeeee Mastro Giovanni de Marco alla marinaaa
Il messaggio volava di bocca in bocca dal primo pescatore
che aveva visto la nave di mio padre doppiare la Palaca, ai ma-
rinai del porto, fino alla nostra casa affacciata su San Pietro.
A mia madre cadeva tutto di mano, si strappava il mantile e
in un lampo era nella chiesa. Io restavo sul portale e la vedevo
cadere in ginocchio e le sue spalle sussultavano lievemente. Poi
scendevamo al porto. Sentivo nelle gambe lansia di correre in-
contro a mio padre e a mio fratello, di salire a bordo tra gli uo-
mini e le mercanzie. Sbarcare era una cosa lunga, cerano di-
sposizioni da dare per il carico, pagare gli uomini, rassettare la
nave.
Il primo abbraccio di mio padre era per la sua donna che se
ne volava da terra attaccata al collo del marito. Io mi avvin-
ghiavo alle loro gambe quasi avessi paura che lappassionata
carnalit di quello stringersi mi escludesse. Si caricavano i carri
grandi che andavano ai magazzini e quando lultimo era parti-
to ci mettevamo dietro ai carri piccoli destinati a casa.
Mio fratello saliva pi lento e faceva un giro pi lungo per-
ch doveva passare sotto a una finestra dove si sussurrava che la
pi bella delle otrantine lo attendesse.
I carri piccoli erano sempre due. Dal primo venivano scari-
cate le casse da viaggio di mio padre e mio fratello e i bauli con
gli oggetti per noi e per la casa. Sul lettone si riversavano stof-
fe, vestiti, quadri, decorazioni, vasellame, spezie, profumi,
gioielli: una meraviglia di colori e forme. Per me cera sempre
qualcosa: una volta un turbante, unaltra un pugnale decorato,
unaltra ancora un paio di stivali di cuoio marocchino.
Il secondo carro restava nel cortile, il carico ben coperto di
:s
tela incerata e sorvegliato da un famiglio. Era una scena che
avevo visto tante volte ma ormai ero abbastanza grande da co-
minciare ad avere delle curiosit.
Ntoni, che c sul carro?
Casse, Marcolino, casse piene rase di libri, di carte, di
scritture. Domattina saliamo a Csole, dai monaci, solo loro le
sanno
Padre, posso venire domani a Csole con voi?
Evvieni, Marcolino, vieni. Ecch monaco ti vuoi fare, di
marinaio e soldato, mo monaco, ah?
Avevo sette anni e non era la prima volta che uscivo dalla
citt. Altre volte ero stato alle masserie con mia madre e con i
compagni ci avventuravamo alla Cala dellOrte o verso la
punta della Palaca per pescare i lutrini e prendere i cari e an-
cora andavamo ad Alimini a mettere le trappole, a catturare le
celne, ma a Csole era la prima volta. Sapevo solo delle visite
di mio padre al monastero di ritorno da ogni viaggio.
Per San Nicola di Csole si saliva tra orti e fichi e ulivi oltre
la valle dellIdro, il fiume che sanava la sete di Otranto e mio
padre raccontava il prodigio di Carlo Magno, un re che, attra-
versando le aride colline tra i casali di Giurdignano e Uggiano,
esasperato dallarsura, aveva dato un colpo di spada alla roccia
e lacqua, sgorgata per miracolo, sera fatta ruscello. Oltre la
valle cominciava una pietraia brulla, magra anche per il pasco-
lo. Le poiane e i gheppi volteggiavano in attesa, per il pasto
quotidiano, di uno scursne malaccorto o di un riccio distrat-
to.
Era mattina alta di giugno e il sole mi bruciava gli occhi
quando arrivammo in vista dellabbazia.
Non ho mai avuto il dono della premonizione e quelle mura
imponenti, le alte finestre, la grandiosit degli edifici che si sta-
gliavano contro il cielo estivo non sortirono su di me altro ef-
fetto che la normale curiosit di un ragazzo. Nulla mi fece pen-
sare che quella visita avrebbe mutato il corso della mia vita.
Non mi lasci stupito neppure laccoglienza festosa che i
monaci fecero a mio padre. Alcuni li conoscevo perch veniva-
:o
no in citt e si fermavano per le devozioni in San Pietro e, da
casa, sentivo i loro canti e le loro preghiere.
Fummo condotti alla presenza dellabate Zaccaria. Era un
uomo vecchio che quasi mi fece paura, tutto vestito di nero,
ma il suo sguardo era dolce e dolce il gesto della sua mano sulla
mia testa.
Benvenuto, Giovanni de Marco e benvenuto al tuo gio-
vane figlio.
Marco, abate, gli diedi il nome dellEvangelista.
Gi, Marco, colui che protegge chi trasporta le parole da
una lingua allaltra.
Oggi potrei dire che in quelle parole di Zaccaria ci fosse gi
tutto il disegno della mia vita. Quando lo conobbi era abate di
Csole gi da ventisei anni. Era stato il papa romano Eugenio
IV a dargli lincarico, ch Zaccaria sempre era stato al suo fian-
co nelle trattative con Giovanni Paleologo e il Patriarca
Giuseppe per tentare di ricomporre lo scisma tra le chiese so-
relle di Roma e Bisanzio.
La conversazione di mio padre con Zaccaria dur a lungo,
quasi lintera giornata.
Ntoni e i monaci scaricarono il carro e li vidi trasportare,
con ogni cura, casse su casse nel parlatorio.
Io venni affidato al giovane monaco Teodoro. Giornata me-
morabile per un figlio di mercante, un ragazzino che appena
sapeva fare di piccolo conto e scarabocchiare il suo nome.
Teodoro correva di qua e di l nel convento a sbrigare fac-
cende e io dietro.
Mo andiamo allo scriptorium, Marco, che dobbiamo
prendere libri per la biblioteca.
Le sale erano grandi e piene di monaci intenti a lavorare,
curvi su tavoli col piano inclinato. Uno dei monaci mi sollev
tra le braccia.
Guarda, ragazzino, guarda quante formiche e ragni e mo-
sche
E cos mi sembr, a prima vista, la scrittura: tanti animalet-
ti in fila, uno dietro laltro, con tante zampette e corni e code
:
attorcigliate. Su quel biancore davvero formiconi sembravano e
malte e pure qualche taranta. Non che non avessi mai visto un
libro; mio padre e prima di lui mio nonno ne avevano portato
qualcuno in casa dai loro viaggi ma non mi era mai stato per-
messo di vederlo aperto e da vicino. Si trattava di oggetti che
fugacemente transitavano per essere subito portati a Csole.
Sulle pareti grandi scansie traboccavano di volumi di ogni di-
mensione. Fasci di carta e di pergamena emanavano uno stra-
no profumo. In un angolo un tavolo era coperto di canne e
penne doca e ciotole piene di polveri scure e liquidi ambrati.
Un monaco appuntiva con una lama canne e penne. Guardavo
le sue mani sfaldare abilmente la canna secca e intagliarla, sfi-
nire le penne in una punta che non avrei mai immaginato si
potesse fare tanto sottile. Di tanto in tanto, canne, penne e cio-
tole venivano distribuite tra i banchi.
Qui vidi per la prima volta i monaci copiare, lo scriptor ri-
portare sulla carta e la pergamena la littera textualis.
Ogni tanto mi affacciavo nella stanza dove mio padre parla-
va con Zaccaria e restavo per un po a guardarli. Mi colpiva la
familiarit della conversazione, le spalle curve, le teste vicine, le
voci basse e gli occhi, come due fessure, a guardare lontano. A
parlare era soprattutto mio padre. Un altro monaco pi giova-
ne con carta e penna annotava le sue parole.
Mercante e capitano di mare, Giovanni de Marco viaggiava
in lungo e in largo ed erano soprattutto gli scali del Levante a
non avere segreti per lui. Come mio nonno, era uno degli in-
formatori di Csole. Non cera conversazione, incontro, tratta-
tiva dalla quale non emergessero informazioni preziose per il
monastero. Csole aveva lambizione di tenere occhi e orecchie
dappertutto.
Marcolino, domani allalba passa Teodoro con gli altri
monaci per andare a fare canne . Quello di mio padre era pi
un invito che un ordine. Portali a Traugnano, ch loro
allIdro le fanno e sono le peggio.
Le paludi di Traugnano le conoscevo come il palmo della
:
mano, tutti i laghi di Alimini erano infestati dalle trappole che
con i compagni mettevamo per le folaghe, i moriglioni, i ger-
mani. Certo che le canne di Traugnano erano buone! Trappole,
gabbie, archi, frecce, spade e lance del nostro armamentario
non erano che canne. Quelle dellIdro erano stente e marce e
subito si spaccavano e facevano filacce. Quel giorno mi sentivo
un condottiero. Avanzavo alla testa della fila dei monaci che i
laghi non che non li sapevano, ma cos, in generale e non sa-
pevano il posto delle canne. A Traugnano i monaci non crede-
vano ai loro occhi e si misero a dare di roncola sulle canne. Ne
fecero tante che non si era buoni a portarle. Sulle sponde di
quei laghi crescevano fiori carnosi, viola, striati di giallo. Ogni
tanto li portavo a mia madre e rimanevano freschi per giorni e
giorni. Le castagne dacqua invece ci lasciavano il segno di do-
lori di pancia e diarree. Nei laghi si consumavano eventi mi-
steriosi come unerba che bruciava a toccarla e ingoiava, con le
sue vesciche, gli insetti che si avvicinavano. Nidi, uova, bisce,
aironi, ibis. Le paludi furono la mia prima conoscenza del
mondo naturale e quando ero stanco mi restava un letto der-
ba, con la faccia al sole, a seguire il volo del falco pescatore.
Avevo calcolato il tempo giusto per fare seccare le canne che,
alla fine dellestate, una mattina mi presentai a Csole. Girai
dalla parte dellorto e le canne erano l dove le avevamo lascia-
te, a fare ombra alle galline, cotte dal sole, di un bel colore gial-
lo bruno.
Marcol, che cerchi?
Era proprio Saverio, il monaco che lavorava ai calami che,
dritto sulla porta del refettorio, mi gridava.
Sono venuto a pulire le canne.
E bravo Marcolino! E via a pulire le canne!
Sfrondare le canne fu solo linizio di un lungo apprendista-
to alla fine del quale avevo imparato una cosa che potrei fare
ancora oggi con gli occhi chiusi.
Allora, Marco, taglia la canna per la lunghezza di un
palmo, poi per lungo di due dita per met spessore
Allinizio le mani mi sanguinarono per il coltello che sfug-
:,
giva e per i bordi taglienti delle canne. Ma Saverio era pazien-
te e io ansioso di fare.
Ecco, Marco, ora ancora un taglio per un dito a togliere
tutta la parte concava. In ultimo tronca la punta di netto, a
scalpello.
Ormai ero ammesso allo scriptorium.
La mia produzione di calami era tanto apprezzata che venni
istruito alla preparazione delle penne doca.
Imparai a scegliere le remiganti, cinque per ogni ala da la-
sciare stagionare a secco. Un sapere che mi cost feroci beccate
che mi lasciavano la faccia piena di lividi.
Queste vanno bene, Marcol, ora taglia le punte e le barbe.
Poi mettile per stanotte con i cannelli nellacqua. Domattina le
tempriamo nella sabbia infuocata.
Solo allora rifilavo le punte. Anche per le penne doca, in
breve, nello scriptorium fu tutto un Marcolino di qua
Marcolino di l.
Mi piace ricordare queste piccole cose perch narrano bene
di come io entrai nel monastero quasi per caso e come, sulle
prime, presi a frequentarlo non perch avessi un disegno della
mia vita, ma cos, senza un fine o un motivo preciso, come un
uccello che si posa su un ramo tra mille e sembra non sceglier-
lo ma quando gli artigli stringono la corteccia si sente sul mi-
glior ramo del mondo. Di me stesso potevo solo sapere che un
giorno mi sarei imbarcato con mio padre e mio fratello e, come
loro, sarei diventato marinaio e mercante e non pensavo che
potesse esserci un altro destino e, men che meno, di avere un
destino da scegliere. La nostra citt a quel tempo era prospera
e il porto pieno di navi e cerano mille mestieri che si poteva-
no fare ma la nave e le tavole di mercatura mi sembravano lu-
nico orizzonte possibile.
Tutto questo mio andare e venire da Csole, il piccolo lavo-
ro di preparatore di calami e penne non li interpretavo come
segni. Lavvenire non poteva dipendere da me, non pensavo
neppure che il mio destino potesse essere in altre mani che
quelle di Dio.
:c
Era un giorno dautunno tardo che la tramontana impazzi-
va nei vicoli, mischiando gli odori dellultimo mosto a quelli
delle prime sanze e del fumo dei camini. Il sole stava basso e
quando suonava il Vespro dalla Cattedrale era quasi buio.
Quel giorno persi una vita e ne trovai unaltra.
Marco, disse mio padre e per la prima volta non mi
chiamava Marcolino, Zaccaria ti vuole a Csole, dice che sei
buono per studiare, per imparare, per leggere e, addirittura,
dice che saresti buono per scrivere.
Come spesso accaduto nella mia vita non dissi n s, n
no. La testa mi si pieg sul collo come a dire s, o almeno cos
credette di capire mio padre.
::
III
Quel pugno danni che seguirono il mio ingresso a Csole
lo ricordo come un turbine. Ero una giovane pianta che una
tempesta aveva sradicato dal suo orto per precipitarla in un
giardino. La giovane pianta era quasi del tutto secca quando le
sue radici riuscirono ad attecchire nuovamente in un terreno
che, in vero, nessun aratro aveva mai smosso cos fertile.
Perch, allinizio, la pianta stava per seccare quando dal la-
voro delle penne e dei calami mi ritrovai a pascolare le pecore.
Cerano altri ragazzi che come me stavano al monastero a
studiare e sudare sul greco, sul latino, sulla scrittura, ma loro
non pascolavano le pecore. Io credevo che ne fossero esentati
perch figli di nobili e mi arrabbiavo perch sapevo comunque
di essere figlio di ricchi e le pecore non le volevo pascolare.
Volevo tornare a casa mia, andare sulla nave con mio padre e
mio fratello. Mille volte meglio marinaio e mercante che pa-
store.
Ma io non ero un semplice studente. Io, per un sortilegio
del destino, ero destinato alla vita monacale e nel mio appren-
distato cera tanto lo studio quanto il lavoro.
Sarei fuggito dallabbazia se, una mattina allalba, una mi-
stura di fascino e di orrore non mi avesse trattenuto. Imparai
come si scanna una pecora e la si dissangua, come si scuoia
quella carcassa ancora calda. Poi ho capito che era come un rito
di iniziazione.
Fu Mauro, il monaco pastore, a insegnarmi tutto.
Mauro, perch quando uccidi una pecora sembra che stai
pregando?
Era lalba e seguivo il pastore fuori dallo stazzo, verso un ri-
lievo in faccia al mare, lontano da Csole.
::
Noi che stiamo fuori dallabbazia, nelle laure delle serre,
siamo come il molo di levante, Marco, noi prendiamo la prima
onda quando gli infedeli o gli sbandati scorrono la campagna.
Il sangue del capro lava da questo coltello il sangue del corsaro
e chi, come me, ha conosciuto il sangue delluomo deve espia-
re per sempre.
Arrivati a un cumulo di pietre la pecora scart che sembra-
va avere capito.
Al primo raggio di sole, quando Mauro la rovesci sulla
specchia, sembr quietarsi offrendo il collo e le pietre si anne-
rirono di sangue.
straordinario come si conserva la memoria di ci che al
momento non si comprende. Quasi che la mente custodisca
pi gelosamente le cose destinate, un giorno, a esserci chiare.
Ho visto troppo sangue nella mia vita, ma stato nei miei
primi giorni a Csole che ho imparato a sgozzare senza guar-
dare negli occhi la vittima, accecato dal primo raggio di sole e
a non avere disgusto del fiotto caldo che investe la mano.
Pi tardi, sulle mura di Otranto, avrei imparato a uccidere
accecato dallodio, a versare il sangue impuro della vendetta.
Mauro abitava con la madre, una donna anziana della quale
si diceva che fosse stata moglie di un ricco mercante leccese e
che, alla morte del marito, chiuso il fondaco, fosse precipitata
nella miseria. Viveva quindi con il figlio e come lui si era insel-
vatichita ma dai suoi tratti si capiva che non era una pastora.
DonnAnna parlava per oscuri proverbi e astruse filastroc-
che.
Era lei a dare il segnale della fine della giornata di lavoro
canterellando:
Scinde lu Sule
Rretu Uggianu
Chiuti le pecure
Ca ni nde sciamu
:+
Le notti di luna nascente la mettevano in agitazione e si pla-
cava recitando lamentosamente una specie di litania.
Notte te Luna Turca
Lu mmassaru nnu sse curca
Notte te Luna Falce
Llassa tuttu e pigghia la calce
Cu lla calce te li muerti
Uddha tutti li cauerti
Mauro un po la derideva ma poi con calce e cazzuola an-
dava a chiudere tutte le crepe che si erano aperte sui tumuli del
vecchio cimitero dove si custodiva la dormitio dei nostri con-
fratelli.
Aracnieddha beddha mia
Fila e tiessi li culuri
Li culuri subbra lla tila
Cha llavatu ntra lla pila
La cchi beddha tessitura
Foi terribili sventura
Ca te figghia ca se uanta
Te mmacrara a taranta
Eravamo seduti davanti al camino una sera che la sentii
mormorare questa filastrocca ed ero stranito dalla curiosit.
DonnAnna, che cosa dite? Chi Aracnieddha?
Cose di donne, Marcol, cose di una ragazza greca che si
chiamava Aracne e filava e tesseva ed era la meglio per bellezza
e bravura. Che vuoi sapere tu che sei maschio e pure novizio?
E perch le fecero la mmacara?
che le femmine devono stare al posto loro, ma
Aracnieddha no, non voleva stare al posto suo e fece sfida di
tessitura ad Atena.
Atena?
:
Ess, allora non cerano Iddio e Ges Cristo, ma tanti dei,
maschi e femmine e facevano lamore come i cristiani e Aracne
li ricam questi amori, che era una cosa proibita e pure Atena
che faceva lamore con Giove.
Insomma, donnAnna, Aracnieddha fece una spiata?
Eh, una spiata e Atena la pun. Stracci la tela e la fece
ragno a tessere per sempre.
Lo sguardo della vecchia si perse tra le lingue di fuoco che
si levavano dal camino e la sentii mormorare:
Fiatu te secra sputazzu te scursne mmienzu lla stan-
za minti lu chiasciune te fiuri e te marange faciti nna
curona sunati li tamburi lla capu cu sse ntrona nna trec-
cia me faciti te nastri culurati facitime bballare a Ssantu
Paulu priti
E che centrano le secare e gli scursni, donnAnna?
Marcol, e tutto vuoi sapere? Ess, il ragno pizzica, pizzica
le donne alla mietitura e le attaranta e pure il fiato e lo sputo
delle serpi attaranta, come un veleno e allora per guarire si
deve fare musica e le donne devono ballare.
Ballare?
S, ballare, ma la musica forte deve essere, una musica che
dalle orecchie arriva al cuore, alle viscere, alle gambe, ai piedi
che battono a terra. E una musica fortissima che pu salvare ma
pure perdere se Santo Paolo non fa la grazia della guarigione.
Allo stazzo di Mauro imparai a rasare e raschiare le pelli per-
ch niente di peli e grasso restasse, a immergerle nellacqua di
calce, a tenderle sui telai e, alla fine, a levigarle con lama e pie-
tra pomice e a tamponarle con la sandracca. Mi impadronii
della tecnica e la mia pergamena era gradita a tutti per leviga-
tezza e candore.
Nei miei primi anni a Csole ne ho prodotta tanta che si sa-
rebbero potute scrivere mille Bibbie.
Ci che aveva valore si scriveva infatti sulla pergamena.
:s
Mio padre era uno dei maggiori fornitori di carta dellabba-
zia. Dai suoi viaggi a Tiro, a Sidone, a Beirut tornava con gran-
di quantit di qutni, la carta di cotone, la bombacina. Eppure
sono sempre stato convinto che la pergamena resta la sede della
vera saggezza.
So bene che questa una mia vecchia fissazione e che ormai
dai torchi viene meglio pressata la carta, ma la pergamena resi-
ste nel tempo, sopporta raschiature e riscritture, infedele al
testo, accetta la correzione fino allerranza, si sottopone di
buon grado alla metempsicosi dei saperi. I testi passano e lei
resta disponibile a riceverne altri senza discriminazioni. Dove
stato vergato un testamento pu trovare ospitalit un salmo.
Sempre libera, vagamente carica di ricordi, di tracce pi o
meno visibili, di lettere pi o meno antiche, la pergamena passa
di mano in mano in una giovinezza che mi appare eterna.
Di contro la carta pu accogliere, nella sua breve vita, solo
un testo. Tra la grafia o le impronte dei caratteri e ci su cui si
appoggiano c un legame di fedelt assoluta e nessuna di que-
ste cose sopravvive allaltra. C qualcosa di ultimativo nella
scrittura e nella stampa su carta che mi inquieta.
A Csole la carta si usava per le scritture vili: appunti, bozze,
brutte copie.
I miei maestri mi avevano insegnato che un re di Sicilia,
Ruggiero, aveva proibito luso della carta per i documenti uffi-
ciali e la stessa cosa aveva fatto il Grande Federico per gli atti
pubblici. Entrambi si fidavano soltanto della pergamena. Un
supporto eterno ma dotato dellastuto pregio di consentire di
cambiare idea.
I primi giorni di noviziato furono particolarmente duri.
Sono arrivato a rimpiangere il tempo in cui pascolavo le pe-
core.
Lattacco contro di me fu concentrico: la falange dellinse-
gnante di greco avanz per prima, sulle ali il latino. Le pattu-
glie degli esercizi di scrittura mi prostravano con feroci incur-
sioni.
Pastore non volevo essere e non ero l per diventarlo, ma ce-
:o
rano momenti che avrei preferito un bel pascolo e una mandria
e il sole pieno e il cielo stellato delle serre al cielo di pietra sem-
pre uguale dello scriptorium. Era proprio un cielo di pietra
quello che mi sovrastava a Csole. Pietra nella camerata, pietra
nel refettorio, pietra nella chiesa. Mi stavo appassionando allo
studio ma, ogni tanto, mi mancavano il porto, i giochi nello
slargo di San Pietro, le corse nei vicoli, le spedizioni alla Cala
dellOrte, ad Alimini.
Tra gli studenti pochi erano otrantini, la maggior parte
erano forestieri: di Lecce, Maglie, Galatone, uno veniva dal ca-
sale di Corigliano, altri da Corf e Leucade.
Come tutta la comunit partecipavamo alleucaristia e alla
salmodia ma con lobbligo solo del mattutino, del vespro e di
compieta. La notte ci lasciavano dormire e la mattina nulla in-
terrompeva le lunghe ore di studio. A turno aiutavamo il mo-
naco ecclesiarca nella pulizia dei vasi sacri, delle suppellettili,
spolveravamo i libri liturgici e lo seguivamo quando dava il se-
gnale delle celebrazioni.
Pi pesante era il servizio con il cellario nella dispensa e nei
magazzini ma, al momento di preparare la mensa, ci scappava
sempre un boccone in pi, il fondo di una pentola da pulire
con il pane.
Noi studenti mangiavamo tutti i giorni. I monaci digiuna-
vano il luned, il mercoled e il venerd. Durante la Quaresima
ci toccava solo minestra di fave e pane. Tuttavia molte erano le
eccezioni: il vino e lagnello, normalmente banditi, facevano la
loro comparsa quando cerano ospiti e a Csole gli ospiti erano
molto frequenti.
Certo, nei rari ritorni a casa, la vigilia di Natale,
dellEpifania e di Pentecoste, la cucina di mia madre mi incan-
tava.
Anche la consegna del silenzio durante il pasto era spesso
violata per la presenza di qualche persona di riguardo alla quale
era consentito di parlare con lIgumeno e questi, in qualche
caso, dava la parola agli altri monaci. Noi piccoli dovevamo
solo ascoltare.
:
Uno dei lavori pi graditi era aiutare Evaristo, il Maestro
delle Erbe. Nel suo antro si raccoglieva tutto quanto cresceva
sulle serre, erbe che stentavano sulle specchie o che infestavano
rigogliose i pascoli. Evaristo le mescolava incessantemente e ne
traeva decotti e pozioni e unguenti e polveri adatte a curare
ogni male.
Solo un pizzico, Marco, e del laudano ancora meno. Vedi,
ragazzo, tra curare il catarro o il mal di pancia e uccidere la dif-
ferenza tutta nella misura. Una foglia cura, due avvelenano.
Il Bene e il Male erano tutti in quella misura. Un insegna-
mento che contrastava le dottrine teologiche che nel contem-
po studiavo. Esse tagliavano con il filo della spada la netta dif-
ferenza tra i due principi. Ci avrebbero pensato gli studi di fi-
losofia a ripristinare la vaghezza del confine e a far maturare nei
miei pensieri ci che la botanica e lerboristica avevano gi
chiaramente palesato.
Il laboratorio di Pietro, il Maestro delle Icone, si apriva nella
parte alta del monastero. Una grande stanza era ingombra di
assi di legno, strumenti da falegname e per la pittura e misture
per i colori. La luce pioveva da una grande finestra schermata
con una leggera tenda di cotone. Pietro aveva alcuni allievi che
studiavano solo la pittura. Noi facevamo lavori pi umili: pu-
lizie, piccole riparazioni sugli strumenti, tagliavamo le tavole e
ne avviavamo la preparazione. Il Maestro saggiava la stagiona-
tura del legno e ci segnava le misure, poi toccava a noi sudare
di sega e di pialla fino a ottenere un pannello dello spessore di
un dito.
Pietro ci insegnava a rafforzarne il rovescio con doghe di
ulivo per impedire ogni incurvamento, quindi si passavano
sette strati di stucco. A ogni passata seguiva unenergica strofi-
nata con un panno imbevuto dolio. Quando la tavola era
asciutta incollavamo una federa di canapa rada che veniva an-
cora passata a olio. Dopo un giorno e una notte davamo la
prima mano di calce mista a colla e olio bollito. Sei o sette mani
attendendo sempre la perfetta asciugatura della precedente. In
ultimo la lucidatura con pomice secca e crine di cavallo.
:
Licona deve possedere la solidit della parete, di una nic-
chia nella parete, ma lassoluta perfezione della sua superficie
impossibile da raggiungere sulla parete.
Il Maestro passava poi a spiegare la tecnica del leggerissimo
intaglio che delineava i contorni delle figure.
Visibili rappresentazioni di spettacoli misteriosi e soprannatu-
rali. La definizione delle icone di Dionigi lAreopagita lho im-
parata molto tempo dopo quellapprendistato da falegname e
tante icone che ho visto mi hanno posto di fronte al sacro, oltre
la loro pur semplice superficie. Rimpiango di non aver mai
visto le opere del Grande Rublv. Dellicona della Trinit di
Mastro Andrej si dice che Dio esiste perch esiste la Trinit di
Rublv.
:,
IV
Nel corso della mia vita ho cambiato uninfinit di giacigli
e mi sono nutrito ora di pane e olio su una pietra, ora di fagia-
ni farciti su tavole colme doro e dargento, ma ho abitato sem-
pre la medesima casa. Ho sempre abitato le parole ed esse
hanno abitato dentro di me. Ho cominciato apprendendone i
segni e copiandole e ho terminato trasportandole da una lingua
allaltra. Tutta la mia vita stata questo gioco infinito.
Gli inizi furono difficili. Le parole erano per me la lingua
del porto dove i suoni si mischiavano e marinai e mercanti da-
vano differenti nomi alla terra, allacqua, al pane, alle vele, a
Dio. Tanti ne sapevo e tanti altri li chiedevo a mio nonno, a
mio padre, a mio fratello.
Quando scendevo al porto con i compagni, allarrivo delle
navi, restavo incantato per i diversi modi di vestire, di accon-
ciare i capelli e cera chi portava la barba e chi la rasava e rasa-
va persino la testa e anche i colori della pelle erano differenti e
differenti erano i loro nomi.
Oggi mi chiaro che ci che mi si figurava diverso era il di-
verso provenire delle storie, ma quegli uomini diversi trovava-
no le parole e i gesti per parlare. Quando la nave accostava alla
banchina bastava un grido perch a terra si afferrasse al volo la
cima lanciata da bordo e si desse volta sulla bitta di pietra.
Origliavo quelle conversazioni e il continuo interpretare tra le
intenzioni di chi parlava e quelle di chi ascoltava.
Ho mantenuto il ricordo di quellimmagine dellhomo lo-
quens e in seguito ho cercato conferma in tante letture a quel-
limpressione infantile che udenti e parlanti fossero legati da un
invisibile telaio fatto di idee e concetti; che invisibili fili legas-
sero parole diverse alle stesse cose. Solo la lingua era il confine,
+c
e tutti facilmente lo varcavano. Non immaginavo che tra lin-
gua, uomini e terra ci fosse un legame. Tutti quei suoni veni-
vano per me dallincessante irrequietezza del mare.
Poi ho appreso che venivano da unantica maledizione.
Mia madre mi portava a pregare nella nostra piccola chiesa
di San Pietro ma, sin dalla pi tenera et, venivo accompagna-
to anche nella Cattedrale dove un tappeto di pietra grande
quanto la chiesa era pieno di storie. Quel mosaico lho cono-
sciuto dapprima a quattro zampe che ancora non mi reggevo
in piedi e le ginocchia e le mani si arrossavano per la scabrosi-
t delle tessere. Era una prima confidenza con le immagini che
appena percepivo a cos poca distanza. Quando ho cominciato
a muovere i primi passi e man mano che crescevo in altezza
quelle macchie di colore diventavano forme e, grazie alle paro-
le di mia madre, storie. Di tutto limmenso repertorio di
Pantaleone il ricordo pi fermo la Torre di Babele. La sua me-
moria coincide con quella che per me fu la prima favola. La
confusio linguarum solo una favola! Molto dopo ero gi avan-
ti nei miei studi quella favola diventata limmagine di un
secondo peccato originale. La dispersione delle parole che di-
viene sanzione del desiderio di onnipotenza. Quante volte ne
ho incontrato la descrizione! Alta 463 cubiti nellApocalisse di
Baruc, 5433 nel Libro dei Giubilei, ma lho incontrata in
Abelardo, nelle Etymologiae sive origines di Isidoro di Siviglia, in
Agostino, in Boccaccio, nellImage du monde di Gossuin de
Metz. Brunetto Latini ne calcola addirittura la base in due
leghe quadrate. Tutti, ancora oggi, ruotiamo intorno a quella
remota maledizione, da quando, dopo Adamo, anche il sapere
venne cacciato dal paradiso terrestre e alla confusio linguarum
segu la divisio populorum.
Quante volte studiando le altre scritture mi sono chiesto se
non fosse stata gi sufficiente maledizione dividere per tre la
lingua comune originaria. Non bastavano i tre idiomi nei quali
fu redatto, secondo il Vangelo di Luca, il cartello apposto sulla
croce di Cristo per designarlo? Ebraico, greco e latino sono gi
tre lingue, tre popoli e tre fedi.
+:
Ero poco pi che un bambino quando ho intrapreso lo stu-
dio di queste lingue. Pi delle altre che ho imparato esse fanno
parte di me. Il greco per me la terra dove sono nato, il latino
laria che respiro ma lebraico lacqua senza la quale non c
vita. Anche ora che non ho alcun dio non posso dimenticare di
averne avuto uno e la sua lingua, lebraico, era quella di
Adamo, lunica lingua pura perch anteriore alla colpa. Quanto
ci si aggira intorno a questo tema! Dal signore di Mirandola a
Nicol di Cusa a un medico ebreo i cui scritti erano custoditi
nella Scuola Talmudica di Otranto, Abraham Abulfia di
Barcellona, che sostenne la perfezione divina della lingua della
Bibbia.
Limmagine della Torre legata alla mia infanzia e ora, di
tanto in tanto, mi piace passare sul mosaico, nel nartece di San
Marco, per vederne unaltra immagine. Essa in tutto simile a
quella di Otranto e si tratta delle uniche due raffigurazioni che
io conosco nelle quali compaiono, appoggiate alla costruzione,
due scale secondo lantica tradizione ebraica. Altre immagini
mi sono passate di mano nei miei studi: lho vista
nellHaggadah dOro, nei mappamondi di Ebsdorf e di
Richard di Haldingham.
Babele, si dice, il simbolo della maledizione di settantadue
lingue! Pu anche essere. Ma la mia lunga esperienza di vita mi
ha fatto pensare pi volte che Babele potesse essere anche un
dono divino. Che il monito del Dio degli Ebrei fosse: capitevi!
Capitevi con fatica! Leggete luno sulla bocca dellaltro i suoni
diversi! Traete dalla diversit larmonia della natura e del divi-
no!
Quel tratto del mio carattere che a Csole veniva definito,
con una punta di biasimo, curiositas, nato sul mosaico della
Cattedrale, anche se i primi semi di questa sorta di inquietudi-
ne che ancora oggi mi porto dentro germogliarono nella mia
anima sulle banchine del porto mentre facevo compagnia a
mio nonno.
Con le spalle alla terra e gli occhi persi sullorizzonte il vec-
chio passava le ore a sorvegliare il vento, il mare e le navi. Da
+:
quando non navigava pi, scendeva al porto la mattina e ci re-
stava fino al calar del sole. Alla mezza mia madre gli mandava
il pane, lolio e il vino. Da impercettibili segni coglieva il ruo-
tare della tramontana e, ben prima che lo leggessi nei Carmina
di Orazio, imparai da lui che anche un forte Japigio comun-
que preferibile allAfrico. questultimo che, come avrei ap-
preso da Marciano, rende Adria funestior.
La sua vita laveva passata lottando e accarezzando quel
mare, prima pescatore e poi mercante. Nei suoi racconti veni-
vo trascinato tra ami, lenze, reti, nasse e arpioni e leggendarie
mangiate di trichos, il pesce seccato e salato che dava una sete
che solo il vino di Alezio poteva spegnere. Tempeste sempre
terribili e pesci sempre immensi delle pi svariate specie li avrei
riconosciuti in seguito nelle manie classificatorie di Aristotele e
Plinio Seniore e nelle fantasie poetiche di Oppiano, Ovidio e
Sallustio.
Al vecchio bastava un taglio di vela sullorizzonte per sape-
re se la nave era di Otranto o straniera.
Una volta chiesi a mio nonno chi eravamo noi.
Imesta grichi, siamo greci fu la sua risposta.
Una punta di delusione graffi la mia anima. Avrei voluto
una risposta che raccogliesse nel piccolo del nostro porto una
pi ampia porzione della vastit del mondo che da l passava.
++
V
A Csole linfinita fluidit delle parole incontrava gli argini
degli alfabeti.
Quei segni che mi si ordinava di copiare innumerevoli
volte mi ricordavano le impronte degli uccelli sulla sabbia
compatta, rasata dal vento, ma queste rimandavano a unim-
magine. Ora si riconosceva lorma del gabbiano, ora del co-
done, ora della beccaccia, cos come il segno che mia madre
faceva sullimpasto serviva a non imbrogliare i pani nel
forno, come il marchio sulla pecora che serve a qualcuno per
dire mia!
Ora tutto cambiava e scoprivo che un legame inscindibile
serrava ai segni i suoni. Ci che al porto era gioco, a Csole di-
ventava regola inflessibile.
Cera qualcosa nella mia natura che inquietava i monaci ma
in seguito avrebbe inquietato anche me e ancora oggi non cessa
di farmi interrogare su me stesso.
Avevo una disposizione allo studio totale. Nella lettura e
nellesercizio dimenticavo me stesso e il mondo. Era come se
desiderassi identificare il mondo nella scrittura.
Il mio primo grammatists ne rimase impressionato. Non
dovette faticare molto a insegnarmi gli alfabeti greco e latino e
in breve leggevo ad alta voce con il giusto tono e mostrando di
comprendere, tanto che passai rapidamente sotto le cure di un
grammatiks, un vero maestro che mi inizi alla lettura dei
poeti e degli storici. Omero non ebbe segreti per me. Venni ad-
destrato allesegsi e alla critica: con facilit spiegavo il signifi-
cato di un testo e ne indicavo la lezione morale da trarne.
Furono gli anni del quadrivium: aritmetica, geometria, astro-
nomia e teoria musicale che si sommavano allo studio delle lin-
+
gue. Soprattutto queste apprendevo velocemente. La mia me-
moria era una cavalletta insaziabile.
Assaliva i campi latini, greci, arabi, con una voracit violen-
ta che lungi dal placarmi rendeva altri appetiti.
Ben presto travalicai i miei doveri. Mi incuriosii al turco, al
siriaco, al copto, allo slavo ecclesiastico che mi veniva facile per
la sua somiglianza alla lingua di mia madre che era venuta dal-
laltra parte del Canale, allarmeno, al georgiano. Quanto alla
mia propria lingua, il greco, mi divertiva cogliere le distanze tra
la scrittura epica di Omero e di Esiodo e lattico letterario e tra
questi e il greco del Nuovo Testamento e via via fino alle paro-
le di tutti i giorni che, puresse ricche di differenti sfumature,
scorrevano tra Otranto e Bisanzio.
Delle mie singolari capacit di apprendimento giunse noti-
zia anche nella casa dei miei genitori. Erano orgogliosi di me e
mia madre, in uno dei nostri rari incontri, mi raccont che per
svezzarmi aveva adoperato, come si usava nella nostra terra,
una mistura di acqua e carbone dal sapore disgustoso che le an-
neriva i capezzoli. Una sorta di inchiostro. Era quindi pi che
naturale che mi nutrissi di inchiostro e delle parole con esso
tracciate.
Capitalis Quadrata Littera Uncialis Textualis
Prescissa Lettre Bourguignonne Attento, Marco, in ultimo
guarda! Lei, la pi raffinata e precisa delle scritture: la Lettera
Nera!
Timoteo, il Maestro delle Scritture del monastero, deposi-
tava le pergamene con i modelli delle lettere sul tavolo come
fossero reliquie.
I miei occhi si sgranavano su quei segni. Ero certo allora, e
in parte lo credo ancora adesso, che in essi fosse racchiuso un
sortilegio.
Intanto per le mie giovani mani quel sortilegio signific co-
piare fino a quando le dita e il polso non erano gonfi e dolo-
ranti. Infinite volte bisognava tracciare ogni ductus, ogni tratto
di penna che componeva la lettera, nella direzione e nellordi-
ne stabiliti. Era facile sbagliare. Bastava uninclinazione errata
+s
del calamo o della penna. Un momento di distrazione e si per-
deva la proporzione tra la larghezza del tratto e laltezza della
lettera. Un tremore della mano e le attaccature diventavano tre-
molanti, le grazie incerte.
Non era infrequente che il sottile ramo di ciliegio che
Timoteo usava per indicare i caratteri si abbattesse con violen-
za sul tavolo del malcapitato allievo e, qualche volta, sulla sua
schiena.
capitata anche a me quella bruciante umiliazione.
A Csole linsegnamento della scrittura era del tutto indi-
pendente dagli altri studi. Io ero tra i pochi prescelti a com-
pierli tutti, ma gran parte dei miei compagni non era in grado
di leggere ci che copiava e non ne sarebbe stata capace mai.
Non si deve pensare che questo rendesse meno precisa la scrit-
tura, anzi. pi facile lerrore per lo scriba che comprende ci
che copia che per lo scriba al quale il testo resta segno incono-
scibile. La mente di questultimo sgombra e i suoi occhi non
si perdono nei sogni ingannevoli della lettura ma restano fissi
sui tratti, sulla loro purezza di segni che a nullaltra immagine
rimandano.
Guarda questa pagina, Marco, appartiene a Ricardus
Franciscus, allievo di Jean Flamel, maestro di scrittura e biblio-
tecario delleccellentissimo Duca di Berry.
La pagina era perfetta e iniziava con una meravigliosa capi-
tale complessa.
Pensa che Ricardus non sa leggere. Tutta questa euritmia
per lui non ha n suono n significato.
Oggi, caro Manuzio, i tuoi torchi ne farebbero un derelitto
o un meccanico come il vecchio Johann Neudrffer che dise-
gna caratteri per i punzoni. Ma ci che per il vecchio Johann
pura meccanica io ho visto sulle pagine di Johannes von
Hagen, dove si dispiegava lestrema precisione delle lettere e li-
nesauribile fantasia di Mastro Drer.
Csole, nelle sue fitte corrispondenze, raccoglieva esempi di
scrittura da tutto il mondo. Jean Froissart ci inviava le pagine
di prova delle sue Chroniques.
+o
Ammirai una bozza della descrizione del torneo di
SantIngleuerch che Mastro Jean aveva preparato per il
Romanzo dei Cavalieri della Tavola Rotonda.
David Aubert aveva spedito a Csole alcune pagine della sua
Vita Christi per il Duca di Borgogna, ma Timoteo custodiva
nel suo archivio pagine di Nicholas Lowe che erano state scrit-
te quando neppure ero nato ma dovevo lo stesso meditare e fa-
ticare sui risvolti discendenti di quel pazzo di calligrafo inglese.
Pi andava avanti la mia formazione di scriba e pi Timoteo
mi riportava indietro nel tempo. Mi impose lo studio di lette-
re sine pedibus, con le basi squadrate. Fui costretto per settima-
ne a copiare degli esempi di scrittura che venivano la luoghi re-
motissimi.
Windmill, Marco, Windmill, sono passati due secoli, ep-
pure guarda queste teste a diamante!
Ero affascinato da quel Salterio, cos come mi lustravo gli
occhi su quelle meraviglie che erano comunque pagine di scar-
to. Da Ormesby venivano i fogli di un altro Salterio e altri an-
cora da Luttrell. Remoti monasteri dellAnglia Orientale.
Ma fu sulla Textura Quadrata che mastro Timoteo mi co-
strinse a esercizi feroci. Quella che lui chiamava Lettera Nera e
per la quale mostrava unassoluta predilezione era una scrittura
ormai passata di moda. Senza curve e con i tratti tutti dello
stesso spessore aveva pochissime grazie: un filetto superiore a
chiudere la c, le ascendenti spaccate e i piedi a diamante.
Attenzione, Marco, raccomandava sempre Timoteo
tra lettera e lettera solo la larghezza di un tratto e tra parola e
parola solo due volte la larghezza della punta del calamo!
Copiare e sudare.
Incipit Liber Exodus Avanti, ragazzo, puoi fare ancora
meglio!
A grandi lettere rosse si apriva una Bibbia che un pellegrino
proveniente da Grandval aveva consentito che si copiasse.
Haec sunt nomina Attento a quellH!
La lettera capitale finemente decorata invitava alla lettura.
Coraggio, Marco, stamattina cominciamo con lonciale!
+
La copia di alcune pagine del Salterio di Vespasiano mi con-
sent di appropriarmi dellUncialis.
Alfabeti di Northumbria e dIrlanda mi incantavano. Molti
secoli prima della nascita di Csole i seguaci di Agostino a
Wearmouth, Jarrow, Lindisfarne e Kells avevano fondato gran-
di monasteri ciascuno con il suo scriptorium.
A tutta una primavera dedicata allapprendimento delle ca-
pitali gotiche segu unestate per imparare a vergare i tratti com-
posti delle versali. In autunno Timoteo mi inizi alle abbrevia-
zioni. Cos IN NOMINE DOMINI NOSTRI JESUS CHRI-
STI. INCIPIT LIBER SACRA MATRIS diventava IN NM
DNI NRI IHU CS. INCPT LIB SACRAMTR
Non affatto difficile, Marco spiegava Timoteo.
Abbreviare come recitare in fretta. Brutta abitudine smozzi-
care i Salmi, ma se lo facciamo per la scrittura
Un santo abate cistercense di passaggio a Csole, in viaggio
verso la Terra Santa, ci fece dono di un suo libretto, il Myroure
of Oure Lady, scritto per le monache del convento di una lon-
tana citt chiamata Syon. Egli raccontava che il Maligno aveva
incaricato un suo diavolo, a nome Titivillus, di raccogliere tutte
le lettere saltate nelle preghiere e pretendeva la consegna di
mille sporte al giorno.
Timoteo, ma cosa poteva farsene mai il Maligno delle let-
tere saltate?
Questo non lo so, Marco, labate non laveva scritto. Io
credo che tutte quelle lettere servissero al Maligno per ingan-
nare i copisti, per disseminarle davanti agli occhi degli scribi e
confonderli.
Cos a Csole appresi i primi rudimenti della Littera
Antiqua che tuttoggi usiamo e che simile alle lettere mecca-
niche dei nostri torchi.
+
VI
A turno, quanti di noi erano destinati a diventare monaci
dovevano aiutare il Signore delle Greggi a pascolare le pecore.
Lo studio mi aveva stimolato la nostalgia per Mauro, per i suoi
tratti rudi e affettuosi. Ora pensavo che ci che mi aveva indi-
gnato nei primi giorni di noviziato sarebbe stata una pausa di
libert. Chiesi e ottenni di tornare per un turno a dormire nelle
grotte, ai lunghi itinerari con le pecore, allodore dello stallati-
co e dellerba.
Allo stazzo cera una novit. In verit non ero certo che fosse
tale, poteva anche essere che il sonno duro di bambino non mi
avesse, al tempo, fatto notare larrivo di una donna poco dopo
il tramonto. Ora mi accorgevo del suo giungere alla casupola di
Mauro ma la mia gi poca curiosit per la faccenda ben presto
veniva vinta dal sonno. Il fatto che al mattino non la vedessi
pi mi faceva persino pensare a un sogno, a una visione di
quelle tanto frequenti sulle serre al calare delle tenebre. Una
notte, ben prima dellalba, Mauro venne come di consueto a
svegliarmi. Intontito dal sonno, non ebbi testa per stupirmi del
suo invito a restare a dormire ancora, che ci saremmo visti poi,
pi tardi, ai pascoli di Uggiano. E il sonno mi riprese al volta-
re della testa.
Era lalba quando mi svegliai di soprassalto. Qualcosa mi
toccava ed ero gi pronto a scalciare uno dei cani o un agnello
quando mi resi conto che a scompigliarmi i capelli erano le dita
di una mano. Nella luce azzurrina riconobbi la donna miste-
riosa. La tunica slacciata lasciava intravedere i grandi seni. Il
suo corpo scuro era disteso accanto a me. Lo spavento si stem-
per rapidamente nel piacere di quella carezza che continuava.
Sentivo come unagitazione, limminenza di qualcosa che do-
+,
veva accadere e che si concentrava sul mio pene che si induri-
va. Tra quel corpo nudo e quanto mi accadeva doveva esserci
un legame ineludibile. Altre volte mi era capitata quelleccita-
zione e anche qualche polluzione spontanea che mi aveva la-
sciato confuso, ma questa volta intuivo che nascosta nel fondo
di quel triangolo scuro che la donna aveva tra le gambe doveva
esserci qualcosa di straordinariamente eccitante. Ora era diste-
sa e le sue gambe erano aperte. Nei suoi occhi si leggeva un sor-
riso che le labbra e i denti bianchissimi confermavano. Mi at-
trasse dolcemente, poi sentii la sua mano guidare il mio sesso
ma gi senza che lo potessi fermare un movimento si era im-
padronito dei miei reni. Mi spingevo in quel rifugio caldo e
umido con scatti furiosi e allimprovviso lo inondai. Restai cos
inerte, con il volto immerso nel suo collo che profumava di
erba prima di scivolare al suo fianco.
Oh s, s! C un giovane puledro al quale insegnare le an-
dature! A sgroppare sono buoni tutti!
Ancora oggi non dimentico lespressione ridente del suo
viso, un misto di grazia materna e malizia beffarda. Ero confu-
so e ancor pi confuso quando la sua mano riprese ad accarez-
zarmi.
Oh s, s! Un giovane puledro da domare: passo, trotto,
galoppo!
Gi non capivo quella faccenda del puledro e i miei pensie-
ri svanirono del tutto quando al tocco della sua mano il mio
pene torn a inturgidirsi. Ora ero io a essere supino e lei, ingi-
nocchiata tra le mie gambe, mi stringeva con una mano i testi-
coli mentre con laltra serrava la radice del mio sesso. Ancora
una volta fui preso da quella sorta di furia dei reni ma lei era
forte e mi teneva con le natiche inchiodate al pagliericcio.
Cercavo di muovermi, desideravo sopra ogni altra cosa tornare
dentro di lei ma invano. Ero immobilizzato e una stretta appe-
na pi forte mi indusse a rinunciare.
Come ti chiami, giovane puledro?
Marco, signora, Marco, Marco! Oh vi prego! Vi prego!
Ho capito, Marco, ma di cosa mi preghi?
c
La mia risposta non fu altro che un gemito. Il volto riden-
te, quei grandi seni e la vagina che sfiorava il pene mi davano
un tremito che non si placava. Mi tenne ancora per un po im-
mobilizzato. Poi lentamente abbass il capo. Una grande ca-
scata di riccioli neri mi imped di vedere la sua bocca aprirsi su
di me, ma sentivo la sua lingua guizzare e le sue labbra e il
morso leggero dei suoi denti, poi pochi colpi della sua mano e
venni ancora. La sentivo ingoiare il mio umore, lentamente,
raccoglierlo con la lingua e ingoiarlo ritmicamente come se
neppure una goccia dovesse andare perduta.
Quando si lev, riavviandosi i capelli, una lama di sole che
filtrava dalla tenda le illumin il volto.
Mio Dio, Mauro al pascolo di Uggiano con
Stai buono l, Marco, lasciamo Mauro alle sue pecore. Tu
sei destinato alla vita monacale e quindi alla castit, ma essa
non un bene in s. Tu devi prima, secondo il nostro costume,
dimostrare la tua capacit. A nulla vale il rinunciare a ci che
non si conosce e quindi non si desidera. Ancor meno di nulla
vale rinunciare a ci di cui non si in grado di godere piena-
mente.
Forse fu lo sgomento che lesse nei miei occhi a farla adagia-
re su di me. Le nostre labbra si unirono e quando timidamen-
te la mia lingua si intrecci alla sua avvertii un sapore che non
so descrivere. Il suo corpo non pesava sul mio. Come se nelle
nostre anatomie ci fosse qualcosa di complementare e i nostri
corpi fossero fatti per gravare luno sullaltro senza danno. I
miei occhi si chiusero sotto londa dei suoi capelli e forse dor-
mii qualche attimo o pi, non posso dirlo. Certo a destarmi fu
il desiderio. Ormai la luce era alta e contemplavo quel corpo
bruno, i grandi capezzoli, i fianchi, la curva delle natiche, le
gambe. Il desiderio mi prendeva a ondate e le mie mani velo-
cemente scorrevano dai suoi seni al suo ventre e le cingevo la
vita e le natiche e senza accorgermene le affondavo tra le sue
gambe dove quel pelo lucido nascondeva una fessura morbida
e bagnata e pi oltre, tra i glutei, dove il bocciolo di unaltra ca-
vit del suo corpo accrebbe ancora la mia eccitazione. Lei mi
:
lasci fare come abbandonata, ma quando presi a baciarla sulla
bocca, sul corpo, sui seni ed ebbi lardire di scendere con le mie
labbra fino alla sua vagina cominci a gemere dolcemente. Ora
anche i suoi fianchi avevano come dei sussulti e le nostre mani
e le nostre bocche cercavano gli angoli pi riposti dei corpi. Il
suo volto non era pi sorridente ma come assorto, gli occhi
chiusi e il respiro leggermente affannato. Rotolavamo sul pa-
gliericcio e quando fu sotto di me cercai di entrare dentro di lei
ma fu pi svelta, rotolammo ancora e mi ritrovai sotto di lei.
Oh no, no! Giovane puledro Marco, oh no, no!
Aveva riaperto gli occhi e dritta a cavallo dei miei fianchi
aveva ripreso a sorridere. Mi prese londa della paura che tutto
fosse finito, che il mio desiderio dovesse restare spezzato, ma
poi il suo volto si fece serio. Si sollev appena perch il mio
pene affondasse ancora dentro di lei mentre le sue mani piom-
bavano pesantemente sul mio petto mozzandomi il respiro. Il
suo peso impediva ai miei fianchi di muoversi. Ora erano le sue
mani a governare il mio respiro perch il ritmo fosse uguale al
suo. Prese a muoversi molto lentamente ruotando i fianchi.
Ogni respiro una rotazione. Le sue mani scivolarono sui miei
fianchi guidandoli in una lenta rotazione inversa alla sua.
Quando dal movimento rotatorio prese a sollevarsi lievemente
per ripiombare su di me annu al mio movimento che le veni-
va incontro e chiuse gli occhi. Il suo volto si fece assente, per-
duto, ma il suo ventre premeva con sempre maggiore forza sul
mio, inarcato verso di lei.
I nostri respiri erano identici e identicamente si andavano
facendo pi veloci, i loro sibili sfociavano negli stessi gemiti.
Poi emise un grido e per il mio corpo fu come un segnale e, an-
cora una volta, venni dentro di lei. Restammo cos mentre len-
tamente mi ritraevo da lei. Ora era il suo volto a essere affon-
dato nellincavo della mia spalla.
Oh s, s! domato il puledrino! Oh s, s! Passo, trotto,
galoppo! Impari presto, Marco, Mauro dice che sei il miglior
discepolo dellabbazia e, per quello che mi riguarda, non posso
che confermarlo. Oh s, s! Allabbazia per tra chi insegna e chi
:
impara ci sono solo i testi, le scritture e queste tanto pi valgo-
no quanto da pi tempo sono morti i loro autori. Io invece
credo che imparare significa partire dallesperienza di qualcuno
vivente. Non vero, Marco?
S, signora, voi voi voi mi avete insegnato la cosa
la cosa pi bella, la cosa che io che io non credo non
posso No! Non potr mai pi tornare al monastero
La sua mano vol a chiudere la mia bocca, ma quel gesto
imperioso si stemper in una carezza.
Taci, Marco, non sai quello che dici.
Ora le mie mani dai suoi fianchi scivolarono verso la fendi-
tura tra le natiche. Con le dita saggiavo la cedevolezza di quel-
lapertura.
Impari presto, Marco, molto presto
La sua voce era leggermente affannata. Il sole era a picco ma
non mi importava pi di Mauro, delle pecore, del monastero.
Sentivo le sue unghie sulle mie spalle, i suoi fianchi contrarsi
ritmicamente. Ora erano le nostre lingue a esplorare i corpi.
Sembrava che sapessimo perfettamente come darci reciproca-
mente piacere. Quando strinse il mio pene tra i suoi seni mi
sembr di vaneggiare ma quando la mia lingua si fece strada tra
le sue gambe lei inizi un lungo lento lamento che si concluse
in un urlo. Ormai non sorrideva pi. Nel suo sguardo cera una
luce di sfida, ma io non avevo pi paura.
Marco, da domani, una volta tornato in abbazia, ripren-
derai la tua thanatou melt, la tua preparazione alla morte,
come Socrate definisce la filosofia, ma il ricordo di me ti per-
seguiter nello scriptorium, nelle aule, nel refettorio e neppure
prostrato davanti alliconostasi con la schiena spezzata dalle
metane troverai la pace.
Aveva parlato con furia e con furia la vidi aggirarsi per la ca-
panna. Mi spinse a sedere sul basso sgabello della mungitura.
In quella posizione mi sembrava di penetrare dentro di lei oltre
ogni limite. Le sue braccia erano serrate intorno al mio collo e
anche le sue gambe si strinsero ai miei reni. Non facevamo
alcun movimento, solo sentivo il suo ventre contrarsi. Rimase
+
cos come a cullarsi ma non riuscivo a compiere alcun movi-
mento che potesse farmi unire al suo piacere. Quando si alz
di scatto aveva ritrovato il sorriso indefinibile degli inizi.
Oh s, s! Oh s, s! Cosa fai con quel bel cetriolo lucido?
Si stava beffando di me che impazzivo di desiderio. Tentai
di afferrarla ma si sottrasse. Era agile e in una lotta non ero af-
fatto certo di avere la meglio. Volevo prenderla ancora. Volevo
venire dentro di lei, volevo che lei mi prendesse conservando il
seme nel suo corpo. Corse fuori dalla capanna e la inseguii. Il
mio timore che qualcuno potesse vederci svan nel deserto della
controra. La vidi entrare nel casolare dello stazzo. La seguii
senza correre. La trovai distesa sulla paglia. I nostri respiri e i
nostri fianchi si accordarono pi di quanto noi stessi volessimo
farlo.
Giacevamo esausti, io ancora dentro di lei, con la testa af-
fondata tra i suoi riccioli quando la sentii mormorare:
Anche il ricordo di te mi perseguiter, Marco, ma la mia
unaltra storia.
Signora, quando potr rivedervi? Sempre che voi lo desi-
deriate io io non conosco neppure il vostro nome
Alberada, il mio nome Alberada, non hai mai sentito
questo nome?
Certo, signora, un nome dei tempi antichi, dei tempi del
Normanno.
Ma che bravo! Oh s, s, che bravo! Conosci la storia,
Marco, ma ti manca la leggenda e luna senza laltra come il
pane senza il sale. Sono Alberada, figlia di Alberada, nipote di
unAlberada, figlia a sua volta di unaltra Alberada.
Non capivo questa lunga stirpe di donne tutte con lo stesso
nome e se ne accorse dal mio sguardo perplesso.
Era il tempo di Boemondo, e il Principe veniva su queste
serre a cacciare e a trovare i suoi amici monaci che vivevano
nelle laure, a mangiare lagnello col monaco Giuseppe che di-
venne poi il fondatore dellabbazia. Fu cos che conobbe una
fanciulla di masseria nota a tutti per la sua straordinaria bellez-
za. Se ne innamor e la ragazza, che prese a sognare gli occhi
verdi del giovane cacciatore, un bel giorno rest incinta.
Boemondo aveva dimenticato tutto accanto a lei, le sue guerre,
la sua politica, i suoi regni e quando nacque una meravigliosa
bambina volle darle il nome di sua madre: Alberada. La picco-
la aveva la pelle e i capelli scuri della madre e gli occhi verdi del
padre. I due erano cos felici e la bambina di tale bellezza da su-
scitare linvidia delle macre delle Serre che fecero crudele sor-
tilegio.
E qual era il sortilegio, signora?
Boemondo sarebbe partito e non sarebbe mai pi tornato
a Otranto, la fanciulla sarebbe morta dopo lallattamento e
anche nel destino della piccola Alberada si sarebbe dovuto ri-
petere il destino della madre: un grande amore, una bellissima
figlia, labbandono delluomo e la morte. Ma il destino doveva
avere sempre lo stesso nome: Alberada, il nome della norman-
na ripudiata dal Guiscardo. E cos fu. Boemondo part per pre-
parare un viaggio alla Terra Santa e poi per tante altre avventu-
re.
La fanciulla mor e la piccola Alberada fu, come tutte noi,
allevata dalle misteriose presenze che popolano queste terre e
proprio una di esse fu mossa a compassione per il crudele de-
stino che le macre ci avevano inflitto. Fu la Lara te li cunti ad
avere piet di noi
Lara te li cunti ? Non so chi sia, signora.
Oh s, s, giovane Marco, tu sai di latino e arabo e greco e
di storia e teologia. Tu sai tutte quelle parole che gli uomini si
scambiano nelle pause tra una guerra e laltra, negli intermezzi
tra lodio e il rancore, ma non conosci le parole delle donne e
s che tua madre avrebbe dovuto raccontarti qualcosa prima di
farti rinchiudere a Csole. La Lara te li cunti la pi dolce
delle presenze delle Serre. Si introduce le sere dinverno nelle
case quando tutti sono intorno al camino e, nelle notti desta-
te, siede sui gradini delle porte dove si prende il fresco e ascol-
ta le storie che le donne raccontano. Solo le donne possono ve-
derla ma non devono farne parola. Lei ha il potere di ricordare
tutte le storie e di questo fece dono alla piccola Alberada per-
s
ch lo tramandasse alla figlia che avrebbe partorito un giorno.
Non la Storia, Marco, quella che voi uomini imparate da
Polibio e da Erodoto, ma le storie, quelle sospese nelle parole
che non finiranno mai sulle vostre pergamene e sulle vostre
carte.
Dallo stazzo tornammo alla capanna. Il suo corpo nudo e
scuro brillava nel sole e nel sole i suoi occhi verdi mandavano
riflessi dargento.
Perdonate, signora, lardire dei miei sedici anni, ma voi
dovete averne almeno il doppio. Come mai non siete morta?
Bella domanda, Marco! Oh s, s, bella domanda! Vedi,
Marco, il mio primo amante stato Evaristo, il Maestro delle
Erbe. Egli mi ha preparato una pozione che mi impedisce di
concepire ma ma ma non credo che le sue polveri e i
suoi decotti potranno ingannare ancora a lungo il sortilegio.
Mentre diceva queste parole si pass una mano sul ventre
serrando gli occhi. Quando li riapr fiss la terra come se vo-
lesse trafiggerla.
La guardai ancora mentre infilava la lunga tunica bianca e
la serrava in vita con una pesante cintura dargento, che mi
sembr adatta pi a sorreggere una spada che a posarsi sui mor-
bidi fianchi di una donna.
Quando mi svegliai il tramonto anneriva le serre. Lei non
cera pi ma non potevo avere sognato. Ero nudo sul paglieric-
cio, il suo odore derba era sospeso nellaria insidiato da un
odore di arrosto che filtrava dalla porta. Mauro e donnAnna
sorrisero nel vedermi.
Rivestiti, il capretto quasi pronto!
Ero imbarazzato, le guance in fiamme. Balbettai qualcosa,
qualcosa sul fatto che ero caduto nel peccato, ma donnAnna
mi zitt con un altro dei suoi proverbi:
Stelle Cruci Mezzelune
Ci stai subbra llu saccune
Cu llu fuecu mmienzu llanche
Te le scerri tutte quante
o
Questa volta capii al volo.
Mangiammo di gusto chiacchierando di pecore e capre e
bevendo vino.
Il mattino dopo tornai a Csole.
Non avrei dovuto, carissimo maestro Manuzio, indulgere
tanto spregiudicatamente nella descrizione del mio incontro
con Alberada. Ella era probabilmente solo un fantasma, forse
un demone della carne, lepifania di una passione che era mio
destino rinchiudere nel fondo del mio corpo e della mia anima.
E cos ho fatto per quasi tutta vita, ma ci che fu tanto severa-
mente custodito affiora con la forza di una concretezza singo-
lare. Fantasma dunque? sortilegio? chiss!
Era passato non molto tempo da quel mio incontro con
Alberada. Il ricordo di lei mi faceva torcere dal desiderio, ma
combattevo la mia passione con la preghiera e lo studio. Una
mattina dinverno ero nello scriptorium a copiare un noioso
manoscritto e il mio sguardo sovente volava oltre la finestra,
verso la terra brulla e il mare scosso dalle tramontane, quando
sul limite di una macchia lontana scorsi una figura bianca che
mi sembr stesse indicandomi a un fagottino che stringeva nel
cavo del braccio. Nella corsa rovesciai tavoli e sgabelli e le carte
e gli inchiostri si sparsero sulle chianche. Feci a precipizio le
scale, ma appena fuori una folata di vento port nebbia e leco
di un vagito infantile. Correvo e gridavo il suo nome ma non
ebbi nessuna risposta. Sentii solo quel vagito affievolirsi nella
distanza. Nei giorni che seguirono i morsi della passione la-
sciarono il passo allangoscia. Il tempo trascorso dal mio in-
contro con Alberada era giusto quello di una gravidanza. Avevo
una figlia e Alberada, quella che ormai era diventata la mia
adorata Alberada, sarebbe morta di l a poco. Chiesi dispensa
allIgumeno e cominciai a battere le campagne, le masserie, i
casali, le grance ma nessuno aveva notizie di Alberada.
Soprattutto i vecchi ai quali chiedevo scuotevano il capo con
un sorriso di compatimento. Andai a trovare Mauro che se ne
stava rintanato con le greggi.
Aveva perduto la sua gioviale ruvidit, lo sguardo era un
lago di tristezza. Alle mie domande chin il capo.
Non tornare mai pi qui, Marco, voglio solo che tu pren-
da questo in ricordo di quanto su queste serre accaduto tra
noi. La lama di bronzo. Sugli scogli di Roca se ne trovano
tante appena i cani scavano nella terra. Scheletri e lame. Chiss
perch si sono uccisi. Portalo sempre con te e ricorda, una
lama, pi della fede, sempre unultima possibilit.
Il manico del coltello era nuovo, di legno dulivo lucido e
ben stagionato ma la lama, pur smozzicata dal tempo, era soli-
da e tagliente.
Quando tornai a Csole era ormai estate piena. Studio e
preghiera, preghiera e studio e la schiena spezzata dalle metane
davanti alliconostasi. Una notte sognai Alberada. Eravamo in
una masseria sconosciuta e io entravo in una grande stanza e
Alberada era seduta davanti al camino con un fagottino nel
cavo del braccio. Mi avvicinavo e lei apriva i panni e appariva
una bimba scura di pelle e di capelli, i cui occhi verdi manda-
vano riflessi dargento.
Al mattino mi fermai a guardare il mio volto riflesso nel-
lacqua del secchio. Cercai di togliermi dei fili di paglia che mi
sembr si fossero impigliati nei capelli. Non vennero via. Non
avevo ancora ventanni e le mie tempie si erano gi striate di
bianco.
VII
A Csole arrivavano di continuo messaggeri, gente di pas-
saggio, ora pellegrini per la Terra Santa, ora capitani di mare,
ora diplomatici in viaggio da e per lOriente, ma nulla turbava
la nostra quiete. Grande fu quindi lo stupore tra noi studenti
quando, poco dopo larrivo di un uomo a cavallo, un grande
trambusto prese i monaci. Il monastero venne ripulito da cima
a fondo, si imbiancavano i muri, si lustravano le chianche, la
chiesa venne ridipinta e persino liconostasi ritoccata e i colori
sulle sacre immagini ripassati, ma era nello scriptorium che il la-
voro non conosceva pi soste. I monaci copiavano a turno
senza interruzione. Una mattina eravamo al termine del desi-
nare quando lIgumeno ci ingiunse di restare ai nostri posti.
Un grande evento si prepara per Csole. Abbiamo avuto
lannuncio della visita di Sua Eminenza Reverendissima il
Cardinale Bessarione. Egli sar qui tra non molto e tutti noi gli
dobbiamo unaccoglienza allaltezza della sua ma anche della
nostra fama. Il Cardinale il pi dotto dei dotti e ci onora della
sua visita non solo per ritirare le copie dei manoscritti che ha
ordinato ma anche per valutare la qualit dei nostri insegna-
menti e quindi dei vostri studi. Non abbiamo alcun timore ma
volevo avvertirvi che tutti sarete interrogati alla sua presenza e
sono pi che certo che darete ottima prova della vostra dottri-
na e della vostra fede. Ora potete andare.
Stavo per uscire con i miei compagni quando fu lo stesso
Igumeno a richiamarmi. Attese che gli altri studenti lasciassero
il refettorio.
Marco de Marco, so di non lusingare il tuo orgoglio se ri-
conosco che sei il migliore tra gli allievi di Csole. Come tale
sarai presentato al Bessarione e dovrai dare prova della tua di-
,
mestichezza con il greco e il latino e, se richiesto, con le altre
lingue che ti sono note, ma non basta. Sappiamo dai tuoi mae-
stri delle tue letture e della tua acutezza nella storia, nella filo-
sofia, nella teologia, della passione con la quale ti sei applicato
allo studio per lunit delle Chiese Sorelle di Roma e
Costantinopoli. Si tratta di un tema molto caro a Bessarione.
Se si dovesse dare loccasione dovrai sostenere anche una con-
versazione con il Cardinale. Ci non viene richiesto ai tuoi
compagni ma il tuo un caso differente. Csole conta molto
su di te.
Non potevo fare altro che annuire. Le parole di Filoteo la-
sciavano nel mio cuore una tenzone tra lorgoglio e il turba-
mento. E fu con questanimo che venni presentato a Bessarione
e al suo seguito il giorno dellarrivo a Otranto.
Il cardinale era anziano, lampia veste ne rendeva imponen-
te la figura, il cappuccio, sovrastato dal cappello cardinalizio,
incorniciava un volto dai tratti marcati e dal naso carnoso.
Allingresso del monastero la pittura di mastro Basilio era
ancora fresca. In un grande stemma, sormontato dalle insegne
cardinalizie, due mani reggevano la stessa Croce di Cristo.
Nella chiesa si tenne funzione solenne e tutti cantammo il
Triodio.
Bessarione ricevette lomaggio dei maggiorenti di Otranto e
si rivolse loro in latino, poi volle che solo noi di Csole ci ri-
unissimo e parl in greco.
Fratelli dilettissimi, porto a tutti voi la benedizione del
Santo Papa Paolo II che ha sempre nel cuore la Chiesa di
Otranto e il venerabilissimo monastero di San Nicola di
Csole. Non trascorso un anno dalla grande gioia per la visi-
ta a Roma del valoroso difensore della fede, Giorgio Castriota
Scanderbeg, che il lutto per la sua morte prematura si aggiun-
ge alla preoccupazione per la perdita di colui che fu argine alle
brame di Maometto II. A voi che avete avuto la bont di rap-
presentare il mio stemma sulle vostre mura non debbo ricor-
dare che solo la mano greca e quella latina insieme potranno
sostenere la Croce di Cristo contro il Gran Turco. Io non sono
sc
uomo darme, piuttosto di preghiera e di qualche diplomazia e
sono sceso fin quaggi perch so quanto vi siete adoperati e vi
adoperate per la causa comune in questa terra esposta a ogni
pericolo. Ci che a Roma pu essere uno scacco diplomatico e
pur anche militare qui pu rappresentare la perdita della fede e
della vita. Sono qui per apprendere non solo dalla forza della
vostra fede ma anche e soprattutto dalla vostra sagacia e dalla
vostra saggezza. Per tutta la vita ho lavorato alla ricomposizio-
ne di ogni discordia tra Roma e Bisanzio e finora ho fallito, ma
ci che la mia volont non stata in grado di produrre potreb-
be Maometto II col timore che sta incutendo a tutta la cristia-
nit. Solo una nuova azione militare, mondata delle nequizie
che nel passato si sono compiute anche nel nome di Cristo,
pu liberare la Terra Santa ma anche la non meno santa per noi
terra di Costantinopoli. Chiunque di voi chieder udienza lo
ascolter, perch non una parola vada perduta.
Ero stupito. Cosa mai poteva dire o fare Csole, la nostra re-
mota abbazia, nel grande turbine che stava scuotendo il
mondo? Non avevo una risposta e quindi tornai a ripassare il
testo che avevo preparato per recitarlo alla presenza del
Cardinale. Avevo tradotto in greco lorazione De
Costantinopolitana clade et bello contra Turcos di Pio II e, dopo
aver ascoltato il discorso di Bessarione, benedicevo lacume del
bibliofilace che mi aveva suggerito la scelta.
Oh nobile Grecia, dunque giunta ormai la tua fine, la
tua morte? Quante citt un tempo famose e potenti sono estin-
te. Dove sono oggi Tebe, Atene, Micene, Larissa, Lacedemone,
Corinto, e le rocche memorabili di cui non esistono pi, non
dico i muri, ma perfino le rovine?
Avevo recitato lorazione tutta dun fiato per lemozione, fis-
sando il muro oltre le teste dei presenti e fui colto di sorpresa
alla fine dallabbraccio del cardinale. Bessarione mi stringeva
tra le braccia e le sue lacrime bagnavano il mio volto.
Me lero cavata e avevo fatto fare una bella figura al mona-
s:
stero e ai miei maestri. Mi tocc persino una pacca sulla spalla
dallIgumeno e questo mi sembr un premio ben pi grande
delle lacrime di Bessarione. Ero tornato nello scriptoriumquan-
do Niccol Perotti, segretario del Cardinale, venne a chiamar-
mi. Il cardinale Bessarione voleva vedermi.
Ottimo greco, Marco de Marco, veramente ottimo. Ma
non il tuo greco che ha strappato le lacrime dagli occhi di
questo vecchio prete. Tu mi hai ricordato la sapienza di un altro
giovinetto che mi fu oltremodo caro e che la peste sottrasse al-
ladorazione del padre e al mio incommensurabile affetto.
Quanti anni hai, Marco?
Diciotto, Cardinale.
Diciotto! La sua stessa et. La stessa et del mio
Buonconte, del giovane da Montefeltro, che Dio abbia piet
della sua anima! Filoteo mi ha detto della tua disposizione per
lo studio, per lapprendimento delle lingue ma mi si dice che
anche la teologia, la storia, la filosofia ti sono familiari. Bene!
Abbiamo bisogno di giovani come te. Il tuo corso di studi
ormai volge al termine e ho suggerito allIgumeno di farti im-
pratichire nellebraico presso la Schola Talmudica di Otranto
prima di affidarti lincarico di riordinare larchivio del conven-
to che so essere preda del disordine per la malattia del vecchio
Demetrio. un incarico che richiede grande riservatezza e del
quale risponderai direttamente a Filoteo, ma Niccol sar in
contatto con te. Dobbiamo ricostruire la memoria di tutti noi
greci sparsi ai quattro angoli del mondo perch se non ci ri-
uscir di far rivivere Bisanzio si abbia ricordo almeno della no-
stra diaspora.
Bessarione part con il suo seguito ma la spedizione si arric-
ch di trenta muli, ciascuno dei quali recava sul basto due casse
di libri. Non credo che tutto fosse stato copiato e quello per cui
non si era fatto in tempo part nella copia originale. Allora non
sapevo che avrei ritrovato qui a Venezia quello che vedevo al-
lontanarsi lungo la valle dellIdro, tra gli ulivi e le prime case di
Otranto.
s:
VIII
Marco, potrai usare una cavalcatura per i tuoi spostamenti.
Le parole dellIgumeno mi lasciarono stupito. Certo la visi-
ta del Bessarione aveva scombussolato i nostri ritmi di vita e io,
in particolare, ne ero rimasto molto impressionato. Adesso non
capivo perch ero autorizzato a contravvenire al nostro canone
che solo in rarissime occasioni consentiva spostamenti con
mezzi diversi dalle nostre gambe.
Dovrai raggiungere quotidianamente la Schola
Talmudica. A piedi perderesti molto tempo. In verit mi limi-
to ad adempiere agli ordini del Cardinale. Personalmente avrei
pi di una perplessit a esporti, cos giovane, alla conoscenza di
una lingua che apre le porte verso saperi tanto lontani dalla no-
stra fede. Il nostro imperatore Giustiniano escluse dallinsegna-
mento in Bisanzio i giudei. Tuttavia Bessarione ha ragione
quando dice che nella diaspora ebraica circolano conoscenze
che non possiamo ignorare. Ho dovuto addirittura trovare un
accordo con rabbi Mordechay per uno scambio. Csole per la
prima volta nella sua storia accoglier un ebreo tra i suoi stu-
denti. Cos sarete in due a mettere in pericolo la vostra fede.
Che Dio illumini le vostre anime!
La Judaica si stendeva nella parte bassa della citt, una zona
che conoscevo bene perch i giochi della mia infanzia non co-
noscevano barriere di sorta e tra i ragazzi non vi erano diffe-
renze. Il quartiere era affollato e pieno di magazzini ricchi delle
merci pi varie. Quelli che mi piacevano di pi erano i sottani
dove si depositavano le sete e i broccati. I loro colori sgargian-
ti illuminavano loscurit di quegli antri. Le bambine costrui-
vano bambole meravigliose con gli scampoli di sete orientali,
damaschi siriani e candidi cotoni del Monte Libano.
s+
Benvenuto, Marco de Marco, salute a te figlio di
Giovanni, lamico degli ebrei di Otranto, capitano di mare tra
i pi coraggiosi e mercante tra i pi abili!
Rabbi Mordechay mi accolse sulla porta del grande giardi-
no della Sinagoga Maggiore. Una fitta siepe di tamerici pro-
teggeva dal vento di mare le palme, i lauri e le viti che si ag-
grovigliavano sui pali della pergola in lotta con i glicini inva-
denti che in quella primavera mostravano tutto il loro rigoglio.
Il vecchio mi mostr le aule di studio che trovai in tutto simi-
li alle nostre, i locali per ospitare i forestieri e per il miqveh, il
bagno rituale. Quindi mi introdusse nella grande aula del
culto.
Questo, Marco, per noi il centro del tutto. Laron qodesh.
Qui sono contenuti i Rotoli della Legge.
Mordechay mi indicava cos un armadio finemente decora-
to che, mi spieg, era posto sulla parete orientale perch quel-
la era la direzione di Gerusalemme. Il luogo ispirava austerit e
raccoglimento, ma non cera nulla di paragonabile alle nostre
iconostasi. Solo un pulpito, che il Rabbi chiam tevah, era de-
stinato alla proclamazione della Legge.
Sul pavimento un grande mosaico rappresentava al centro
un candelabro a sette braccia e sui lati, da una parte, un cedro
e un ramo di palma e dallaltro un corno dariete. La severa
semplicit di quel mosaico mi fece una buona impressione a
fronte dellaffollato mosaico della Cattedrale.
Ti troverai a tuo agio con noi, Marco, la nostra antica cul-
tura ha pi dun punto di contatto con la tua. Uno dei nostri
grandi maestri, Donnolo Shabbetai da Oria, ben cinque secoli
fa, cominci lo studio del mondo greco e ne approfond, nel
suo Sefer Hachmoni, il Libro Del Sapiente, lastrologia, la filo-
sofia, la medicina. Soprattutto questultima materia fu per
Donnolo fonte di diletto ed egli riprese le dottrine di Galeno,
la teoria degli umori e della simpatia cosmica nel suo Sefer
Mirqahot che voi chiamate Libro Delle Misture. Donnolo ap-
prese la sapienza greca proprio qui a Otranto e ancora a
Rossano che, ben prima di Csole, fu luogo di studi profondi.
s
Ma non sempre i rapporti tra greci ed ebrei furono buoni. Al
tempo dellImperatore di Bisanzio, Romano Lecapeno, i tuoi
fecero strage della nostra gente e uccisero persino il tesoriere e
circoncisore della nostra comunit del quale indegnamente
porto il nome.
Cos ancora una volta imparai un alfabeto. Allinizio degli
studi mi era facile immaginare che a Otranto le lettere greche
arrivassero da oriente seguendo dallalba il corso del sole e quel-
le latine si allontanassero verso il tramonto. Poi ho dovuto im-
parare che la fatale maledizione di Babele aveva rinchiuso ogni
lingua in una terra. Ora, mentre imparavo a tracciare laleph, il
taw, il samek, intuivo che quella lingua non veniva n
dallOriente n dallOccidente, non aveva una terra. Essa era
quanto di pi vicino al divino avessi mai studiato.
In verit mi sentivo un po ridicolo. Avevo pi di diciotto
anni e i miei compagni non superavano i cinque o i sei. Per loro
ho visto compiere un rito meraviglioso. Cerano tante tavolet-
te sulle quali erano trascritte le lettere dellalfabeto che veniva-
no cosparse di miele e i miei piccoli compagni le leccavano.
Che nel sapere potesse esserci dolcezza lo appresi nella
Sinagoga di Otranto. Ma non fu lunica sorpresa.
Leggendo i versetti della Bibbia, con mio grande stupore,
imparai a respirare. Ciascuno andava detto con un solo fiato e
ciascuno aveva un suo senso compiuto che andava colto.
Leggere e scrivere una lingua meno di nulla, Marco!
Le parole di rabbi Mordechay si abbatterono sulla mia fron-
te nella quale la durezza dello studio dellebraico aveva traccia-
to pi di un solco.
Ora, mio giovane allievo, ti sembra che il discernere segni
e suoni e lencomiabile maestria con la quale tracci quei segni
e articoli quei suoni siano un patrimonio sufficiente.
Rabbi, ma mi sono esercitato nelle letture secondo i vostri
ordini.
Nulla e ancora nulla, Marco, non c un termine ad quem,
un punto dove arrivare nel quale la conoscenza compiuta. Pi
ss
volte la nostra lingua inganna chi la studia. Essa ora sembra
darsi compiutamente al sapere ma un momento dopo il signi-
ficato delle parole si eclissa. Non hai altra possibilit che conti-
nuare a studiare, studiare sempre. Leggere e rileggere e le paro-
le ti sembreranno sempre uguali, ma diverso sar il loro senso.
Insegnarti a leggere lebraico. Questo era il piccolo incarico che
avevamo ricevuto da Csole e questo abbiamo fatto. Tutto il
resto dipende da te. La nostra casa, come il nostro cuore, resta
aperta, Marco. Torna quando vuoi.
Presi cos labitudine di tornare spesso alla Sinagoga
Maggiore. Mi ero legato damicizia a un giovane coetaneo.
Paolo era stato mio compagno di scorribande quando eravamo
piccoli. Il destino ci aveva divisi, io a Csole e lui alla Sinagoga
Maggiore. Cos le nostre strade tornavano a incrociarsi.
Io a studiare da rabbino e tu da monaco, Marco, bella fine
che abbiamo fatto! Ti ricordi quando pensavamo di andare per
mare e chiss quali viaggi avremmo intrapreso?
Gi, ma ci toccato viaggiare nelle parole, nelle pagine,
nei libri. Non detto che sia meno interessante.
Ma s! C chi gira il mondo e resta con la testa chiusa, noi
invece
La mia me lavete aperta, spaccata addirittura, Paolo. Qui
da voi si studia in maniera molto diversa che allabbazia.
Ti ho visto faticare, Marco, ma, vedi, per noi la Bibbia
non ha un senso generale. Quello che ci interessa sono i singo-
li versetti, non la loro somma.
Strana idea, Paolo, a Csole tutto funziona esattamente al
contrario. Di ogni opera conta il senso generale.
Allora sei fortunato a poter praticare questo duplice ap-
proccio allo studio. Ricorda che la Bibbia, per noi, ha settanta
facce. Vuol dire un numero di significati infinito.
Fortunato, s, fortunato
Quella fortuna mi costava grandi fatiche. Era tuttaltro che
facile seguire i maestri che improvvisavano anagrammi di pa-
role, spostamenti di lettere, calcoli numerologici e se una paro-
so
la si ripeteva non era mai per caso e ogni diverso contesto nel
quale si collocava serviva a illuminare il senso dei contesti pre-
cedenti.
Davar aher! Unaltra interpretazione!
Il comando del Rabbi piombava improvviso nella discussio-
ne che si era accesa sullinterpretazione di un testo quando
sembrava che si stesse per approfondirne il significato. Le voci
tacevano in una pausa che sedava il pensiero per un attimo ma
velocemente si ripartiva e la discussione riprendeva allinfinito.
I ventiquattro libri della Bibbia assunsero per me una forma
circolare. A Csole la lettura era solo una linea retta.
Nel Talmud mi sentivo perduto e mi chiedevo se fosse poi
cos importante restare attaccati alla propria fede e non fosse
meglio vivere da nomade tra le fedi e i saperi.
E allora, Marco, sempre pi difficile?
Troppe parole annebbiano, Paolo, questo linsegnamento
dellEcclesiaste.
Troppe parole, vero. Eppure noi ebrei ne abbiamo biso-
gno, Marco. Quando il Tempio di Gerusalemme venne di-
strutto dallempiet dei Romani non ci rest che costruire un
immenso edificio di parole e ciascuna parola un mattone, una
tegola, un cucchiaio di malta. Un Tempio immenso che pos-
siamo portare sempre con noi, nella memoria e nella speranza.
Una mattina destate decidemmo di tornare bambini e ci
avviammo al porto. Pensavamo di dimenticare Bibbie e letture
e studi ma non fu cos.
Il sole bruciava seccando il sale sulla pelle dopo il bagno.
Marco, che cosa ci divide?
Tutto e niente, Paolo, ci che le nostre gerarchie dividono
mi lascia indifferente. Piuttosto mi scervello sulla distanza tra
Abramo e Platone.
Abramo e Platone? Gerusalemme e Atene? Rivelazione e
filosofia?
s
Esatto! Fede contro lgos. Amore obbediente versus libero
pensiero.
Teologi versus filosofi, allora?
Esegsi contro sintesi! Facciamo ancora un bagno?
Nuotammo fino al calare del sole dietro le case di Otranto.
Di Paolo continuo ad avere notizie tramite i suoi dottissimi
libri. A Milano dirige un importante scriptorium e non c bi-
blioteca che abbia segreti per lui.
s
IX
Il mio primo incarico importante a Csole fu il riordino
dellarchivio. Alcuni armaria traboccavano di carte e pergame-
ne in un tremendo disordine. Relazioni, appunti, note, corri-
spondenze erano ammucchiate sulle scansie. Lordine cronolo-
gico era determinato solo dal fatto che, per secoli, i miei con-
fratelli si erano limitati a poggiare fogli e fasci di documenti gli
uni sugli altri in pile tanto alte quanto traballanti, puntellate le
une dalle altre e a ogni piccolo movimento cera il rischio di
crolli rovinosi che avrebbero mescolato fogli e senso, tempo e
parole. Tutta la storia del nostro convento era contenuta in
quelle stanze, poggiava su quelle assi di quercia.
In realt cera un archivista, ma tutti al monastero riteneva-
no che fosse malato. Demetrio era anziano, non partecipava ad
alcuna attivit comune, restando chiuso negli archivi dove
anche dormiva e consumava i frugali pasti che un famiglio gli
portava. Solo tra i confratelli pi vecchi cera qualcuno che ri-
cordava vagamente di aver sentito il suono della sua voce. Pi
duna volta avevo sentito sussurrare il nome di quella che si ri-
teneva fosse la causa del suo stato di prostrazione: bile nera.
Una forma di profonda melanconia che inchiodava
Demetrio, dallalba al tramonto, davanti a una finestra con lo
sguardo perduto sul mare. Poi si diceva che cadesse in un sonno
tanto profondo quanto agitato e che solo nel sonno pronun-
ciasse parole incomprensibili e i versi di quelle che sembravano
sconosciute apocalissi.
Cera di che essere intimiditi da quella presenza. Mi rin-
francava limpressione che quel mio preliminare aggirarmi per
larchivio non lo disturbasse, ma non dava neppure segno di
gradirlo. Di fatto non mi degnava di uno sguardo e, daltra
parte, non osavo rivolgergli la parola.
s,
Compresi rapidamente che i documenti partivano dalla
fondazione dellabbazia. Cominciai dallinizio, il naso e la
bocca coperti da bende di cotone per proteggermi dalla polve-
re che si sollevava dalle pergamene.
Intatta e ben stirata dalla pressione di una montagna di altri
documenti emerse la Donazione di Boemondo di Taranto, il
principe normanno alla generosit del quale si doveva la nasci-
ta della nostra abbazia. Nella narratio, in latino, del diploma
era scritto che Csole doveva seguire regulam beati Basilii e, ap-
presi successivamente da Demetrio quando cominci a rivol-
germi qualche parola, lo stesso Boemondo aveva voluto stabi-
lire la nostra costituzione sub certis archimandritis nostro inter-
veniente studio Grecorum more; mentre, nel testo greco, si spe-
cificava il rango autodespota del monastero.
Mi fu chiaro cos perch Boemondo e sua moglie Costanza
fossero sempre ricordati nelle nostre preghiere.
Rammento ancora: Per la morte dei servi di Dio e di eter-
na memoria Boemondo e Costanza e la loro beata memoria
Signore sii misericordioso.
Per la morte dei sempre memorabili servi di Dio, di re
Ruggiero il Grande e di re Guglielmo e della Regina Elvira e
del Duca Ruggiero, preghiamo Dio
Signore sii misericordioso.
Boemondo non aveva voluto essere da meno del cugino
Ruggiero che in Sicilia era molto popolare tra la gente di fede
greca. Oggi che con la memoria ritorno a quegli eventi capisco
il carattere politico di quella generosit. Noi greci eravamo
esposti a ogni vento: saraceni e predoni arabi scorrevano le
coste, bande longobarde e franche battevano le campagne e le-
terna discordia intestina del nostro impero rendeva tutto in-
certo tranne le sempre pi pesanti tassazioni. Nulla di strano
dunque se i nostri fratelli di Sicilia abbracciarono i normanni
come liberatori dal pesante giogo della mezzaluna. vero che i
cavalieri del nord recavano insegne papali, ma queste erano leg-
gere e fluttuanti. I nostri vescovi accettavano la giurisdizione
oc
romana che restava per distratta, incostante, perduta in altri
interessi e pi lontani giochi politici.
Le ambizioni di Boemondo erano grandi, ma lo spazio nei
dominii normanni era poco e contenderselo voleva dire intra-
prendere una guerra fratricida. Il principe guardava a oriente e
aver merito presso i greci di Otranto gli poteva tornare utile a
Costantinopoli.
Mi piaceva sfogliare quelle pagine, le pergamene irrigidite
dal tempo, la carta spugnosa che rischiava sempre di diventare
polvere a un tocco appena malaccorto. Il mio incarico era quel-
lo di rimettere ordine, non di leggere e studiare, eppure era dif-
ficile non farsi catturare dalle prime righe di una lettera, dalla
copia di una relazione inviata a Costantinopoli, da un docu-
mento che arrivava da molto, molto lontano: remoti conventi
in terra franca e germanica o dallEgitto, dalla Siria.
Pi procedevo nel lavoro e pi mi stupivo che gli scritti di
carattere propriamente religioso fossero unesigua minoranza
dellimmenso volume di materiale nel quale mi aggiravo.
Anche quando si trattavano temi di fede questi mi apparivano
sottoposti a considerazioni politiche e diplomatiche e militari.
Lo spazio maggiore era occupato da corrispondenza, da un
particolare tipo di corrispondenza che da ogni parte del
mondo era indirizzata agli igumeni. Si trattava di una specie
di rapporti, di racconti di situazioni. Vi erano descrizioni di
scenari, di citt e di paesi e di costumi civili e abitudini e di
come si esercitavano i poteri e accurate note su chi fosse po-
tente e chi no e per quali motivi. Unattenzione particolare era
dedicata alle discordie interne tra cittadini e tra maggiorenti e
tra esponenti di una stessa comunit religiosa e tra comunit
di fedi diverse. In alcuni casi si arrivava anche al pi basso pet-
tegolezzo. Pi duna volta mi sono stupito che negli archivi di
un luogo santo trovassero ricetto storie di alcova, di amori il-
leciti, di vizi inconfessabili, di perversioni immonde accanto a
notizie di ruberie e violazioni di patti, di accordi mercantili, di
intese finanziarie. Nessuna delle corrispondenze era firmata in
o:
chiaro. Poche lettere e numeri alternati chiudevano quei mes-
saggi pi o meno lunghi ma si capiva che a scrivere poteva es-
sere stato ora un mercante, ora un diplomatico, o un soldato,
un prete, un monaco. Tante calligrafie e molte tradivano, que-
sta la poca dimestichezza con la scrittura di un marinaio, quel-
la lapprossimativo vocabolario di un uomo darmi.
Moltissime erano le note vergate in calligrafia casolana che ri-
portavano relazioni fatte a voce agli igumeni. Anche per que-
ste la fonte era indicata con qualche lettera e qualche numero.
Cera poco da chiedere spiegazioni. Era chiaro che lidentit
dei corrispondenti di Csole era tenuta gelosamente nascosta
e forse solo i maggiorenti avevano la chiave per decifrare quel-
le sigle. Molto dopo avrei appreso che la consuetudine di ci-
frare le informazioni risaliva agli efori di Sparta che corrispon-
devano in codice con i generali della citt e da Svetonio avrei
imparato che Cesare criptava le proprie lettere di argomento
politico e militare. A Csole venne un giorno in cui ne fui
messo a parte si usava una variante del Quadrato di Polibio
con associazioni di lettere e numeri a coppie di coordinate che
ne identificavano la posizione. Scelta ovvia per Csole che, alla
pari del grande storico, si fidava soprattutto delle informazio-
ni dei testimoni oculari.
Una sera mi capit tra le mani un grosso fascicolo avvolto
in una larga striscia di cuoio. Mi apparve cos un ampio fron-
tespizio: Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum.
Nullaltro. Cercai anche nellultima pagina un colofone che mi
consentisse di risalire allautore. Niente. Solo lultima parola
dellultima frase terminava con una specie di svolazzo o di mac-
chia come di chi si addormentato allimprovviso sullultima
lettera. Era inquietante lanonimato di quelle centinaia di pa-
gine. Cominciai a leggere e continuai fino a quando il sonno
non mi vinse. Ancora oggi lettura e sogno si confondono nella
mia memoria e altre letture e i racconti dei miei confratelli ruo-
tano nei ricordi.
Avvenne tanto tempo fa, dopo il primo succursus che i ca-
valieri cruce signati portarono alla Terra Santa. Quando il no-
o:
stro benefattore Boemondo torn dalla prigionia dei seguaci di
Maometto. Lo accompagnava un uomo silenzioso e gentile.
Nessuno seppe mai il suo nome. Sembra che fosse originario
della Terra Franca. Il suo fisico e la sua anima erano molto pro-
vati, sul volto si leggeva una sofferenza di lunga data, come se
i suoi occhi avessero a lungo guardato cose delle quali non per
molto si pu reggere la vista. Si ferm qui a Csole e pass il
resto dei suoi giorni a scrivere. Una mattina lo trovarono morto
con il capo reclinato sulle pagine, con la penna in mano.
Ancora oggi non riesco a ricordare se Demetrio mi abbia
davvero parlato o se io non stia soltanto rammemorando il
sogno di una conversazione e lincubo delle sue parole.
Leggevo, classificavo cercando di distinguere in quel mate-
riale eterogeneo, ma avevo almeno il vantaggio che quasi nes-
sun testo era privo di data. Tuttavia il disordine era massimo.
Lettere che provenivano da Cluny si affastellavano tra docu-
menti che arrivavano da Costantinopoli, da Beirut, dal Sinai e
da mille altri luoghi. Mi imbattei in un fascio di diari di pelle-
grinaggio. Una santa mano li aveva raccolti in un solo scaffale
e ordinati almeno per data se non per provenienza. I testi in-
trecciavano racconti di viaggio tra la Francigena e la Lotaringia
e la Burdingalense, ma tutti convergevano su Otranto per lim-
barco verso la Terra Santa. Il pi antico era il manoscritto di
Nikulas di Munkatvera. Raccontava della sua partenza da
Tinghor nella lontanissima isola di Islanda nellAnno del
Signore 1154.
Su questo gravava un incartamento con la rilegatura corro-
sa dal tempo sulla quale erano ancora leggibili le insegne di un
re, Filippo Augusto. Fui vinto dalla curiosit e appresi del ri-
torno, nel 1191, di questo sovrano dalla Terra Santa, del suo
approdo a Corf e del suo sbarco apud civitatem archiepiscopa-
lem que dicitur Octrente feria 6, sexsto idus Octobris. Pi ordina-
to e meglio conservato era il diario di Matthaeus Paris. Sul
frontespizio si leggeva Iter de Londinio in Terram Sanctam. Era
stato compilato nel 1253 ed era solo un noioso elenco di tappe
per un lunghissimo itinerario. Lo scorsi velocemente fino
o+
allIntroitus Apuliae versus marchiam di Ancona. Nulla di inte-
ressante se non la descrizione di un singolare santuario sul
Monte Gargano dove una mirabile statua dellArcangelo
Michele collocata in una grotta profondissima, meta di una
moltitudine di pellegrini provenienti dalle pi remote contra-
de.
o
X
Occorrevano anni per accedere alla biblioteca e anni si im-
piegavano a percorrerla tutta. Non era solo il gran numero di
libri a richiedere una lunga fatica, ma la saggezza degli igume-
ni aveva stabilito la regola che un certo tipo di letture richie-
desse un certo grado di preparazione e di fortificazione nella
fede. Cos, mentre tutti avevano accesso alle prime grandi sale,
in minor numero si accedeva alle successive e in pochissimi alle
ultime. Vi era poi unultima sala la soglia della quale solo ligu-
meno e il suo segretario potevano varcare. Io ebbi questo privi-
legio. La diligenza con la quale avevo condotto il riordino del-
larchivio mi aveva confermato la fiducia di Filoteo ed egli mi
volle come suo segretario. Anche in questo forse seguendo
unindicazione del Bessarione. Sin dai primi giorni di lavoro in
archivio avevo notato intorno a me la discreta sorveglianza
degli anziani. Pi volte ebbi limpressione che essi origliassero
le mie conversazioni con gli altri monaci. Era evidente che si
saggiava la mia affidabilit e questa dipendeva essenzialmente
dal fatto che non facessi parola di quanto andavo apprendendo
nel mio lavoro. Non delusi la fiducia riposta in me e per quan-
to, alle volte, mi venissero rivolte maliziose interrogazioni non
caddi mai in alcuna trappola. Piuttosto sviavo la conversazio-
ne, simulavo di non aver compreso la domanda e se le richie-
ste si facevano pi pressanti e circostanziate mi stringevo nelle
spalle protestando di non aver mai visto alcun documento che
trattasse la tal questione. Fu cos che, grazie al mio incarico di
segretario, la biblioteca di Csole mi si dischiuse in tutta la sua
ricchezza.
La Prima Sala, aperta a tutti, conteneva Bibbie, i Quattro
Vangeli, una Vita Sancti Antonii, il venerabile eremita, per
os
mano di Atanasio, gli scritti di Paolo di Tebe, di Pacomio, il
Panegyricus Arseniii scritto da Teodoro Studita, la descrizione
delle opere di Giovanni di Lycopolis, i Detti di Parmenio e di
Macario lAlessandrino, glInni di Sinisio. Mentre dalla Bibbia
e dai Vangeli avevo tratto fortificazione nella fede e conoscen-
za del mondo, tutte quelle vite di venerabilissimi monaci mi
apparivano e mi appaiono tuttora un immenso lago di noia.
Ma gi nella Seconda Sala lincontro con Evagrio Pontico
cominci a stimolare la mia curiosit. Evagrio era stato nomi-
nato lettore da Basilio il Grande e diacono da Gregorio
Nazianzeno. Le sue considerazioni sulla vita attiva come prelu-
dio della contemplazione e della gnosi mi affascinavano, cos
come le opere di Giovanni Cassiano di Dobrugia sul significa-
to spirituale e morale della vita cenobitica.
stato per nella Terza Sala che ho incontrato per la prima
volta la lettura come puro piacere. Divorai tutti e dodici i libri
della Topographia Christiana di Cosma Indicopleuste. Prima di
ritirarsi in eremitaggio nel Sinai, Cosma era stato allievo di
Teodoro di Mopsuestia e dei Nestoriani di Nisibi. Aveva viag-
giato a lungo e descritto minuziosamente paesaggi, usanze e co-
stumi del mondo. I suoi disegni mi incantavano. Luniverso era
tracciato come una immensa scatola il cui coperchio il Cielo
Superiore, mentre pi in basso il Cielo Inferiore contiene il fir-
mamento. Tra i due cieli la dimora di Dio e degli Eletti che
vegliano sulla terra delluomo. Questa pi elevata a setten-
trione e a Occidente e i fiumi che da l discendono, come il
Tigri e lEufrate, sono impetuosi mentre il Nilo ha una corren-
te modesta. Quanto alle sue dimensioni, Cosma ritiene che
dallIndia allestremo dellOccidente vi siano pi o meno quat-
trocento giorni di cammino e duecento dal paese di Iperborea
alla terra degli ultimi etiopi e che comunque ogni cognizione
geografica debba essere compatibile con le Sacre Scritture e con
gli insegnamenti di Mos, Divino Cosmografo. Gi allora le
sue severe ammonizioni ai cristiani perch si attenessero ai con-
cetti astronomici e cosmologici della Bibbia, ripudiando come
falsi ed eretici gli insegnamenti di Tolomeo, mi apparvero ec-
oo
cessive. E proprio di Tolomeo la biblioteca annoverava tanto la
versione greca del Megle mathematike syntaxis quanto la ver-
sione araba Al-Majisti. Era bello perdersi tra epicicli e orbite de-
ferenti tanto che intrapresi anche la lettura del Tetrabiblo e
della Geografia ma non tralasciai lOttica con i suoi appassio-
nanti insegnamenti sulla luce e lo studio degli Armonici che mi
introdusse alla teoria dei suoni.
La mia vita era chiusa nelle sale della biblioteca e, quando
dalle finestre lo sguardo correva sul mare attraversato di tanto
in tanto da una vela, pensavo a mio padre, a mio fratello, ai
loro viaggi e una punta di desiderio per quella vita avventuro-
sa pungeva il mio cuore. Mi rifugiavo allora tra i geografi e tro-
vavo diletto e consolazione nei quarantatr libri di Strabone
sulle sue peripezie al seguito di Elio Gallo in Egitto e nei di-
ciassette libri dei suoi viaggi nei luoghi pi remoti.
Grandi scrittori di viaggio i greci, Marco, dotti quanto
basta e coraggiosi quanto necessario, ma dovresti dare unoc-
chiata anche alle opere di Messer Polo veneziano e di Ibn
Battuta di Tangeri. Con loro ti spingerai oltre le terre sotto in-
fluenza greca, romana o del popolo di Israele. Troppo spesso
noi greci raccontiamo di ci che ci circonda convinti di rac-
contare il mondo. Intanto comincia con questo!
Il consiglio mi veniva da Areta di Diso, uno dei biblioteca-
ri, che mi allung il pesante tomo del Kitab Rugiar.
Al-Idrisi ti consentir di esercitarti nella lettura dellarabo
ma soprattutto avrai idea del mondo del settentrione e delloc-
cidente, delle terre dei Franchi, degli Angli e dellAl Andaluz.
E fu cos che di lettura in lettura incontrai Marco Polo e
Abu Abd Allah ibn Battuta, di tutti i migliori. Areta mi fece
delle particolari raccomandazioni circa il fatto che delle me-
morie di Battuta, a quanto sapeva, esisteva nei monasteri greci
quellunica copia. Che grande differenza con i diari dei pelle-
grini in viaggio per la Terra Santa! Per questi il viaggio era solo
strumento di mortificazione con il fine di giungere al Sepolcro
di Cristo, di contro amavo chi, come Polo e Battuta, vedeva nel
viaggio stesso e non nella meta il fine ultimo. Non furono
o
poche le difficolt che incontrai nella lettura in lingua franca
della Descrizione del Mondo di Polo ma me la cavai con mino-
re fatica nel brillante arabo di Battuta. Il consiglio di Areta era
stato prezioso. Gli stessi Erodoto, Ctesia di Cnido, Megastene
e Scilace non reggevano al confronto, ma fu lo stesso bibliote-
cario a moderare i miei entusiasmi.
Stai attento a Messer Polo, Marco! Non sempre egli di-
stingue tra ci che vede e ci che desidera vedere e tra ci che
ha visto e quanto gli hanno raccontato i marinai ubriachi nelle
taverne. Ben pi aderente al reale Battuta, ma tra i due la dif-
ferenza totale. Polo si avventura in partibus infidelium, men-
tre il tangerino, nei suoi pur smisurati viaggi, si muove sempre
nella Dimora dellIslam.
Hai ragione, Areta, ma ci che mi attrae in questi libri
lidea che nessun luogo il centro di nulla. Se ripenso ai diari
di pellegrinaggio, da Soewulf di Worcester fino a Wilbrand di
Oldenburg o alla Johannis Wirziburgensis descriptio Terrae
Sanctae, li vedo incardinati in un Axis Mundi che ancora
quello di Ezechiele: Haec dicit Dominus Deus: ista est Jerusalem,
in medio gentium posui eam, et in circuitu eius terras
Non c dubbio! Non sempre le sante intenzioni sono utili,
anzi spesso lo sono di pi, per la causa di Cristo, le informazioni
di gente come tuo padre che le ansie di penitenza dei pellegrini.
Come sempre leggevo con voracit ma, al tempo stesso, mi
interrogavo sul perch nella biblioteca di un monastero tra
tanta teologia ci fosse un cos forte interesse mondano e mi
chiedevo che rapporto ci fosse tra gli infiniti libri di viaggio
nella biblioteca e le tante relazioni che giacevano nellarchivio.
Alcune erano chiaramente politiche e ormai posso anche citar-
ne gli autori da tempo morti: Marsilio Zorzi, bailo a Tiro di
Soria, Jacopo Badoer, ambasciatore della Signoria in
Trebisonda, Armenia e Tartaria e ancora Alvise da Mosto,
Benedetto Dandolo, Giacomo Dolfin e tanti altri. I pi erano
veneziani e genovesi ma non mancavano dalmati e natural-
mente greci, qualche fiorentino e pi dun turco.
o
Ben presto cominciai a rendermi conto che lavanzare
nelle sale di lettura avvicinava le opere al nostro tempo. Avevo
limpressione che a Csole ci fosse come lidea che pi uno-
pera era remota e tanto pi sicura ne fosse la lettura per delle
giovani menti. Infatti tanto dalle Scritture quanto da quelle
vite di anacoreti, stiliti, reclusi, nemoriti e diaconi emergeva-
no certezze, verit solide come il granito e una luce solare che
fugava ogni dubbio. Il tempo che vi si era depositato le ren-
deva inattaccabili. Per comprendere la fallacia della mia
prima impressione dovetti attendere lingresso in una delle ul-
time sale, quella dedicata alle eresie. Qui si tornava brusca-
mente indietro nel tempo. I libri che le riguardavano erano
accuratamente catalogati. Pochi volumi per gli Ebioniti, per i
seguaci di Montano, Sabellio e Paolo di Samosata, appena pi
ricchi gli scaffali riservati a Nestoriani, Monofisiti e
Monoteliti, cos come tre ripiani erano occupati da opere ma-
nichee. Impressionante era lintera parete occupata dagli
Gnostici. A sua volta essa era suddivisa in una ridda di eresie
e quanti ne erano preda si definivano Ofiti, Ofiani, Perati,
Arcontici, Severiani, Cainiti, Nicolaiti, Prodiciani, Antitatti e
per gli altri non ho pi memoria. A farmi da guida in questa
che mi appariva una pericolosa foresta fu Eustazio di
Celesiria, dotto maestro di tutte le filosofie, un uomo sottile
e arguto.
Ecco la fonte di tutte le eresie mi disse afferrando un vo-
lume dallo scaffale. con queste chiacchiere roboanti che
Simon Mago ha turlupinato le genti di Samara. Sarebbero
queste sciocchezze la Grande Rivelazione.
Perch questo era il titolo sul frontespizio del volume che
Eustazio lasci cadere sul tavolo mentre ne afferrava un altro.
Apocalisse Canonica! Buono questo! Si chiamava Cerinto,
per lui Cristo era solo una brava persona, per nulla divina e
certo non concepito virginalmente, ma dai uno sguardo anche
allAntithesis! Il suo autore, Marcione, era un noleggiatore di
cammelli, gi meglio di Teodoto il Conciatore che era convin-
to che Dio avesse solo adottato Cristo.
o,
Molte erano solo fantasiose fandonie, ma lesaltazione ope-
rata dai Cainiti dei Grandi Ribelli contro Dio: Caino, Esa,
Sodoma e soprattutto Giuda, lasciava lanimo scosso e anche i
riti magici degli adoratori del Diavolo Serpente mi fecero gran-
de impressione.
Tuttavia ci che mi turbava di pi nella lettura era la sete di
conoscenza che traspariva dalle opere e come questa fosse il
motore di una straordinaria libert dei pensieri, di un moto alle
volte frenetico dellimmaginazione.
In bella mostra sul tavolo della sala restavano, in forma di
antidoto, le opere di Ippolito, di Giustino, di Filastrio e di
Epifanio da Salamina ma, ben in vista, su tutte gravava il De
Praescriptione Haereticorum. Tertulliano, che pi di tutti mi fu
maestro. Erano i grandi critici dello gnosticismo e la loro vee-
menza nel confutarlo era pari alla loro dottrina.
Venni guidato anche nella lettura dei seguaci di Ario.
Eterosiasti ed Eustaziani, Eusebiani e Acaciani occuparono
molte delle mie giornate cos come i Concili di Nicea e
Antiochia, di Sardica e Seleucia. Certamente ero interessato
alla materia della discussione ma non potevo trattenermi dal
fantasticare su quei luoghi remoti dei quali spesso, nel corso
dellinfanzia, avevo sentito parlare da mio padre che o li aveva
direttamente praticati o aveva ben conosciuto uomini che da
quei luoghi provenivano.
Quando il potere imperiale di Roma dilag per tutto il
mondo greco, noi fuggimmo. Ma dove mai potevano fuggire
dei dotti, dei vecchi e vecchissimi letterati? Caro Marco, fug-
gimmo senza muovere un passo. Fuggimmo in unidea, in un
pensiero. Fuggimmo in una lingua.
Come sarebbe a dire in una lingua, Eustazio?
Ci che ci circondava era solo violenza e tracotanza.
Immensi poteri che si scontravano e non vi era pi confine tra
luso delle parole, delle fedi e delle armi. Restava una memoria
o, se preferisci, un sogno. Il sogno di un passato che appariva
grandioso a fronte di un presente miserabile. Il sogno, la me-
moria era lEllade, la Grande Patria Greca di una volta, ma essa
c
era fisicamente scomparsa, restavano solo le sue parole e in
quelle ci inabissammo.
Eustazio, di questa immensa biblioteca non comprendo la
straordinaria variet di volumi, a quanto so inusuale per un
monastero.
Diciamo che forse negli anni igumeni e bibliofilaci si sono
un po fatti prendere la mano, ma noi stiamo solo applicando,
probabilmente con qualche eccesso di zelo, linsegnamento del
nostro Padre Basilio il Grande. Troverai negli scaffali a lui de-
dicati un suo trattatello, Ad adolescentes. Esortazione ai giovani
sul modo di trar profitto dalle lettere elleniche. Poche pagine ma
sulle quali si fondato il rapporto tra la nostra fede e gli studi,
il loro valore in forma e sostanza. Nello stesso Nazianzeno tro-
viamo le tracce di Omero, Esiodo, Aristofane, Plutarco,
Luciano e i lirici, gli alessandrini. Tanto Basilio quanto
Gregorio avevano avuto maestri cristiani e pagani e dagli uni e
dagli altri avevano tratto rafforzamento di fede e dottrina.
Eppure noi nascemmo nella Tebaide, nel rifiuto del
mondo
Certo, Marco, da giovane sono stato in un lungo pellegri-
naggio a Gebel el Galala, dove le pietre roventi del deserto
dEgitto si specchiano nel Mar Rosso, dove Antonio, Pacomio
e Macario consumarono la loro anachoresis, la loro separazione
dal mondo in lotta contro i demoni del desiderio e dellaccidia.
Finiti gli anni del martirio nel sangue escogitarono il martirio
del nulla, del vuoto e della sua visione affollata di immagini
maligne.
Eustazio, ma forse non era questo che la fede ci chiedeva:
moltitudini di fellah perduti nei deserti. Negarsi al mondo era
negarsi alla fede che per quel mondo era stata rivelata.
Proprio cos, Marco. Separarsi dal mondo serve a diven-
tare pi forti ma questa forza va esercitata nel mondo per la
fede e, se necessario, per la sua unit quando essa minacciata
di rottura, come Basilio ci ha insegnato. Egli sconfisse i segua-
ci di Ario e molto si adoper con il Papa Damaso per lunit
della fede dOriente e dOccidente.
:
Quanto a questo il maestro di tutti noi, Bessarione, ci ha
esortato al pensiero e allazione nel mondo, ma non vedo pro-
prio che ruolo possa avere Csole nel grande tumulto che scuo-
te le chiese, i regni, gli imperi e i principati.
Non sottovalutare i nostri poteri, Marco! Csole ha forni-
to pi di un consigliere a principi e cardinali e imperatori. Il
nostro compito quello di suggerire, di indurre, di creare le
condizioni perch la causa nella quale crediamo trionfi. que-
sto il fine del nostro archivio, della nostra biblioteca.
Eustazio, ma se il fine la ricomposizione della frattura tra
le Chiese Sorelle, allora si tratta di questioni teologiche, dottri-
nali, se vogliamo, liturgiche, azzarderei filosofiche
e politiche, Marco, soprattutto politiche.
Politiche? E che centrano gli azzimi o il filioque con la po-
litica?
Nulla, infatti, ma devi sapere che la rottura tra Roma e
Bisanzio antica, antichissima e a ogni rottura seguito un
tentativo di ricomposizione e a ogni ricomposizione una nuova
rottura e mai, dico mai, rotture e ricomposizioni furono aliene
da motivazioni essenzialmente politiche. Noi siamo stati, di
volta in volta, sostenitori delle une e delle altre secondo la con-
venienza degli eventi e gli umori degli uomini. Il culmine di
una rottura si consum proprio dove tu, Marco, adesso poggi
i tuoi piedi
Sotto i miei calzari non cerano che le chianche impolvera-
te della biblioteca
Qui? In questa biblioteca?
S, in questa biblioteca. Accadde tra la met di ottobre e
la met di novembre dellanno 1231 dalla nascita di Nostro
Signore, quando Giorgio Bardane, Metropolita di Corf, si in-
contr con il francescano Bartolomeo, inviato dal papa
Germano II per una disputa sul Purgatorio. In archivio trove-
rai la relazione e i verbali stilati dallo stesso Bardane. Noi greci
avevamo idee diverse dai latini e di diverso avviso restammo
entrambi.
E fu una rottura cos importante? In fondo eravamo stati
:
noi greci, Clemente Alessandrino, Origene, a dare lavvio alla
dottrina del Purgatorio.
Gi, quei due poveri eretici! Ma il problema non era solo
dottrinario. Questo Luogo Terzo non esiste nelle Scritture, ma
per Roma non era possibile lasciare i morti al loro destino, in
un riposo o una dannazione eterna. Roma aveva bisogno di di-
videre il potere sullaldil con Dio stesso e la posta del gioco era
altissima. Se con gli eretici si poteva andare avanti col ferro e
soprattutto col fuoco, con Bisanzio occorreva la politica. Altro
che dispute teologiche!
La conversazione con Eustazio mi lasci perplesso. Nello
stesso tempo cominciavo a vedere Csole sotto unaltra luce.
Quel grande edificio che sembrava perduto tra il mare e le serre
ora mi appariva meno isolato di quanto la sua geografia voles-
se far credere. Mi ripromisi di tornare sullargomento con
Eustazio, anche se non volevo dare limpressione di essere trop-
po curioso.
Larchivio era una miniera inesauribile di informazioni.
Trovai la relazione e i verbali vergati da Bardane. Il suo scon-
tro con Bartolomeo era stato violentissimo, fitto di citazioni:
San Gregorio il Dialogo e ancora Giovanni, Matteo, Marco,
Luca.
Mi accorsi che la mia foga nella lettura aveva scosso
Demetrio.
Se il Purgatorio a incuriosirti, Marco, dai unocchiata a
questo.
Il vecchio deposit un grosso faldone di pelle sul mio tavolo.
Cominciai a scorrere quei documenti. Il primo recava la
data del 6 marzo 1254. Era una lettera del Papa Innocenzo IV
indirizzata a Eudes di Chateauroux, legato presso i greci di
Cipro:
noi, considerando che i greci affermano di non trovare
presso i loro dottori alcun nome proprio e certo per designare
il luogo della purgazione, e che daltra parte nelle tradizioni e
nelle autorit dei Santi Padri tale nome il Purgatorio, voglia-
+
mo che per lavvenire questa espressione sia accolta anche da
loro
Noi vogliamo caro Marco, Innocenzo IV anche in
punto di morte non aveva dubbi e il suo tono nei nostri con-
fronti rude e ultimativo, ma solo linizio di una battaglia.
Guarda!
Demetrio sfil dal faldone un altro malloppo di fogli:
Libellus de processione spiritus sancti et de fide trinitatis contra er-
rores Graecorum, opera di Nicola di Durazzo, vescovo di
Crotone dellanno 1262.
un volgare miscuglio di menzogne e false attribuzioni.
Sembra che il grande Tommaso dAquino, invitato da Urbano
IV a esaminarlo, abbia provato un grande malessere nel legger-
lo, tant che lanno dopo sent il bisogno di comporre questa
sorta di dichiarazione di guerra.
Fu cos che passai alcuni giorni sul Contra errores Graecorum
di Tommaso. Laquinate si era ritirato per tutta unestate a
Orvieto per stilare trentadue capitoli sulla processione dello
Spirito Santo nella Trinit, cinque sul primato del papa roma-
no e due sulla consacrazione del pane azzimo e il Purgatorio.
Mi colpiva la data, lanno 1263, di quella vera e propria di-
chiarazione di guerra dottrinale. Decisi di parlarne a Demetrio.
Se, come dice Eustazio, su tutte queste dispute c lo zam-
pino della politica, esiste un legame tra lasprezza di Tommaso
e la nostra riconquista di Costantinopoli? I tempi sembrano
coincidere
Ma bene! Benissimo! Vedo finalmente che il nostro gio-
vane archivista sta entrando nella logica di Csole. Per le peco-
re e le metane sono buoni tutti ma Csole non solo stazzo e
chiesa. S, un legame esiste. Tommaso doveva preparare le armi
teologiche per uno scontro che poteva anche essere un incon-
tro
Non capisco, Demetrio
Al tempo degli epilettici, degli ultimi Lascaris, Csole de-
cise di appoggiare un giovane nobile, Michele Paleologo.
Secondo noi era lunico in grado di riconquistare
Costantinopoli. Una nostra discreta azione diplomatica gli as-
sicur lappoggio dellaristocrazia nicena e, alla morte di
Teodoro II, riuscimmo, non senza un piccolo spargimento di
sangue, a farlo nominare reggente per il giovane Giovanni IV
Lascaris. Sarebbe bastato tendere una mano e riprendere
Costantinopoli se Roma non si fosse messa di mezzo suscitan-
do unalleanza tra Manfredi, Guglielmo di Villehardouin di
Acaya e Uros di Serbia. Manfredi ce lo vedemmo passare sotto
le finestre che si imbarcava alle Fogge per andare a conquistare
Durazzo, Valona e Butrinto. Ma il nodo era Venezia. Noi greci
non saremmo mai potuti tornare nella nostra casa sul Bosforo
fino a quando quel fantoccio di Baldovino II avesse goduto del-
lappoggio della Serenissima.
Demetrio, ma Csole a Venezia aveva solide amicizie e si
poteva mercanteggiare con la Signoria garantendole gli stessi
privilegi che aveva con Baldovino.
Ci provammo, ma fu tutto inutile. Il problema, in realt,
non era soltanto Venezia. Era dai palazzi oltre il Tevere che si
premeva su Venezia e San Marco rest sordo alla nostra diplo-
mazia. Non ci restava che puntare su Genova.
Su Genova? Ma era pericolosissimo stuzzicare Venezia con
Genova!
Gi, ma non cera altra soluzione. Laccordo tra il
Paleologo e i genovesi fu firmato a marzo dellanno di Nostro
Signore 1261 e allalba del 25 luglio Alessio Strategopulo prese
Costantinopoli quasi senza battaglia.
E i veneziani?
I veneziani sul momento abbozzarono, ma ricordati,
Marco, Venezia non ce lha perdonata e non ce la perdoner
mai. Prima o poi la Serenissima presenter a Csole il conto di
quello che considera tuttora un tradimento.
Guerre di spade e guerre di dogmi e liturgie. Una lunga se-
quenza di dispute che diventavano duelli, concilii che diventa-
vano battaglie campali.
Dovevo leggere, studiare. Capire. Le conversazioni con
Eustazio e Demetrio mi lasciavano intravedere quali erano i
s
terreni ai quali la benevolenza del Bessarione mi aveva destina-
to. Mi ritorn in mente lironia di mio padre quando per la
prima volta gli avevo chiesto di portarmi a Csole: ecch, mo-
naco ti vuoi fare? Ma questo apprendistato aveva ben poco a che
fare con la vita monacale e, daltra parte, mio padre doveva sa-
pere bene, per esserne in qualche modo parte, che idea della
vita monacale si avesse a Csole. Continuai nella lettura di una
miriade di relazioni. Costantinopoli era stata ridotta un leta-
maio dai latini. Chiese spogliate, arredi e reliquie venduti, il pa-
lazzo delle Blachernae devastato. Doveva essere il rapporto di
un mercante quello che offriva questo desolante quadro. In un
greco molto approssimativo lessi dellinsediamento di Michele
VIII, del suo ingresso in citt, accolto da una folla festante che
recava limmagine della Hodegetria. Il Paleologo con la moglie
Teodora erano stati incoronati in Santa Sofia che tornava cos
alla fede ortodossa
o
XI
Era linizio dellinverno del 1479. Alcune galee bastarde
della Muda di Beirut si fermarono a Otranto sulla via del ri-
torno a Venezia. Giosafat Barbaro, patrizio veneziano e vec-
chio amico di Csole, pot salire al monastero giusto il tempo
perch le navi facessero provviste di acqua e frutta fresca.
Giosafat era uno dei nostri migliori informatori. Oggi non
giurerei che la sua fedelt alla causa cristiana fosse maggiore
della fedelt per la Serenissima e soprattutto per i suoi perso-
nali affari ma, per noi, Barbaro era sempre stato una fonte pre-
ziosa di notizie. Fu cos che con un anno e mezzo di anticipo
sapemmo che la Sublime Porta meditava di aggredire la Terra
dOtranto. Venni chiamato dagli anziani a verbalizzare il rac-
conto del veneziano e per questo ho lucida memoria di quan-
to disse. Venezia stava concludendo un trattato di pace con
Maometto II. La Serenissima avrebbe ceduto al Sultano
Scutari e il suo territorio, la fortezza di Kruja che tanto aveva
resistito ai turchi con Skanderbeg, lisola di Lemno,
Negroponte e il Braccio della Maina. Entro la primavera la
Signoria doveva restituire quello che aveva impiegato sedici
anni a conquistare. Maometto II si impegnava a riconsegnare
a Venezia i territori costieri della Dalmazia e di una esigua
parte dellAlbania. Barbaro parl ancora di trattative econo-
miche per i crediti che il Sultano vantava per forniture di al-
lume e degli accordi che lambasciatore Giovanni Dario stava
prendendo per ottenere esenzioni sulle importazioni e le
esportazioni tra Venezia e la Porta. Dario e il plenipotenziario
ottomano Lufti Beg, secondo le informazioni di Barbaro,
erano gi a Venezia con ricchi doni per il doge Giovanni
Mocenigo e per la firma definitiva era questione di giorni.
Insomma Venezia, in cambio della rinuncia a Scutari,
avrebbe avuto mano libera su Cipro e con poca spesa poteva
comprare dai Turchi la piena agibilit commerciale in tutto il
Mediterraneo Orientale, in barba ai fiorentini che erano arri-
vati fino a Istanbul per tramare contro la Serenissima.
Barbaro raccont che Maometto II aveva ricevuto da
Firenze un dettagliatissimo rapporto sul fallito tentativo dei
Pazzi di rovesciare Lorenzo de Medici e sulle feroci vendette
che ne erano seguite. Poi la scomunica al Medici e linterdetto
del Papa alla citt erano la conferma dei violenti dissidi che la-
ceravano lItalia.
Le contese e la debolezza dei principati in lotta stuzzicava-
no gli appetiti del Sultano. Le stesse difficolt nelle quali si di-
battevano gli Aragona di Napoli spingevano gli strateghi del
Corno dOro a sognare le mezzelune garrire sul Golfo e persi-
no nella citt dei Papi.
Giosafat Barbaro aveva allora sessantasei anni. Da oltre qua-
ranta viaggiava. Conosceva le terre tra il Volga e il Don, la
Tauride, la Ciscaucasia, la Moscovia. Era stato Rettore a
Scutari, Console alla Tana, Ambasciatore presso lo Sci di
Persia Hussun Hassan. Le sue informazioni erano precise, egli
non era un marinaio che raccoglie le chiacchiere del porto e del
bazar.
Nella capitale dellImpero era ben chiaro che la lunga quan-
to inconcludente guerriglia che impegnava il Regno dAragona
e Sisto IV contro il Medici sguarniva non tanto militarmente
quanto dattenzione politica lItalia centrale e meridionale. I
generali di Maometto II conoscevano perfettamente linconsi-
stenza militare delle bande mercenarie con le quali i principati
italiani guerreggiavano tra loro e gli antagonismi, le gelosie, le
invidie che dividevano stati e staterelli rissosi e infedeli nelle al-
leanze. Piegare militarmente lItalia sarebbe stato facile. Solo
una preoccupazione frenava lImperatore: che il boccone fosse
troppo grosso e che facesse gola a ben altre potenze europee.
Luigi XI si era annesso lArtois, la Franca Contea e, con la
morte del suo avversario di sempre, Carlo il Temerario, signo-
re di Borgogna, stava per mettere le mani sullAngi, sul Maine
e la Provenza. Cera da credere che il Ragno avrebbe potuto
volgere i propri appetiti verso lItalia. Barbaro raccontava che
nei palazzi sul Bosforo si seguiva con attenzione il lavorio di-
plomatico di casa dEste per raccogliere alleati intorno a Ferrara
e muovere guerra a Venezia.
Gli strateghi di corte vedevano solo Milano come antagoni-
sta politico e militare ma lambizione, al momento, non era
quella di piantare le bandiere delle sure sulle Alpi, quanto tro-
vare un raccordo con gli Sforza per dividersi lItalia a spese degli
Aragona, del Papa e di Venezia. Gli emissari di Istanbul aveva-
no gi preso cauti contatti con il Moro in esilio e mercanteg-
giavano un appoggio diplomatico della Sublime Porta per un
suo rientro a Milano. Ludovico Sforza ben sapeva che anche
laiuto degli infedeli gli sarebbe stato utile per avere ragione del
giovane e riottoso nipote Gian Galeazzo.
Siate pronti al vento che cambia ci mise in guardia
Barbaro. La pace sar firmata e tutto sar scritto in un tratta-
to, ma del patto fanno parte anche gli sguardi e le parole so-
spese, quelle che cadono nella conversazione e sembrano gal-
leggiare nellaria. La Terra dOtranto, si dice a Istanbul, fece
parte dellImpero di Bisanzio e ci che fu di Bisanzio ora della
casa di Osman e pi duna volta a queste affermazioni sembra
che il Dario abbia sorriso distogliendo lo sguardo. Negli am-
bienti della Porta si sussurra che il nuovo bailo, Battista Gritti,
stia per giungere a Istanbul proprio con un messaggio di que-
sta natura. Attenti allodio di Venezia per la casa dAragona!
Le informazioni del patrizio misero in agitazione
lIgumeno. Fu subito convocato il consiglio ristretto dei mona-
ci anziani. A quellepoca avevo solo ventisei anni e mai avrei
pensato di poter accedere a quello che mi appariva come cena-
colo di sapienza e vaso di ogni saggezza.
Con mia grande sorpresa invece venni chiamato non solo
per il mio ruolo di segretario dellIgumeno ma perch si riten-
ne che la mia opera di verbalizzatore delle parole di Barbaro,
unita allesperienza di traduttore dalle lingue araba e turca, po-
,
tesse essere utile. Io traducevo tutti i firmani imperiali che si
trovava il modo di far recapitare a Csole, per cui avevo dime-
stichezza linguistica con le logiche della corte ottomana e forse
avrei potuto essere daiuto.
Ma non fui di nessun aiuto.
Le riunioni durarono parecchi giorni. Le voci, inizialmente
concitate, lentamente si infiacchirono. Chi sosteneva lurgenza
di correre a Roma per unambasceria al Papa si stanc di con-
trastare chi parteggiava per una missione segreta a Istanbul e
questultimo di dimostrare linutilit della tesi di fare vela per
Venezia a chiedere aiuto al doge. Ci fu anche chi propose che
fosse lIgumeno stesso a recarsi a Napoli e Roma per convincere
che il pericolo non era Lorenzo de Medici quanto la flotta turca.
Io tacevo. Cosaltro avrei potuto fare? Lagitazione dei mo-
naci non mi contagiava, anzi il pericolo di uninvasione otto-
mana mi sembrava quasi un diversivo alla monotonia.
Conoscevo alla perfezione il diritto islamico e sapevo quindi
con certezza che n la vita n la fede sarebbero state in perico-
lo sotto Maometto II. Noi appartenevamo allAhl al-Kitab, era-
vamo Gente del Libro e sotto le bandiere dellIslam avevamo il
diritto a diventare Dhimmi, protetti dai nemici e liberi di pro-
fessare la nostra fede. In cambio avremmo dovuto pagare la
jizya, la tassa di capitazione imposta ai non musulmani.
Avremmo dovuto solo mettere la mano alla borsa e chinare il
capo come recita il versetto del Corano che prescrive di pagare
la tassa di propria mano ed essendo umiliati.
Questa era la Sahifa, la legge del Profeta, applicata in tutto
il Mashreq. Otranto, secondo la legge ottomana, avrebbe fatto
parte di una millet, della nostra comunit religiosa ma sotto-
messi alla Porta.
Csole poteva pagare la sua libert. La nostra rendita an-
nuale era di 600 fiorini doro. Eravamo il pi ricco monastero
dellItalia meridionale. Possedevamo uliveti e vigneti e terre sa-
tive e pascoli per 3.000 tomoli, saline a Badisco e diritti di fo-
restaggio su immense terre demaniali. Erano di nostra proprie-
c
t le grance e i casali di San Giovanni Melcantone, Santa Maria
di Badisco, Santa Maria del Torlazzo e SantAngelo dei Greci
nella Diocesi di Monopoli. Tutto secondo la legge della
Sublime Porta sarebbe rimasto nostro.
Io stesso avevo studiato nellarchivio il Firmano del 1454
con il quale Maometto II, dopo la conquista di Costantinopoli,
aveva nominato Patriarca Georgios Scholarios Gennadios inve-
stendolo di ogni giurisdizione sul nostro popolo, sulla nostra
chiesa con tutte le sue propriet, sulle nostre scuole e i nostri
tribunali. Sapevo che uno dei primi atti di governo di
Maometto II era stato quello di rassicurare le nostre comunit
dellAthos. Queste, dopo la conquista di Tessalonica, avevano
riconosciuto la sovranit ottomana e il Conquistatore non
avrebbe interferito nella loro autonomia.
Per la nostra abbazia si sarebbe trattato solo di un problema
di tassazione facilmente superabile, pi duro sarebbe stato per
i mercanti e i nobili che non avessero abbracciato lIslam, ma
di questi non avevo alcuna stima, quindi pagassero pure e per-
dessero cariche e prebende o si facessero musulmani. Non ca-
pivo lagitazione dei miei fratelli. Non correvamo pericolo al-
cuno e comunque Csole non aveva flotta n cavalleria. Non
avevo nessuna esperienza politica ma, sin dalla lettura di
Cesare, di Cicerone, di Livio, avevo capito che non si ha forza
diplomatica senza forza militare. In passato Csole aveva con-
tato molto, ma la sua forza politica e diplomatica era stata frut-
to della pur perennemente vacillante potenza di Bisanzio. I
miei fratelli discutevano come in un sogno, avvinti da un ri-
cordo che faceva apparire loro urgente e necessario assumere
decisioni a ben vedere di assoluta ineffettuabilit.
Avrei potuto, forse dovuto, parlare, mettere in guardia, sug-
gerire, almeno sussurrare qualche parola che rompesse il sorti-
legio di una memoria collettiva che restava vita comune e sulla
base della quale si abbozzavano ipotesi diplomatiche e finanche
militari che a me apparivano destituite dogni fondamento.
Eravamo impotenti. Non restava che prenderne atto.
Avrei dovuto, forse potuto, indurre Csole al silenzio, a si-
:
mulare indifferenza, ad attendere passivamente la sorte. La no-
stra agitazione sarebbe fatalmente giunta allorecchio della
Sublime Porta che, al pari e pi di noi, aveva spie ovunque.
Certo a Otranto, probabilmente al monastero. Nel Serraglio
imperiale Csole non era amata. La nostra sapienza suscitava
ammirazione ma anche invidia; rispetto e sospetto. La diffi-
denza dellImperatore, poi, era notissima. Mi sfior persino il
timore che tutta quella mobilitazione, peraltro innocua, di voci
alterate avrebbe potuto attirare sullabbazia i fulmini della ven-
detta ottomana. Ma fu un attimo e non ci pensai pi.
Per la verit avevo qualche idea di quale potesse essere una
via da percorrere per avere un piccolo ruolo in tutta la vicenda.
Una via che aveva la sinuosit della mediazione politica.
Sapevo bene quanto grande era lascendente ebraico sul
Gran Turco. Il suo medico personale, Jacopo da Gaeta, era un
ebreo e svolgeva delicatissimi compiti nellamministrazione
delle finanze dellImpero. Egli era stato medico personale del
padre del Conquistatore e addirittura circolavano voci di un
patto scellerato tra il giovane Maometto e Jacopo che avrebbe
condotto il suo primo padrone, Murad II, alla morte per spia-
nare la strada allirruente figlio. Le ricompense per lebreo sa-
rebbero state potenza e ricchezza, ma soprattutto un ruolo pre-
minente nella corte. Jacopo da Gaeta infatti non solo aveva la
totale fiducia del Sultano perch lo aveva curato dalla gotta,
malattia ereditaria di casa Osman, ma si occupava anche di de-
licatissime questioni di governo. La Schola Talmudica otranti-
na era tra le pi famose. Certo Jacopo ne conosceva lautore-
volezza pur se non ne riconosceva probabilmente lautorit.
Perch dunque non rendere partecipi i rabbi delle nostre infor-
mazioni e tentare unazione congiunta che certo non avrebbe
fatto recedere Maometto II dai suoi disegni, ma avrebbe potu-
to guadagnare a Csole, e magari a Otranto, non solo una mag-
giore sicurezza ma anche un ruolo allaltezza della sua sapienza
nel mediare laccesso turco alla penisola? Ricordo bene che
Barbaro aveva persino accennato alla presenza di un orator
Judeo, tal Simone, nelle trattative con la Signoria.
:
Unaltra via aveva limpervia durezza dello scontro diretto.
La pace tra Venezia e la Porta scopriva il fianco a Mattia
Corvino. Solo il sovrano ungherese aveva un diretto interesse a
contenere il Gran Turco. Solo lui aveva le milizie sufficienti
perch almeno ci fosse battaglia. Solo Corvino avrebbe com-
battuto per il proprio personale interesse ma anche per la fede
cristiana. E comunque aveva sposato una principessa
dAragona. Certo il sovrano era al corrente che il trattato era
alle firme del Doge e del Sultano. Forse correre a Buda poteva
avere un senso per spingere il re a chiamare a raccolta principi
e sovrani e smuovere il papa.
Ma furono solo pensieri fugaci che rimasero chiusi nella mia
mente. Non avevo lautorit e il prestigio per poter avanzare la
pi modesta delle ipotesi.
In quei giorni avevo un solo desiderio: vedere come sarebbe
andata a finire tutta quella storia.
+
XII
La decisione ultima scatur pi dallinconsapevolezza della
nostra fragilit che dalla fertile mente del nostro fratello Milizio
che la illustr: inutile puntare sullAragona, pi attento alle ir-
requietezze dei baroni che al Turco, inutile puntare sul Papa,
che comunque aveva in sospetto la nostra ortodossia. Dunque
bisognava convincere il Medici, unica mente politica lucida, a
chiudere rapidamente con Napoli una pace separata. Il Papa,
isolato, avrebbe accettato lo status quo, Lorenzo avrebbe avuto
mano libera per piegare i fiorentini riottosi alla sua primazia e
Ferrante sarebbe rimasto libero di vigilare sui confini del suo
regno e quindi di difendere questa remota provincia del regno
dalla minaccia ottomana. Restava da chiedersi che rapporti in-
tercorressero tra il signore di Firenze e la Sublime Porta. Dalle
poche notizie che avevo mi ero fatto lidea che Lorenzo doves-
se intendersela con il Sultano pi di quanto fosse lecito per un
cristiano, ma anche questo poteva tornare utile.
Milizio era troppo vecchio per intraprendere il faticoso iti-
nerario alla volta di Firenze e la scelta cadde su di me. Non
avevo alcuna esperienza ma ero abbastanza giovane da poter af-
frontare ogni difficolt e sarei stato istruito a dovere per porta-
re a termine lambasceria.
Lordine impartitomi mescolava nel mio animo il timore e
il desiderio. E il primo svan rapidamente nelleccitazione dei
preparativi per il viaggio.
Non avevo molto tempo. Un veliero veloce mi avrebbe por-
tato fino ad Ancona e da l avrei raggiunto Firenze. Venne sti-
lato un pro memoria che dovevo recapitare a Lorenzo de
Medici. Fui io stesso a scrivere quanto mi veniva dettato dai
confratelli anziani sotto la direzione di Milizio.
Partii in una notte di scirocco e mentre limbarcazione pic-
cola e veloce volava al gran lasco non mi riusciva di dormire.
Sulla sinistra indovinavo le pinete dietro le spiagge e il porto
di Adriano. Qui e l un fuoco segnalava un approdo. Come mi
sembrava lontana da tutto Otranto! Roma affacciata su un
altro mare, Costantinopoli oltre lo Jonio, lEgeo e gli Stretti
Anche Venezia mi appariva lontana. Firenze poi lontanissima
in questo viaggio mezzo per mare, mezzo per terra. Mi perva-
deva lansia di praticare quella lontananza. Ero giovane e per la
prima volta con un po di denaro e un saio quasi nuovo mi fi-
guravo come una specie di ambasciatore di Csole. In realt il
mio ruolo era poco pi che quello di un corriere.
Ero ansioso di percorrere la distanza, qualsiasi distanza, cos
mi voltai di scatto per vedere ancora qualche lume di Otranto
ma a poppa cera solo il buio della notte. Mi sembr un triste
presagio e nelleccitazione del viaggio provai una fitta leggera,
un dolore tenue, quasi un desiderio di tornare indietro a
Otranto e ancora indietro nel tempo, alla casa di San Pietro, al-
linfanzia, allodore del petto di mia madre. Mi torn forte il
pensiero di Alberada, lunica donna della mia vita, e di quella
figlia con lo stesso nome che chiss dovera, perduta nel fitto
dei boschi, allevata da chiss chi. E se tutto fosse stato solo un
sogno?
Non potevo immaginare che quel viaggio sarebbe stato il
primo di una serie infinita di peregrinazioni che si sarebbero
concluse qui, a Venezia, in questa citt tanto diversa dalla mia
Otranto eppure affacciata sullo stesso mare.
Lequipaggio era composto tutto di otrantini e tutti cono-
scevo perch avevano navigato con mio padre e mio fratello.
Viaggiammo sicuri e rapidi senza uno scalo fino ad Ancona.
Mastro Pantaleo, il comandante, grande amico di mio padre,
mi indic una costa montuosa e cos appresi dellesistenza di
un monte di nome Cnero. Pantaleo aveva capito al volo lo
sgomento che screziava il mio entusiasmo per quel viaggio e, in
pi di unoccasione, con un sorriso o una battuta affettuosa, fu-
gava lansia che mi assaliva. Conoscevo qualcosa della sua sin-
s
golare vita. Al mare si era dato non pi giovane dopo anni nei
quali aveva insegnato le matematiche e poi aveva fatto altri me-
stieri. Al mare si diceva fosse stato spinto da strani malesseri che
lo coglievano sulla terraferma e che solo a bordo di qualche
mezzo in navigazione si dissipavano.
Pantaleo era lunico dei capitani di mare di Otranto a viag-
giare sempre con la compagna della sua vita, donnAngela, che
non era delle nostre parti. Bionda di capelli e azzurra di occhi
sembrava pi una normanna e chiss in quali viaggi i due si
erano conosciuti. Dopo anni nel monastero con rari ritorni a
casa avevo quasi dimenticato che cosa fosse la cucina di una fa-
miglia. DonnAngela in quei pochi giorni di navigazione non
solo mi riport ai sapori della tavola di mia madre ma da lei co-
minciai a capire che esistevano altri sapori, di altre terre, dove
tutto cresceva sotto un altro sole e non cera pesce che tra le sue
mani non diventasse prelibatissimo per spezie esotiche e ricet-
te raccolte negli approdi di mezzo mondo.
Separarsi da mastro Pantaleo e donnAngela fu doloroso. La
dolcezza e la serenit di quella coppia che condivideva una vita
tanto avventurosa e, alle volte, disagevole, avevano attraversato il
mio cuore. Ci abbracciammo ripromettendoci fedelt damicizia.
Un giovane marinaio, Pietro di Noha, sarebbe rimasto con
me per accompagnarmi nel resto del viaggio. Pi pratico di me,
acquist cavalli e provviste. Attraversavamo boschi e villaggi,
montagne e citt fino a un susseguirsi di dolci colline. Oltre un
culmine coperto di ulivi, con mia grande sorpresa, si stendeva
una citt grande, irta di torri e campanili e le strade che vi con-
ducevano erano affollate di viandanti e di carri. Ero arrivato a
Firenze. Quanti libri che avevo letto e copiato venivano di l,
quanti sapienti e scrittori che amavo erano vissuti in quella
citt. Non potevo presentarmi direttamente a Lorenzo, dovevo
raggiungere un certo monastero e consegnare una lettera di ac-
credito. Avrebbero provveduto i confratelli fiorentini a farmi
ottenere udienza dal capo della casata dei Medici.
o
Siate il benvenuto, Marco, i nostri amici greci dicono ogni
bene di voi. Sembra che siano molte le lingue che per voi non
hanno segreti e che i vostri studi abbiano spaziato dallebraico
allarabo al persiano. Firenze una casa sempre aperta per gli
amanti delle buone letture e della amabile conversazione. Ho
sentito dire grandi cose della vostra abbazia, mi si dice che ospi-
ti una straordinaria biblioteca. Quanto alla casa de Medici essa
sempre stata aperta ai dotti greci. La mia famiglia ha accolto
Costantino Lascaris, Demetrio Chalkokandyles, Teodoro
Spandugnino, Paolo Tharchaniotis, ma Firenze stata genero-
sa con Paleologi, Cantacuzeni e Comneni.
Laccoglienza del signore di Firenze era gentile, affettuosa
addirittura, ma egli non faceva cenno alcuno ai motivi per i
quali io ero giunto fin l.
Qualche giorno prima avevo mandato Pietro a portare la ri-
chiesta di udienza e a consegnare lambasceria ma non capivo
neppure se Lorenzo lavesse letta, o almeno fatta leggere a qual-
che suo segretario.
Il mio primo incontro con lui avvenne nel cortile del suo
palazzo. Mi avrebbe ricordato il chiostro di Csole per il porti-
co quadrato con tre arcate su ogni lato se non fosse stato per il
ricco fregio, adorno di medaglioni in stile antico, che le sovra-
stava, dividendole dal piano superiore. Poi, a differenza di
Csole, si levava un fitto brusio per le tante persone presenti,
riccamente abbigliate, in attesa di essere ricevute dal Signore
che, al centro di un crocchio di fedelissimi, passeggiava rivol-
gendo la parola ora a uno ora allaltro.
Venivo coinvolto in un vortice di conversazioni che non la-
sciavano spazio alle mie preoccupazioni. I giorni passavano e
non vi era appiglio nei discorsi di Lorenzo perch potessi en-
trare nellargomento che mi stava a cuore. Non osavo prende-
re liniziativa perch ben conoscevo la delicatezza della questio-
ne. Il signore di Firenze intanto amava esibirmi nei convivi e in
pi di unoccasione lasci scivolare degli accenni al fatto che
egli sapeva essere ben generoso con gli studiosi disposti a tra-
sferirsi alla sua corte.
Lansia mi bruciava. Non ero l per fare sfoggio della mia
cultura. Avevo un incarico preciso e dovevo portarlo a termine.
Non posso comunque negare che lapprezzamento di Lorenzo
mi lusingava. La presenza discreta di Pietro mi riportava a
Otranto. La sera, quando mi ritiravo nella casa che la
Compagnia de Medici aveva messo a nostra disposizione, il
suo sguardo interrogativo cercava i miei occhi.
Ancora nulla, Pietro, il signore di Firenze non fa cenno
alla nostra ambasceria. Ho chiesto consiglio a un suo amico,
Marsilio Ficino, che mi tratta con grande familiarit ed egli mi
ha raccomandato di non sollecitare Lorenzo ma di attendere
che sia lui a introdurre il discorso.
Caro Marco, trattenetevi ancora un po, la serata tiepi-
da
Anchio, divenuto ormai un frequentatore abituale degli
Orti, sapevo che al tramonto Lorenzo amava essere lasciato
solo per qualche ora prima della cena. Stavo quindi per pren-
dere congedo quando egli mi ferm. Era primavera inoltrata e
ormai linquietudine che provavo per la mia incompiuta mis-
sione si era stemperata nella piacevolezza di quella vita agiata.
Restammo soli.
Caro Marco, ho abusato della vostra pazienza. Purtroppo
era necessario attendere una ambasceria senza la quale ogni col-
loquio con voi sarebbe stato vano. Ora che la notizia mi giun-
ta possiamo parlare di quanto vi preme. Sappiate che apprezzo
il vostro suggerimento di una rapida pace con lAragona ma
sappiate, al tempo stesso, che non alzer un dito perch la
Porta risparmi dal suo attacco le vostre terre. Devo molto a
Maometto II. Egli ha imprigionato quel cane di Bernardo
Bandini, della famiglia dei Baroncelli, lassassino di mio fratel-
lo Giuliano. Era sfuggito alla caccia dei miei uomini e il re di
Napoli si reso complice della sua fuga offrendogli una galeaz-
za che lo portasse a Istanbul. Sisto IV, in combutta con i Pazzi,
arm la sua mano perch sterminasse la mia famiglia e io stes-
so scampai per caso alla morte. LImperatore mi ha reso un
grande servizio e ho motivo di credere che quel ribaldo mi
verr consegnato perch io possa farlo pendere dalle finestre del
Bargello. Da tempo avevo in animo di chiudere queste ridico-
le scaramucce con il Papa e la casa dAragona. Gi il mio amico
e banchiere, Filippo Strozzi, si sta adoperando perch si giunga
a un accordo. Alla corte di Napoli non sono in pochi ad avere
debiti con Filippo e si dice che lo stesso Ferrante abbia dovuto
ricorrere a casa Strozzi per qualche suo problema finanziario.
Insomma siamo sulla strada giusta per giungere a una pace con
lAragona e quindi col Papa, ma non pensate che questi possa-
no in alcun caso soccorrere Otranto. Quanto fu di Bisanzio
del Gran Turco. Ferrante lo sa; come lo sa e lo vuole Venezia.
Quanto al Papa, poi, non pi tempo di imprese nel segno
della croce.
Sebbene ignorassi la circostanza della fuga del Bandini a
Istanbul, la risposta di Lorenzo non mi stup affatto.
Quelluomo era palesemente incline pi alla guerriglia che alla
guerra. La sua politica si fondava su quel tanto di spada che so-
stenesse la sua lingua sciolta e la sua mente labirintica. Non
cera niente di epico nella sua fantasia e per pensare di sbarrare
le porte dItalia a Maometto II ci voleva un bello spirito epico.
Ma Lorenzo era un politico, il suo spirito era concentrato sul
mantenimento del potere grazie a delicati equilibri diplomati-
ci in territorio italiano.
Mio caro Marco, questa vecchia Italia divisa e rissosa non
pu nulla contro la Porta. Siamo pi abili con il pugnale che
con la spada e per fermare Maometto II ci vogliono molte,
moltissime spade. Noi ne abbiamo tante quante bastano alle
nostre guerricciole. Poi si pu dire che non vi sia potentato ita-
liano che non abbia cercato e non cerchi il favore del
Conquistatore. Io stesso lo cerco per i miei disegni e cos, co-
stretta, lo blandisce Venezia, lo blandiscono Napoli e Milano e
le Signorie di Rimini e Ancona. Tutti inviamo ambasciatori e
dignitari alla Porta e tutti siamo l per denigrarci lun laltro e
,
far s che il Sultano sospetti ora di questo ora di quel potente.
Quanto al Papa, chi pu dire che il suo odio verso la vostra
chiesa non sia superiore a quello verso il Turco? Forse solo
Mattia Corvino pu avere lambizione di fermare il dilagare
della casa di Osman.
Mi gratificava laccenno di Lorenzo a Mattia Corvino. Il
fatto che anchegli lo considerasse lunico vero antagonista del
Gran Turco mi riempiva dorgoglio. Pur dal mio remoto osser-
vatorio otrantino avevo visto giusto. Mi permisi di dirglielo ed
egli mi fiss stringendo le palpebre senza aggiungere altro.
La mia missione a Firenze era conclusa. Seppi che Antonio
de Medici si preparava a partire per il Corno dOro con ricchi
doni per il Sultano e un messaggio di Lorenzo al glorioso prin-
cipe che sempre dimostrava ai fiorentini il suo amore e immen-
so favore.
Il Bandini sarebbe stato consegnato a Firenze perch la ven-
detta si compisse.
Non mi restava che tornare a Otranto e a questo mi accin-
gevo anche se a malincuore. La vita di corte cos diversa da
quella che trascorrevo a Csole mi attirava, ma il mio compito
era ormai esaurito. Stavo per recarmi a prendere congedo da
Lorenzo e da quelli della sua corte che ormai consideravo come
amici, quando un famiglio di casa de Medici mi anticip con
una convocazione urgente di sua Signoria.
Venni introdotto, con mio stupore, nello studio privato di
Lorenzo. Era inusuale il luogo e il fatto che fossimo soli.
Allora Marco, pu il signore di Firenze chiedere allillustre
abbazia di Csole i servigi di uno dei suoi uomini migliori?
Ero confuso e soprattutto non sapevo cosa rispondere.
Nessuna preoccupazione, Marco, un mio messaggero
gi in viaggio per Otranto. La lettera ben congegnata. Chiedo
tempo per riflettere e ragionare con altri Principi dei vostri sug-
gerimenti. Intanto avverto i vostri superiori che rimarrete a di-
sposizione della Signoria. pi che probabile che la Porta gi
sappia della vostra iniziativa e cos sar del contenuto della mia
,c
missiva. Maometto II va blandito ma anche tenuto sulla corda
dal sospetto che una coalizione contro di lui sia sempre possi-
bile, altrimenti il nostro ruolo si deprezzerebbe ai suoi occhi.
Stupida politica, Marco, ma necessaria. Avrete un compito
quindi. Partirete subito con un mio messaggio per Mattia
Corvino. Questo potrebbe accentuare le preoccupazioni del
Conquistatore su quel fronte. Certo non lo distoglier dalle sue
mire italiane ma guadagneremo tempo. Ho saputo che la sua
salute malferma.
Cera poco di che riflettere. Lorenzo aveva gi scritto una
parte della mia vita. Gli eventi, lontano da Csole, erano pi
potenti di ogni mia volont. Se la mia libert nella biblioteca
dellabbazia si manifestava nella scelta di questo o quel volume,
nel gioco della vita forze impari mi muovevano come una pic-
cola pedina.
Come sempre un grano di nostalgia per Otranto, su un
piatto di bilancia del mio cuore, si equiparava al grano di desi-
derio davventura sullaltro.
Marco, dopo la missione da Corvino sarete libero natu-
ralmente di tornare a Otranto, ma voglio sappiate che la casa
dei Medici sempre aperta per voi.
Stavo per prendere congedo ma Lorenzo stavolta aveva an-
cora qualcosa da aggiungere.
C una famiglia de Marco di Otranto tra i clienti della fi-
liale di Roma della nostra Compagnia. So che si tratta di vostro
padre. Ho incaricato Giovanni Tornabuoni di avere la massima
cura delle vostre sostanze.
Nulla sapevo degli affari di famiglia, ma appresi quindi che
pi dun filo mi legava a quelluomo scaltro e pieno di fascino.
Fu cos che mi ritrovai sulla strada per Ancona. Nel porto ci
attendeva la nave di un mercante fiorentino socio daffari della
Compagnia de Medici che fece rotta verso Zara. Entravamo
nel cuore del Golfo di Venezia. Nella mia sacca da viaggio, oltre
la lettera di Lorenzo per Mattia Corvino, conservavo gli accre-
diti che la Compagnia mi aveva fornito. Tutte le tappe del viag-
gio erano gi stabilite e in ogni citt avremmo avuto ospitalit
,:
e aiuto. A Zara il Priore di Santa Anastasia ci attendeva. Durad
Boric mi accolse come un vecchio amico.
Fu un incontro fugace ma ricordo la passeggiata che facem-
mo lungo la Calla Larga.
La sua parlata era leggermente diversa dalla lingua che avevo
appreso da mia madre ma ci intendevamo alla perfezione.
Scoprivo cos una cosa che mi avrebbe accompagnato durante
tutto il viaggio: avevo le parole anche per la terra oltre
lAdriatico.
Messer Marco, passerete la notte nella canonica di San
Simeone e domattina vi attenderanno una guida e cavalli,
provviste e la mappa del vostro itinerario. Prenderete la strada
per i laghi di Plitvice e da l per Slunj. Verrete accolti nelle ca-
noniche di alcune chiese che troverete indicate. Accoglienza
povera, ma vi rifarete a Dubovac, nel castello dei Francopani e
a Zagabria. A Dolac, nella Piazza del Mercato vi attende ma-
stro Jozo, un banchiere nostro amico. Vi dar tutte le istruzio-
ni per proseguire. Dalle notizie che abbiamo la strada fino a
Zagabria sicura. Oltre la Sava dovrete guardarvi dalle scorre-
rie turche.
Quella notte non mi riusciva di dormire. Passeggiavo per la
chiesa, intorno allarca dargento che conserva le spoglie di San
Simeone e mi figuravo il viaggio oltre le montagne e i fiumi che
dovevo attraversare. Cercai allora di pregare e mi inginocchiai
davanti a un bassorilievo della Madonna con il Bambino. Al
mattino Pietro mi trov assopito ai piedi di quella immagine
sacra in fondo alla navata sinistra della chiesa.
Voltammo le spalle al mare e non molto dopo la nostra stra-
da cominci a salire. Per lunghi tratti dovevamo smontare per
non affaticare troppo i cavalli. Matija, la nostra guida, era di
poche parole. Il suo passo era sempre lo stesso, a piedi o a ca-
vallo non cambiava. Procedeva lento e non voleva mai fermar-
si. Neppure il meraviglioso spettacolo dei laghi di Plitvice sem-
br commuoverlo. La notte, ovunque si dormisse, si stendeva
accanto a me, avvolto nel suo mantello, con la mano stretta alla
daga e avrei giurato che dormisse con un occhio solo.
,:
Lospitalit dei Francopani e di mastro Jozo a Zagabria ci
consol dei disagi del viaggio. La casa di questultimo sulla
Piazza del Mercato era sontuosa e la sua mensa ricca. Jozo ci ac-
compagn in barca sullaltra sponda della Sava.
Ora restava solo il percorso per Varazdin, dove gli uomini di
Mattia Corvino sarebbero venuti a prenderci.
Da Varazdin, messer Marco, avrete buona scorta. I turchi
scorrono la Valle della Drava fino alla Carniola. Hanno gi at-
taccato molti villaggi.
Da Zagabria verso Oriente la campagna si faceva pi dolce
per colline e pascoli. Il grano era maturo e i contadini falciava-
no sotto la sorveglianza delle milizie. La guerra era nellaria.
A Varazdin le strade erano piene di soldati. Il Castello di
Erdody, la nostra meta, affollato di uomini armati.
Matija esib le credenziali e fummo introdotti in una gran-
de sala piena di cavalieri. In mezzo a loro un uomo gigantesco,
dallaspetto rozzo e dallo sguardo cupo, ascoltava i rapporti di
alcuni ufficiali.
Paolo Kinizsi, bano di Temesvr mi sussur allorec-
chio Matija. il comandante supremo delle zone meridio-
nali.
Venite avanti, italiani! la voce di Kinizsi era tonante.
Benvenuto, Marco de Marco, siete capitati in piena guerra. I
turchi hanno attaccato Nedeljanec e Ptuj e Ljuotomer ma li ab-
biamo fermati. Tremila cadaveri di giannizzeri stanno conci-
mando la Valle del Raab. Il grosso dellesercito della Porta si sta
ritirando verso Semendria. Ali Beg, con i suoi saccomanni, ha
passato il Danubio a Orsova, alle Porte di Ferro, seminando
morte e distruzione tra Vrhely e le valli dello Strel e del Maros.
Il programma di viaggio cambia, de Marco, re Mattia ci atten-
de a Belgrado, poi ci uniremo alle truppe di Stefano Bthory,
voivoda di Transilvania, per ricacciare gli infedeli nellinferno,
dovessimo inseguirli fino a Costantinopoli! Sappiamo che Ali
Beg intende attestarsi tra Orastie e Mlbach, al Campo del
Pane. Un pane che sar durissimo per i suoi denti!
,+
XIII
Il resto del viaggio fu una lunghissima cavalcata tra villaggi
distrutti e raccolti bruciati. Greggi di uomini e animali in fuga,
chiese e conventi dati alle fiamme e cadaveri insepolti. I turchi
battevano la campagna, non osando attaccare le guarnigioni.
la loro tattica, de Marco, vogliono prenderci per fame
ma il grano brucia per tutti e se dobbiamo crepare, creperemo
di fame insieme, turchi e ungheresi e serbi e valacchi e molda-
vi e transilvani. E il corso del Danubio sar il pi grande cimi-
tero del mondo.
Proprio il Danubio che spesso costeggiavamo era per me
fonte di perenne stupore. Al ricordo dellIdro, ma anche dei
fiumi italiani, appariva come un mare, laltra sponda, alle volte,
a stento visibile ora nella nebbia, ora nel fumo degli incendi.
Messaggeri a cavallo arrivavano di continuo per portare no-
tizie e ordini del Re. Kinizsi leggeva le missive con il volto sem-
pre pi incupito. Neppure i rari raggi di sole che ravvivavano il
fiume sembravano strapparlo al suo rimuginare.
E sul Danubio incontrai Mattia Corvino. Il Re con la sua
corte ci aveva atteso fuori Belgrado perch le truppe non si fer-
massero un istante e i cavalieri neppure scendessero da cavallo.
La citt mi appariva immensa, pi grande di Firenze che pure
mi era sembrata grande. Su una collina si levava una fortezza di
pietra bianca dalla quale si poteva controllare la Sava, il
Danubio e la campagna.
Dopo che Kinizsi ebbe fatto rapporto ebbi il privilegio di
cavalcare accanto al sovrano. Corvino lesse il messaggio di
Lorenzo senza smontare.
Non senza preoccupazione vidi la sua mano accartocciare la
,
lettera, stringerla con rabbia prima di cacciarla in una sacca
della sella.
Mattia Corvino tacque a lungo e i suoi occhi socchiusi
erano fissi sul collo del cavallo.
Siete solo un messaggero, messer de Marco, e vi devo ri-
spetto. A nulla varrebbe sfogare la mia ira su di voi. Avete fatto
tanta strada per recapitarmi le chiacchiere di Lorenzo, le sue
mene da stratega senza esercito, da banchiere senza soldi. In
Italia non sapete neppure che cosa sono i turchi. Al massimo
avete esperienza di qualche scorreria di pirati. Quanto a quel-
laborto di spedizione mal congegnato dal Della Rovere quasi
ventanni fa, servito a chiarire che a Roma vogliono leccare
losso, non morderlo. Sisto IV troppo occupato a tramare con
Venezia contro Milano, con Napoli e Siena contro Firenze, a
dissipare fortune per nipoti e famigli. In Italia siete troppo di-
visi, quanto a Francia, Borgogna, Spagna, Inghilterra e persino
Germania, sperano tutti che sia Mattia Corvino a fare muro
contro gli infedeli. Ora che Venezia ha capitolato rimpiango di
non aver accettato le condizioni di Maometto II. Per anni il
Turco mi ha assillato con le sue proposte di pace. Mi offriva
tutto e in cambio chiedeva solo il libero passaggio delle sue
truppe attraverso lUngheria. Ma ad accettare mi sarebbe sem-
brato di tradire me stesso, il mio popolo, la mia fede
Non mi restava che annuire.
Posso, anzi devo impegnare gli eserciti della Porta per di-
fendere la mia gente ma questo non impedir una campagna
dItalia. Anchio ho i miei informatori e so che Venezia vi ha
venduto al Sultano. La Signoria si illude che Maometto II si li-
miter a impossessarsi delle terre che furono di Bisanzio, della
vostra Terra dOtranto, ma si sbaglia. La Puglia sar solo la
piazzaforte dalla quale cercher di scalare lItalia e nessuno in
grado di fermarlo. Solo la sua gotta potrebbe impedirglielo e gli
altri mali dai quali so che viene colpito. Nessuno, nella casa di
Osman, supera i cinquantanni ma una magra consolazione.
Dopo ogni Osman c sempre un altro Osman pi feroce e ag-
guerrito.
,s
Cos anche questa missione era compiuta. Dopo Lorenzo
toccava a Mattia Corvino togliere ogni speranza di salvezza per
la nostra terra. Otranto e Csole sarebbero cadute in mano
turca. Era solo questione di tempo. Ormai non mi restava che
intraprendere la via del ritorno a casa.
Non se ne parla neppure, de Marco, di fronte al mio re e
al Medici sono io responsabile della vostra salute. Tanto la via
del nord che quella verso il mare sono insicure. Le spie del
Sultano conoscono i nostri e quindi i vostri spostamenti. Senza
unadeguata scorta non andreste lontano e, in questo momen-
to, non posso distaccare neppure un uomo per voi. Dovete re-
stare con me fino a quando non raggiungeremo gli eserciti del
Voivoda di Transilvania.
Il tono di Paolo Kinizsi non ammetteva repliche. Era il de-
stino e non la mia volont a tracciare il cammino. Era linizio
dellautunno e le nostre soste diventavano sempre pi brevi e le
tappe pi lunghe. Le avanguardie partivano al galoppo per ve-
rificare il tragitto e rientravano a notte fonda. Fu una notte che
ci scaldavamo intorno al fuoco che uno degli ufficiali, inviato
in avanscoperta, piomb al galoppo quasi fin dentro la tenda
di Kinizsi. Ne nacque un grande trambusto, grida, ordini, im-
precazioni e su tutte le voci quella del comandante.
In marcia, in marcia, tutti a cavallo!
Non vennero neppure spenti i fuochi. Marciavamo nel buio
seguendo le torce delle guide. Faceva appena giorno e un sole
malato saliva nella caligine quando giungemmo ai piedi di una
collina. Man mano che la salivamo un clamore portato dal
vento mi sgomentava. Giungemmo di slancio sulla cresta.
Era il 13 ottobre 1479, giorno di San Colomano. Non
avevo mai visto nulla di simile. Ai miei piedi, nel Campo del
Pane, si svolgeva unimmensa battaglia.
Bthory sta per cedere! Allattacco, per lUngheria, per la
nostra Santa Ortodossia!
Lurlo di Paolo Kinizsi mi risuona ancora nelle orecchie.
La cavalleria corazzata si precipit al galoppo per il pendio
seguita dai serbi di Demetrio Jaksic, dai valacchi e dalla caval-
,o
leria sassone. Nella mischia furibonda giganteggiava Kinizsi, la
sua spada mieteva i turchi come grano maturo e il terreno si co-
priva di sangue e di corpi.
Al tramonto quanto restava delle schiere ottomane si diede
alla fuga.
Quel giorno rimasero sul terreno trentamila turchi ma la
vittoria era costata la vita di ottomila ungheresi e duemila tra
sassoni e valacchi. Laccampamento ottomano venne saccheg-
giato e quella notte unorrenda festa si svolse, un selvaggio ban-
chetto fu allestito e i corpi dei turchi uccisi erano tavole e tri-
clini per i vincitori. Una tregenda di danze prese il via, accesa
dal vino e dal cibo. A Campo del Pane capii che cos la guer-
ra, come la follia e la ferocia avvolgono gli uomini in una neb-
bia sanguigna.
Allalba, con una nutrita scorta, ero gi sulla lunga strada
per raggiungere il mare.
Il nostro percorso fu massimamente tortuoso per guarni-
gioni ottomane, e signorotti ora serbi, ora bosniaci, ora erzego-
vesi fedeli alla Porta. Ebbi cos tutto il tempo di pensare e ri-
andavo ai racconti di mia madre. Stavo attraversando la sua
terra. Montagne aspre e fiumi grandi e veloci. Facemmo una
tappa a Visegrad, sulla Drina. Il nome di quella citt lo cono-
scevo. Guardavo lo scorrere dellacqua verde e mi aspettavo di
vedere le vile, gli spiriti del fiume che popolavano le fiabe di
mia madre. Matija aveva deciso che era pi sicuro raggiungere
il mare per la via di Crnagora, un paese di alte e nere monta-
gne, fitte di boschi. Era originario di quelle parti e conosceva
tutti i passi e le scorciatoie. Speravo, oltre ogni cresta, di vede-
re il mare ma oltre ogni valico cera solo una mare di pietra e
di alberi.
come se un immenso artiglio lavesse graffiata questa
terra.
Matija cercava di distrarmi dallumore nero che mi prende-
va per lesasperante lunghezza del viaggio.
Un artiglio daquila lha graffiata da Austro a meridione
perch il mare fosse difficile da raggiungere come un miraggio.
,
Una barriera di inverni ghiacciati ed estati feroci separa il mare
Adriatico dal mare di grano della piana del Danubio. Solo le
aquile possono facilmente valicare queste montagne. Per que-
sto le aquile sono animali molto amati tra i picchi e le gole della
Dinarica. In tanti le raffigurano sugli elmi e le insegne di guer-
ra, ma lartiglio dellaquila non ha dilaniato solo i corpi. la-
nima di queste terre a essere dilaniata. LUngheria e la Porta
stanno giocando i bosniaci contro i serbi e i serbi contro gli er-
zegovesi e questi contro i dalmati. Tanti sono rimasti bogomi-
li, ma c chi si fatto cristiano romano e chi rimasto fedele
a Bisanzio e chi invece ha abbracciato lIslam e tutti fanno
guerra a tutti.
E tu, Matija, da che parte stai?
Io? E che centro io, messer Marco? Io sono nato sul mare!
Gi, sul mare! Quante volte quella frase di Matija mi tor-
nata alla mente! Come se lessere nati sul mare disponesse le
nostre anime pi alla pace che alla guerra e nello stesso tempo
ad avere fedi pi tiepide, meno inclini a essere affermate con le
armi.
Oltre un cresta il tramonto si fece pi abbagliante. Il sole si
rifletteva sulla liscia superficie di un golfo stretto tra alte rocce
a strapiombo.
fatta, messer Marco, tu sei sul mare e io sono a casa.
Siamo a Perast.
Il mattino dopo un piccolo veliero mi portava oltre le
Bocche di Cattaro. Otranto era l, dove finisce lAdriatico.
Allimbarco Matija mi abbracci e mi lasci scivolare nella
mano un ciottolo di fiume lucido e liscio.
La nave passer di l disse indicandomi uno dei due iso-
lotti che chiudevano il porticciolo. Getta l questa pietra e la
Madonna del Coltello ti far grazia di tornare a Perast. Questa
casa tua, messer Marco!
,
La nave accost per un momento e una salva di sassi part
da bordo verso lisola che, ebbi modo di osservare, era costitui-
ta da ciottoli in tutto simili a quello che avevo lanciato.
Sbarcai a Otranto di notte. Il porto era avvolto in unoscu-
rit silenziosa. La citt dormiva tranquilla. Tutto mi sembrava
lontano ora, la crudelt della guerra, la minaccia dei turchi, la-
stuzia di Lorenzo, leroismo di Mattia Corvino, la ferocia di
Kinizsi, la quieta amicizia di Matija.
,,
XIV
I primi raggi del sole screziavano i pascoli intorno a Csole.
Labbazia si stagliava imponente. Il mio rapporto allIgumeno e
al Consiglio degli Anziani fu lungo ed esauriente. Csole tras-
se la conclusione che la sconfitta turca a Campo del Pane
avrebbe acquietato Maometto II per un bel po. Non ero dello
stesso parere, ma il mio parere non venne richiesto.
Tornai alle mie abituali occupazioni nellarchivio e nella bi-
blioteca.
Cinquecento stadi, ha scritto Scilace nel suo Periplo.
Strabone sostiene che siano solo quattrocento.
Di che parli, Demetrio?
Oh, solo della distanza che separa Otranto dalla punta che
chiude la baia della Valona. Guarda! Sembra quasi di toccarla,
che basterebbe qualche ora di remo per raggiungerla.
Demetrio stava dritto davanti alla finestra di levante dellar-
chivio. La tramontana spazzava il canale e le cime degli
Acrocerauni erano illuminate dal tramonto. La baia della
Valona sembrava vicinissima. Da tempo Demetrio aveva preso
a dire qualche parola. La mia presenza nellarchivio sembrava,
di tanto in tanto, rompere il muro della sua immensa tristezza.
Le frasi, in genere brevi, che mi rivolgeva non sempre ave-
vano un senso compiuto o lorganicit di un discorso. Pi che
altro la sua voce, alle volte, sembrava fare affiorare i frammen-
ti di un lunghissimo pensiero serrato nella sua mente.
Pi era evidente che egli gradiva la mia compagnia, pi mi
inquietavano quei brandelli di ragionamento che mi centelli-
nava. Quando poi si addormentava parlava nel sonno e quelle
recitazioni apocalittiche che provenivano dai suoi incubi mi la-
:cc
sciavano addosso un senso di malessere, di tragedia imminen-
te.
Eravamo quasi nel cuore dellinverno. Mi piaceva guardare
dalle finestre di levante il Canale imbiancato dalla tramontana
e le nuvole dacqua alzarsi dalle Orte, dove le onde si frangeva-
no potenti. Le vigne, verso Torre Pinta, si erano fatte gialle, poi
rosse e ora erano perfettamente spoglie. Il grano era stato se-
minato e questo mi sembr un segno di buon augurio nella cu-
pezza della stagione.
Hidruntina patria mea a dragone mahumetano devastaba-
tur
Cosa c, Demetrio, come hai detto?
Mi precipitai a scuotere il vecchio che mi sembrava in preda
al delirio. Si riscosse.
Un drago musulmano, Marco, un drago feroce, gonfio
dellempiet dellIslam, distrugger la nostra terra. Non sono
parole mie. Verdino le lasci scritte prima di morire nel 1279.
Ora la sua profezia si avvera, Marco!
Ero annichilito. Nessuno poteva avere informato Demetrio
di quanto andava maturando a Istanbul. Nessuno, a parte me,
parlava con lui e io ero rimasto fedele alla consegna del segre-
to. Anche Demetrio, come Verdino, aveva il dono della profe-
zia!
Demetrio, perch hai smesso di parlare con i nostri con-
fratelli?
Marziale ci ricorda che gran cosa il tacere. Solo cos,
seguendo linsegnamento del nostro maestro Virgilio, il pen-
siero rimane racchiuso nel profondo della mente. E poi per
parlare necessario avere qualcosa da dire che sia pi impor-
tante del silenzio. So bene, Marco, che passo per essere affetto
da bile nera, un umore freddo che mi precipiterebbe nella eva-
gatio mentis. Ma non cos. Troppi anni in questo archivio,
troppe cose del mondo, dei poteri, della politica e chi pratica il
potere e la politica si avvolge in una follia che neppure ricono-
sce e vi precipita senza ritorno. Io sono riuscito a risalire questa
follia forse con unaltra follia.
:c:
Il ricordo del viaggio era ancora fresco e le scene della bat-
taglia di Campo del Pane, indelebili nella memoria, mi rende-
vano inquieto. Lincombere su tutto delle parole di Demetrio
mi assillava dangoscia. Solo nello studio cercavo conforto, ma
tra larchivio e la biblioteca una sorta di attrazione che non
controllavo mi portava a leggere di guerre. NellAntico
Testamento incontravo il Dio degli Eserciti. Cercai conforto in
Agostino dIppona ma restavo impietrito da parole come:
poi certamente giusta quella guerra che stata comandata da
Dio, che si specchiavano nelle parole della Sura ventinove-
sima del Corano: Combattete coloro che sono infedeli tra
le genti della Scrittura, quelli che non praticano la vera religio-
ne
Continuando a sfogliare carte e pergamene mi capit tra le
mani ancora una Historia Hierosolymitana, ma questa volta sul
frontespizio cera in bella mostra il nome dellautore: Fulcherio
di Chartres. Nella lettura mi imbattei nel racconto delle gesta
del nostro benefattore Boemondo: la presa di Antiochia, la sua
improvvisa rivolta contro il potere imperiale di Costantinopoli.
Cera qualcosa che non capivo.
Demetrio, che interesse poteva mai avere Boemondo, cri-
stiano latino e normanno, a fondare il monastero di San Nicola
di Csole?
Marco, Marco, ma allora il nostro giovane archivista vuole
penetrare nelle arcana imperii? Marco, vuoi correre il rischio di
penetrare in un segreto che non si nasconde tra le carte dellar-
chivio e neppure tra i volumi della biblioteca?
Ma che segreto e segreto, Demetrio, solo che mi sembra
strano che un principe normanno fedele a Roma faccia una do-
nazione per fondare un monastero fedele a Bisanzio.
Tu vedi una contraddizione che attiene alla fede ma abba-
zie, monasteri, vescovati e patriarcati, la loro fondazione o isti-
tuzione, come pure la loro distruzione, poco o nulla hanno a
che vedere con la fede.
Ancora il potere, Demetrio?
:c:
Certamente! Fu la brama di potere e ricchezza a coinvol-
gere i nostri Santi Padri che abitavano le grotte e le capanne
sulle quali sorge ora lorgoglioso monastero di San Nicola di
Csole. Sulle serre, tra il casale di Uggiano e la Cala dellOrte,
essi nulla sapevano delle tenzoni tra Roma e Bisanzio, della tra-
gica disputa tra quei due invasati di Michele Cerulario e
Umberto Di Silva Candida. Dediti alla contemplazione e alla
preghiera a stento avevano sentito nominare Leone IX e solo da
qualche pellegrino in viaggio per la Terra Santa avevano appre-
so qualcosa delle riforme che si covavano nella remotissima ab-
bazia di Cluny, in terra franca. Ci volle il Guiscardo a scuoter-
li dallonfaloscopia, dal passare la giornata a guardarsi lombeli-
co e pi del Guiscardo li scosse il figlio di lui, Boemondo. I
normanni tuttavia furono generosi con noi greci della Terra
dOtranto. Qui, dalle nostre parti, tra noi e i vescovi latini sa-
pevamo aggiustarci senza danno per nessuno. Che il pane per
la Comunione fosse lievitato o azzimo non era un problema
che toglieva il sonno, altrettanto per il digiuno del venerd o del
sabato e persino per il filioque. Quanto alla possibilit dei preti
di sposarsi non saprei dire se erano i nostri preti a invidiare il
loro celibato o i loro a invidiare il matrimonio dei nostri.
Demetrio, ma stai parlando solo di differenze liturgiche,
quelle dogmatiche erano ben pi serie
Sicuro, ma quelle liturgiche le capivano tutti, mentre
quelle dogmatiche restavano nel chiuso delle biblioteche. Da
entrambe le parti si voleva una rottura di popoli, non di gerar-
chie e quindi era necessario rompere su cose alla portata di
tutti.
Ma allora in piena rottura tra le Chiese Sorelle, perch
Boemondo
Beh, innanzi tutto Boemondo amava la Terra dOtranto e
la nostra citt in particolare. Amava venire a caccia in queste
lande e, cos, divenne amico di Giuseppe, il nostro primo igu-
meno, uomo dottissimo e arguto. Giuseppe aveva conosciuto
Psello e, a Costantinopoli, era stato maestro della grande Anna
Comnena, prima di ritirarsi definitivamente a Otranto.
:c+
Giuseppe aveva seguito con grande preoccupazione le campa-
gne del Guiscardo in Epiro, Macedonia, Tessaglia, fino allasse-
dio di Larissa e fu molto addolorato quando Boemondo part
al seguito del padre.
Il Santo Giuseppe aveva gi colto che la rottura religiosa
avrebbe potuto trasformarsi in guerra?
Esatto! E quando un giorno Boemondo, reduce da un
lungo viaggio, lo inform dellappello di Urbano II al Concilio
di Clermont per la liberazione della Terra Santa, Giuseppe
cadde in una profonda tristezza e, come me, pass per essere af-
fetto da bile nera.
Anche lui, come te, un po profeta di sventure?
Non bestemmiare Marco, la profezia un rarissimo dono
di Dio generato dalla fede. Prevedere ci che pu condurre alla
sventura invece dovrebbe essere terrena capacit di chi capisce
i poteri e i loro equilibri. Giuseppe aveva capito perfettamente
a quali immensi disastri e dolori e rotture sempre pi profon-
de avrebbe portato unimpresa militare latina in Terra Santa.
Era ovvio! Lavrebbe capito anche un bambino. Giuseppe scon-
giur Boemondo
Che si guard bene dallascoltarlo
Boemondo non era meno Guiscardo del padre. Della
Terra Santa gli interessava meno di nulla, voleva un suo regno
e voleva ritagliarselo in Oriente a spese della debolezza di
Bisanzio. In fondo voleva solo perseguire il fallito disegno del
padre.
Ma allora la donazione? Labbazia?
Non sempre la spada, per quanto valorosa, sufficiente a
conquistare un regno e poi aveva temibili concorrenti: il
Signore di Bouillon, Raimondo di Tolosa, Ugo di Vermandois,
Roberto di Fiandra, e tanti altri conti e duchi e cadetti affama-
ti di gloria, potere e ricchezza.
Ma Boemondo e i suoi normanni erano di gran lunga i
pi forti sul piano militare
S, ma la partita non si giocava solo sul campo di batta-
glia. Nella fase iniziale della spedizione era indispensabile lap-
:c
poggio e la fiducia del Comneno e la fondazione di Csole fu
la credenziale con la quale Boemondo si conquist il suo favo-
re e, si dice, quello della di lui figlia Anna. Csole non nacque
da un atto di fede, ma da un disegno di dominio e potere, da
una sete di ricchezza e bottino. Non dimenticarlo mai, Marco!
:cs
XV
Ora tutto mi appariva terribilmente chiaro.
Le parole di Demetrio si legavano a quelle di Giosafat
Barbaro, di Lorenzo de Medici, di Mattia Corvino e alle tante
che avevo letto sui libri e trovavo conferma a quellidea di fon-
dazione di una antica inimicizia tra Oriente e Occidente che
avevo incontrato nellOdissea. Singolare come la leggenda si
impadronisce della storia. Una guerra per una donna! Ci aveva
pensato Erodoto a rimettere a posto le cose ed Euripide e
Platone: non Elena era giunta a Troia rapita da Paride ma solo
il suo idolon, lingannevole immagine di un fantasma, come
narrano i versi di Stesicoro. Ma allora qual il seme della guer-
ra? Sfogliando il Protagora appresi che la guerra meros, parte
della politica e mi colp lassonanza con moira, destino. Guerra
nellIliade, guerra nellEneide e ancora titanomachie e giganto-
machie e batracomiomachie e guerre nei Persiani, nei Sette con-
tro Tebe, nellAntigone e nellAiace, nellEcuba e nelle Troiane e
persino nelle commedie di Aristofane, negli Acarnesi e, ironia
delle parole, nella Pace.
Storie di guerra, come una maledizione, che si ripetevano
nelle parole di Niceta Coniata, dalla lettura del quale avevo ap-
preso dellorribile massacro consumato dai latini dopo la presa
di Costantinopoli in quel tremendo 13 aprile dellanno 1204
dalla nascita di Nostro Signore.
Oh, le pagine di Niceta, Gran Logoteta de Segreti, Ispettore e
Giudice del Velo, Prefetto del Sacro Cubicolo! La porpora e loro
ridotti a sangue e bile, Comneni e Angeli, eroi e tiranni, santi
e smidollati e prostitute e ruffiani assatanati di ricchezze ed eu-
nuchi ingordi donori e il lampeggiare delle spade e la vertigi-
ne delle torture e lo sgomento delle esecuzioni.
:co
La mia terra, la casa, la famiglia, il mio monastero erano an-
cora una volta in bilico sul crinale di odi antichissimi e sempre
rinnovati da nuovi rancori.
Anchio presi a odiare. Odiavo quelle carte, quelle lettere,
quelle relazioni. Avrei dovuto archiviare una immensa mole di
materiale inviatomi da Niccol Perotti, il fedele segretario del
Bessarione che, alla morte del Cardinale, si era ritirato a Roma
in Santi Apostoli ma preferivo andarmene per le campagne, alle
masserie, agli stazzi, stare con i pastori e i contadini, bere il loro
vino, mangiare il loro pane.
Sapevo bene cosa cera nei faldoni di Perotti: ancora una
volta tutta la storia dei Concili di Ferrara e Firenze. Dispute e
ancora dispute e, alla fine, ununione tra le Chiese che non era
stata ununione e relazioni su relazioni, su Marco Eugenico che
predicava per la rottura e lettere dal Principato di Mosca nelle
quali si gridava al tradimento della fede ortodossa e note sul-
lincalzare delle forze ottomane e le frenetiche trattative di
Costantino XI con Alfonso dAragona e col Papa per avere
aiuto. E mi veniva in mente la frase di quellalto funzionario
imperiale che avevo letto in qualche relazione: Preferirei vede-
re in mezzo alla citt un turbante turco che una mitra latina
Venne accontentato il 29 maggio dellanno della mia nasci-
ta, 1453.
Disertavo la biblioteca e larchivio. Vagavo per la campagna.
Dai crinali delle serre un mare di ulivi verso Occidente e pine-
te e pietraie verso Oriente. Mi illudevo di poter incontrare
Alberada, quel primo e unico amore che aveva lasciato nella
mia anima una ferita non rimarginata, dalla quale stillava la
goccia di sangue del pensiero di quella figlia che ignoti esseri
soprannaturali allevavano nei boschi, tra le specchie e le grotte,
nel fitto delle pinete.
Tornai a fare il periplo degli Alimini. Girare intorno ai laghi
era unimpresa che da bambini ritenevamo eroica. Le piogge di
quellinverno avevano esteso le paludi e di tanto in tanto mi ri-
trovavo tra le canne ad affondare nella mota. I piedi imprigio-
:c
nati dallabbraccio del fango che sembrava non volesse lasciar-
mi andare mentre la testa se ne volava lontano: Firenze,
Belgrado, Istanbul, Roma, luoghi remoti dove si stava prepa-
rando il destino di questa terra immersa in un inverno che non
voleva finire mai.
Ma linverno fin.
Allimprovviso i mandorli fiorirono appena preceduti da un
sommesso verdeggiare delle viti. Un vento tiepido marezzava
gli uliveti di verde e grigio.
A Csole la vita scorreva sempre uguale, scandita dal lavoro
e dalla preghiera. Sul Canale le vele si facevano pi frequenti
man mano che laria si riscaldava. Una sera tornarono le ron-
dini. I nidi sotto i tetti dellabbazia si ripopolarono e laria era
piena dello stridere di questi uccelli che si diceva venissero dalla
pi lontana Africa e mi sembrava impossibile che animali cos
piccoli avessero potuto attraversare un mare tanto grande.
Ripresi il lavoro nellarchivio, ma la sera mi piaceva cammina-
re fino al mare. Arrivavo alle Fogge e mi immergevo nellacqua
ancora fresca. Dellinfanzia mi era rimasta la vigoria nel nuota-
re e mi spingevo fino al largo dove non vedevo pi il fondo e
sotto di me un buio immenso mi sosteneva sul pelo del mare.
Al tramonto vedevo arrivare il vecchio Stefano che, con gli orci
dellolio in spalla, andava ad accendere il lume sulla Torre. Il se-
gnale dellingresso al porto di Otranto. Mio padre diceva che
quella luce lavrebbe sempre riconosciuta tra le infinite luci dei
tanti segnali e fari che aveva visto. Diceva che era pi forte e
brillante per il marchingegno che la moltiplicava e infatti la fi-
nestra a mare della Torre era chiusa da un telaio di legno nel
quale era incastrato un cristallo. Ricordo bene quella sera, ero
un bambino, e con mio padre, mio fratello e Stefano il
Guardiano eravamo saliti sulla Torre e mio padre aveva aperto
la sacca nella quale custodiva una specie di pietra che aveva tro-
vato da un mercante di una lontana citt che credo si chiamas-
se Trebisonda. Mai ne avevo visto di simili. Quadrata, di tre
palmi di lato e spessa pi di quattro dita. Si poteva guardarci
dentro e attraverso di essa le cose sembravano ora pi grandi,
:c
ora pi piccole ma era alla luce delle lampade che la pietra
mandava riflessi accecanti e colori meravigliosi. Con Stefano
fecero tanti esperimenti e da una barca al largo arrivavano se-
gnali di luce a ogni spostamento della pietra davanti alla lam-
pada. Alla fine, dopo molte prove, la pietra fu sistemata e non
solo proteggeva la fiamma dal vento del Canale ma le dava una
forza misteriosa che, diceva Stefano, la rendeva visibile fino alla
Valona.
Maledette le secare!
Raggiungevo Stefano dopo la mia nuotata e bevevo il suo
vino. In cambio dovevo ascoltare i suoi improperi contro le
serpi. Stefano le accusava di bere lolio della lampada e si la-
mentava di dover dormire con un occhio solo e il bastone in
mano per scacciarle.
Maledette le secare e la loro fame di olio! Tre volte in que-
sta invernata mi hanno spento la lampada e per tre volte sono
stato rimproverato dai Capitani del Porto. Adesso dicono che
sono vecchio e che quel bicchiere di vino che bevo per riscal-
darmi la notte non lo reggo pi e il sonno mi vince e le secare
si prendono gioco di me.
Consolavo Stefano delle sue angustie e me ne tornavo a
Csole nelle notti che si facevano via via pi calde.
Lestate gravava ormai sulla Terra dOtranto con il maglio di
un sole implacabile.
Ai primi di agosto un temporale squarci la calura. Una
mattina il cielo si abbui, tanto che nellarchivio dovetti accen-
dere la lampada. Nella grande calma di vento il mare era una
lastra di piombo illuminata dai fulmini. E venne a piovere, ma
prima sui tetti crepit una grandine aspra, sassi dal cielo con
terribile violenza. Pensai ai pianti dei contadini per la vigna in
pieno frutto. I chicchi erano grossi come noci e li vedevo roto-
lare sul sagrato della chiesa e nel cortile.
E grandine grande, come del peso di un talento, scende dal
cielo sugli uomini, e bestemmiarono gli uomini Dio, per la
piaga della grandine, poich grande la sua piaga, moltissimo.
:c,
Il temporale aveva sprofondato Demetrio nella sua melan-
colia e dalle sue labbra tornava a scorrere lApocalisse di
Giovanni.
La pioggia poi fu tale che non si vedevano le pinete e si sca-
ten un vento che fece volare i fogli fin dentro lo scriptorium e
spezz il fico. La terra arsa si bevve lacqua da non poterne pi
e, allo spiovere, le pozze sembravano tanti specchi sparsi nella
campagna. Il vento si port il temporale lasciando una tra-
montana fresca e il sole torn a bruciare sul Canale che frigge-
va di onde.
Qualcuno poi ha detto che fu il mare grosso a deviare i
Turchi su Otranto, ma fu alla controra che vedemmo la flotta
della Porta ballare sotto le raffiche e non si capiva se dovevano
passare verso Brindisi, tornare alla Valona o sbarcare a Otranto.
Dalla finestra dOriente dellarchivio indicai a Demetrio le
navi al largo. Il vecchio si limit a uno sguardo sul Canale. Poi
lo sentii mormorare:
E vidi dal mare una bestia che saliva, con dieci corna e
sette teste e sulle corna dieci diademi e sulle sue teste un nome
di bestemmia.
Sono queste le ultime parole pronunciate nella sua vita dal
mio amico Demetrio.
::c
XVI
Dalle Fogge allOrte era tutto un brulicare di navi turche-
sche. Iniziavano gli sbarchi degli uomini, dei cavalli, delle armi
e delle macchine da guerra. Bombarde, catapulte, mai viste
tante e tanto grandi. Nessuno a contrastare gli uomini di
Ahmed Pasci che quasi si stupivano di non incontrare resi-
stenza. Da Csole vedevamo le prime pattuglie avanzare guar-
dinghe come se temessero che quella tranquillit celasse una
trappola, che da un momento allaltro le armate cristiane ir-
rompessero sulla scena a fare strage, a ricacciare in mare gli in-
vasori, ma la campagna era deserta, avvolta nella calura dago-
sto, assordata dalle cicale. Mi sembrava quasi di avere gi visto
questa scena, tante erano state le cronache di conquiste turche
che avevo letto. Gi sapevo che da un momento allaltro sareb-
be arrivato un messaggero con una nutrita scorta a leggerci le-
ditto con il quale Maometto II dichiarava il suo possesso su di
noi. Ma il messaggero tardava e mi stupiva il fatto che i turchi
sembravano prepararsi a un assedio della citt di lunga durata.
Otranto non era in grado di resistere allinvasione. I turchi do-
vevano pur saperlo, eppure innalzavano tende e accendevano
fuochi e disponevano recinti per i cavalli e costruivano forni
per il pane. Il colle della Minerva, quasi in faccia allabbazia, era
un brulicare di uomini e masserizie. Sembrava che fossero ve-
nuti pi a costruire una loro citt che a conquistare la nostra.
Tutto quel lavorare dei turchi mi inquietava. Perch co-
struivano un cos grande accampamento se sarebbe bastato un
colpo di bombarda per fare arrendere la citt e dormire e man-
giare comodamente nelle nostre case? Invero dalla citt comin-
ciavano ad arrivare voci di unintenzione di resistere allassedio,
di vendere cara la pelle, dellimminente arrivo di truppe da
:::
Napoli, ma mi sembravano per lo pi vanaglorie da ubriachi.
Truppe da Napoli non ne potevano arrivare. Non che Ferrante
non tenesse alla Terra dOtranto ma era noto il suo astio per
lArcivescovo, a suo tempo fedele a Gian Antonio Orsini del
Balzo, e il Re, si sapeva, non voleva neppure sentirlo nomina-
re. Lidea quindi che lAgricoli e i suoi preti infedeli alla casa
dAragona se la dovessero vedere con i turchi doveva far sorri-
dere pi di qualcuno alla corte di Napoli.
Resistere non era possibile e, soprattutto, non era utile.
Sul momento bisognava capitolare. Ci avrebbe pensato
lAragona a riconquistare le sue terre se ne avesse avuto la pos-
sibilit e la voglia.
Pi il tempo passava e pi diventavo inquieto, mentre i miei
fratelli sembravano tranquilli. Le ore scorrevano come se intor-
no la campagna fosse deserta, appena solcata da qualche peco-
ra e da qualche pastore. Solo il cortile dellabbazia affollato di
bestiame era il segno di una qualche novit. LIgumeno Filoteo
aveva ordinato di ritirare le greggi ma solo per paura di qualche
intento rapinoso dei turchi, e perch sarebbe stato nelle regole
consegnare formalmente le bestie agli infedeli a segno di resa
anzich farsele rubare da qualche banda che scorreva lentro-
terra.
I turchi giunsero a Csole al tramonto.
Sentimmo solo il rumore degli zoccoli dei cavalli sulla pie-
traia. Si fermarono in silenzio davanti al portone principale,
come ad aspettare che qualcosa accadesse. Nessun araldo a leg-
gere leditto. Dallarmamento e dai vestiti capii che erano trup-
pe scelte, giannizzeri forse, non quelle orde urlanti, mal vestite
e mal armate che i califfi lanciavano come prima ondata negli
assalti. Cera da star sicuri quindi che non avessero intenti ag-
gressivi e mi spinsi a immaginare che quello spiegamento di ca-
valieri fosse un segno di riguardo per il monastero. LIgumeno
era pronto a rendere la nostra capitolazione e anche il tributo
per la resa era stato gi preparato. Mancava solo che laraldo
leggesse, secondo costume, il firmano imperiale.
Eravamo riuniti nella chiesa pronti a uscire per accogliere i
:::
nuovi padroni e nel silenzio cercavo di indovinare che cosa pas-
sasse nella testa di tutti, dallIgumeno allultimo dei confratel-
li. Cera una grande serenit e mi sembrava di immaginare
come sarebbe stata la nostra vita nellimpero ottomano, ma
non mi riusciva di figurarmi i cambiamenti. Avevo sentito delle
proibizioni di suonare la campana e avevo visto mastro
Giorgio, il nostro falegname, gi lavorare a una grande siman-
dra. Laveva ben levigata e aveva intagliato unimpugnatura nel
mezzo e con un piccolo martello ne provava il suono. Era lu-
nico strumento con il quale i turchi generalmente consentiva-
no che i cristiani chiamassero alla preghiera.
Non cera motivo di avere paura. Non era forse cristiano
Waraga ibn Nawal, zio di Khadija e sensale del matrimonio del
Profeta? E non eravamo stati noi, greci e cristiani, il sale della
terra fertile della Mezzaluna?
Era quasi buio e le preghiere del Vespro erano terminate,
quando lIgumeno ordin che uscissimo incontro ai turchi.
Forse questi avevano voluto attendere la fine delle nostre ora-
zioni per leggere leditto ed era bene non farli aspettare ancora.
Si form il corteo guidato da Filoteo e via via tutti gli altri
in ordine di importanza e quindi det. Io ero pochi passi alle
spalle dei primi e cos vidi bene, quando lIgumeno giunse da-
vanti allufficiale turco, la lancia di questi trapassargli il petto. I
turchi si avventarono contro di noi senza un grido, e senza un
grido morivano i miei confratelli falciati dalle scimitarre e dalle
lance. Fu solo la fortuna a non farmi fuggire verso il monaste-
ro ma a farmi correre, distinto, verso il querceto che cresceva a
cento passi e da l lungo le macchie. I turchi uccidevano mec-
canicamente, senza passione, roteavano i cavalli con gli occhi
vitrei e calavano fendenti su fendenti. Fu solo la fortuna, aiu-
tata dal buio, a far s che nessuno mi vedesse mentre correvo
verso le pinete. Correvo e sentivo quasi il rumore degli zoccoli
che avrebbe preceduto il colpo di scimitarra ma ero gi tra gli
alberi e nessuno mi aveva inseguito. Correvo ancora laceran-
domi il saio e il petto e le mani contro la sterpaglia fino a quan-
do una forra mi fece mancare la terra sotto i piedi.
::+
Quando ripresi i sensi era notte fonda e un chiarore rossa-
stro saliva verso il cielo.
Risalii dolorante oltre il bordo del crepaccio e lentamente tor-
nai sui miei passi. Sul limite la vegetazione si faceva pi rada. I
tronchi si stagliavano netti contro il bagliore di un rogo immen-
so. Csole bruciava. Le fiamme avvolgevano la chiesa, lala delle
celle e altissime si levavano dallo scriptorium e dalla biblioteca.
Ero a pi di duecento passi ma le folate di calore che mi in-
vestivano non scalfivano il gelo del mio corpo tremante.
Non era la paura o il dolore a farmi tremare, era solo una
grande stanchezza. Continuavo a osservare le fiamme che di-
voravano il mondo nel quale avevo trascorso una buona parte
della mia vita. Ignoravo se qualcuno dei miei confratelli fosse
sopravvissuto alla strage. Certo le fiamme stavano divorando
tutto ci che avevo letto, studiato, copiato e soprattutto amato.
Eppure avvertivo indistintamente che salvando la mia vita
avevo salvato tutto ci che avevo amato. Provai orrore per il
mio egoismo, ma molto tempo dopo mi sarei dato una spiega-
zione della mia indifferenza di allora. Sopravvivere significa
conservare la memoria. E la memoria tutto. Quelluomo gio-
vane, raggelato nella pineta aveva indosso solo un saio lacero,
ma nella sua testa aveva Csole, i suoi libri, la sua storia e, con-
tro ogni evidenza, intatta, la temeraria ambizione che il sapere
potesse dominare gli uomini e la loro violenza, la loro barbarie,
i loro odi e i loro calcoli abietti.
Da tempo so che non cos. La pergamena e la carta sono
fatalmente succubi della ben pi dura materia di cui fatta una
spada.
Mi nascosi nella cripta diroccata di Torre Pinta. I turchi non
ne avrebbero mai scoperto laccesso sepolto tra le felci. La torre
che sovrastava la cupola era invasa dal fico selvatico che ne ce-
lava il parziale crollo. Era il posto ideale per spiare le loro
mosse. Allalba ero gi di vedetta. A meridione si levava ancora
una colonna di fumo dallabbazia. A settentrione, sotto le
mura, era tutto un brulicare di turchi, di bombarde, di cata-
::
pulte e balestre e lance e alabarde. Era linizio dellassedio e per
tutto il giorno sotto i miei occhi inorriditi si svolse cruenta bat-
taglia. Fino a Torre Pinta giungevano i boati e latroce schian-
to delle palle di pietra sulle case e le strade. Gli urli dellassalto
giungevano appena attutiti come un canto selvaggio che si
perde nel vento. Al tramonto si concluse la prima giornata di
assedio. Otranto non era caduta, i soldati si ritirarono negli ac-
campamenti ma le mura orgogliose della citt erano squarciate
dai crolli.
L cerano mia madre, mio padre, mio fratello, gli amici, la
mia infanzia, la mia casa, i miei ricordi di unaltra vita perduta
indossando il saio e per un attimo millusi che la distruzione di
Csole me la potesse far ritrovare. Fu quellattimo a farmi tor-
nare il sangue nelle vene. Improvvisamente mi prese la furia di
rivedere la mia famiglia, la mia citt. Correvo sul costone della
Valle dellIdro, incurante del pericolo che i turchi mi vedesse-
ro, ma quelli che si ritiravano verso il Colle della Minerva non
sembravano fare caso a me. Cera un punto nel quale dovevo
assicurami di non essere visto da nessuno. Era tra le rovine di
alcune tombe dei messapi, gli antichi abitanti della nostra terra.
Da l partiva un cunicolo che portava dentro le mura di
Otranto.
Correvo nel buio del sotterraneo con la schiena curva, in-
curante delle radici che sferzavano il mio corpo, dello squittire
dei topi, delle ragnatele che mi accarezzavano il volto. Correvo
cos forte che quasi piombai sulle lance spianate di Angelo
Olivella e Curzio dAlessandro. Erano di guardia allingresso
del cunicolo dentro le mura e sentendo i miei passi e temendo
che i turchi, scoperto il passaggio, stessero tentando un colpo
di mano, avevano dato lallarme e si preparavano ad affrontar-
li.
Marco, ma sei tu, Marco de Marco, sei salvo, corri a casa
che gi ti piangono per morto, che a Csole tutti sono morti,
tutti uccisi da questi infami, che Dio li maledica! Tutti uccisi,
ma che uccisi! Assassinati senza combattimento
Curzio, amico mio, e mio padre, mio fratello, la mamma?
::s
Corri a casa, stanno bene, oggi sulle mura tuo padre e tuo
fratello hanno fatto faville, hanno ricacciato pi turchi loro che
una tempesta e la casa tua sana e tua madre stata sempre in
San Pietro a pregare, corri, corri a casa.
La casa era intatta. Ci ero arrivato davanti di furia. Era notte
e silenzio e lodore di basilico gremiva laria di ricordi. La fine-
stra, affollata di craste, grondava gerani e la porta era socchiusa.
Ci guardammo senza una parola, poi restammo avvinghiati
luno allaltro in un silenzio rotto solo dai singhiozzi di mia
madre. Ammucchiati in un angolo cerano i vestiti di mio
padre e mio fratello, sozzi di sangue e di polvere.
Poi venimmo a ridere, a ridere senza freno intorno alla ta-
vola che sembrava imbandita come per la festa. Mia madre apr
la mattra e cacci formaggi e conserve di melanzane. Una fame
rabbiosa ci prendeva e il vino scorreva dallo mbile e mangiam-
mo come se fosse lultima volta che dovevamo mangiare ma
con unallegria sfrenata. Mai avevo visto mio padre cos. Si van-
tava dei turchi uccisi con una ferocia che me lo sfigurava e cos
mio fratello. I de Marco, noti per la loro austerit, per essere di
pochissime parole, sembravano due soldati ubriachi con le
mani strette sulle ucale che raccontavano bravate di guerra
prima di crollare schiantati dalla fatica e dal nurumaru.
Pi tardi, con mia madre nellorto mi chiedevo se cos la
guerra, se improvvisamente tutto comincia ad andare pi velo-
ce e tutto sembra correre verso il limite, il ridere, il mangiare,
luccidere, lessere uccisi.
Marco, figlio mio, cerca di dormire, domani sar battaglia
ancora.
Mi avevi gi pianto morto, madre?
No, Marco, ti piangevo ma non per morto, una madre lo
sa dalle viscere se il figlio morto, e io sentivo che non eri
morto. Zi Carmela poi lo aveva visto nelle chiare duovo e nel
piombo fuso che tu non muori. Tu chai sette e sette vite, come
un gatto, e muori e rinasci ma sei sempre tu e sei sempre di-
verso.
::o
E voi, madre, che vi ha detto di voi zi Carmela?
Niente, Marco, di noi niente ci disse, che il tuorlo il
tuorlo si ruppe e tutto si mischi.
::
XVII
Dei giorni che seguirono non ho una memoria ordinata.
Ricordo che ebbi appena il tempo di chiudere gli occhi a mio
padre, trafitto da una lancia. Solo a tarda sera accostammo il suo
corpo a quello degli altri caduti che nessuno aveva avuto il re-
spiro di seppellire. Cerano tanti che conoscevo e tra loro rico-
nobbi una fusciacca algerina e una bella camicia di mussola che
una volta era stata bianca. Seppi cos che anche mio fratello era
morto, non potevo riconoscere il volto devastato dalla ferita.
Ricordo vagamente che combattevo sulle mura. Al conven-
to quando il desiderio di una donna mi inondava prendevo la-
scia e spaccavo legna fino a restare esausto, con le mani tanto
gonfie che dovevano passare tre o quattro giorni perch potes-
si tornare a scrivere.
Sulle mura ci ero salito con lascia di casa. Una lama dalma-
ta che ti potevi fare la barba e un manico dulivo che lequili-
brava come una stadera. Allepoca ero forte e resistente e con-
servavo lagilit della giovinezza. Quello che non posso dimen-
ticare che non ebbi alcuna paura a trovarmi nella battaglia e
che nessuno sgomento mi colse quando cominciai a uccidere.
Abituato al colpo sul taccaro di ulivo mi faceva specie che tra
la carne e le ossa lascia penetrasse morbida come in un liquido
troppo denso. Mi resi conto che ci mettevo troppa forza. I colpi
dovevano essere pi leggeri ma pi veloci. Non cera nessun bi-
sogno di spaccare un tronco fino al cuore. Troppa fatica e al-
trettanta per liberare la lama che veniva come risucchiata dalle
profondit di quella carne macellata.
Piuttosto era meglio mozzare un braccio e aprire appena
una fronte per lasciare morire dissanguati quei cani maledetti.
::
Una sera, mentre ripulivo lascia dal sangue raggrumato, mi ac-
corsi che non solo la legna ma anche la carne umana fa perde-
re il filo alla lama. Non mi ricordavo da quanto non tornavo a
casa e quando arrivai nella piazzetta vidi la porta e le finestre
sbarrate. Mi arrampicai sul muro dellortale e trovai sbarrata
anche la porta del giardino, ma la ruota della mola era accanto
al pozzo. Mi dimenticai di tutto mentre la lama fischiava e si
faceva lucida per lattrito. La saggiavo col pollice e sentivo il
metallo diventare poroso, bruciante. Come assetato.
Mia madre! Allimprovviso mi percosse il pensiero che certo
qualcuno doveva averla avvertita della morte del marito e di un
figlio. E Nina, la promessa di mio fratello, chi poteva averle
detto che si doveva considerare vedova prima delle nozze?
Le strade erano deserte e senza un lume, solo una luna alta
spaccava di fredda luce i vicoli.
Neppure labbaiare di un cane ma nel silenzio solo un fru-
sco lontano, e non poteva essere risacca poich unimbiancata
era calata sul mare. E il frusco portava verso la Cattedrale.
Sul sagrato quel suono diventava il rombo di una preghiera.
Tutte le donne di Otranto, i vecchi, i bambini, tutti quelli che
non erano sulle mura in attesa della battaglia che sarebbe rico-
minciata di l a poco, erano nella Cattedrale. Sullo scranno lar-
civescovo Stefano Agricoli a benedire il suo gregge. Sul perga-
mo cera frate Fruttuoso a predicare. Era un domenicano e lo
conoscevo bene. Spesso veniva a Csole per le dispute. Intere
giornate a discutere del filioque e poi la sera tutti insieme, a
mangiare un agnello innaffiato con il vino del casale di
Giurdignano. La Cattedrale era piena pi che nella notte del
Natale dei latini e tutti pregavano ad alta voce, solo i bambini
dormivano sulle coperte stese sul mosaico, cullati dalle avema-
ria. La Grande Madre di Otranto si era aperta a tutti: cerano i
cristiani romani, cerano quelli di San Pietro e non mi meravi-
gliai neppure di vedere le giudee e dei vecchi rabbi affollare le
navate. Tutto quello che la pace consentiva causidicamente di
dividere, ora la guerra e la certezza di un destino nefasto univa.
Forse ognuno pregava a modo suo, ma tutti pregavano lo stes-
::,
so Dio e per gli stessi motivi e con lo stesso infimo barlume di
speranza.
Mia madre la trovai con le altre donne di San Pietro stipate
nella navata di destra. Quando il suo sguardo asciutto si pos
nei miei occhi fu come se una lama gelida mi tagliasse la faccia.
Hai fatto appena in tempo, figlio, allalba sarei venuta io
a cercarti sulle mura.
Madre madre non non
Non cosa? Non volevi essere tu a dirmi della morte di tuo
padre e tuo fratello? Marco, Marco, so che sulle mura ti sei
fatto onore, che hai combattuto da uomo, ma non ci vuole
molto coraggio a uccidere quando sullaltro piatto c la certez-
za di essere uccisi. Il coraggio ci vuole quando si deve, guar-
dando negli occhi, dire parole che portano la morte nellanima.
Madre, sono stato a casa
Quale casa Marco? Non c pi nessuna casa, restano
mura e oggetti che non mi appartengono, sono di unaltra vita,
di un altro tempo. Siamo ricchi, potrei anche riscattarmi, i tur-
chi sanno bene chi siamo, le loro spie sanno chi pu pagare e
chi no, ma che vita sarebbe con un solo piatto a tavola, un
corpo solo nel letto, annegata nel silenzio.
Tratter io per te e per me, madre, ce ne andremo a
Napoli, a Venezia, dove vuoi
Non dire sciocchezze, Marco, sono troppo vecchia per
unaltra vita e abbastanza giovane da morire con dignit. La
mia famiglia fuggita per troppo tempo davanti ai turchi. Ora
basta. Sono lultima del fis di Selenica. Spero solo che quel ma-
ledetto turco che mi uccider abbia buona mira e un ferro af-
filato. Non voglio agonizzare come una capra.
Taci, non sai neppure quello che dici, riscattiamoci, fug-
giamo lontano da Otranto
Sei proprio un prete, Marco! la fede che ti d sempre
una possibilit in pi. E lavrai una possibilit. Tu, tu soltanto
fuggirai. Io so che tu devi vivere perch la memoria di noi tutti
viva. Tu dovrai sopravvivere anche ai momenti in cui la vita ti
sembrer la pi feroce delle torture e una lama la pi dolce
::c
delle carezze. Ne abbiamo parlato anche tra noi donne di San
Pietro. Fuggi, conserva le parole, conserva la memoria di
Otranto e di Csole, e non dimenticare mai il nostro sangue,
quello di tua madre sparso dalla Sava alla Voiussa e quello di
tuo padre e di tuo fratello versato sulle mura di Otranto. Potrai
andare a morire allaltro capo del mondo, figlio mio, ma ap-
parterrai sempre alla gente del Canale. Noi siamo diversi.
Non posso fuggire, non posso lasciarti, combatter sulle
mura e verr a morire con te
No. Tu ora tornerai sulle mura a combattere perch un de
Marco non si sottrae alla battaglia, ma devi stare bene attento
a non farti uccidere e a cogliere lattimo, prima che tutto sia
perduto, per metterti in salvo. Prendi questo sigillo, portalo a
Roma dove cercherai Giovanni Tornabuoni, il capo della
Compagnia de Medici in quella citt. lui che ha in custodia
il danaro della famiglia che adesso tuo.
giusto che io racconti anche di mia madre, donna Zaffiria
di Selenica e del suo singolare destino: stato come se i turchi
lavessero inseguita fino a Otranto per ucciderla. La sua fami-
glia era fuggita dal paese degli Schiavoni perch mio nonno
non si era voluto fare musulmano. Aveva combattuto con
Skanderbeg, ma quando i turchi dilagarono mise la famiglia su
un gozzo e via sul Canale. Il vecchio Arianit di Selenica era
stato voivoda di villaggi e casali dalla costa fino a Tomorrica e
gi fino alla Voiussa. La sua donna, Comita, era nipote della
madre di Skanderbeg. Tutta la storia della famiglia di mia
madre, originaria della Serbia, era una lunghissima battaglia
contro i turchi. Mio nonno, quando ero bambino, si abbando-
nava ai ricordi e mi parlava di suo padre che si era coperto di
sangue e di gloria combattendo alla Piana dei Merli.
Ero ancora in fasce e mia nonna cantava per farmi addor-
mentare:
Sir Muratte a Cssovo piomb
E come giunse breve un foglio scrisse
:::
E mandollo a Crscevo alla reggia
Al sovrano Lazaro di Serbia:
Lazaro Di Serbia imperatore
N pu darsi n accaduto mai
Che una terra sia di due padroni
Che un vassallo due tributi paghi
Imperatore, non possiamo entrambi
Mandami le chiavi ed i tributi
Lauree chiavi de le citt tutte
Il tributo di settanni interi.
Se mandarmi questo non intendi
Scendi allor di Cssovo sul campo
Il dominio partirem coi brandi
Giunto il foglio a Lazaro, ei lo scritto
guata e versa lacrime cocenti
Era un chiodo nella famiglia di mia madre quella tragedia
perduta in una calda giornata di giugno dellanno 1398. Ho
imparato a memoria la storia di Lazar, principe Hrebljanovic e
dei suoi due generi, Vuk Brancovic e Milos Obilic, eppure mi
resta sempre un dubbio su chi fu il vero eroe di quella battaglia,
se il prudente Vuk o Milos che si vot alla morte fingendosi di-
sertore e riuscendo ad assassinare il Sultano. Certo per mio
nonno era come se i settantasettemila soldati e cavalieri serbi e
albanesi, sepolti nella terra di Kosovo polje, fossero morti il gior-
no prima del suo racconto.
Abbiamo difeso la nostra Santa Ortodossia, Marco, abbia-
mo cercato di salvare le icone, le nostre terre, le nostre case, le no-
stre vite. Ma troppa la discordia nel campo cristiano, troppo di-
visa la nostra fede per reggere allurto della mezzaluna.
Arianit si lasciava andare alla memoria e, nonostante let, le
sue parole si facevano penetranti, la sua mente pi acuta.
Manc a noi cristiani il realismo della spada e lutopia del-
lunione. Luno non poteva darsi senza laltra. Le nostre fedi,
greca e latina, si divisero pi e pi volte e ogni volta che le no-
stre Chiese erano sul punto di ridiventare sorelle, i semi della
:::
discordia tornavano a generare frutti velenosi che ci indeboli-
vano fino allinsussistenza.
Cos il vecchio mi raccontava, come una favola triste, la sto-
ria della sua fuga e quando narrava dei tradimenti e delle con-
versioni alla fede di Maometto degli amici con i quali aveva
combattuto spalla a spalla, i suoi occhi si velavano di pianto.
Arianit e Comita riposavano da tempo nella terra di Otranto.
La morte aveva risparmiato loro latrocit turca.
Forse ci furono ancora un giorno o due o tre di battaglia,
non riesco a ricordare, ma rammento bene lalba del primo
giorno della seconda decade dagosto, quando le bombarde
turche tuonarono tutte insieme e le mura di Otranto gi di-
roccate si squarciarono e i turchi dilagarono travolgendo quei
pochi di noi che erano ancora in piedi. In un lampo mi ritro-
vai sotto le mura di ponente dove si apriva il cunicolo che por-
tava alle tombe dei messapi. Se la fortuna mi avesse assistito
avrei fatto a ritroso la strada che avevo percorso per entrare
nella citt assediata. Nella mia corsa non incontravo n otran-
tini n turchi. Mi lasciai a mano dritta la Cattedrale dalla quale
si levava un canto. I morti cantavano e quella follia, anzich in-
durmi a correre accanto a mia madre, mi spinse a correre an-
cora pi forte verso i sotterranei.
Non dimenticare mai il nostro sangue apparterrai sem-
pre alla gente del Canale Noi siamo diversi
Le parole di mia madre mi ronzavano nelle orecchie e mi
sentivo stranito a ripensare a quelladdio per sempre senza la-
crime e senza abbracci, freddo, duro davanti a una donna che
era stata per me vaso di ogni dolcezza e che da allora ancora
oggi mi si erge davanti come una dea della guerra e della me-
moria. Correvo senza voltarmi e per quegli strani scherzi dei ri-
cordi mi veniva in mente uno dei proverbi che avevo sentito da
piccolo da donnAnna:
Quannu rria la capeddhuta
Ggira la capu
E mmoscia la cuta
::+
Era quanto stavo facendo di fronte alla tempesta turca.
Raggiunsi ancora il mio nascondiglio di Torre Pinta.
Tuttintorno era un deserto di silenzio. Solo da Otranto arriva-
va leco lontana di un clamore ma poteva essere come quello
che si sente da lontano nei giorni delle feste in piazza. Avevo bi-
sogno di riordinare la testa, di raccogliere le idee e aspettare che
le acque si calmassero per raggiungere almeno Lecce.
Mangiavo luva appena matura e i fichi, per lacqua dovevo
scendere di notte allIdro, ma ormai mi sentivo abbastanza si-
curo. I turchi si erano abbandonati al saccheggio della citt e
ogni tanto dallaccampamento partivano i drappelli a scorrere i
casali nellentroterra.
Per due giorni, allalba, mi arrampicai sulla sommit della
torre per controllare la situazione. Il terzo giorno, il sole era an-
cora basso sul mare quando mi affacciai e contro la luce fatica-
vo a distinguere un trambusto nel campo turco. Sembrava un
corteo e, parando i raggi del sole con la mano, vidi che era
gente legata. Mi sembravano soprattutto uomini maturi e vec-
chi e i soldati li spingevano a colpi di frusta e di bastone e si ca-
piva che gridavano insulti e bestemmie. Tutti furono spinti
sulla radura alla sommit del Colle della Minerva dove su un
palco, circondato dalle sue guardie, cera Ahmed Pasci e un
altro che mi parve abbigliato come un ulema.
Questultimo parlava e parlava ma la distanza era troppa
perch potessi capire le parole. Poi i soldati cominciarono a
portare i prigionieri a uno a uno verso il religioso e a quel
punto li perdevo di vista perch una schiera di turchi li copri-
va e a ogni prigioniero che veniva portato, dopo qualche mo-
mento, si sentiva un clamore lontano e non capivo se a gridare
erano i turchi o gli otrantini. Man mano che il sole saliva, sali-
va la mia inquietudine per quella cosa che sembrava un ritua-
le, una bizzarria, una cerimonia che non solo la distanza ren-
deva incomprensibile.
Poi linquietudine divenne angoscia quando mi fu chiaro
che nessuno degli otrantini ritornava nel gruppo e neppure
usciva dallaltra parte del campo e neppure ancora era portato
::
alle navi dove erano state raggruppate le donne giovani e i ra-
gazzi che sarebbero finiti in schiavit.
Non potevo avvicinarmi al campo senza rischiare di essere
visto ma un presentimento nefasto mi attanagliava il cuore.
Aguzzavo gli occhi tanto che mi dolevano e mi doleva tutto il
corpo per la tensione che lattraversava. Doveva essere mezzo-
giorno quando nel campo turco fecero squillare le trombe del
rancio e i soldati che coprivano la vista della parte bassa del
palco di Ahmed Pasci si mossero.
Sulle prime mi colse una leggera vertigine. Un tappeto di
corpi si stendeva ai piedi del palco, intorno a una pietra che
brillava rossa di sangue ancora fresco. Pensai anche a una fan-
tasia della calura che mi attanagliava le tempie e pi aguzzavo
lo sguardo e pi quello che vedevo mi appariva irreale, persino
un corpo decapitato, stava l in mezzo, ritto, a gambe larghe e
ancora, legati gli uni agli altri, centinaia di otrantini sembrava-
no attendere imperturbabili la loro decapitazione e sembrava-
no soavemente discorrere tra loro e con i loro guardiani e salu-
tarsi come se dovessero partire per un lungo viaggio. Mille pen-
sieri mi attraversavano la mente e le mille domande che si af-
follavano sulle mia labbra si aggrumarono in una sola: a quale
mai infame ordalia i turchi stavano sottoponendo gli uomini di
Otranto? Che si trattasse del tentativo di estorcere agli otranti-
ni una conversione allIslam sulla punta della scimitarra non mi
venne in mente allepoca e non lo credo neppure adesso.
Per me quella strage resta, ancora oggi, un enigma.
::s
XVIII
Avevo assunto limpegno di fuggire, di essere il depositario
di una memoria, ma quando avevo accettato pensavo di dover
essere testimone solo di una pur cruenta battaglia, di una guer-
ra di conquista. E cos restavo immobile, inchiodato a quel-
lorrore che mi scorreva sotto gli occhi. Come avrei potuto te-
stimoniare di quellindecifrabile infamia?
Sulle prime fu naturale che mi interrogassi sul perch il mio
Dio avesse potuto lasciare accadere quel massacro, ma mentre
fissavo la massa dei corpi decapitati in un lago di sangue mi an-
davo convincendo che non la responsabilit di Dio era da ac-
certare, bens quella degli uomini.
Oggi, con un amaro sorriso che mi attraversa il volto, posso
dire che il decisivo impulso a fuggire, a salvare la mia vita, nac-
que da una disputa sulla lingua che si accese nella mia mente in
preda alla febbre. La mia citt aveva voluto essere martyr, per noi
greci un modo di essere testimoni. Io invece stavo scegliendo di
essere latinamente superstes. Un altro modo di essere testimone.
Sopravvivere per serbare memoria, per cercare le ragioni e le
cause dellorrore tra le passioni e i calcoli degli uomini.
La distruzione di Csole fu generata da una ben calcolata
macchinazione politica e cos la strage dei miei confratelli. Per
gli otrantini che morirono in battaglia non resta che la gloria e
lonore, ma per tutti quelli che si fecero massacrare sul Colle
della Minerva porto ancora oggi nel cuore il peso di un miste-
ro, il piombo di una sorta di follia. Ho studiato a lungo la dot-
trina del martirio. Conosco linsegnamento chi mi rinnegher
davanti agli uomini, io lo rinnegher davanti al Padre mio, ep-
pure proprio io che assistetti a quella memorabile strage reco
nei recessi della mia anima la sensazione di un perire sine causa.
Non stato solo il conforto di Tertulliano a farmi apparire as-
::o
surdo il martirio, ma ancora una volta mi soccorse la cono-
scenza delle parole. I carnefici erano muslim, parola che ben sa-
pevo indicare la condizione di chi totalmente si sottomette alla
volont del suo Dio. Cosa mai avrebbe potuto comprendere
della professione di fede degli otrantini un muslim? Eppure tur-
chi e otrantini, carnefici e vittime mi apparvero, e mi appaio-
no ancora, come muslim, colti da uninsania di sottomissione
assoluta ciascuno a una pretesa volont del proprio dio. Su quel
colle non cerano uomini capaci di decidere della propria vita
ma solo inumani strumenti di volont supreme e irresistibili.
Come poteva essere ben accetta la morte di tanti innocenti
otrantini a un Cristo che aveva accettato di essere ucciso per-
ch noi non fossimo uccisi? Un Dio che sdegnava il sacrificio
del capro e del toro poteva accettare che in suo nome fosse ver-
sata anche una sola goccia di incolpevole sangue?
Dovevo fuggire. Attendere la notte e fuggire lontano.
Sapevo che mi attendeva un lungo cammino. A Lecce intanto.
Se i turchi non erano arrivati fin l avrei potuto trovare ospita-
lit presso un amico, Antonio de Ferraris. Speravo che fosse a
Lecce. Eravamo diventati amici quando, al suo ritorno da
Venezia, aveva cominciato, di tanto in tanto, a frequentare
Csole. Suo zio era stato abate del monastero ma Antonio
aveva compiuto i suoi studi nel Cenobio di Nard e a Napoli,
a Ferrara e Venezia. La sua casa era a Napoli ma in Terra
dOtranto ci tornava spesso per amore: quello per la moglie, la
contessa Maria Lubelli, che al bel golfo partenopeo preferiva le
sue terre del feudo di Sanarica, il grigioverde degli ulivi, il rosso
della terra e il gelo dellacqua che vi sgorgava.
Presi la via dellinterno verso il Casale di Bagnolo e da l per
Cursi. Mi rinfrancava non vedere nelle campagne segni di di-
struzione. I turchi non erano ancora penetrati fin l. A Zollino
cercai Sergio Stiso. Era un grande amico di Csole. Aveva una
magnifica biblioteca e una piccola scuola di lingua greca. Lo
trovai che imballava libri e carte, pergamene e masserizie. I
carri gi stavano per muovere.
::
Marco, sei vivo! So tutto dellorrore di Otranto.
Gioacchino, il tuo confratello, passato di qui e mi ha detto.
La notizia che Gioacchino era vivo mi accendeva di speran-
za che qualcun altro di Csole si fosse salvato dalla strage. Stiso
mi rifocill e mi diede un abito e scarpe nuove.
Andiamo via, Marco, i turchi potrebbero essere qui da un
momento allaltro. Fuggiamo per Lecce. Ahmed Pasci, al mo-
mento, non oser attaccarla. Troveremo ospitalit dal Galateo e
poi, poi vedremo che sar delle nostre vite. Se abbiamo fortu-
na a Napoli, a Firenze o chiss. La Terra d Otranto finita, al-
meno per ora. Antonio e la contessa Maria sono al Casale di
Trepuzzi e mi hanno fatto sapere che la zona sicura e trovere-
mo ospitalit per noi e i nostri poveri libri.
A Trepuzzi infatti trovammo laccoglienza fraterna del
Galateo. I libri di Stiso vennero nascosti in alcune cisterne che
la stagione aveva lasciato asciutte. Vennero sigillate con calce e
pomice e coperte di frasche.
Avemmo cos notizie recenti da Napoli e, strano a dirsi per
me che ne venivo, dalla stessa Otranto.
Amici miei, il disastro per Otranto e Csole e Castro e
Badisco e Roca ormai compiuto. La ferocia di Maometto II
si abbattuta come non mai sugli otrantini. La resistenza della
citt ha acceso la sua vendetta e non solo battaglia c stata, ma
strage. Strage nella Cattedrale. Larcivescovo Stefano stato
massacrato e tutto il clero e le donne, i vecchi e i bambini che
vi si erano rifugiati. Il mondo di Pantaleone stato lordato del
sangue di tanti innocenti.
Pensavo a mia madre, la vedevo caduta, trafitta su quelle fi-
gure che aveva amato e che mi aveva insegnato ad amare.
Strage alla Minerva e non si riesce a capire perch. C chi
dice che gli ulema dei giannizzeri abbiano cercato di costringe-
re alla conversione i superstiti della battaglia, altri che questi
abbiano provocato i turchi con preghiere e canti, che il marti-
rio se lo siano cercato a ogni costo, altri ancora dicono che
Maometto II abbia voluto mandare un segnale che giungesse
forte fino a Roma.
::
Io che avevo visto tutto non sapevo che dire. Pensavo che
avere visto forse non basta per capire, che altri, magari senza
aver visto nulla, avrebbero dato le loro spiegazioni, avrebbero
raccontato quellefferatezza come meglio aggradava loro. Cos
lidea di mia madre e delle donne di San Pietro che io dovevo
salvarmi per conservare la memoria dei fatti di Otranto da su-
bito cominci a vacillare nella mia mente. Stiso e il Galateo
erano perplessi per il mio silenzio che appariva uninspiegabile
reticenza.
Amici miei, le circostanze hanno fatto di me un uomo
darme e mentre brandivo unascia sugli spalti di Otranto non
mi sono interrogato sullo ius ad bellume sullo ius in bello. Oggi
che i miei occhi e la mia mente sono offuscati dal ricordo di
tanto orrore non riesco a tornare uomo di lettere, anzi queste
mi appaiono ingannatrici, come le parole di Cicerone: ma
conseguita la vittoria, si debbono risparmiare coloro che du-
rante la guerra non furono n crudeli n spietati. Ma i gene-
rali turchi non devono aver letto Dei Doveri e forse non sono
i soli a non averlo fatto.
A tutto questo e alla natura di questa guerra penseremo a
tempo, Marco, limportante ora che i turchi si sono fermati.
Ho notizia che gli ordini della Porta sono che si attestino, al
momento, a Otranto senza ulteriori avanzate. Sembra anzi che
Ahmed Pasci stia per essere richiamato a Istanbul. A Napoli
fra Roberto Caracciolo preme sullAragona per una spedizione
che ricacci in mare gli infedeli. Mi dicono che stia infiamman-
do gli animi invocando una nuova peregrinatio armata per bat-
tere gli ottomani e liberare i Luoghi Santi e nelle prediche si
strappa il saio e si mostra in unarmatura da guerra. Trovate da
teatro che conosco bene, sin da quando Roberto frequentava
lAccademia del Lauro a Nard.
Se siamo nelle mani di fra Roberto andiamo bene! La sua
predicazione non dar tregua alla casa dAragona ironizz
Stiso al quale lospitalit del Galateo aveva fatto tornare il buon
umore. Altro che iuvenculus praesumptuosus come lo definiva
il Da Fossa! Caracciolo ha ben smentito il malum finem che gli
::,
aveva predetto Giovanni da Capestrano. Persino il Pontano
stato costretto ad accoglierlo nella sua Accademia.
Lascendente di Roberto sul sovrano almeno pari alla-
scendente che esercita sulle principesse di casa dAragona e
sulle nobildonne napoletane. Le sue citazioni dei padri della
Chiesa, di Cicerone, Livio, Macrobio, Plinio, Seneca, Orazio e
Persio e del Grande Aristotele commuovono non solo le menti
maschili ma soprattutto pi dun cuore femminile.
Lironia di Stiso aveva suscitato il sarcasmo del Galateo.
Alloscuro di questi lazzi cortesi, mi limitai a mettere en-
trambi al corrente delle mie missioni presso Lorenzo de Medici
e Mattia Corvino e di quanto avevo visto della distruzione di
Otranto e Csole.
Lagosto se ne finiva nella campagna di Trepuzzi con le ulti-
me vampate di calura. Le sere erano meno afose e se le conver-
sazioni mi inducevano a restare, dovevo pur decidere che cosa
fare della mia vita. Non volevo, inoltre, abusare dellospitalit
di Galateo.
Amici miei, settembre favorevole ai viaggi e uneredit
della quale non conosco la consistenza mi attende presso la fi-
liale di Roma della Compagnia de Medici. A Roma, daltra
parte, un maestro di greco e qualche altra lingua pu sperare di
sbarcare il lunario. Andr ai Santi Apostoli a cercare un vecchio
amico, Niccol Perotti, che fu segretario del Bessarione e che
potrebbe aiutarmi. A Firenze ho una promessa di ospitalit di
Lorenzo. Sono in una singolare condizione: il nulla alle spalle
e il mondo di fronte.
Stiso e Galateo insistettero perch mi fermassi. Volevano
che insieme raggiungessimo Napoli, ma la corte dAragona, per
quanto generosa verso i sapienti, sapevo che nutriva diffidenza
verso noi greci. Roma e, forse, Firenze mi apparivano mete pi
adatte. Avevo notizia che a Roma, tra la via Paolina e la strada
dei Bergamaschi, si erano stabiliti molti greci e che gi si parla-
va della possibilit che il Papa promuovesse la fondazione di un
Collegio per la nostra comunit.
Un cavallo e un po di denaro furono il viatico del Galateo.
:+c
XIX
Roma non sapevo neppure come immaginarla. Qualche
volta ne avevo sentito parlare a Csole e qualche volta da mio
padre che era sbarcato una volta alla foce del Tevere e aveva ri-
salito il fiume fino a un porto che mi sembrava di ricordare si
chiamasse Ripetta e non fu poco lo stupore per la mia buona
memoria quando, cercando il quartiere dei greci nella Citt
Santa, fui indirizzato verso la riviera di Ripetta. Roma era una
grande confusione, sembrava che tutto fosse in costruzione e
nelle vie larghe carri, folla e animali si muovevano continua-
mente. Presi alloggio in una modesta locanda sulla via Paolina
e mi diedi a cercare la sede della Compagnia de Medici che mi
venne indicata nei pressi della Dogana.
Il colloquio con Giovanni Tornabuoni fu rapido.
Messer Marco, i vostri averi sono stati salvaguardati. Gli
affari vanno tuttaltro che bene, ma Lorenzo ha disposto che
tutto quanto vi apparteneva andasse tenuto in particolare cura.
Ho suddiviso i vostri investimenti presso altri banchieri: dai
Chigi, dagli Altoviti e presso casa Strozzi, ma il grosso stato
affidato alla cura di Meliaduce Cicala, Tesoriere Generale della
Reverenda Camera Apostolica. Questi sono i vostri rendiconti.
Vostro padre vi ha lasciato ricco. Io, su incarico di Lorenzo, mi
sono adoperato per rendervi molto ricco.
Questultima frase mi lasci di stucco. Tutto avevo pensato
per la mia vita ma non la ricchezza. Sapevo che la mia famiglia
aveva vissuto nel benessere, ma non immaginavo che le fatiche
di anni di mio nonno e di mio padre ora mi avrebbero reso
ricco. Fu una singolare giornata. Uscivo dal portone della
Compagnia de Medici stranito. Ricordo vagamente di aver
camminato a lungo in Campo Marzio e da l per Parione e
:+:
Ponte e per la via Recta fino alla Mercatoria e a Ponte
SantAngelo, ma non un volto, non uno dei mirabili monu-
menti che certo avr visto rimasto nella mia memoria.
Davanti ai miei occhi cera solo la figura di mio padre, la sua
nave, i suoi magazzini, poi la nostra casa di Otranto, mia
madre, mio fratello. Quei danari erano di tutti noi e ora il de-
stino li aveva messi solo nelle mie mani. La sera nella locanda
non mi riusciva di dormire ma pi che gli schiamazzi della stra-
da era una sensazione di sgomento che mi teneva desto.
Al mattino mi incamminai per la via Paolina e pi oltre
giunsi alla chiesa dei Santi Apostoli. Erano passati dodici anni
da quando avevo visto Perotti ma i nostri rapporti epistolari
erano stati regolari, anche dopo la morte del Bessarione.
Marco, carissimo Marco, sei vivo! Quando ho saputo dei
fatti di Otranto ho pensato di avere perduto anche te oltre a
ogni speranza per la nostra causa. Sei vivo! Da non crederci con
quello che accaduto a Csole!
Raccontai a Niccol le mie vicissitudini.
Non poteva essere altrimenti, Marco, ma non era fatale.
Bessarione si battuto fino alla morte per salvare le nostre chie-
se dal Turco, giunse quasi alla rottura con Bisanzio dopo il
Concilio di Firenze, quando si accorse che limperatore
Giovanni VIII Paleologo non era in grado di difendere il pur
fragile compromesso raggiunto. Ma il Cardinale sbagliava
quando scrisse che il Paleologo e Murad II convenerunt in
unum per favorire lespansione turca. A Costantinopoli era an-
cora vivo il ricordo di quel 13 aprile 1204. Ci che accadde alla
caduta di Costantinopoli nelle mani dei latini fece scrivere a
Joffrois de Villehardouin che persino i musulmani sono
umani e benevoli a confronto di questa gente che porta la croce
di Cristo sulle spalle. La predicazione di Marco Eugenico con-
tro lUnione infiammava gli animi e poi lUnione con Roma
port rottura con Mosca, dove gli stessi greci avevano semina-
to lodio per i latini. La sorte di Constantinopoli era segnata e
anche il tentativo del Piccolomini era votato al fallimento.
Eppure Bessarione non si stanc mai di tentare una nuova
:+:
composizione tra le Chiese e un nuovo pellegrinaggio allinse-
gna della Croce. Ma invano.
Niccol, il ricordo della vostra visita a Csole e della con-
siderazione che il Bessarione mostr per me, allora umile stu-
dente, mi hanno sempre accompagnato in questi anni. Avere
conosciuto il Cardinale stato un grande privilegio. Averlo cos
poco conosciuto una grande sventura.
Hai ragione, Marco, Bessarione non uomo che si di-
mentica. Pensa che, giovanissimo, fu allievo del Cortasmeno e
del Crisococce e, a poco pi di ventanni, fu accolto nel
Cenacolo di Mistr da Giorgio Gemisto Pletone. Non solo fi-
losofia ma anche matematica, astronomia, oratoria, storia, poe-
sia. Quando ebbe la tiara di Nicea egli era il pi brillante intel-
letto dOriente.
Fu per questo che partecip al Concilio di Ferrara?
Certamente! La sua presenza, fortemente voluta da
Giovanni VIII, doveva equilibrare quella di Marco Eugenico,
avverso a ogni compromesso con i latini. Limperatore aveva un
animo singolare. Al tempo stesso confidava e diffidava di
Bessarione.
Niccol, ho letto qualcuno dei verbali del Concilio che
inviasti a Csole. Come andarono veramente le cose?
Beh, intanto su Bessarione pes molto il colpo docchio!
Il colpo docchio?
S. Larrivo a Venezia. Il corteo navale, il Bucintoro, la re-
galit di Francesco Foscari, la ricchezza della citt, la sontuosi-
t dellaccoglienza, lapertura di Rialto per fare passare le gale-
re. Bessarione cap al volo che a Occidente non cerano i bar-
bari.
I barbari?
Gi, i barbari. Perch questo si pensava dei latini a
Costantinopoli e con qualche ragione, come sai. Ma si ricre-
dette ancor pi quando iniziarono le dispute. LEugenico si li-
mitava ad arroccarsi, Bessarione invece discuteva. Infatti quan-
do a Firenze si proclam lUnione, il Cesarini lesse lAtto
Latino ed egli lAtto Greco. Da l alla porpora il passo fu breve.
:++
Eugenio IV gliela mand a Costantinopoli perch gli coprisse
le spalle.
E tu quando lo conoscesti?
Appena tornato da Costantinopoli, qui in Santi Apostoli.
Era amareggiato dal rifiuto dellUnione che dilagava fino a
Mosca e dalla minaccia incombente dei turchi. Non faceva che
dettarmi lettere per muovere a unimpresa contro gli Osman:
Francia, Castiglia, Morea, Ungheria e soprattutto Venezia
erano i suoi alleati.
Ma fin male
Malissimo. A Varna tramont ogni speranza e anche il suo
amico fraterno, Cesarini, trov la morte. Poi la mezzaluna mar-
ci sulla Morea e su Trebisonda dove cess di esistere la glorio-
sa casata dei Comneni. Tuttavia non era uomo di rassegnazio-
ne.
Lo aspettava ancora il duro colpo di Costantinopoli.
Durissimo. Ma non si diede per vinto. Diffondere le let-
tere greche e una nuova impresa militare fu la nostra occupa-
zione quotidiana. Missioni presso Alfonso dAragona, in
Germania, il Congresso di Mantova e soprattutto un continuo,
strettissimo rapporto con Pio II e Venezia.
Venezia allora non deluse il Cardinale.
No, Venezia si dissangu sullExamilion, sulle mura del-
listmo di Corinto: Bertoldo dEste, Alvise Loredan, Orsatto
Zustinian e anche il Capitano da Mar, Vettor Capello, ci la-
sciarono la vita e la tragedia del Piccolomini.
Il papa che mor ad Ancona?
Ad Ancona, a capo di unimpresa che non cera. Era ago-
nizzante e gli si tenne nascosto che nessuno aveva risposto al
suo appello e tocc al Bessarione tenere lorazione funebre. Era
la fine. Il Cardinale tent ancora inutilmente di convincere
Luigi di Francia a muovere guerra al Turco. Un viaggio gravo-
so e disperato. Ero con lui quando mor, in casa di Antonio
Dandolo, a Ravenna. Tutta una vita dedicata allo studio, alla
fede e alla guerra.
Caro il mio Niccol, ad anni di studio ho sommato le-
:+
sperienza della battaglia. Fui spettatore della disfatta dei turchi
al Campo del Pane e delle atrocit cristiane nei loro confronti,
poi ho avuto la ventura di combatterli sulle mura di Otranto e
ho visto la loro di atrocit contro i miei concittadini. La guer-
ra gi sufficiente maledizione perch si debba aggravarla con
le insegne della Croce o le bandiere delle Sure. Ma cos stato
e, da quanto intuisco, cos sar sempre. Altre fedi magari muo-
veranno altre spade e bombarde e catapulte. C sempre un
Dio degli Eserciti che sonnecchia. Guai a destarlo!
Forse hai ragione Marco, e forse stato meglio che
Bessarione abbia fallito. Daltra parte egli tent di muovere
unimpresa darmi contro il Turco con mezzi palesemente de-
stinati a fallire. Non promise ricchezze e principati a quanti sti-
molava a prendere le armi, ma us strumenti tanto sottili che
in pochi compresero le sue esortazioni.
Cosa vuoi dire Niccol? Tu stesso mi informasti delle let-
tere che il Cardinale mandava in giro magnificando le ricchez-
ze della Morea
S, lo fece qualche volta ma credette, con il suo amico
Giovanni Bacci, che fosse pi utile affidare ai libri e ai pennel-
li di maestro Piero della Francesca le sue esortazioni allunione
delle Chiese e alla battaglia contro gli infedeli. Insomma, ten-
tarono di muovere Federigo di Montefeltro allimpresa con una
piccola tavoletta sulla quale era rappresentata una singolare
Flagellazione di Cristo.
Che assurdit, Niccol, e poi perch piegare larte alla po-
litica?
E me lo chiedi proprio tu che vieni da Otranto dove il tuo
confratello Pantaleone si spezzata la schiena per costruire
quella specie di talismano politico che il mosaico della
Cattedrale? Scusami Marco, ma del tutto naturale che i tur-
chi lo lordassero del sangue dei tuoi fratelli cos come del
tutto naturale che abbiano bruciato la biblioteca e larchivio di
Csole. Il ferro e il fuoco non devono soltanto distruggere i
corpi ma anche i mezzi attraverso i quali le menti comunicano
i messaggi, costruiscono il consenso o generano il dissenso.
:+s
Ferro, fuoco e messaggio. Ciascuno di questi elementi non pu
fare a meno degli altri due se vuole raggiungere e conservare il
dominio.
E che cera di strano in questa Flagellazione?
Nulla, solo che il Cristo alla colonna rappresentava la
Chiesa colpita dal Turco, Pilato vestiva i panni di Giovanni
VIII Paleologo e in grande evidenza Bacci e Bessarione discor-
revano alla presenza di Buonconte da Montefeltro, il figlio pre-
maturamente scomparso di Federigo. Fu quel giovane che tu,
con la tua sapienza greca e latina, rammentasti a Bessarione
fino a commuoverlo.
Niccol, allora tutto perduto, il Gran Turco dilagher
nellItalia?
No, non tutto. LItalia un boccone troppo grosso anche
per il ventre di Maometto II. La Porta ha la forza militare e po-
litica per minacciare lAragona ma non Roma.
Gi, Roma non Costantinopoli.
Naturalmente! Se Roma fosse minacciata lo sarebbero
anche troppe teste coronate che dallinvestitura papale traggo-
no potere e ricchezze.
Niccol, ma perch Roma abbandon Costantinopoli al
suo destino? Nelle tante carte che mandasti per larchivio di
Csole ho trovato molte pagine sui convulsi tentativi dellulti-
mo Paleologo di assicurarsi un aiuto da Niccol V, ma mi resta
oscura la passivit latina.
Intanto Bisanzio non era pi un impero ma solo una citt.
Nella testa dellAragona poi cera semmai lidea di contendere
agli Osman quanto restava per farne un regno latino.
Non cera salvezza quindi?
Nessuna, e in verit credo che il Papa tra un Paleologo e
un Osman sul trono di Bisanzio, preferisse questultimo.
Meglio un musulmano di un ortodosso?
A conti fatti s. Alla decadenza politica e militare di
Bisanzio non aveva corrisposto una decadenza della vostra fede.
Anzi! Dalla Grecia alla Serbia e fino alla Moscovia lortodossia
aveva dilagato senza ostacoli e la mitezza di Basilio il Cieco non
:+o
ingannava Niccol V. Il pericolo per la Chiesa di Roma non ve-
niva pi da Costantinopoli ma da unaltra possibile Terza
Roma nella quale si andavano accentrando poteri immensi e
ricchezze mai viste. Meglio un cuneo musulmano a dividere le
due Chiese Sorelle!
Ma le conseguenze dellabbandono di Bisanzio al suo de-
stino stanno diventando pericolose per la stessa Chiesa latina. I
turchi sono a Otranto!
E ci resteranno, a Otranto. Al pi scorreranno le campa-
gne fino al Limitone, oltre non credibile che vadano.
Potrebbero avere lardire di tentare qualche incursione verso
Bari, ma ne dubito molto.
Tu insomma sostieni che la rovina di Otranto, come la
presa di Costantinopoli, fanno parte di un disegno concordato
tra la Chiesa latina e la Porta?
Assolutamente no! Tante e terribili sono le empiet che si
consumano oltre il Tevere, ma non si arriva a spartirsi il mondo
direttamente, come un bottino di briganti. Le intese alle volte
sono nellaria, nella logica delle cose, frutto della sagacia degli
uomini o, per cos dire, dellispirazione di Dio.
Gi, ma a Otranto a morire sono stati latini, greci ed
ebrei.
S, ma intanto di Csole restano solo qualche muro e
qualche colonna anneriti dalle fiamme, cos della Schola
Talmudica e della Sinagoga non rimasta pietra su pietra. Al
Papa tutto questo non dispiace. Per la Cattedrale invece sar
sufficiente spazzare il sangue e il letame dal mosaico per farla
ritornare al suo splendore. Quanto ai morti, a loro riservato
un glorioso futuro. Quando, prima o poi, la casa dAragona
trover conveniente andarsi a riprendere Otranto, a tutti sar
riservata laureola del martirio e della beatitudine latini. Greci
ed ebrei compresi.
Ma assurdo! Non si pu arrivare a tanto!
E perch no? La morte lunico evento nei confronti del
quale siamo tutti uguali e tu, in nome di un causidico rispetto
delle memorie dei singoli, vorresti che Santa Madre Chiesa di-
:+
stinguesse, nella sua immensa misericordia, un martire latino
da un martire greco o da un martire ebreo? Per la maggior glo-
ria di Dio queste sono piccolezze insignificanti. La Chiesa ha
sempre avuto bisogno di martiri e viviamo in una fase nella
quale scarseggiano. Vuoi che doman laltro si convochino dot-
tori e sapienti per distinguere un cranio ebreo da una tibia la-
tina o un femore greco?
:+
XX
Poco dopo lalba ero gi sulla via Flaminia in viaggio per
Firenze. Nella mia anima, dopo tanto tempo, cominciava a ger-
mogliare un grano di serenit. Quando mi fermavo a riposare
scorrevo le pagine di una Refutatio che Perotti, con toni vio-
lenti, aveva scritto contro i deliri del Trapezunte. Niccol tor-
nava, dopo pi di dieci anni, su una polemica tra questi e il
Bessarione, a dimostrazione della sua assoluta fedelt non solo
allamico ma anche alla causa platonica.
In quel viaggio per non ero in vena di meditazioni filoso-
fiche.
Il destino di Otranto, soprattutto della Santa Abbazia di
San Nicola di Csole, si era compiuto. La conversazione con
Niccol Perotti chiudeva il cerchio delle mie confuse illazioni,
del mio vano almanaccare intorno a frammenti di pensieri che
non era poi cos difficile mettere insieme per dare un senso al
disegno. Disegno non di un supremo destino ma tracciato da
mani e menti di uomini, da calcoli pi che terreni.
Procedevo al passo lungo la Cassia tra querceti e uliveti. Di
tanto in tanto un vigneto mi apriva lorizzonte di una campa-
gna ondulata attraversata da torrenti nascosti nellintrico delle
macchie. Il locandiere che mi serv vino e minestra mi disse che
eravamo appena a unora di cavallo da Siena. Ero incerto tra il
fermarmi a riposare nella quiete di quella campagna o cercare
un alloggio in citt. Mi risolsi col chiedere una stanza e ne ebbi
un saccone in terra appena sopra la stalla, che lodore delluri-
na e del letame era tanto forte da non farmi dormire. Neppure
la brocca di vino alla quale attingevo mi faceva trovare il sonno,
anzi mi prese come una febbre agitata nella quale mi tornava-
no alle orecchie le parole di Perotti, di Demetrio, di Eustazio e
ancora Kinizsi e Mattia Corvino e Lorenzo.
:+,
Fu il vino a farmi bestemmiare.
Doveri mentre i Turchi uccidevano mio padre, mia
madre, mio fratello, i miei compagni, i miei amici? Doveri
quando il fuoco divorava il mio lavoro e quello di tanti altri
come me, per secoli chini sulle pergamene? Doveri quella mat-
tina dagosto che il sangue si faceva nero al sole feroce come la
lama della scimitarra?
Urlavo, urlavo e un pianto senza lacrime mi squassava.
Singhiozzi come un vomito violento. Dal locandiere appresi
poi che per tre giorni non avevo avuto pace e che aveva persi-
no chiamato un prete temendo che fossi indemoniato e una
vecchia guaritrice di un paese vicino che lo aveva tranquillizza-
to dicendogli che il diavolo non centrava per niente e che quel
vomito che mi tormentava era lanima che si liberava di certi
umori. Per tre giorni avevo urlato, vomitato, avevo strisciato su
pavimento insozzato dalle mie stesse feci. Poi mi ero addor-
mentato tanto profondamente che sera temuto che fossi
morto.
Mi svegliai senza memoria di nulla, riposato e pieno dap-
petito. Era mattino pieno e i campi, oltre la finestra, erano
smaltati di una luce brillante, ondulati e ricchi di casali e vi-
gneti verdissimi. Una terra cos ricca, pensai, non mi era anco-
ra capitato di vederla. La cosa pi straordinaria per dovevo an-
cora vederla. Un po titubante il locandiere mi porse una scheg-
gia di specchio tutta macchiata ma sufficiente perch potessi
ammirare i miei capelli quasi del tutto bianchi.
A Siena mi fermai per cambiare cavallo e mangiare.
Camminavo per le strade ma ero come assente, leggero e quan-
do la stanchezza mi prese entrai in una chiesa a riposare. Gli
occhi mi si fissarono su una crocifissione graffita alla buona su
una lastra di marmo. Lartista aveva inciso un Cristo tutto stor-
to appeso a una croce malamente tracciata. Solo ai piedi della
croce aveva curato un po di pi le figure della Madre tra le Pie
Donne, ma ancor pi curata era unaltra figura isolata che ri-
volgeva allUomo sulla croce uno sguardo perplesso. Alla base
della croce un teschio.
:c
Lopera di vostro gradimento, messere?
La domanda che mi aveva scosso dallosservazione veniva da
un gentiluomo elegante.
No, signore, mi sembra tracciata rozzamente, solo la
Madre e questaltra figura mi sembrano meritevoli di conside-
razione.
Dite bene. Il nostro Guccio della Mannaia, che Dio abbia
piet della sua anima, non aveva tanta mano per le figure sacre,
quanta per delle singolari immagini di spettatori del sacro.
Spettatori per.
Beh, anche per il teschio ha avuto una buona mano!
Senza dubbio! La morte, la sua immagine deve essere sem-
pre presente nella Chiesa, altrimenti
Altrimenti?
Altrimenti nulla niente, le mie sono solo chiacchiere.
Ma, ditemi, siete mai stato dai monaci di San Galgano?
No, ho sentito parlare dellabbazia, ma non vi ho mai
messo piede.
Male! Dovete visitarla, non solo per la saggezza dei nostri
cistercensi, ma per vedere con i vostri occhi che cosa si pu fare
con il martirio e la morte.
Al massimo un reliquiario
Di pi. Il cranio di San Galgano stato incastrato in
unimmensa teca di rame e dargento di lavorazione finissima e
le sue orbite vuote occhieggiano tra gli smalti e i ceselli. Non
solo un reliquiario e neppure un monumento funerario. un
grande strumento scenico, un apparato teatrale. Morte e mar-
tirio. Un immenso potere fondato su questo. Un corpo senza
martirio ben misera cosa.
Per Firenze non feci pi nessuna sosta. Il cavallo lo abbeve-
ravo nei torrenti e per farlo riposare smontavo camminando al
suo fianco. Da Siena mi ero allontanato, infastidito dallo sco-
nosciuto che mi aveva importunato con i suoi vani discorsi. Mi
sentivo bene ma mi era rimasta la curiosit per quei tre giorni
di follia dei quali non avevo nessun ricordo. Mi sembrava che
::
un umore freddo mi scorresse nel petto. Mi sorprendevo del
fatto che i pensieri scorressero limpidi senza incontrare nella
mia anima appigli che potessero trattenerli. La tragedia che
aveva sconvolto la mia vita mi appariva come quei bassorilievi
che si vedono, di tanto in tanto, nelle chiese. Scene di battaglia
e martirio. Corpi e volti fermati in un momento che lo sculto-
re vorrebbe supremo ma che il pi delle volte lascia trasparire
tutta la casualit della vicenda, linnocenza feroce di chi, carne-
fice o vittima, solo corpo, strumento, vita senza pensiero, do-
lore puro, pura ferocia. Lincontro con lo sconosciuto di Siena
mi aveva infastidito pi di quanto fossi disposto ad ammette-
re. Tutta quella storia sulla teca con il teschio di San Galgano
mi fece transitare davanti agli occhi limmagine dei crani degli
otrantini ben allineati in qualche teca. Morte e martirio: un
vero trionfo. Cercavo di scacciare queste assurdit dalla mia
anima, ma il tramonto incombente popolava le selve, ai lati del
sentiero, di ombre che alludevano alloscurit che sale dalle or-
bite vuote dei teschi e incontra i nostri sguardi su una soglia di
silenzio che tacita il frastuono delle nostre filosofie.
Limperfetto blaterare della sapienza incontra laoristo di un
punto oltre il quale non c n pensiero n parola.
La mia mano corse sotto il mantello allimpugnatura della
lama, antico dono di Mauro. Non fu la paura del buio a spin-
germi. Non era fuori di me il mio avversario. Non seppi co-
gliere lattimo. Qualcosa si incepp e la lama rimase nel fode-
ro invece di penetrare veloce nel mio petto. Tra la perfezione
del silenzio e il chiacchiericcio delle filosofie avevo scelto que-
stultimo.
::
XXI
Dalla sommit di una collina la citt che tanto amavo mi
apparve allimprovviso. Era mattina alta e la luce dellautunno
segnava dolcemente le ombre. LArno scorreva tranquillo ai
miei piedi. Ormai ero in grado di riconoscere il ponte della
Carraia, le cinque arcate di Santa Trinita, il Ponte Vecchio con
le sue botteghe e, pi oltre, il Ponte alle Grazie. Smontai da ca-
vallo e restai l a riflettere su quei luoghi che mi apparvero da
subito familiari anche se la mia permanenza a Firenze non era
stata poi molto lunga.
Riconoscevo i tragitti delle mie passeggiate: Santa Maria
Novella, un po pi oltre San Lorenzo e il palazzo di Lorenzo
in via Larga, la Santissima Annunziata, lOspedale degli
Innocenti, Santa Maria del Fiore, il Battistero, Orsanmichele.
Distinguevo, con la mia vista allora buona, la Loggia della
Signoria dove avevo passato pi duna serata in piacevoli con-
versazioni e pi in l Santa Croce. Rimontai a cavallo e venni
gi quasi di galoppo per porta San Frediano, passai davanti al
Carmine e mi fermai ai giardini davanti San Felice.
Improvvisamente mi venne il dubbio se presentarmi cos da
Lorenzo o prima cercare alloggio e magari cambiarmi dabito
come la mia nuova condizione di persona facoltosa avrebbe ri-
chiesto. Dovevo proprio a Lorenzo questa nuova condizione
della quale sovente non avevo memoria.
Bentornato, Marco de Marco! Mi rincresce molto per la
sorte della Terra dOtranto, dellabbazia di San Nicola di
Csole. Dal Tornabuoni ho appreso della tristissima sorte della
vostra famiglia. Me ne dolgo con tutta la mia anima. Qui avete
casa e famiglia.
:+
Ringrazio la bont di vostra Signoria. Ho in animo infat-
ti di stabilirmi a Firenze.
Ottimamente. Vi si trover una casa adatta alle vostre ne-
cessit e al vostro censo.
Lorenzo come sempre era affabile e ospitale. Ripresi dunque
la frequentazione degli amici, le passeggiate alla villa di Poggio
a Caiano e agli Orti.
Eccolo qua, messer Marco, Glossa super Apocalipsim, parto
della fantasia di Giovanni da Viterbo, appena uscito dai torchi.
Sar Ferrante leroe delle nostre armi contro il Turco.
Lorenzo mi lanci un libriccino. Nelle sue parole sarcasmo
pi che ironia.
Caro il mio giovane otrantino, la vostra disgrazia fa aguz-
zare le penne se non lingegno dei nostri domenicani che sfor-
nano libelli per infiammare gli animi alla battaglia contro la
Porta, per la liberazione di Otranto, ma non solo. Ferrante
vuole passare il Canale, sbarcare alla Valona. pazzo! Sogna lo
scudo dAragona sul Corno dOro. Papa Sisto finalmente ha
trovato qualcosa di pi serio di cui occuparsi ma Edoardo IV e
i tedeschi gli hanno risposto picche. Il legato del Papa,
Giuliano della Rovere, inviato a Vendme, ha raccolto la devo-
zione e laffetto di Luigi XI ma non una lancia.
Non vorrei essere inseguito dalle bombarde ottomane fin
qui.
Nessuna paura, de Marco, sappiamo tutti che la salute di
Maometto II alla fine e a nulla gli servir lebreo che lo cura.
Ma pi che la malattia potrebbero essergli fatali proprio le
cure
Vostra Signoria intende dire
Nulla, nulla, ma il giovane Bajezid sembra ansioso di suc-
cedere al padre e si racconta che al-Lari, un altro dei medici del
Conquistatore, sia particolarmente fedele al penultimo degli
Osman.
Eppure, come dice Mattia Corvino, dopo ogni Osman ne
viene sempre un altro pi agguerrito e feroce.
Non detto. E comunque Bayezid avr il suo da fare dopo
:
la successione a liquidare i fedelissimi di suo fratello Gem
Sultan. Altro che campagne dItalia!
La casa dei Medici aveva locchio lungo e le orecchie avvez-
ze a cogliere ogni sussurro dallEuropa allAsia. Tutta quella po-
litica comunque mi dava noia. Preferivo la compagnia dei let-
terati e dei filosofi.
Siamo tutti greci! cos, caro Marco, siete stati voi con i
vostri maestri, Fozio, Leone il Matematico, Giovanni il
Grammatico, Arete di Cesarea e tanti altri a salvare la vostra
cultura e a trasmetterla. Proprio cos, Marco, siamo tutti greci
e ciascuno di noi ha imparato da Psello a essere un uomo, es-
sere cangiante e volubile, anima razionale che usa di un corpo,
strana mescolanza di contrari che si armonizzano
Erano queste le mie chiacchiere preferite.
A Firenze avevo ritrovato lospitalit di Lorenzo e lamicizia
affettuosa di Marsilio. Di frequente salivo alla villa di Careggi
che Piero de Medici gli aveva donato. Entrai a far parte
dellAccademia, un circolo di dotti e tra questi mi fu caro
amico Cristoforo Landino. Per me che venivo da Csole dove
tutto aveva una sua regola e una sua gerarchia, era piacevole
quellambiente libero nel quale non vi era unautorit ricono-
sciuta. La frequentazione non era determinata da altro che da
un comune sentire e da un comune amore per il sapere.
Era una mattina chiara, la tramontana lustrava i colli intor-
no a Firenze. Marsilio mi aveva invitato a restare a dormire a
Careggi e stavamo bevendo il latte che un massaro portava ap-
pena munto.
A Platone, Marco! Bisogna tornare a Platone perch la re-
ligione non diventi gretta superstizione e la filosofia iniqua ma-
lizia. Le nostre teologie finora non hanno avuto altro oggetto
che Dio. A noi il compito di riportare al centro lUomo.
Marsilio mi introdusse nel suo studio. Sullo scrittoio un fa-
scio di carte piene della sua calligrafia fitta e minuta.
Theologia Platonica. Non so ancora se sar il titolo defini-
tivo ma da Platone promana la mia teoria sullanima e lamo-
re. La prima centro della natura, intermediaria di tutte le
:s
cose, catena del mondo, volto del tutto, nodo e copula del
mondo, nata da Dio a Dio ritorna per atto damore
Vorrei avere la tua fede, Marsilio, ma non la trovo nelle
cose della vita come nella storia. Da questa mi giungono noti-
zie di dei grotteschi come quelli adorati dai miei progenitori
greci, malvagi come quelli di Egizi, Fenici e Cartaginesi. Che
dire del Dio assente degli Ebrei? Quanto al Dio dei cristiani e
a quello dei musulmani ho visto entrambi battersi con i corpi
dei loro fedeli e accenderli dira, di empiet e di ferocia e poi
lasciarli marcire, gonfi di umori pestilenziali, lordi di sangue
nero, pasto per corvi e serpenti Non c che morte in fondo,
Marsilio, morte e freddo. Come si dice dalle mie parti, panta
nifta scotinsempre notte buia
No, Marco, no
S, Marsilio, s! Solo con la propria mente e con le proprie
mani si pu costruire un piccolo riparo fragile contro il freddo
e la notte in attesa della morte C molta pi verit nel filo
di una spada che in mille volumi
Il colloquio di quella mattina rest per sempre come unom-
bra tra me e Marsilio ma senza intaccare la nostra amicizia,
anzi. La diversit radicale nel fondo delle nostre anime sembr
essere un legame ben pi forte dellaffinit. Marsilio, che
dellAcademica familia si riteneva pater, mi tratt sempre come
un figlio prediletto.
Pico lo aveva esortato a tradurre Plotino ed egli volle avva-
lersi del mio aiuto. In pochi anni ponemmo mano a
Giamblico, Proclo, Porfirio, Prisciano, Teofrasto, Sinesio,
Psello. Marsilio voleva costruire una sorta di corpus platonicum
e spesso la nostra diversit affiorava.
Marsilio, noi stiamo traducendo, occorre il rigore della
parola e della storia, non siamo come credenti di fronte a una
rivelazione
Certo, Marco, ma devi cogliere levidenza che il nostro
Platone, con ragioni pitagoriche e socratiche, segue la legge
mosaica e predice quella cristiana
:o
Non questo il punto. Non possiamo trovare nelle paro-
le antiche solo il sostegno a quanto crediamo, anzi, a quanto tu
credi oggi.
Sed tu, Bessario, accademiae lumen, medicamentum confe-
stim saluberrimum hebetibus et caligantibus oculis adhibuisti
Marco, Marco, loder in eterno il Bessarione e lo deprecher
per il fatto che quando ti conobbe giovinetto anzich lodarti
avrebbe fatto bene a darti delle nerbate.
E perch mai, Marsilio?
Perch non c studio, non c materia che non sia neces-
sario piegare a un disegno, anche riscrivendola se necessario e,
se necessario, forzandola.
Marsilio, sei matto!
Caro Marco, ci vedremo al sabato per un banchetto ri-
poso dai tormenti, rilassamento dalle preoccupazioni, cibo
dello spirito, testimonianza damore e di munificenza, lusinga
della benevolenza, condimento dellamicizia, alimento della
grazia, consolazione della vita
Marsilio, Marsilio, ma si tratta solo di una cena
Certo Marco, e tu sai quanto tengo alla misura ma non si
pu solo discettare di vita attiva, felicit e infelicit, unione di
anima e corpo
La mia vita a Firenze trascorreva cos.
Un giorno, acquistando delle risme di carta da Domenico
di Piero, ebbi notizia di una stamperia. Loccasione fu una pila
di Donatelli, elementari grammatiche latine scritte da un certo
Donati. Sfogliandone una copia appresi che uscivano dai tor-
chi delle suore domenicane apud sanctum Iacobum de Ripoli ma
lo stabilimento era in via della Scala. Fu cos che conobbi suor
Angela dei Rucellai, suor Lucrezia dei Panciatichi e Domenico
da Pistoia, procuratore del convento, e frate Pietro da Pisa,
confessore del monastero. Era questultimo persona di grandis-
simo spirito e, pur senza tradire il segreto, mi fece molto ride-
re dellaffollamento di sante monache davanti al suo confessio-
nale dopo la composizione del Morgante, che tuttavia fu nulla
:
a fronte di quel che accadde il 13 maggio 1484, quanto dai
santi torchi di via della Scala vennero fuori le copie della prima
edizione a stampa del Decamerone. Nel negozio di carte e libri
di Domenico di Piero conobbi Benedetto Dei. Di lui avevo
sentito parlare nei modi pi svariati: spia, avventuriero, com-
merciante, cronista.
Messer Marco, non siamo mai stati presentati ma sappia-
mo qualcosa luno dellaltro. Siete da poco a Firenze e permet-
tetemi di farvi omaggio di qualcosa che possa tornarvi utile alla
vita in questa citt. Vi troverete anche qualche spiegazione delle
vicende che vi hanno di recente tanto travagliato.
Passai cos diversi giorni a leggere la Cronica Fiorentina dal
9 Dicembre 1434 al 1480. Dei era di una minuziosit che a
tratti trovavo estenuante, ma mai mi capitato di leggere pi
precisa descrizione di citt e mai tanto amore per una citt ho
visto trasparire come dalle pagine di Dei. Era vissuto a lungo a
Istanbul e appariva chiaro che vi aveva svolto il ruolo di spia per
conto dei Medici e di agente provocatore in danno di Venezia.
Mi capit di incontrarlo ancora.
Vi ho letto con grande piacere, messer Benedetto, e ho ap-
prezzato il vostro amore per Firenze non solo nel descriverla ma
anche nellagire negli interessi della Signoria dei Medici.
Vedete messer Marco, nella mia vita ho amato solo due
cose, Firenze e il danaro, e ho cercato il modo di coniugare en-
trambe le mie passioni e lho fatto nellunica maniera che po-
tesse rendere queste passioni interessanti. Correndo lavventu-
ra e rischiando persino la vita. Quanto allo scrivere, diventa-
to il diletto della mia vecchiaia.
Vi dilettate egregiamente
Siete generoso con me ma, sapete, chi per anni ha dovu-
to scrivere dissimulando e cifrando e rendendo chiaro a po-
chissimi ci che doveva restare oscuro a eventuali occhi indi-
screti ha una padronanza della lingua non comune. Non c
scuola migliore per la scrittura che il mestiere di spia.
Rimasi imbarazzato per quella improvvisa sincerit.
Via, messer Marco, nessun imbarazzo tra noi! Avete tra-
:
scorso anni nellarchivio di Csole a leggere soprattutto rap-
porti di spie, a riordinare le trame che Bisanzio prima e
Bessarione poi ordivano per ora riunire, ora dividere le due
Chiese sullinteresse del momento, per tentare di ricacciare i
turchi, rafforzare ora Firenze, ora Venezia, indebolire ora il
Papa, ora lAragona. Tuttavia, permettetemi, come spia non
siete molto accorto. Lorenzo stato sincero con voi quando
siete venuto la prima volta a Firenze ma sarebbe bastato che voi
aveste osservato con maggior cura i disegni preparatori di
Bertoldo di Giovanni per la medaglia che il Medici aveva in
animo di inviare al Sultano per capire che la sorte di Otranto
era segnata.
In effetti ricordo che Lorenzo mi mostr quei disegni ma
essi mi parvero soltanto un po troppo encomiastici.
Errore, messer Marco, errore! Una scritta recitava
Mahumet, Asie ac Trapezuntis Magneque Gretie Imperator.
Capite, messer Marco, Magneque Gretie... Poteva essere lim-
presa di Rodi o quella di Otranto. Saggissima ambiguit. Per il
Gran Turco era il segnale dellaccordo di Firenze, dopo quello
di Venezia, a colpire lAragona, a invadere la Terra dOtranto.
:,
XXII
Peccato che questa morte non abbia rimandato il mio caso
almeno fino a quando avessi potuto completare la vostra bi-
blioteca!
Furono Pico e Poliziano, presenti alla morte di Lorenzo, in
quel pomeriggio daprile dellanno 1492, a riferirmi le testuali
parole del signore di Firenze ormai in agonia.
la vostra biblioteca, dunque, la biblioteca che Lorenzo ar-
ricchiva giorno dopo giorno per noi, per i suoi amici,
Poliziano, Pico, Marsilio e tanti altri. Lo stesso Pico mi aveva
riferito dellintenzione manifestata da Lorenzo due mesi prima
di morire di affidare le cose della politica al figlio Piero per po-
tersi dedicare completamente ai suoi studi prediletti.
La biblioteca di Lorenzo, per tutti i miei anni fiorentini, fu
per me pi casa della mia casa, pi rifugio e porto sicuro che le
braccia di una donna, famiglia pi di una famiglia. In essa si
era accumulato il patrimonio di Cosimo il Vecchio, dei figli di
lui, Piero e Giovanni. Immense erano state le acquisizioni di
Lorenzo che aveva provveduto allinvio di agenti ovunque. E io
fui tra questi. Poi vennero acquisite intere biblioteche, quella
ricchissima di Francesco Filelfo con opere di Aristotele,
Diodoro Siculo, Eschilo, Sofocle, Euripide, Plutarco,
Senofonte e il raffinatissimo De animi recreatione dello stesso
Filelfo. Appena due anni prima della morte di Lorenzo, gli
eredi di Francesco Sassetti cedettero al nostro benefattore ben
sessantasette volumi: Agostino e Gerolamo e il De opificio Dei
di Lattanzio e le Epistulae di Paolino da Nola. Ma il vecchio
Sassetti non si dilettava solo di religione. Ricordo che catalo-
gammo diversi lirici: Catullo, Properzio, Tibullo; alcuni satiri-
ci: Orazio, Giovenale, Persio e ancora tragedie di Seneca e poe-
metti di Claudiano.
:sc
Le sostanze che avevo ereditato mi consentivano una vita
agiata e, libero dalla costrizione di guadagnarmi il pane, pote-
vo, grazie alla benevolenza di Lorenzo, dedicarmi completa-
mente allo studio. Le frequenti incursioni del signore nella sua
biblioteca che considerava a disposizione di tutti i suoi amici e
la stessa presenza di tanti sapienti creavano molto disordine. A
me, che ero tra i pi giovani, venne affidato lincarico di man-
tenere una parvenza di ordine.
Fu cos che scoprii che una biblioteca deve avere un fine
preciso. A Csole la biblioteca era una sorta di insano tentativo
di raccogliere ogni scibile, di tenere aperta ogni strada, di la-
sciare allo studioso un infinito arco di possibilit. I Medici non
la pensavano cos. Da Cosimo a Lorenzo, si capiva chiaramen-
te che vi era unidea precisa degli studi.
Negli scaffali dove erano conservati i libri di Cosimo il bloc-
co maggiore erano gli storici e i filosofi latini. Tra i primi Livio,
Cesare, Curzio Rufo, Valerio Massimo, Sallustio, Giustino,
Eusebio, Svetonio, Tacito. Per i secondi non vi era divisione tra
cristiani e pagani: le Tusculanae Disputationes si appoggiavano
a una copia dei Moralia di Gregorio Magno e il De falsa
Religione sosteneva il De finibus bonorum et malorum. Cosimo
non amava i poeti. Pochi, e tra questi soprattutto autori come
Virgilio adatti a essere interpretati in forme filosofiche e cri-
stiane, secondo la moda del tempo. Anche in Piero si evinceva
un passione per i filosofi e gli storici ma tra questi, con mia
grande soddisfazione, comparivano i primi volumi di autori
greci. Lorenzo voleva che si rispettasse il canone che Tommaso
Peretuncelli aveva stabilito per Cosimo: teologia e filosofia al
vertice, tutto il resto a seguire.
Tuttavia lincarico pi delicato che il signore di Firenze volle
affidarmi, e non a caso, fu di tenere i contatti con Giano
Lascaris del quale intanto ero divenuto amico fraterno. Giano
viaggiava alla ricerca di manoscritti greci; almeno questo era,
come diceva Lorenzo, pretexto virtuoso et non inutile, ma nella
sua ricerca doveva raccogliere informazioni politiche e militari
utili alla casa dei Medici. Io stesso gli consigliai di visitare, sulla
:s:
via per la Grecia, le biblioteche di Terra dOtranto: di Sergio
Stiso a Zollino e a Corigliano e Monte Sardo. Cominciarono
cos ad arrivare manoscritti da Corf, Tessalonica, Serre,
Monte Athos, Tessaglia e Creta. Pico e Poliziano furono spedi-
ti nelle Romagne e a Venezia nellintento, fallito, di mettere le
mani sulla biblioteca del Bessarione.
Csole! Man mano che le casse di libri, spediti da Giano, ar-
rivavano mi sembrava di tornare indietro nel tempo, alla mia
giovinezza tra le mura dellabbazia solide e sicure.
Solo unaltra volta nel corso della mia ormai lunga vita sono
tornato a ricordare la tragedia di Otranto. stato quando
Lorenzo de Medici mi invi a Pavia presso un certo convento per
copiare alcuni manoscritti dei quali aveva necessit per la sua bi-
blioteca. Recavo una sua lettera di presentazione per la badessa.
Ella mi ricevette con cortesia. Era una donna minuta e let
e il suo stato religioso non avevano cancellato del tutto i segni
di una certa bellezza. Il suo sguardo aveva la stanca limpidezza
di chi ha molto letto e molto studiato.
Sono Marco de Marco, al servizio di sua signoria Lorenzo
de Medici, inviato a copiare i manoscritti che trover elencati
nella lettera
Mi guardava accigliata e senza una parola, poi proruppe:
Un dilettante, solo un dilettante, bibliomane e vanitoso.
Questo il tuo signore, vanaglorioso raccoglitore di carte e libri
che non legge, che si fa raccontare da voi, che si fa riassumere
dalle sue amanti o dai suoi paggi. Oh povero Lorenzo! Avrebbe
potuto essere un sapiente, un saggio, forse anche uno scrittore
o un filosofo e invece solo un raccoglitore di libri, un frivo-
lo conversatore. Maledetta la politica che lo ha avvelenato e il
potere che lo ha accecato con le sue vane contese.
Rimasi interdetto per quellinvettiva. Tacevo non osando ri-
battere. Ero confuso di fronte a tanta furia, con tanta autorit
palesata.
La signora si accorse del mio imbarazzo, della mia confu-
sione.
:s:
Va bene, va bene, non preoccuparti, Marco, rimprovero
Lorenzo da anni e da anni non mi ascolta ma ti consentir
ugualmente di copiare per lui.
Venni sistemato in uno scrittoio, in una immensa bibliote-
ca. Uno stuolo di novizie lavorava intorno a me, erano giovani
e leggevano, copiavano, restauravano volumi, carte, pergamene
antichissime. Ogni tanto la signora passava tra i banchi, sorve-
gliava il lavoro di tutti, con voce sommessa consigliava, correg-
geva, esortava.
Il lavoro delle novizie era perennemente interrotto.
Cominciava dopo Prima, ma gi veniva sospeso per le preghie-
re di Terza, Sesta e Nona.
Al Vespro la giornata di lavoro era considerata conclusa e re-
stavo da solo a copiare. Dovevo fare in fretta e solo un po di
cibo e di sonno erano le mie pause.
Era notte alta e la testa mi ciondolava sullo scrittoio quan-
do la signora apparve davanti a me.
Ancora qui, Marco? Hai un buon allenamento alla scrit-
tura e non parli come i fiorentini. Da dove vieni?
Da molto lontano, signora, da Otranto, una citt sul
mare, nel regno dAragona fuggii da essa quando venne
presa dai turchi e non vi ho mai pi fatto ritorno.
Il suo sguardo si fece improvvisamente penetrante, mi fissa-
va negli occhi come se dovesse riconoscermi per avermi forse
incontrato in un altro tempo.
Otranto, Otranto, ma Otranto non esiste pi, Marco de
Marco, tu vieni dal nulla, Otranto solo un brandello di me-
moria per chi lha conosciuta una volta. Ora non c pi nes-
suna citt di nome Otranto.
Non vorrei contraddirti, signora, ma Otranto esiste, esi-
ste ancora oltre le sue sventure, venne riconquistata lanno
dopo la sua distruzione e mi si dice che sia tornata a vivere li-
bera
Ti sbagli, Marco! Forse, affacciato sul mare di Puglia, esi-
ste un borgo che si fregia del nome di Otranto, che usurpa il
nome di una citt leggendaria per la sua sapienza, per la dot-
:s+
trina dei suoi monasteri e delle sue scuole talmudiche, ma
Otranto, quella Otranto, la mia Otranto non esiste pi.
La tua Otranto, signora?
S, la mia Otranto. La mia famiglia aveva interessi in quel-
le terre e la mia giovinezza trascorsa anche l. Venivo da que-
sta citt nebbiosa e l, appena fanciulla, conobbi la luce, la fe-
rocia del sole, lazzurro implacabile del cielo e nelle notti lu-
centi di stelle conobbi la dolcezza dellamore, il languore della
passione appagata.
Abbassai intimidito lo sguardo. Se ne accorse.
No, Marco, nessun pudore ormai, dopo tanti anni.
Stiamo parlando di unaltra vita nella quale cera spazio per il
mare e per lamore e la musica e il canto. A Otranto ho vissu-
to libera dagli obblighi del mio rango che invece qui, a Pavia,
rinserravano le mie membra, il mio cuore, la mia intelligenza.
A Otranto potevo frequentare il porto come una ragazza del
popolo e dal popolo minuto venivano i miei amici, le mie com-
pagne di gioco. Mio padre, grande mercante, trattava solo con
i maggiorenti, don Francesco Zurlo, don Giovanni de li
Falconi, il vescovo, ma mi lasciava a correre sul mare con i figli
dei pescatori: Cola, Nachira, Alfio, Antonello e la piccola
Idrusa, la mia amica pi cara. Al pari di loro mi era permesso
luscire scalza e, come loro, lasciavo che la pelle si cuocesse nel
sole. Avevo sedici anni quando Antonello dAlessandro si ac-
corse di me. Io in verit da tempo mi consumavo per i suoi ric-
cioli neri e i suoi occhi lucenti. Fu la mia veste bagnata, incol-
lata al corpo, dopo un bagno alla Palaca a far s che Antonello
scoprisse che la goffa bambina aveva ormai un seno e gambe
forti e nervose e fianchi morbidi. E fu impazzimento, amore
furioso come solo nellet pi giovane pu essere, quando solo
i corpi dominano i sentimenti e lintelletto. Me ne volavo da
casa allalba tra gli strepiti delle fantesche e tornavo al tramon-
to incurante dei loro mugugni. Mio padre era troppo preso dai
suoi affari per far caso a me e poi perch mai si sarebbe dovu-
to preoccupare di una figlia che per casa cantava come un
merlo e rideva forte e faceva i gradini a quattro a quattro? Forse
:s
pensava che al ritorno a Pavia sarebbe venuto il momento del
freddo, della nebbia e delleducazione, ma intanto mi godessi il
sole e il mare. Perch a quello e solo a quello attribuiva la mia
esaltazione.
Interruppi il fiume delle sue parole.
Antonello, ma con Antonello dAlessandro ero amico e
con Cola e Nachira e Alfio, eravamo piccoli e cero anchio al
porto e a correre tra i vicoli e a pescare allOrte. Almeno fino a
quando non entrai a Csole.
A Csole? Marco, a Csole?
Sembrava stupita e subito si avvicin al tavolo per osservare
la mia scrittura.
A Csole, Marco! Avrei dovuto capirlo subito che venivi
da l, chiaro, chiaro dalla tua scrittura, limpida e piana come
solo a Csole si insegnava. Tu vieni da Csole, vieni da un
regno di saggezza e sapienza. Povero Marco
S signora, fui tra i pochissimi a scampare al massacro.
Oh s, il massacro, il sangue, il martirio Non vidi nulla
di quellorrore. Quando le prime vele turche si affacciarono sul
Canale mio padre mi costrinse a fuggire. Una scorta gir il
paese fino a quando non mi scovarono in un aranceto presso la
cattedrale. Ero con Antonello e persi nel nostro amore nulla sa-
pevamo di turchi e Aragonesi e Maometto II e Ferrante e sure
e bibbie. La nostra battaglia e la nostra preghiera erano solo i
nostri corpi e i nostri occhi che annegavano gli uni negli altri.
Mi portarono via che urlavo e scalciavo e venni condotta al si-
curo nel Casale di Maglie. Non ho mai pi rivisto Otranto. La
mia famiglia torn qui e qui sono nata unaltra volta. Ebbi no-
tizia che non uno dei miei amici era sfuggito alla morte ma di
un nome solo mi importava e anche di lui seppi che una sci-
mitarra aveva aperto il suo petto liscio e abbronzato. Morii e
nacqui ancora una volta. Il mio corpo mor e nacque la mia
testa. Il convento era una buona soluzione e lo studio, i libri, le
carte, le pergamene. Ti sei macchiato di una grave colpa,
Marco, stanotte hai riportato alla memoria i fantasmi di unal-
tra vita.
:ss
Ti chiedo perdono, signora, di essere stato involontaria
causa di un dolore ma, se pu consolarti dividere con me una
parte di questo dolore, sappi che anchio perdetti famiglia,
amici e confratelli e la mia citt, la mia terra.
No Marco, nessun dolore ormai. Per provare dolore ne-
cessario che il corpo sia vivo, che le sue passioni non siano del
tutto spente. Da tempo altre passioni mi percorrono. Qui rac-
colgo parole, parole scritte. Le mie novizie sono perennemente
in viaggio. Cercano i sapienti, i letterati, i filosofi e chiedono
loro i manoscritti o almeno la promessa che, alla loro morte, sia
gi disposta la consegna al convento delle loro carte. Questa
ora la mia passione e la notte mi aggiro tra queste carte e le
ombre di chi ha scritto si levano dal fondo dei fogli a farmi
compagnia.
:so
XXIII
Era un inizio dottobre gi freddo e di piogge. LArno sera
ingrossato che pareva inverno pieno. Laria era quella delle cose
che finiscono: la stagione, lanno, il secolo e chiss quantaltro.
E Marsilio mor. Ci ritrovammo a murarlo in Santa Maria del
Fiore. Barbaro, Pico e Poliziano lo avevano preceduto di qual-
che anno. Niccol Machiavelli, il mio amico segretario, pur sa-
pendo quanto Marsilio mi fosse caro, non si fece vedere e nep-
pure mi scrisse. Qualche giorno prima avevamo avuto una di-
scussione che era finita in un alterco. La causa era stata la messa
a morte del capitano di ventura Paolo Vitelli per i fatti di Pisa.
In Palazzo Vecchio si erano incarogniti per le burle di Carlo
VIII. Il francese, dopo solenne promessa di restituire alla
Repubblica tutte le citt perdute da Piero de Medici, aveva
venduto Sarzana ai genovesi per trentamila ducati, ceduto
Pietrasanta ai lucchesi e Montepulciano a Siena. Pisa era una
piazzaforte vitale per Firenze e il Valois aveva pensato bene di
lucrare altri ventimila ducati e cederla ai pisani stessi.
Niccol sera battuto allora per unazione militare, ma
Firenze non aveva esercito n un condottiero in grado di por-
tare a buon fine la guerra. Fu indispensabile comprare luno e
laltro. In quei giorni Niccol si assunse gran parte della re-
sponsabilit delle decisioni. Lassedio and per le lunghe e
quando la malaria colp pi dellartiglieria pisana, Vitelli deci-
se di togliere il campo. Niccol fece in modo che fosse accusa-
to di tradimento. Con la tortura cercarono di estorcergli la con-
fessione di essere stato corrotto dal Duca di Milano, ma Vitelli
non confess. Niente prove dunque, ma Niccol pretese, tra lo
sdegno di molti, che fosse messo a morte. Le voci correvano ed
ero allarmato per il comportamento del mio amico segretario.
Con difficolt riuscii a ottenere udienza.
:s
Mi ricevette senza alzare gli occhi dalle carte che ingombra-
vano il suo tavolo tra un via vai di persone. Chiesi di parlargli
da solo ma non me lo concesse. Cercai di dirgli che non si
manda a morte qualcuno per un errore e che lerrore era stato
pi suo che del Vitelli nel sottovalutare la forza dei pisani ac-
cresciuta dal fatto che questi si battevano per difendere le loro
case mentre gli uomini del Vitelli lo facevano per il soldo.
Tradimento, messer Marco, tradimento!
Non c prova del tradimento, Niccol.
Non importa. Vitelli ha causato un gran danno a Firenze
e merita infinito castigo.
Questa solo vendetta, ottusa vendetta!
Senza accorgermene avevo urlato. I funzionari erano immo-
bili e fissavano ora me, in piedi davanti allo scrittoio, ora
Niccol, seduto con gli occhi sulle carte. Poi quegli occhi si le-
varono fino a configgersi nei miei.
Messer Marco, la vostra presenza a Firenze ci infinita-
mente gradita, ma non immischiatevi in politica, cosa della
quale siete digiuno e tanto meno in faccende di guerra. Per
quello che ne so, lunica volta che avete combattuto sugli spal-
ti di Otranto siete fuggito davanti alle alabarde di Ahmed
Pasci
Piccolo bastardo, ingrato, tronfio segretario di una tronfia
repubblichetta
Non una parola di pi, messer Marco, altrimenti sar co-
stretto a farvi arrestare.
Uscii sbattendo la porta.
Firenze mi stava morendo nel cuore. Nel volgere di pochis-
simo tempo Piero aveva dissolto la sottile trama alla quale
Lorenzo aveva dedicato tutta la sua vita. Quel principato in
forma di repubblica che aveva reso Firenze potente oltre le sue
reali forze era ormai dissolto. Senza Barbaro, Poliziano, Pico e,
in ultimo, Marsilio la citt mi era muta. Michelangelo se nera
fuggito dopo la morte di Lorenzo. Lo ricordo ancora quel ra-
gazzo con la faccia storta. Lorenzo lo accolse nel Giardino di
:s
San Marco chera scappato dal Ghirlandaio dovera a bottega.
Aveva fatto lite con mastro Domenico che gli negava di stu-
diare certi suoi modelli. Lo vedevamo passare le ore a osserva-
re gli ornati e quelle statue antiche che i Medici si facevano por-
tare da Roma e cominci a rifarle tali e quali, anzi migliori, che
migliore mano degli antichi aveva sul marmo. Per Lorenzo fece
una battaglia di Centauri, ma mai la finiva e se pure il Nostro
se la voleva portare a casa, il ragazzo rimandava sempre, sem-
pre diceva che cera qualcosa da finire e il tempo pass tanto
che il Medici mor senza quel marmo che quando andavamo
alla bottega del Buonarroti non si stancava di ammirare.
Michelangelo divenne tanto abile nel copiare gli antichi che
tutta Firenze rise della beffa che tent al Riario vendendogli per
antico un Cupido addormentato che aveva fatto. Ma rise bene
il Cardinale che se naccorse e glielo rifiut. Leonardo era sem-
pre pi impegnato a Milano in un suo affresco in Santa Maria
delle Grazie, i figli del Pollaiolo se nerano andati a morire a
Roma, quanto a un altro amico, il Botticelli, da tempo viveva
rinchiuso nel suo studio, sempre pi incupito, intento a dipin-
gere certe sue storie di donne illustri.
Gi dopo la cacciata di Piero mera toccato di assistere, im-
potente, al saccheggio del palazzo di via Larga. Non era stato
come le fiamme dei turchi per la biblioteca di Csole e per for-
tuna al popolaccio interessavano pi gli arredi che i libri, ma la
Signoria decise che tutte le opere fossero chiuse in casse sigilla-
te e portate nel convento di San Marco. Qualche anno dopo i
libri tornarono al loro posto, anzi, con il Lascaris e Bartolomeo
de Ciai ci adoperammo per recuperare quelli rimasti da Pico,
a casa di Poliziano, alla chiesa di San Lorenzo. Fu un lavoro in-
grato che ci cost anche i sospetti di avere trafugato pi di vo-
lume. Accuse false come dimostra la numerazione stilata, anche
da me, nellanno della morte di Lorenzo, segnando, come da
sue istruzioni, la prima e lultima pagina di ogni volume. Forse
la biblioteca era tornata a essere la stessa, ma ero io a essere
cambiato. Unamarezza sorda mi prendeva nellaggirarmi in
quella sala terrena di via Larga. E poi regnava un cupo silenzio,
:s,
proprio quello che si addice a una biblioteca. Ai tempi di
Lorenzo era piena di voci, di dispute accese, di lazzi. I libri si
studiavano, ma tra i libri si viveva. Ora ben un terzo della bi-
blioteca finiva nella disponibilit di Iacopo e Alamanno Salviati
per motivi che neppure volli sapere. Un immenso patrimonio
rischiava cos di andare disperso.
La lite con Niccol Machiavelli, il suo cinismo e la durezza
con la quale mi aveva trattato stavano colmando la misura.
Partire dunque, cercare un altro cielo, unaltra citt, altri amici.
Ma dove?
La scelta non era facile con gli eserciti di Luigi XII che scor-
razzavano per lItalia.
Di Roma neanche a parlarne. I Borgia lavevano ridotta a
una cloaca di sangue.
Volevo liberarmi dalla cappa dangoscia di Firenze, di quegli
anni infestati di Arrabbiati e Piagnoni, di congiure e violenze.
Marsilio, il pi dotto dei dotti, era stato il mio grande amico
ma laverlo visto passare disinvoltamente, lui, pi mediceo dei
Medici, al sostegno della Repubblica e ancora dal plauso al
Savonarola alloffesa della sua memoria mi faceva ripensare a
Demetrio, il mio maestro nellarchivio di Csole, ai suoi inse-
gnamenti sul potere e la politica che precipitano luomo nella
follia.
Ripensavo cos a Otranto, ormai sotto il controllo della
Serenissima, ma mi sembr un posto pi adatto per morire che
per vivere. Non era ancora tempo.
Avevo quarantasette anni. A Firenze avevo trascorso quasi
ventanni della mia vita.
Fu, ancora una volta, la sorte a decidere il mio destino.
La lettera arriv portata da un corriere da Roma. Avevo sen-
tito spesso parlare di Pietro Bembo, la sua fama di dotto era
ben diffusa a Firenze. In molte pagine mi diceva della sua
preoccupazione per la biblioteca del Bessarione. Il Cardinale,
ben prima della sua morte, laveva donata alla Serenissima. I
:oc
volumi giacevano in decine e decine di casse chiuse in una stan-
za di Palazzo Ducale. La Signoria non si decideva a dare defi-
nitiva e congrua sistemazione ai libri nellarea di San Marco,
come stabilito nella donazione, in ipsa ecclesia, seu apud ipsam
ecclesiam. Era quindi indispensabile vegliare sulla buona salute
dei volumi e farne accurato inventario perch non ci fossero
perdite. Il Bembo era in ansia per i frequenti prestiti che i di-
gnitari della Signoria concedevano. Insomma era molto con-
creto il pericolo della dispersione di un immenso patrimonio li-
brario. Era giunto a me attraverso la badessa pavese, alla quale
aveva confidato le sue angustie. Le continue assenze da Venezia
gli impedivano di occuparsi personalmente del lascito e la pia
e colta gentildonna gli aveva suggerito il mio nome.
Leggendo quelle pagine confesso che la fronte mi si imper-
l di sudore. La biblioteca di Bessarione! Era quasi una leggen-
da per numero e qualit dei volumi. La biblioteca di Bessarione
significava poi i tanti e tanti libri copiati a Csole che, pur nu-
merosi, dovevano essere una piccola parte di quelluniverso del
sapere che il Cardinale aveva raccolto nella sua vita. Quanto mi
fossi adoperato per la salvezza dei libri dei Medici gli era noto
e proprio per questo, nonostante Venezia pullulasse di dotti
greci, sperava non rifiutassi la mia opera per una biblioteca che
aveva come fine proprio la conservazione e la diffusione del sa-
pere della mia gente.
Al famiglio che attendeva la risposta non ebbi, per lemo-
zione, la forza di tracciare altra parola sul primo foglio che mi
capit in mano: Accetto.
Perdonate lardire, messer Marco de Marco, ma il mio pa-
drone era tanto certo della vostra risposta che queste sono le
credenziali per i Procuratori di San Marco.
Venezia era per me un mistero. Non che ne sapessi poco.
Anzi! Un diplomatico francese che avevo conosciuto a Firenze,
Philippe De Commines, me ne aveva parlato come della citt
pi splendida che avesse mai visto, che pi rendeva onore agli
ambasciatori e affermava di non aver mai visitato citt pi sa-
viamente governata.
:o:
Scrissi subito a Giovanni Maria degli Angiolelli, antico
amico dellabbazia di Csole, per chiedergli ospitalit nella sua
casa di Vicenza.
Arrivate nella Serenissima in un bel momento, caro mes-
ser Marco, la Signoria ha appena perduto Lepanto e, daltra
parte, chi buono a far quattrini non mai stato buono a far
altro! Antonio Grimani a capo di una flotta! Avrei capito se con
il Turco cera da fare affari, ma non battaglia, e di mare per
giunta! Cinquanta galere sottili, quindici grosse e trenta carac-
che gli hanno affidato e adesso la mezzaluna sventola su
Lepanto. Bel risultato! Ora lo stanno riportando a Venezia e gli
andr bene se lo esilieranno in Dalmazia, ma, colmo della fol-
lia, mandano al suo posto quel rincoglionito di Benedetto
Pesaro che partito in gran pompa e, si dice, con a bordo una
sua amante neppure ventenne. Roba da far rivoltare le ossa di
San Marco!
Sono contento di trovarvi in eccellenti condizioni ma so-
prattutto, come sempre, informatissimo
Informatissimo informatissimo quando a Venezia
non resta nulla da sapere se non pettegolezzi, ciacole, niental-
tro. Dunque venite a occuparvi dei libri del Bessarione! Poco
c mancato che andassero in cenere quando bruci lala do-
riente di Palazzo Ducale.
S, ho accolto linvito del Bembo. Firenze mi era venuta a
noia oltre ogni dire.
Gi, queste gran citt che vivono della luce dun uomo
che le innalza a grandi capitali e che, alla sua morte, precipita-
no nelle mani di qualche inetto che ha lunico pregio di porta-
re lo stesso nome. Qui a Venezia s saputo da sempre che le re-
pubbliche son meglio delle signorie e soprattutto delle signorie
mascherate da repubbliche.
Bembo mi dice che la Serenissima dovr dare una siste-
mazione definitiva alla biblioteca.
Si ciacola di come sistemare i libri del cardinale ma non si
decide nulla. Sera detto che sarebbero andati nella Sala
:o:
Novissima di Palazzo, ma gi se la sono accaparrata gli uffici dei
consigli. Si vedr. I veneziani sono tanto veloci sul mare quan-
to lenti sulla terra. Il campanile di San Marco fu offeso dal ful-
mine dieci anni fa e potrete vedere che sono ancora l a pren-
dere le misure per rifarlo.
Intanto dovr cercare una sistemazione per me.
Niente di pi facile! Ho buone relazioni con le famiglie
antiche, vi si trover casa in un lampo.
Messer Gianmaria, oggi vi ho visto in volto per la prima
volta, ma ricordo bene le vostre corrispondenze, le vostre lette-
re allIgumeno e forse ricorderete che vi scrissi da Firenze quan-
do seppi del vostro ritorno a Vicenza
E io vi risposi elusivamente, limitandomi a invitarvi nella
mia casa e ora sono felice che abbiate accettato quel lontano in-
vito.
In quella lettera vi chiedevo
Lo so, ricordo bene cosa mi chiedevate, ma non c rispo-
sta alle vostre domande. Ero sulle mura di Negroponte la mat-
tina dellultimo assalto e vidi morire mio fratello Francesco e
quando i turchi entrarono per le porte di Giudecca e Burchiana
il massacro fu grande: uomini, donne, vecchi, bambini, gli
amici Paolo Erizzo, Alvise Calbo, Giovanni Badoer, tutti truci-
dati e il bailo squartato. Mi salvai perch fui fatto schiavo.
Ma questa battaglia, messere, non assassinio.
Battaglia, assassinio, cosa volete, de Marco? Sono passati
ventanni e state ancora a interrogarvi su ottocento otrantini
passati a fil di spada mentre dallo Ionio agli stretti il mare po-
trebbe cambiare colore per il sangue che si versa! A
Negroponte, quando la battaglia fin, Maometto ordin che si
mettessero in cerchio, inginocchiati e con le mani legate, alcu-
ni prigionieri e che fossero decapitati sotto i suoi occhi. Sai
quanti erano, de Marco? Lo sai? Erano ottocento, ottocento
teste ho visto cadere!
Ma il Turco voleva che si convertissero allIslam come a
Otranto?
Ma che conversione e conversione, de Marco! State dietro
:o+
alle chiacchiere del Pontano, del Vivaldi, del Galateo, di
Giovanni Albino e Sigismondo de Conti o del mio amico
Sanudo o del Sadoleto. Li ho letti tutti come voi e ciascuno la
racconta diversa, ora per questo ora per quel particolare. Tutti
grandissimi storici e quel povero arcivescovo Stefano lo hanno
fatto morire in cento modi: chi decollato, chi squartato, chi
persino di paura e pure il nome gli hanno cambiato e ora vor-
remmo ottocento, tra giudei, latini e greci, che si fanno decol-
lare per non abbracciare il Corano? Martiri, gi si dice! Ma al-
lora potremmo fare martire tutto il Mediterraneo. Ununica
grande aureola da Gibilterra al Bosforo!
Messer Gianmaria, ma anchio ho visto con i miei occhi
Cosa avete visto? Avete visto una lama calare su un collo
ottocento volte e state ancora a chiedervi perch? Il perch
tutto in quella lama, nel fuoco e nelle martellate che lhanno
forgiata, nella pietra che ne ha affilato il taglio. Non ci sono
altri perch!
Forse non basta vedere per capire ma vorrei sapere
Cosa volete sapere voi che vivete tra i libri! Avrei voluto
avervi con me nel castello della Pazza di Dimotica
La Pazza di Dimotica?
Certo! La sorella del Conquistatore, pazza e sadica e put-
tana da fare impallidire tutte le puttane di Venezia! Bella, bel-
lissima. Si faceva chiavare dai suoi schiavi e poi li uccideva.
Quando ne aveva voglia, con le sue stesse mani. Mona e morte,
de Marco, che ne dite?
Siete aspro
Ho visto morire troppa gente perch possa credere che esi-
sta una spiegazione, un motivo, una causa. Maometto II ucci-
deva per calcolo, la sorella per divertimento. Spiegatemi la dif-
ferenza dal punto di vista della vittima!
Nessuna. Entrambe traggono origine dallempiet
dellIslam.
Empiet dellIslam? Empiet dellIslam, dite, messer
Marco? Forse avete dimenticato le pagine delle Gesta Dei per
Francos, gli orrori narrati da Fulcherio: stupri, omicidi, stragi,
:o
saccheggi e da Raimondo di Aguilers: la presa di Gerusalemme
fu un bagno di sangue che non si ebbe mai leguale e non di-
menticate che, durante la spedizione comandata dal vostro be-
nefattore Boemondo, le torme dei Tafur, i disperati al seguito
di Pietro lEremita si nutrirono anche della carne dei nemici
uccisi in battaglia. Lempiet, de Marco, non nella Croce o
nella Mezzaluna! Lempiet nellanimo di chiunque impugni
una spada. Ma queste follie le possiamo dire solo noi viaggia-
tori. Noi che abbiamo bevuto tante acque diverse e mangiato
tanti pani differenti.
Nellimmediato, grazie ai buoni uffici dellAngiolelli, trovai
ospitalit in San Zanipolo, dai domenicani.
Rialto, il Bacino di San Marco: Venezia si apr ai miei passi
con la sua sontuosa vitalit. Mi spingevo fino a San Nicol dei
Mendicoli e da l a Rio Marin dove mi incantavo a vedere la-
vorare i panni e passavo per Santa Maria dei Frari e ripassavo
Rialto per vagare alle Mercerie e ogni bottega era una mirabi-
lia degli oggetti pi strani e me ne andavo fino a San Pietro di
Castello e allArsenale.
Io il porto della mia Otranto lo ricordavo bene. Navi ne
avevo viste e persino della flotta turca avevo precisa memoria,
ma allArsenale restai incantato. Mai tante e tanto grandi e una
foresta di antenne e pennoni e artimoni e sartie e tra di esse un
brulicare di battelli di ogni dimensione e una moltitudine di
uomini intenti ai pi svariati lavori.
:os
XXIV
Non devo certo ricordare a te, Eccellentissimo Maestro, le
vicende che portarono al mio ingresso nellAccademia, la lette-
ra con la quale il Bembo mi incaricava di prendere contatti con
tuo suocero, Andrea, per il prestito dei libri del Bessarione de-
stinati alle stampe e lemozione quando, per la prima volta, mi
trovai tra tavoli di lavoro, torchi, punzoni e lincalcolabile nu-
mero di dotti che entrava e usciva e le conversazioni, le dispu-
te quando non le liti ora su uninterpretazione ora sul senso di
una frase. Una confusione apparente che rivelava invece lacu-
ta passione che tutti ci accomunava.
Chiunque tu sia, Aldo ti supplica di dire ci che ti preme
pi brevemente che puoi e di andartene subito, a meno che tu,
come Ercole allo sfinito Atlante, non voglia darci una mano
soccorrevole. Avremo sempre abbastanza lavoro per te e per
tutti quelli che vengono da queste parti.
Mai potr dimenticare il timore che il cartiglio apposto al-
lingresso dellAccademia mi procur. Avevo paura di essere
importuno e invece invece mai accoglienza fu pi affettuosa
e cordiale e mai tanta stima mi si dimostr.
Per tutto questo, carissimo Maestro, ti sar grato fintanto
che avr vita. Mai mi capiter di descrivere lAccademia come
un luogo dove cera appena il tempo di grattarsi le orecchie
o affermare che il vostro vino era annacquato e il cibo un po
di molluschi pescati nelle chiaviche. Geert non ha un buon
carattere, bisogna comprenderlo, eppure quando fu degli
Adagia e si invent quella firma Desiderius Erasmus, scelse i tor-
chi dellAccademia. Quanto alla scelta di stampare da
Frobenius di Basilea il suo libro sui Padri, so per certo che fu
:oo
corrotto con arrosti di cinghiale e vini del Rodano. Scherzo na-
turalmente.
La fratra, quella rete che Bessarione aveva tessuto per tutta
la vita, reggeva ancora a quasi ventanni dalla sua morte. Molti
di noi non si erano mai neppure visti in faccia ma tutti sapeva-
mo molto di ciascuno. Ci aveva pensato il fedele Niccol
Perotti a tenerci uniti con le sue lettere. Ritrovai Zaccaria
Calliergi, Nicola Vastos che per primi avevano stampato libri in
greco e Marco Masuro, Arsenio Apostolis, Giovanni
Gregoropulos, Demetrio Ducas. Tutti avevamo nellinsegna
dellancora e il delfino un approdo sicuro.
Inter Graecos latinissimus, inter Latinos graecissimus.
Molte volte, nelle conversazioni nelle quali tornava il nome
del Bessarione, avevo inteso questa definizione del Cardinale
coniata dal nostro maestro Lorenzo Valla. Infinite volte essa mi
ritorn in mente aprendo le casse nelle quali era custodito il te-
soro bessarioneo. Lincarico che il Bembo mi aveva affidato era
quello di una prima catalogazione delle opere.
In calumniatorem Platonis. Edizione di Sweynheym e
Pannartz di Subiaco del 1469. Copia identica del volume che
Bessarione aveva donato a Csole, ormai cenere dispersa.
Era stato il primo libro stampato che avevo avuto tra le
mani. Lo ritrovavo qui a Venezia. Linvettiva contro il
Trapezunte era solo un pretesto. Il fine invece la conciliazione
tra fede e lgos. Lo stesso per le Epistulae et orationes, che il
Cancelliere della Sorbona, Guillaume Fichet, amico fedelissi-
mo di Bessarione, aveva fatto stampare a Parigi nel 1470. Dalle
casse non venivano fuori solo libri. Lettere a Michele Apostolis
perch da Creta inviasse libri, con lo stesso fine a Teofane, ve-
scovo di Atene, ai librai Leonardo e Lamponimo. Trattative per
lacquisto da Nando Palmieri di Aversa della biblioteca di
Giovanni Aurispa. Messaggi agli scriptoria organizzati in Santi
Apostoli e a Creta, dove si alternavano alla copia Giovanni
Rhosos, Demetrio Trivizias, Giorgio Tzangaropoulos e tanti
altri.
:o
La lunga permanenza nella biblioteca di Csole e poi in
quella dei Medici mi aveva dato una grande esperienza, ma tra
i libri del Cardinale mi ritornava in mente il suo insegnamen-
to non tam multos quam optimos libros colligere. Lintera opera
di Aristotele era stata mirabilmente copiata in un unico, ele-
gantissimo manoscritto.
Pi che di catalogazione la mia era una missione di control-
lo. I Conservatori di San Marco, per ordine del Bembo, mi ave-
vano consegnato lAtto di Donazione del Bessarione. Il docu-
mento, scritto in bella rotonda e con magnifiche miniature ro-
mane, conteneva un elenco dettagliato di tutte le opere.
Index librorum utriusque linguae quos Bessario Cardinalis et
Patriarcha Costantinopolitanus Basilicae Beati Marci Venetiis dicavit.
Dovevo accertarmi che mani rapaci non avessero sottratto
nulla. Ma non riuscivo a limitarmi al controllo.
Cercai con ansia la copia della lettera inviata dal Cardinale
al doge Cristoforo Moro.
I libri sono pieni delle parole dei saggi, degli esempi degli
antichi, dei costumi, delle leggi, della religione. Vivono, di-
scorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci ammaestrano, ci
consolano
Non erano solo le parole di un dotto. Quelle righe traccia-
te ai Bagni di Viterbo alla data del 31 maggio dellanno 1468
erano piene damore.
Se non ci fossero i libri, noi saremmo tutti rozzi e ignoranti
e senza alcun ricordo del passato, senza alcun esempio; non
avremmo conoscenza alcuna delle cose umane e divine; la stes-
sa urna che accoglie i corpi cancellerebbe anche la memoria
degli uomini
La sezione dedicata ai filosofi era imponente: Alessandro di
Afrodisia, Temistio, Plotino, Proclo, Giuliano e sfogliandoli
ravvisavo i segni dello studio accurato del Cardinale. Cos per
gli storici.
Le orazioni di Demostene erano quasi logorate dalluso.
Chiss se Bessarione ne aveva tratto ispirazione per le sue ap-
passionate perorazioni contro i turchi!
:o
Poeti, tragici ed epigrammisti, pur in gran copia, non reca-
vano tracce evidenti di studio. Solo Omero sembrava letto e ri-
letto.
Opere astrologiche, matematiche, giuridiche, mediche, bo-
taniche, di erudizione.
Controllarle una per una non fu nulla rispetto allimmenso
lavoro di verifica delle opere teologiche che costituivano il gros-
so della biblioteca.
Michel, un amico francese di grandissima sapienza, mi fece
notare una volta che gli ebrei, i cananei, i samaritani, i caldei,
come tutti gli arabi e i turchi e i tartari scrivono da destra verso
sinistra mentre i greci, i georgiani, i maroniti, come tutti i lati-
ni, scrivono da sinistra verso destra. Cos nel Catai, tra i cinesi
e nel Giappone si scrive dallalto verso il basso e sembra che
nelle nuove terre scoperte oltre gli oceani la scrittura si muova
per spirali e cerchi concentrici. Piccola cosa allora la pur splen-
dida biblioteca di Bessarione! Piccola cosa scritta da sinistra
verso destra!
E mi torna in mente quella Torre di Babele nel mosaico
della Cattedrale della mia Otranto. Oggi posso dire che la con-
fusio linguarum mi appare chiaramente pi un dono che una
maledizione.
Di tanto in tanto tornavo a trovare lAngiolelli nella sua
bella casa vicentina. Nonostante lasprezza della prima conver-
sazione sulla sorte di Otranto, le parole finivano per ricadere su
quelle vicende turchesche che tanto avevano pesato sulle nostre
vite.
Ahmed Pasci! A voi otrantini non poteva capitare sorte
peggiore!
Vi capitato di conoscerlo, messer Gianmaria?
Conoscerlo dire poco, che al suo seguito fui costretto a
correre in lungo e in largo di guerra in guerra. Piccolo, scuro,
un misero ciuffo di barba, grossissimo il naso. A corte, alle sue
spalle, si rideva per la sua umile origine di staffiere. La rapida
carriera la doveva alla moglie, figlia di Ishaq Pasci, che spesso
allietava il letto del principe Mustaph. Questo fatto lo incru-
:o,
deliva e ne aumentava labiezione man mano che saliva nelle
gerarchie.
Raccontate, vi prego
Ero presente agli assedi di Selefke, di Maniaun, di Alara,
di Managvat e Lula. Ovunque stragi feroci. E quando
Maometto II gli ordin di sedare la rivolta di Tas Eli, a chi gli
fece osservare che non erano pi rimasti sudditi ai quali far pa-
gare i tributi rispose che non cera suddito pi fedele di un sud-
dito morto. Poi vi fu la Gran Festa di Caramania
Gran Festa?
S, Ahmed Pasci invit tutti i notabili di Caramania a un
grande banchetto di riconciliazione, allietato da corse di caval-
li, danze e musiche e spettacoli. Egli si cur personalmente che
una commissione di funzionari vegliasse sulla perfezione del ri-
cevimento. Al culmine della festa i suoi giannizzeri uccisero
tutti gli ospiti. Non uno usc vivo.
Anche a Csole arriv notizia di questa strage, ne giunse
una versione che mi parve un po romanzata.
Per raccontare bisogna sopravvivere. Pochi sopravviveva-
no alle spedizioni di Ahmed Pasci e quei pochi preferivano di-
menticare. Poi qualcuno si appropriava della vicenda e la col-
locava, a suo piacimento, nel tempo e nello spazio.
Al convento ci giunse qualche notizia dellassedio di
Caffa
Oh, Caffa! Qui Ahmed tocc il fondo della sua abiezione.
Quando la citt si arrese, promise a tutti libert in cambio degli
averi. Valacchi, polacchi, russi, georgiani e circassi pagarono su-
bito e subito vennero messi in ceppi e venduti per schiavi.
Latini, ebrei, greci e armeni ricevettero lordine di dichiarare i
loro averi per stabilire la tassazione. Ma non di tassa si tratt,
che tutto venne loro sottratto e i giovani fatti schiavi.
Insomma, messer Gianmaria, volete dire che Ahmed
Pasci era il visir pi crudele della Porta, che la casa di Osman
si serviva di sadici assassini?
Affatto! Il Conquistatore era un sovrano come tutti gli
altri che popolano le corti dEuropa e dAsia, come tutti iden-
:c
tificava il potere con larbitrio e massimamente si preoccupava
che la notizia di una grande carneficina qui consigliasse una
resa senza condizioni l. Ditemi, de Marco, perch mai
Francesco Contarini e otto suoi ufficiali furono tagliati a pezzi
sotto le mura di Kruja?
Devo pensare si trattasse di un messaggio
Un messaggio, bravo, un messaggio alla Serenissima e al
partito anti turco di Venezia. Un messaggio per dire: meglio
fare affari che guerra!
Cos anche la strage degli otrantini fu un messaggio?
Gi, ma il Conquistatore lo aveva fatto precedere da un
altro messaggio: la nomina di Ahmed Pasci a sangiaqbeji della
Valona. Non si manda un simile personaggio in una zona cos
remota dellimpero se non per fare capire a Venezia che la Porta
poteva chiudere lAdriatico a suo piacimento.
Ma allora Venezia era scossa dalla peste e senza alleanze,
ricordo bene la visita a Csole di Giosafat Barbaro che ci in-
form delle trattative per la pace.
Venezia era sola! Firenze e Milano erano con noi ma per
le faccenduole italiane. Il Papa e lAragona avevano altro per la
testa, Luigi IX si preoccupava solo di uneventuale alleanza tra
Venezia e la Borgogna e il Gran Turco se la godeva quando le
sue spie lo informavano che la peste si portava via quaranta ve-
neziani al giorno.
Messer Gianmaria, si diceva che i saccomanni fossero
giunti in Carinzia e al Tarvisio.
Proprio cos, ma la Porta stendeva le sue mani anche su
Cefalonia e Zacinto. Per la tua Otranto non cera speranza e
men che meno per voi di Csole!
Cosa mai potevamo noi poveri monaci di fronte agli eser-
citi ottomani?
Via, de Marco, sapete bene che di distruggere Otranto al
Conquistatore non importava un bel nulla. Eravate voi il ber-
saglio, linsidia che andava distrutta.
Messer Gianmaria, insidia un monastero, una biblioteca,
qualche traduttore e un pugno di copisti?
::
Certo! Tutto per anni al servizio del Bessarione e, dopo la
sua morte, al servizio del partito greco in Italia, tutti intenti a
tramare per convincere a unire le forze contro la Porta.
Siete la seconda persona, dopo Benedetto Dei, a rappre-
sentare Csole come un covo di spie intente a tramare
Niente di offensivo, messer Marco, da Cluny a Chartres,
da SantElia di Carbone a Csole non conosco abbazia, mona-
stero, convento e persino trappa che si sia dedicata solo alla pre-
ghiera. Ci sono tante, tantissime cose da fare ad maiorem Dei
gloriam.
A Firenze avevo frequentato botteghe di stampa ma a
Venezia sembrava che questarte fosse la pi importante delle
attivit. Locatelli, Torti, Bevilacqua, Tacuino, Pincio, De
Gregori avevano seguito gli insegnamenti di Giovanni da Spira,
ma lAccademia fu per me il luogo pi caro.
Illustre Manuzio, devo alla tua benevolenza e a quella di tua
moglie Maria, di Andrea, gli anni pi proficui della mia vita.
Ricordo bene le conversazioni per decidere della stampa di
questo o quel libro tratto dalla biblioteca del Bessarione, ma tu
assecondasti la mia inquietudine. A lavori di traduzione alter-
nasti quei viaggi a caccia di nuove tecniche di stampa, di nuovi
modelli e dei nostri contraffattori che erano tanti.
Fui a Salins, a Lione nellofficina di Maillet, da dove ripor-
tai quel Messale di Besanon che recava un falso marchio vene-
ziano, a Parigi da Nicolas Du Pr, ma andai giusto dirlo
a spiare la produzione di Gering e Friburger al Soleil dOr, nella
via di Saint Jacques. Mi rassicurai subito: messali, manuali per
confessori e altra robaccia commerciale a uso di devoti. Di
fronte, alla rue Fromentalle cerano Csar e Stoll. Ancora ro-
baccia, ma per studenti e professori. E ancora a Saint Etienne
de lIsle, in casa di Jean Crs e Robin Fouquet dove acquistai
Le songe de la Pucelle.
La concorrenza temibile veniva dalla regione tra il Reno e
::
lElba. Grninger, Schensperger, Schott e il pi temibile di
tutti: Amerbach di Basilea. Ammirai allora unedizione in un-
dici volumi che Jean de La Pierre aveva stampato delle Opere di
Agostino. La produzione teologica era forte ma poca roba
greca.
Ben presto mi resi conto che in Spagna la nuova arte sten-
tava ad affermarsi e cos in Inghilterra, ma francesi e tedeschi
avevano gi invaso il mercato con le loro opere.
A Pilsen, da Bernhard von Breydenbach comperai, per cu-
riosit, un dizionario in lingua cca, a Praga una brutta Historia
Trojanska ma mi astenni dallacquistare un Petrarca in lingua
boema.
A Cracovia, da Fiol di Franconia, ritrovai lambiente della
mia antica fede greca e mi affascinava la stampa nei caratteri ci-
rillici. Mi piacque fermarmi in quella citt dove ungheresi,
ucraini, bavaresi, alsaziani, slesiani e franconi intrecciavano
parlate e cadenze, racconti e canti. Ospite del vescovo
Warminski ne conobbi il brillante nipote, Kopernik, che aveva
studiato a Bologna, Roma e Padova e rimasi affascinato dalle
sue singolari teorie sul movimento degli astri. Non ne capivo
molto ed egli mi promise linvio di unopera alla quale stava la-
vorando. Prendemmo a frequentarci.
Una sera eravamo con alcuni conoscenti in una taverna di
fronte alla Jagelloniana quando un uomo vecchissimo e molto
malandato ci chiese di offrirgli da bere. Il vino scioglieva le lin-
gue e non fu poco il mio stupore quando questi afferm di
chiamarsi Villon e di essere poeta. Mi era capitato a Parigi di
sentir parlare di un poeta Villon, morto almeno quarantanni
prima dopo una vita sregolata nel corso della quale aveva, pi
volte, conosciuto la prigione. Fui brusco.
La coincidenza pu arrestarsi allomonimia, signore, altri-
menti devo credervi un impostore.
Via mes amis, non vi irritate, limpostura la mia profes-
sione. Di pi! La mia disciplina. Se me lo consentite, la mia
arte. Anzi direi che in questa materia, mentre lor signori sono
solo dei giovani apprendisti, io sarei Maestro e, per un altro
:+
bicchier di vino, sarei anche disponibile a insegnar loro qualche
primo rudimento.
Smettetela, ubriacone!
Dovetti placare i miei amici. Il vecchio era indisponente e
puzzava, tuttavia cera qualcosa in lui Intanto parlava france-
se. Kopernik taceva, il suo sguardo brillava di curiosit.
Ordinammo ancora da bere. Il vecchio restava in piedi accanto
al nostro tavolo suscitando limbarazzo dei miei commensali.
Il suo atteggiamento era inquietante e gli amici ben presto
lasciarono la taverna. Restammo solo io e Kopernik.
Ebbene, Villon o comunque vi chiamiate, sedete dunque,
c ancora tempo per un altro bicchiere.
Per un bicchiere c sempre tempo, signore. Potremmo
rimpiangere domani di non averlo bevuto oggi.
Daccordo. Quanto al vostro essere poeta lasciatemi ri-
spettosamente dubitare della vostra parola.
Fate bene a dubitare perch non fui poeta ma menestrel-
lo, pagliaccio e saltimbanco. La strada, le taverne e i bordelli
sono stati la mia casa, o forse no
Suvvia, signore!
E va bene, vi confesser il mio passato di agiato cortigia-
no che ha dissipato il proprio patrimonio in bottiglie di
Borgogna e fanciulle
Fanciulle, dite?
Fanciulle, mio signore, la Flora, la belle Rommaine, la gros-
se Margot. Non avete anche voi nella memoria des dames du
temps jadis?
Non del genere cui voi alludete.
Peccato, signore, che non abbiate mai conosciuto la belle
Heaulmiere.
Kopernik assisteva impassibile alla nostra strampalata con-
versazione quando luomo quasi lo aggred.
Non sarete forse prete? Il vostro bicchiere resta pieno, non
parlate e ve ne state l con laria da osservatore.
Ma che avete contro i preti?
Nulla, signore, nulla, ne uccisi uno tanti anni fa
:
Davvero? Voi un assassino?
E perch forse voi non lo siete?
La mia mano si serr con tale forza sul bicchiere da rom-
perlo. Sangue e vino lordarono il tavolo. La voce mi mor in
gola. La mano era piena di sangue. La guardavo inorridito. Il
fantasma della battaglia di Otranto entrava come un uragano
nei miei occhi mentre nelle orecchie risuonava beffarda la frase
del vecchio: Perch forse voi non lo siete? Il ghigno dello sco-
nosciuto e gli occhi impauriti di Kopernik...
Mi risvegliai sotto una tenda. Dallesterno il bagliore di un
fuoco e un canto accompagnato dal liuto.
Soient Grecques, Egipciennes
De Hongrie ou dautre pays
Espaignolles ou Cathelennes
Il nest bon bec que de Paris
Mi sentivo la testa leggera. Intorno alla mano una stretta fa-
sciatura macchiata di sangue. Mi alzai a fatica.
Oh l l, signore, questi vini di Galizia fanno brutti scher-
zi, come va la ferita?
Basta cos, piantatela!
Intorno a un grande fuoco il vecchio e Kopernik circonda-
ti da uomini e donne.
Non arrabbiatevi, signore, date piuttosto qualche soldo al
buon carrettiere che vi ha portato fin qui.
Kopernik, dove siamo?
Fuori Cracovia, messer Marco, nellaccampamento dei
Secani.
Aegyptiens, se preferite, signore. Ursula vi ha medicato, io
canticchio e il vostro giovane amico Nikolaj racconta ai begli
occhi di Sancha le sue buffe idee sul Sole.
Gli uomini avevano la pelle scura e i loro abiti erano sgar-
gianti. Le donne, dai lunghi capelli sciolti, portavano collane
doro.
:s
Via, Kopernik, andiamocene!
Il giovane si alz con evidente malincuore ma furono le mie
gambe a non obbedire.
Hai perso sangue, italiano, e poi hai messo un po di di-
sordine tra le linee della tua mano
Ursula ha ragione, dovete riposare e farvi tornare le
forze quanto alla vostra mano cerano pi vetri che ossa
Fui sistemato accanto al fuoco. Fissavo la legna che brucia-
va e mi sembrava di vedere bruciare Csole, Otranto, mia
madre, mio padre, Demetrio. Un dolore che veniva da lontano
mi attraversava il cuore come un fiume nero. Su un argine spo-
glio Alberada.
Non guardare molto il fuoco, italiano, molte vite e molto
dolore e molte strade, molte citt, molti libri troppi
Cosa sai tu di me? Di dolore, citt, strade, libri?
Ho curato la tua mano, pulito le tue ferite. Volevi cancel-
lare le linee della tua mano, tracciarne altre, ma non possibi-
le. La tua una strana mano. Mano che ha ucciso ed espiato,
che ha scritto molto ma una mano che non ha ricevuto molte
carezze e poche ne ha fatte.
cos, Ursula
Oh l l, signore, fate attenzione a Ursula, vi dir il passa-
to e, per qualche moneta, il futuro
Buon uomo, vi prego basta, basta chiacchiere, basta
Basta chiacchiere, dite? Vabbene. Ora vi fate serio per le
parole di una zingara?
Non so pi quali sono le parole giuste da ascoltare e nep-
pure quelle da dire. Ma chi sei, maledetto ubriacone?
Maledetto ubriacone. Definizione mirabile, signore, bon
follastre sarebbe anche meglio, ma potrei aggiungervi un non
insignificante particolare: il non morto. La forca era il mio de-
stino, il mio paese voleva la mia morte e la ebbe.
Accidenti a voi, ma allora chi siete?
Ma sono solo qui per servirvi, per cantarvi unaltra canzo-
ne, procurarvi una donna, una bottiglia di rosso
Vi prego
:o
Nessuno mi prega. Per me solo carcere ed esilio e fame e
freddo e vecchiaia ma
Ma?
Ma almeno una volta ebbi fortuna. Era il 1463 ed ero ap-
pena uscito dal carcere dello Chtelet quando incappai nellen-
nesima rissa. Mi trovai faccia a faccia con il marito di Ursula e
capii che il suo coltello era pi veloce del mio. Benissimo! Era
unottima occasione per uscire di scena alla grande, ma quan-
do la lama stava per spaccarmi il cuore lasciai cadere il mio col-
tello e parai il colpo con la mano.
Meraviglioso spettacolo! Sangue, sangue e sangue e ossa e
tendini e muscoli e finalmente quella mano maledetta non po-
teva pi reggere penna o calamo. Felicit immensa!
Siete pazzo!
Certo, pazzo di felicit. Divenni anchio un compagnon de
la Coquille, uno zingaro, un senza volto, nome e dimora.
Letterati e delinquenti e sbirri mi piansero morto.
La Coquille mi accolse e da allora viaggio e viaggio nel sole,
nella pioggia, nel vento!
Il tempo si ferm. Il suo trascorrere lo compresi dopo dalla
mia mano guarita. Le ferite rimarginate.
Dovevo partire.
Tutta la Coquille si radun per salutarmi.
Baxtal drom, Marco! Buon viaggio.
:
XXV
Quando ripenso alle mie avventure mi prende la voglia di
andare, di lasciare Venezia.
Questa citt nella quale viviamo avvolta in un sogno di
grandezza. Si ritiene potente e, contro ogni evidenza, coltiva il-
lusioni di invincibilit e di dominio. Crede che il suo matri-
monio col mare sia un vincolo indissolubile ed esclusivo. Ma il
mare ignora la fedelt, alieno da ogni vincolo, limmagine
stessa della volubilit e dellerranza. E poi su quale mare
Venezia vorrebbe esercitare il proprio dominio? Il nostro
mondo ormai una piccola porzione a fronte delle smisurate
vastit che si vanno aprendo. Il Regno di Castiglia non cono-
sce pi i propri confini. In ultimo mi sono giunte notizie di un
grande viaggio del capitano Hernn Corts sulle rotte che fu-
rono di Colombo e Ponce de Len. Si dice che abbia scoperto
una terra dove si usano stoviglie e spade doro e si pregano di-
vinit sconosciute che richiedono sacrifici umani e il sole bru-
cia sempre, pi forte che nel pieno della nostra estate. Venezia
stata signora del nostro mare, del mare di noi greci, di un
mare oltre il quale nei giorni di tramontana si intravede quasi
sempre almeno unidea di terra. Oggi per le signorie si gioca-
no su mari sterminati. Oltre le Colonne dErcole, se si abban-
dona la navigazione costiera e si tiene la prua verso il tramon-
to, passeranno giorni e giorni prima di vedere un uccello vola-
re e unombra di terra lieve sullorizzonte.
Phillip Schwarzerde, un giovanissimo studente al quale ho
procurato dei libri, mi ha inviato una sua eccellente operetta, De
corrigendis adolescentium studiis, che ha firmato con il nome di
Melantone. Nella lunga lettera di accompagnamento, scritta da
Heidelberg, racconta che un suo maestro di modeste origini, si
:
dice che sia figlio di minatore, ma di grandissima dottrina, stia
scrivendo unopera costituita da un gran numero di tesi che, a
suo parere, metteranno a rumore tutta la Chiesa. Sembra che
una grande mobilitazione di spiriti venga suscitata. Melantone
parla persino di tal Lucas Cranach che con le sue mirabili inci-
sioni sostiene la causa di questo monaco che altri non che quel
Martino Lutero del quale ci giunsero notizie come eccellente
professore di Lectura in Biblia. Melantone troppo giovane e
vede in ogni cosa i possibili segni di grandi riforme e mi dice di
un certo Zwingli che avrebbe glossato unedizione del Nuovo
Testamento del nostro Erasmo. Pare che i suoi sermoni sulla
semplicit del cristianesimo delle origini riscuotano un grande
successo a Zurigo. La lettera di questo giovane studente dareb-
be limpressione del parto di una fantasia visionaria ma le sue
considerazioni sul sostegno delle armi dellElettore di Sassonia a
questi movimenti innovatori mi inducono a credergli.
Non sono solo in Oriente le terre dove si mescola guerra e
religione e gi il cuore di questa vecchia parte del mondo fu
straziato dagli scontri tra i seguaci di Hus e le armate di
Martino V. Il rogo del vecchio Jan appicc lincendio che di-
vamp prima tra hussiti utraquisti e taboriti contro Procopio il
Grande, fino alla strage fratricida di Lipany. Allora non solo il
Papa ma anche Sigismondo di Lussemburgo soffi sul fuoco
della fede per bassi calcoli di potere.
Nella mia vita troppo spesso ho constatato che dietro le pa-
role della fede c sempre qualcuno che sta facendo il filo alle
spade.
Come vedi, nihil novi.
Qualche mese addietro ho ricevuto da un vecchio amico la
bozza di un opuscolo. Mi diceva che ha intenzione di titolarlo
De Principatibus e di farne dedica a quel povero Lorenzo de
Medici che di Lorenzo non dovrebbe neppure avere il nome.
Te ne far avere una copia ma non per suggerirtene la pubbli-
cazione, come forse spera lautore. I palati dei clienti della no-
stra Accademia sono troppo delicati e il mio Niccol ama in-
vece lacre sapore del ragionamento serrato. Lo conobbi che era
:,
un giovinetto in Firenze, affamato di libri che la modesta con-
dizione familiare gli impediva di acquistare e di buon grado lo
rifornivo di pagine sulle quali meditare. Ma so gi che hai in-
dovinato di chi parlo! Si tratta di Niccol di Bernardo, della fa-
miglia dei Machiavelli, che fu Segretario della Repubblica col
Soderini. Tanti anni or sono ebbi gran lite con lui, ma larrivo
di questo manoscritto segno di pace fatta. Lho gi ringrazia-
to e riempito di elogi epistolari. Le sue vicende ci sono note,
ma ora in disgrazia coi Medici che pure abbisognerebbero
come il pane del suo ingegno e questo libretto, del quale ti rac-
comando attenta lettura, sarebbe assai utile anche in qualche
palazzo veneziano. In esso Niccol ha concentrato la sua espe-
rienza di anni di osservazioni sulla politica dei molti potenti
con i quali ha avuto familiarit e in specie con quel duca di
Valentino che tanto ha fatto tribolare principati e repubbliche.
Ricordo che aveva solo diciannove anni quando mi piomb in
casa una mattina di fine maggio che io gi mi accingevo a de-
sinare. Aveva appena assistito in piazza della Signoria al suppli-
zio del povero Savonarola.
Messer Marco, hanno impiccato fra Gerolamo, bruciato
sul rogo il corpo e disperso le ceneri in Arno!
Mi colpiva la sua freddezza. Sembrava che lo spettacolo or-
ribile al quale aveva assistito pi che sconvolgerlo gli avesse solo
fornito materia di meditazione.
Era inevitabile, Niccol, la sorte del Savonarola era segna-
ta. Ne ho ascoltate di prediche in Santa Reparata che ancora era
vivo Lorenzo! E mi ricordo di quellinizio di primavera quan-
do il fulmine cadde sulla chiesa e i conci si confissero sulla casa
dei Medici e la notte della cometa. Quando mor Lorenzo co-
minci a morire Firenze e anche Gerolamo. Alla Repubblica
che tu tanto ami, Gerolamo ha fatto da levatrice non senza
laiuto dei francesi. Credevi davvero, caro il mio Niccol, che
la Repubblica avrebbe resistito al potere del Borgia o che Carlo
VIII si preoccupasse di vegliare sulla sorte di un frate?
Alessandro VI sa bene che dalla Todescheria a Firenze il mal-
contento nella Chiesa grande. Oltre le Alpi la sua influenza
:c
debole, ma Firenze piccola cosa. sufficiente che lo Spagnolo
minacci di embargo i mercanti fiorentini perch questi gli bru-
cino sul rogo anche le loro madri.
Dite bene, messer Marco, la piet per fra Gerolamo non
vi fa velo. Le cose stanno come voi dite e ne traggo particolare
soddisfazione perch negli stessi termini ne ho scritto a
Ricciardo Becchi, nostro ambasciatore presso il Papa che mi ha
usato la benevolenza dincaricarmi di seguire le prediche del
Savonarola, di seguirne i passi di spiarlo insomma.
Vorrei che tu meditassi su questa morte, Niccol, e sulle
sue cause e concause e su questi valenciani che hanno occupa-
to i Sacri Palazzi e Roma. Tieni docchio Cesare, il figlio che
Rodrigo ha avuto da Vannozza Cattanei. Si dice che sia uomo
intelligente e violento, incline ai piaceri e alle congiure, che
abbia ucciso il fratello, Juan de Gandia, e che ora mediti di ab-
bandonare la porpora e il pugnale per vestire la corazza e im-
pugnare la spada.
Devo alla vostra benevolenza non meno che ai sacrifici di
mio padre quanto ho appreso in questi anni. Quanto ai vostri
consigli li terr in gran conto, anche perch ora ne avr molta
necessit. La novit del giorno infatti non soltanto la morte
del Savonarola.
E qual mai laltra nuova, Niccol?
Messer Marco, a giorni il Consiglio degli Ottanta mi pro-
porr alla nomina di Segretario della Seconda Cancelleria.
Lincarico riguarda gli affari dei domini di Firenze e le sue rela-
zioni con gli altri stati.
Guardavo quel volto affilato. Poco pi di un ragazzo ma le
pieghe degli occhi e della bocca mostravano gi una passione
maturata nella disciplina dello studio. Tirai un lungo sospiro. Il
giovane Niccol Machiavelli stava per divenire Segretario della
Seconda Cancelleria. Potevo essere soddisfatto. Allinsaputa
dello stesso Niccol, in pi occasioni, conoscendo le sue incli-
nazioni, avevo segnalato, per il tramite di Marsilio, il suo pre-
coce ingegno ai maggiorenti della citt. Decisiva era stata lalta
considerazione per lui del mio amico Becchi che avevo convin-
::
to a prenderselo nel modesto ma delicato ruolo, diciamo cos,
di osservatore delle cose di Firenze. Ricciardo infatti per il suo
difficile incarico di ambasciatore presso il Papa aveva assoluto
bisogno di un occhio che scrutasse per lui le cose della
Repubblica. Oggi quel successo mi appare in altra luce, ma quel
giorno, anche se la morte del Savonarola ci aveva comunque
turbati, bevemmo alla fortuna di una carriera politica nascente.
Quando Niccol ebbe lasciato la mia casa potei abbando-
narmi al dolore. No, non quello delle lacrime che purtroppo
non conosco, ma a quel dolore che sale dal petto e gela le mem-
bra. Sapevo che Gerolamo era stato messo a morte ma quel
poco che mi restava di cuore aveva dissolto questo pensiero
dalla mente. Ora Niccol aveva reificato il sangue e la polvere
di quello che fu, comunque, un amico. Avevo incontrato il
Savonarola nel Convento di San Marco che mi ero da poco sta-
bilito a Firenze. Nellambiente che avevo preso a frequentare
usava lascolto dei sermoni ed erano dobbligo quelli di
Mariano da Gennazzano, ma sermoni pronunciavano Donato
Acciaiuoli, Cristoforo Landino, Giovanni Nesi per la
Compagnia dei Magi e lo stesso Poliziano nella Compagnia del
Vangelista. Con questultimo e Pico e altri eravamo assidui del
chiostro di San Marco. Con Gerolamo lars predicandi rag-
giungeva vette elevatissime, sia che dicesse contro labuso dei
pellegrinaggi e delle indulgenze che contro le superstizioni e i
vaniloqui degli astrologi, in questultimo caso fortemente so-
stenuto dalle Disputationes adversus astrologiam divinatricemdel
conte di Mirandola. Cerano in noi diversit di culture e di in-
tenti. Io, in particolare, temevo che il rigore di Gerolamo po-
tesse sfociare in cieco fanatismo. Comunque eravamo amici e
insieme con il suo discepolo prediletto Roberto Ubaldini ve-
gliammo Poliziano, assistemmo alla sua sepoltura in San Marco
e davanti al corpo del nostro amico giurammo fratellanza.
Forse non stato un caso che sia stato Niccol a portarmi la
notizia della morte inutilmente crudele di Gerolamo. Ci vole-
va la sua voce di ghiaccio per spegnere le fiamme del ricordo di
quel pazzo amico.
::
XXVI
Venezia, come la mia piccola Otranto, snodo e cerniera tra
grandi mondi che si preparano allo scontro, ma essa ormai
solo una comparsa. Non sono le pretese a essere troppo eleva-
te, sono inadeguati gli strumenti, povere le idee, deboli i sog-
getti, mediocri i protagonisti. Siamo nellepoca delle grandi
monarchie che gravano da terra mentre dal mare lOsman ci ha
cavato gli occhi di Modone e Corone e pi duna volta il fuoco
dei villaggi friulani incendiati dai saccomanni stato visibile
dal campanile di San Marco. dalla rotta di Agnadello che
nessuno crede pi alla infallibilit diplomatica e militare del
Senato e non sono certo le furbizie dei suoi ambasciatori che
potranno ripristinare la gloria e il potere perduti di Venezia. Sul
Mediterraneo domineranno la Spagna e la Porta, mentre
sullOceano la stessa Spagna e altri grandi paesi si divideranno
i mondi futuri. Avremmo almeno potuto essere per lItalia e la
Libert, ma gi molto se resta da strillare per San Marco.
Csole fu la rovina di Otranto. La mia citt era un borgo
marinaro prospero e operoso. Dalle campagne vino e olio af-
fluivano al porto per limbarco. La Sublime Porta avrebbe sot-
tomesso il territorio secondo la legge islamica. Invece non fu
cos. Fu distruzione e morte e incendio e stupro e saccheggio e
folle, inutile martirio.
Noi eravamo sul confine di due mondi, estrema periferia e
al tempo stesso estremo avamposto di due mondi in guerra.
Ciascuno avvinto da un folle disegno di dominio militare di
terre, corpi e anime. Anche Csole su questo confine si era la-
sciata avvincere da un disegno altrettanto folle, quello di do-
minare il sapere e le cose attraverso il sapere. Ambizione ben
pi insana.
:+
Da qualche tempo mi chiaro perch ogni allievo che mo-
strasse, come me, una particolare predisposizione allapprendi-
mento delle lingue venisse in ogni modo agevolato, blandito,
incoraggiato.
Csole non tollerava barriere al suo sapere e non poteva
neppure lontanamente concepire che una lingua, per quanto
parlata in una remota contrada, potesse sfuggire alla sua insa-
ziabile sete, essere freno alla sua inesauribile fame.
E tutto quel dispendio di energie per raccogliere testi, quel
frenetico corrispondere con i luoghi pi remoti, quellincessan-
te brama di informazioni, quellansia di sapere cose del mondo.
S, certo! Csole era anche un luogo di preghiera, ma quel
rendere lode a Dio e a Cristo suo Figlio mi appare oggi un
adempimento che compivamo pi spinti dallabitudine che da
un vero sentimento religioso.
Fu questa ybris a perderci e a perdere la citt.
Daltra parte non poteva che essere cos. Csole nacque da
un gesto di generosit di Boemondo, sotteso a unambizione
sfrenata e a un sogno folle di dominio e un sogno di dominio
lha sepolta.
Addio, dunque, maestro Manuzio! Addio a te, alla tua fa-
miglia, agli amici. Forse ci rivedremo, forse no. Potrei partire
ancora o restare. Ho viaggiato molto ma pi che un andare ho
sempre pensato che il mio fosse un tornare. Addio!
Marco de Marco
in Venezia
il 16 di gennaio dellanno di Dio 1515
:
EPILOGO
Cala dellOrte
Tutte le volte che la panna di vento accade di notte, quan-
do al cambio dallo scirocco alla tramontana laria si babba e il
mare si fa olio, possiamo uscire dalla nostra tomba dacqua e
passeggiare su questa scogliera fino allora che sulla cresta degli
Acrocerauni la notte si chiarisce. Gli otrantini ci conoscono
bene e qualcuno, ogni tanto, torna su queste rocce per ascolta-
re le nostre storie, le nostre nostalgie, i nostri sogni. Tutti sanno
che siamo presenze benigne in grado di tenere a bada il mala-
nimo degli scazzamurrieddhi, i cattivi umori delle macare e, so-
prattutto, le nefaste apparizioni degli sciacuddi. Noi amiamo la
compagnia dei lari con le loro bizzarre dolcezze. stato uno
di loro a guidarmi nelle notti di luna piena sulle scogliere fino
al Capo di Leuca per indicarmi le vene di roccia colorata dalle
quali Pantaleone ha tratto le tessere per il suo mosaico. Al chia-
rore della luna brillava il rosso dei coralli che il tempo aveva im-
prigionato nel calcare e locra e lazzurro e il verde e il nero di
pietre delle quali non conosco il nome.
Non abbiamo vita facile su queste scogliere. Non esiste al
mondo luogo pi infestato di questo. Qui sono arrivati, da
ogni dove, pellegrini e crociati. Tutto un universo di esseri so-
prannaturali li seguiva nel loro viaggio ma a Otranto, al mo-
mento di imbarcarsi e affrontare il mare, un vero e proprio ter-
rore li coglieva alla vista di quella sterminata pianura inquieta.
stato per questo che gli Spriggan, quei codardi arrivati al se-
guito dei cavalieri di Cornovaglia, sono rimasti tra queste
rocce; al pari dei Goblin del Devon ebbero appena lardire di
varcare la Manica ma alla vista dello Ionio spazzato dallo sci-
:s
rocco si abbarbicarono alla terra, come i Pixie che per tutto il
viaggio avevano molestato i santi pellegrini di Dartmoor e i
Trow e i Bogle che, dalle isole Shetland a Otranto, avevano
messo a dura prova la pazienza di un numeroso gruppo di mo-
naci.
Non parliamo neppure della folla di Ozegan e Korrigan che
si sono trascinata dietro i normanni. Da Avalon a Gaunes, alla
Foresta di Brocliande, a Bnoic, tutta lArmorica sembrerebbe
rimasta orfana di elfi e folletti. Un vero disastro sono i Jinn.
Essi non hanno paura del mare e giunsero qui al seguito delle
truppe di Ahmed Pasci. Entit di aria e di fuoco, sono molto
orgogliosi del fatto che il Corano li nomini spesso. Hanno un
grande senso dellonore e ricordano a tutti la loro discendenza
dalla stirpe dei pi fedeli servitori del re Salomone. I Jinn per
trovarono la strage degli ottocento otrantini un gesto tanto di-
sonorevole per un musulmano che abbandonarono la spedizio-
ne al suo destino e, non a caso, per Ahmed Pasci e i suoi uo-
mini inizi una lunga catena di sventure. Ora passano le notti
a lamentarsi per il tragico destino della casa di Osman, piango-
no di nostalgia per la Sublime Porta e le notti nel Serraglio e a
Pera e negli oscuri sotterranei del Topkapi. Sono del tutto in-
nocui ma le loro strida e i loro singhiozzi incutono terrore.
Anche i sefarditi in fuga verso i Balcani hanno lasciato su
queste rive una masnada di insopportabili dibbuk.
Tocca a noi fantasmi impedire gli eccessi e proteggere gli
otrantini da questorda scatenata, i viaggiatori che si avventura-
no sulla costa, gli amanti in dolce passeggiata. Tutti, dopo il
calar del sole, verrebbero certamente importunati se non peggio
e a nulla vale mettersi gli abiti al rovescio e ostentare mazzetti di
hypericum. Noi che veniamo dalla Terra Sotto le Onde abbiamo
linquieta saggezza che deriva dalla morte per acqua. Non pos-
siamo avere pace ma non vogliamo toglierla a nessuno.
No. Nessuna delle anime di chi mor nei fatti del 1480 si
mai risvegliata. A esse per sempre negata linquietudine.
Eroismo e martirio sono una tomba troppo pesante.
:o
Dopo aver interrotto il mio lavoro con lAccademia del
Manuzio le mie giornate restarono vuote, le ore mi sembrava-
no uno sterminato deserto, cercavo di colmarle leggendo qual-
che libro ma dopo un po cominciavo a saltare le pagine e ogni
tanto una frase mi spingeva ad aprire un altro libro e anche di
quello leggevo qualche riga e un sonno mi coglieva breve e agi-
tato e di nuovo le mie dita scorrevano sui dorsi e ne coglievo
un altro ancora e iniziavo a leggere aprendolo a caso e mi sem-
brava di non capire quanto i miei occhi scorrevano. Allora usci-
vo di casa incupito e vagavo per le calli e i campielli e i miei
passi portavano sempre verso lArsenale dove le navi prendeva-
no il mare e le seguivo con gli occhi fin quando era possibile
scorgere sullorizzonte un fazzoletto di vela. La sera, come da-
bitudine, Lei mi accoglieva nella sua casa ma neppure il suo
desco raffinato mi offriva consolazione. I suoi occhi mi scruta-
vano appena e il sorriso dissimulava unombra di preoccupa-
zione che le attraversava la fronte. Non avevo proferito parola
sul fatto che non lavoravo pi ma era evidente che sapeva gi
tutto con quella sua rabdomantica qualit di leggere nei miei
pensieri, di scorgere nella mia anima sentimenti dei quali nep-
pure io avevo piena contezza.
Lavevo conosciuta quando lo splendore della sua giovinezza
trasmigrava in una affascinante maturit e il suo al tempo per
me inspiegabile nubilato appariva una condizione stabile e ir-
reversibile. La prima volta che vidi Lei fu nella sala di scrittura
dellAccademia. Entr accompagnata dal Maestro che manife-
stava nei suoi confronti la deferenza di solito riservata ai grandi
clienti. Manuzio la guidava tra i tavoli dove alcuni di noi erano
intenti alle traduzioni e le illustrava le opere in lavorazione.
Signora, permettete di presentarvi il nostro poliglotta, il
traghettatore di ogni lingua, il nostro Marco de Marco. In altri
tempi lo avremmo definito il nostro protocalligrafo per lele-
ganza della sua scrittura ma non solo di questo si tratta; allita-
liano e al greco paterni ha sommato la materna lingua serba e
poi il latino, lebraico, larabo, il persiano. Protesta di avere
delle esitazioni in aramaico, ma noi non gli crediamo
:
Quando i suoi occhi si poggiarono nei miei capii che non
sarei stato in grado di far altro che farfugliare qualche parola di
circostanza tanto era il fascino che emanavano. Restai in piedi,
con la penna in mano a cercare di schernirmi da quegli enfati-
ci elogi.
Lei si limit a sorridere con benevolenza e a gettare uno
sguardo distratto sulle mie pagine.
Per tutto il resto della giornata feci finta di niente ma la
notte dovetti ammettere con me stesso che lapparizione di
quella donna mi aveva scosso. In attesa del sonno la rivedevo
muoversi con grazia tra gli scrittoi, discorrere disinvolta con il
Maestro, sfogliare con tocco leggero i volumi sparsi qui e l e
in ultimo scoccarmi uno sguardo nelluscire sulla veranda inon-
data di sole.
I suoi occhi avevano i toni delloro antico. Sulle tempie, la
precocit di qualche capello color della cenere lungi dallinvec-
chiarla ne accentuava il fascino.
Fu cos che i miei giorni divennero una lunga attesa, attesa
di vederla comparire in Accademia, di incontrarla per strada e
poich questo non avveniva mi informai discretamente su chi
fosse e dove abitasse e presi ad attraversare regolarmente il
campo sul quale si affacciava il suo palazzo. Certo speravo di
vederla, di incrociare il suo sguardo, speravo in un cenno di sa-
luto, in un sorriso. I giorni passavano e limmagine di Lei si di-
latava nella mia anima, dilagava nei miei pensieri. Come un
giovane innamorato divenni svogliato e distratto, di frequente
ero costretto a cancellare parole sbagliate quando non intere
frasi. Sapevo che tutto ci mi rendeva ridicolo ai miei stessi
occhi ma avevo deciso di essere indulgente con questo pi che
maturo innamorato.
Accadde una sera destate. Passeggiando con Lorenzo Lotto
ero riuscito tra le chiacchiere a trascinarlo fino al Campo delle
Fiaccole. Le finestre del suo palazzo erano spalancate e illumi-
nate e ne proveniva una musica gradevole. Mentre la immagi-
navo ricevere con grazia i suoi ospiti una voce mi scosse.
:
Messer Marco, oh s, siete voi messer Marco, non vi ram-
mentate di me?
Se mi rammentavo di Lei! Mi era arrivata alle spalle, ac-
compagnata da un servo che reggeva una lampada. Il chiarore
della fiamma le incendiava il volto e i capelli.
Messer Marco torn a ripetere ci siamo incontrati
nellAccademia
Riuscii appena a borbottare qualche parola, che certo ricor-
davo il nostro incontro e che, mentendo, ero sorpreso di in-
contrarla.
Ma questa la mia casa, vedete quelle finestre, da dove
proviene quella musica? Oh, i miei poveri ospiti che mi staran-
no attendendo gi da un pezzo!
La sua voce era ferma e brillante e la ostentata trascuratezza
nei confronti dei suoi ospiti mi deliziava, ma la mia lingua era
paralizzata, i pensieri fermi, distoglievo il mio sguardo dal suo
come un ragazzo imbarazzato e mi tocc incrociare gli occhi di
Lorenzo che mi fissava di sbieco con unespressione divertita.
Messer Marco, ho bisogno della vostra sapienza greca. Ho
acquistato degli antichi manoscritti. Il nostro amico Manuzio
non si adonter se ve ne chiedo la traduzione?
Farfugliai che no, certamente Manuzio non avrebbe avuto
lardire di ingelosirsi per il tempo necessario alla traduzione.
Molto bene. Dunque vi attendo per domani, dopo il
Vespro, sono certa che la vostra sapienza sar allaltezza dei miei
desideri.
Per molti anni le nostre sapienze furono allaltezza dei nostri
desideri. Non solo le nostre menti ma anche i nostri corpi si
nutrirono luno dellaltro.
Sta cambiando il tempo, Marco.
Il suo corpo nudo, pieno e maturo si stagliava nella finestra
al leggero chiarore della luna.
Sta cambiando il tempo, Marco.
:,
Sin dalla prima frase avevo colto nellinflessione della voce
che lei non stava parlando dello scirocco che aveva preso a inu-
midire laria.
Sta cambiando il tuo tempo.
Ero disteso nel suo letto. Il buio avvolgeva la stanza. Quella
notte avevamo fatto un amore ancor pi lungo e lento, come
se nulla di quella felicit che ci coglieva dovesse andare perdu-
to, smarrito dalle punte pi estreme dei nostri sensi.
tempo che tu vada, Marco, tempo che tu raggiunga la
tua memoria. Nulla pu trattenerti tra le case e i canali di que-
sta citt, tra le mura di questo palazzo, tra le mie braccia. Nulla
pu trattenerti persino tra le mie gambe. Ci sono desideri pi
forti del desiderio. Vorrei maledire Kemal e Manuzio ma sa-
rebbe risibile. Non a loro che si deve la tua memoria. La tua
vita stata soltanto memoria
No, ti sbagli, la mia vita stata memoria fino a quella
mattina in cui sei entrata nellAccademia, fino a quella sera in
cui, con il pretesto dei manoscritti greci, abbiamo discusso fino
allalba della Commedia e del Libro de Alexandre, del
Narrenschiff, ricordi? E di icone e pitture. E fino a quella notte
in cui i tuoi ospiti ci annoiavano con le loro chiacchiere e i no-
stri sguardi dintesa lasciavano presagire che i nostri corpi non
avrebbero accettato oltre di non unirsi. Tu mi hai strappato alla
memoria, a una vita fatta di pagine e di parole. Tu hai dato
corpo al corpo, cose alle cose, persino il cibo che avevo sempre
ritenuto una necessit da soddisfare fugacemente con te dive-
nuto rito e piacere. Tu hai mescolato la vita alle parole, la real-
t al sogno.
Ma erano solo pause, Marco, pause che riuscivo a strap-
pare al tuo personale teatro, a quella macchina di cassetti e
scomparti che solo di tanto in tanto sono riuscita a farti serra-
re. cos che ho tentato di trasformare la tua memoria in
sogno, in vagheggiamento di un passato che poteva anche es-
sere inventato. Sbarrando il passo alla tua memoria ho cercato
di proteggere i tuoi sogni. Ora il pi remoto degli scomparti
che attende di essere aperto ed esso contiene una memoria che
:,c
pu essere pericolosa per la tua stessa vita. Ricorda, io posso
proteggere i tuoi sogni, non la tua vita!
La mattina dopo mi imbarcai con la muda per Tangeri. Non
ci salutammo come per un addio. Sapevamo che non ci sa-
remmo visti mai pi ma le nostre parole furono lievi e lieve il
bacio e rapido il serrarsi delle mani.
La galea era grande ma si destreggiava bene nelluscire dal
Passaggio della Fossa. La marea si stava ritirando e una corren-
te leggera ci spingeva dalla laguna verso il mare aperto allegge-
rendo il lavoro dei rematori. A dritta, dalla parte di
Malamocco, una festa di vele colorate: i burchi approfittavano
anche loro della corrente. Sandoli, batele, tarete, cocche, im-
barcazioni grandi e piccole affollavano la laguna bordeggiando
in ogni direzione. Oltre lultima isola il parn diede lordine di
fermare i remi e alzare gli artimoni. Le vele si gonfiarono
schioccando e la galea si inclin leggermente. Dal castello di
poppa sentivo lacqua frusciare lungo la chiglia ma ben presto
le chiacchiere dei miei compagni di viaggio, mercanti e uomi-
ni daffari, sovrastarono ogni suono. Restavo appartato guar-
dandomi intorno. Mi voltai verso Venezia che mi apparve
come una striscia dorata poggiata sullorizzonte. In quel lucci-
cho cera la mia casa, la biblioteca di Bessarione, i miei amici
greci, lAccademia, cerano Manuzio, Gentile e Giovanni e il
Lotto Cera Lei, la donna che aveva dato un senso ai miei
anni maturi e dalla quale avevo appreso pi che da tutte le pa-
gine lette. In primo luogo lironia che sottrae alle cose guarda-
te ci che presumono di essere per restituirle a ci che sono.
Avvertivo confusamente che questo sarebbe stato il mio ul-
timo viaggio e confusamente ritornavo con la memoria a quel
primo imbarco sulla nave che da Otranto mi portava ad
Ancona con lambasceria per Lorenzo de Medici. Allora ave-
vamo salpato al tramonto. Questa volta lancora era stata leva-
ta allalba. Tra i due viaggi per mare, una lunghissima notte af-
follata dai sogni di battaglie, viaggi, libri, persone. Ricordavo
leccitazione di quel primo viaggio e la confrontavo con la
:,:
calma assoluta che mi pervadeva ora lasciando Venezia. Poi,
come allora, fui assalito dal desiderio di tornare indietro.
Ricordavo quel mio lontanissimo desiderio di ritornare, non
solo a Otranto, ma, nel tempo, alla mia infanzia e alla casa pa-
terna per cui, anche lasciando la laguna, mi prese un impeto di
nostalgia ma non per Venezia, non per la mia vita trascorsa in
quella citt. Il solo struggimento che provai fu per quella notte
appena trascorsa nella casa di Lei, per le sue labbra, il suo corpo
e le sue parole.
Messer Marco!
La voce del parn mi scosse dalle riflessioni.
Messer Marco, venite nella mia cabina! Siete uomo di
carte e vorrei farvi vedere le mie carte.
Il comandante dispieg sul tavolo una sottile pergamena e
tutto il Golfo di Venezia si apr davanti ai nostri occhi. In
mezzo al mare era disegnata una grande rosa dei venti. Dal suo
centro si dipartivano trentadue linee.
Messer Marco, siamo appena usciti dalla bocca della la-
guna e abbiamo davanti alla prua almeno settantaquattro mi-
glia per Parenzo, facciamo rotta per levante, una quarta a me-
ridione. Se il vento regge a met di doman laltro saremo al no-
stro primo scalo.
E il giorno pass lieve come lo scirocco che risalivamo e
anche la notte e io dormivo e mi svegliavo di continuo e il
sonno era profondo e senza sogni e la veglia unattesa vacua.
Ora cercavo di leggere qualche pagina di libro, ora guardavo il
mare, ora le manovre della nave. Come quelli di un bambino
svogliato che ci sembra preda di pensieri leggeri i miei occhi
sfioravano tutto senza sostare su nulla.
Solo una striscia pi azzurra davanti alla prua ferm la mia
attenzione. LIstria aveva un colore appena pi scuro del mare.
Messer Marco, venite che leggiamo il portolano
Il comandante era gentile e la sua premurosit la attribuivo
al carattere anomalo della mia presenza a bordo. N marinaio,
n mercante, n diplomatico, dovevo apparire a quel bravuo-
mo una presenza da trattare con particolare rispetto.
:,:
Non mi ricordo neppure pi quante volte sono entrato a
Parenzo, messer Marco, eppure tutte le volte sono preoccupa-
to. Brutto porto, messer Marco, brutto porto leggete, legge-
te
Mi allung il portolano.
Il detto Parenzo terra picciola e ha scogli 3. Lintrata del
detto porto per ostro lasciando i detti scogli dalla banda di
garbino vuolsi accostare al detto scoglio per il capo della terra
perch in bocca una secca che ha pi quattro dacqua
Quattro miglia ogni clessidra, messer Marco, un buon
andare. Vedete? La costa dIstria gi ce la stiamo lasciando di
poppa.
E in verit quellidea appena un po pi azzurra di terra sfi-
lava alle nostre spalle, oltre la breve scia della galea. Il coman-
dante era in vena di ciacole.
Belle carte nevvero? Caro messer Marco, sulle mie navi
sempre carte di prima qualit. Queste sono moderne, ma ho
conservato quelle dei miei avi disegnate da Petrus Visconte di
Genova e da Angelo Dulcert di Majorca. Pergamene sottili e
disegni precisissimi, tutto segnato minuziosissimamente, nep-
pure la pi piccola secca veniva dimenticata.
A Venezia avevo disposto che il mio amico banchiere Alvise
Pisani consegnasse tutti i miei averi a Lei. Non si trattava di
gran cosa: una casa dignitosa con dignitosi arredi, qualche ren-
dita e la biblioteca, lunico bene al quale tenevo. Sin dai tempi
di Firenze avevo cercato se non di ricostruire il mondo di
Csole almeno di ravvivarne lidea impegnandovi non poca
parte delle mie sostanze. I libri mi avevano seguito a Venezia ed
erano stati una buona compagnia. Della biblioteca facevano
parte tutte le mie carte: appunti, labbozzo di qualche scritto e
moltissime lettere. Le mie conservate in copia e quelle ricevu-
te. Lei ne ebbe gran cura e fino a un certo punto il mio spirito
ne ha seguito le vicissitudini nelle mani di un suo erede, un ni-
pote amante delle buone lettere. Poi i figli scapestrati di costui
:,+
cominciarono a disperdere patrimonio e biblioteca e molte
delle mie carte finirono nei camini come esca per i tocchi di
quercia della Carnia. Solo un lontano discendente di un ramo
collaterale della mia famiglia, cassiere di banca a Trieste, allini-
zio del secolo ventesimo, si mise sulle tracce di quanto era ri-
masto. Il che avvenne per caso quando il mio nome fu pro-
nunciato nelle chiacchiere svagate che si rincorrevano tra i ta-
volini di un certo caff triestino. Il locale era frequentato da
scrittori e poeti e uno di questi, tal Umberto, traeva magro so-
stentamento da una libreria antiquaria. Per le sue mani erano
passati alcuni volumi appartenuti alla biblioteca di Marco de
Marco e sapeva che qualcosa era rimasta a Venezia in Ghetto
Vecchio. Il libraio Saba non ne sapeva di pi. Il cassiere part
per Venezia e si aggir a lungo in Ghetto e per la citt. Frug
in tutte le librerie antiquarie e consult i cataloghi di tutte le
biblioteche. Ormai era sul punto di rinunciare. Passava le gior-
nate nei caff sulla Piazza di San Marco e non disdegnava la
compagnia di alcune fanciulle che, di tanto in tanto, facevano
la loro comparsa nellatrio del suo albergo. Nella generosa re-
tribuzione delle loro grazie il cassiere comprendeva anche il
fatto che le fanciulle ascoltassero la storia della sua ricerca. Fu
cos che la giovane Adele, una fanciulla dai grandi seni, lo in-
dirizz dal suo affezionato cliente Jakob che alla passione per
quelle sferiche e sode protuberanze anteponeva soltanto una
sfrenata mania bibliofila. Jakob sapeva qualcosa di Marco de
Marco ma erano i sefarditi ad avere avuto per le mani quanto
restava della sua biblioteca. Cos il cassiere fin in casa Mendes
e da l fu introdotto al cospetto di Joseph Rodriga. Pi che una
casa era un deposito: libri, vestiti, suppellettili e oggetti delle
pi svariate nature si affastellavano ovunque accomunati dal-
laria di aver conosciuto giorni migliori e da una sottile coltre
di polvere. Su tutto Joseph Rodriga dominava dallalto del suo
scranno e della sua vecchiezza. Il vecchio sefardita impose al
cassiere una lunga storia familiare di persecuzioni dalla
Castiglia a Lisbona. Una fuga angosciosa stretti dalle spie che il
Grande Inquisitore, Toms de Torquemada, sguinzagliava sulle
:,
tracce di chiunque non si confessasse cattolico romano. Via, al-
lora, lontano dalle torture e dai roghi. Via, prima ad Anversa,
poi a Lione, a Spalato e quindi a Venezia dove un suo avo,
Daniel Rodriga, aveva commerciato zucchero e spezie ed era
entrato in possesso per oscuri motivi di una parte della biblio-
teca di Marco de Marco. Il cassiere ascoltava paziente ma molte
delle parole del Rodriga se le perdeva mentre annegava nei
begli occhi di Esther, la figlia del vecchio che, sfaccendando tra
le masserizie, non mancava di incrociare il suo sguardo con
quello dellospite. Comunque il pi della biblioteca de Marco
era stato venduto ma qualcosa era rimasta, un piccolo baule
che nessuno si era mai dato pena di aprire. Quando il baule fu
portato, il cassiere chiese che venisse aperto per stabilire un giu-
sto prezzo e gi metteva mano al danaro per soddisfare la ri-
chiesta che Rodriga stava per proferire quando Esther batt le
mani tre volte. Il vecchio tacque di colpo e anche il cassiere
rest come paralizzato, con la mano in tasca.
Padre, non c prezzo per la memoria! Questo giovane
non uno dei tanti antiquari a caccia di memorie altrui. Per
quanto strano possa essere per un goym, egli cerca la sua me-
moria. Il baule di de Marco pagato, ma non pu ancora es-
sere aperto. Lospite non ha ombra!
Potete immaginare lo stupore del cassiere quando si accorse
che, in effetti, il suo corpo era come attraversato dalla luce della
lampada.
Quello che accadde dopo confuso.
Certo la famiglia del cassiere perse di lui ogni traccia per
molte settimane. Esther lo condusse nella zona pi remota e
buia della casa.
Rabbi Ammi disse: colui che vuole mettersi in viaggio e
desidera sapere se torner, deve entrare in una dimora oscura.
Se vede il riflesso della sua ombra sar sicuro di far ritorno
Esther ospit il digiuno del cassiere per sette giorni e, per
sette notti, giacquero insieme ma senza che lui la toccasse. Nel
buio leggevano lHorayot e luomo non si stupiva di decifrare
quella lingua che non conosceva.
:,s
Dormi in pace, cassiere, nel sonno la tua anima esce per
andare a vedere il luogo che le destinato nel mondo a venire,
tu non ne sei consapevole perch hai perso il dominio su di lei,
ma io veglier su entrambi.
Lottava notte la donna lo condusse sulla riva della laguna,
dove un ruscello si versava nel mare e preg. Poi gli chiese di
fissare il buio e quale colore avesse lombra. Il cassiere quasi non
credeva alle sue parole quando confess che essa era rossa e vi-
vida. Insieme attesero lalba e il primo sole stagli due lunghe
ombra sulla sabbia.
Addio, cassiere, ora puoi anche aprire il baule ma dentro
non c nulla per te e ancora nulla per il figlio maschio che
avrai, per il figlio di tuo figlio che porter il tuo nome, forse
ma attento! Tuo nipote, come te, rischier ogni tanto di perde-
re la sua ombra ma non darti pena, cassiere, Esther veglier
anche su di lui.
Il baule viaggi da Venezia a Trieste, poi a Roma e infine nel
Salento. Pass al figlio del cassiere e ancora ai di lui figli, una
femmina e un maschio. Fu questultimo, in questo vostro ter-
ribile tempo che, spinto dalla curiosit, rimosse i ferri e prese a
sfogliare la vecchia copia del De rerum natura nella quale, di-
strattamente, avevo conservato la copia della lettera di com-
miato ad Aldo Manuzio nella quale raccontavo qualcosa della
mia vita. Temo che egli abbia preso troppo sul serio quella let-
tera scritta in un momento di umor nero. Vi avevo rappresen-
tata la mia esistenza nella tetra luce di un nomade dedito solo
alla lettura, allo studio, alla riflessione sulle crudelt del mondo
e sulla vanit di ogni ricerca di piacevolezza fuori dai libri e le
carte. Pi duna volta ho visto questo mio lontano parente ag-
girarsi nelle strade di Otranto, tra le rovine di Csole, nei pres-
si di Torre Pinta, sulle rocce delle Orte, per i vicoli intorno a
San Pietro con lo sguardo perduto di chi non cerca nelle cose
ma nella memoria di esse.
Con quella prerogativa dolcemente triste che abbiamo noi
non morti di seguire le vicende dei vivi, lho visto inabissarsi
:,o
sulle tracce della mia vita, passare ore e ore sui banchi della
Laurenziana e della Marciana, leggere i libri che io avevo letto,
attraversare i luoghi che io avevo attraversato e, nei mutamen-
ti che essi avevano subito, lho visto abbassare lo sguardo e
aguzzare i pensieri perch quelli per lui fossero non come nella
realt erano ma come io li avevo visti e vissuti. Mi duole che la
mia lettera a Manuzio non sia finita in un camino e sia ora
nelle sue mani. Vorrei avvicinarlo durante qualche sua passeg-
giata notturna a Otranto e dirgli che in quella lettera c solo
una parte della verit sulla mia vita, che nella mia vita c stato
anche il piacere dello stringere i fianchi di un cavallo lanciato
al galoppo, lallegria del canto, delle chiacchiere nella compa-
gnia quando le bottiglie e i piatti mostrano il fondo, la spen-
sierata passione tra le gambe di una donna. Ho paura che non
mi crederebbe. Temo che egli non possa riconoscermi che in
quella lettera perch egli come io solo in parte sono stato.
Ma voglio concludere il mio racconto.
Lo scalo a Parenzo fu breve. Passammo al traverso della Pola
e da l cominciammo a scendere lAdriatico tra le isole dalma-
te. Facemmo altri scali. A Spalato mi piacque passeggiare tra le
rovine del palazzo di Diocleziano. Poi facemmo rotta su
Ragusa. Il comandante non mancava di indicarmi i nomi delle
isole che lasciavamo alla nostra sinistra: Lesina, Curzola,
Lagosta. Una pietra bianchissima si intravedeva appena in un
folto di querce e cipressi che arrivava a qualche passo dal mare.
Gran costruttori di navi, messer Marco, questi ragusei.
Concorrenti pericolosissimi. Pagano la quercia della montagna
di Gargano poco o nulla e lavorano carene che sembrano chi-
tarre per lucentezza e perfezione.
Perch ci siamo fermati a Ragusa, comandante?
Pelli, cera e argento. Questi diavoli di dalmati ne hanno
in abbondanza e ai prezzi migliori. E poi, vi confesso una mia
debolezza: qui si mangiano i migliori funghi della costa adria-
tica. Stasera vi porter dalla siora Dube, vedrete!
:,
Ora avevamo davanti alla prora limbocco del Canale
dOtranto. Appena fuori dal porto di Ragusa, oltre lo scoglio
di SantAndrea, un vento fresco gonfiava le nostre vele.
Quando la terra fu invisibile oltre poppa rinforz ancora. La
nave sembrava uno strumento musicale. Le sartie vibravano
come corde di liuto e la stessa coperta sotto i passi risuonava
cupamente. Tutto era percorso da una tensione sonora.
Il vento era una bora violenta che si era rafforzata per tutto
lAdriatico con i venti che venivano dalle montagne della
Dinarica, dalle terre di mia madre.
Vedevo il volto del capitano teso ad ascoltare ogni suono
che proveniva dalla nave e sembrava annusare laria.
C odore di neve in questo vento, messer Marco! Neve
lontana, non solo quella delle prime montagne, questo odore
di neve delle steppe, ben oltre il Danubio. Il vento rinforzer
ancora e dobbiamo ridurre le vele.
Lentamente ci che mi era sembrato vibrazione musicale di-
venne frastuono. Ora il vento urlava sulle sartie.
Non possiamo entrare nel porto di Otranto con questo
mare. Ma dobbiamo avvicinarci perch dal faro capiremo la
misura per andarci a ridossare oltre Castro, ad aspettare che
passi questa furia di tramontana. Se i miei calcoli non sono sba-
gliati tra mezza clessidra dovremmo cominciare a scorgere il
lume della Torre.
Il vento spense anche la candela nella cabina. Il buio asso-
luto era interrotto solo dai lampi. Nel grande rumore si distin-
gueva lurlo di qualche comando.
Mi tornarono in mente le imprecazioni di Giosafat Barbaro
contro le male tramontane. Comera lontano quel nostro in-
contro a Csole. Alla fine del lungo colloquio con i maggio-
renti dellabbazia, quando apprendemmo della sorte segnata
della Terra dOtranto, ebbi lincarico di accompagnare il patri-
zio allimbarco. Barbaro era un turbine di parole, di immagini,
di visioni. La sua cantilena veneziana si era accordata con i
ritmi di tante altre lingue. Anchio ne conoscevo tante ma non
avevano suono. Allepoca raramente avevo avuto occasione di
:,
parlarle. Per me le lingue erano soprattutto scritte. Barbaro, li-
bero dallangustia delle sue gravi informazioni per il monaste-
ro, si lanci in mirabolanti racconti delle sue avventure.
Caro il mio giovane Marco, ero alla Tana, dove un fiume
che si chiama Don sfocia nel mare e un mercante egiziano che
avevo conosciuto mi rivel, in punto di morte, il segreto di un
grande tesoro. Risalendo il Don per un certo tratto si raggiun-
geva un luogo del quale mi fece minuziosa descrizione. Si trat-
tava di un contebbe, che altro non significa che collina di sab-
bia. L, mi disse, era sepolto lultimo re dei Sarmati con tutte le
sue ricchezze.
E voi, messer Barbaro, le andaste a cercare?
Certo! Organizzai una spedizione con centoventi uomini.
Risalimmo con le slitte il fiume ghiacciato e quando giungem-
mo sul luogo che io ritenni fosse quello indicato dallegiziano,
i miei uomini cominciarono a dare di pala e piccone non-
ostante il gelido vento della steppa che ci sferzava.
E il tesoro?
Nulla, nulla di nulla. Questa la cosa pi preziosa che tro-
vammo.
Barbaro tir fuori dal farsetto quella che sembrava un fram-
mento di maniglia dargento che terminava con una testa di vi-
pera di ottima fattura.
La mia rabbia era immensa. Nello scavo venivano fuori
scorse di miglio, avanzi di legna bruciata, lische di pesce, tutte
cose che mi facevano pensare di essere nella direzione giusta
ma, alla vigilia della Pasqua, le male tramontane furono tanto
forti che gli uomini si ammutinarono e fui costretto a fare ri-
torno. Oh, le male tramontane! Tutta la vita le ho combattute
in terra e in mare.
Addio al tesoro quindi?
S, ma legiziano non aveva mentito. Allinizio dellestate
successiva un tataro dellOrda dOro che era stato al mio servi-
zio torn sul posto, da solo. Il disgelo gli fece scoprire che la
collina aveva un culmine che non era nel luogo del nostro
scavo. Su quel culmine diede di piccone. Non trov Indiabu, il
:,,
re dei Sarmati, ma una principessa che lo aveva atteso nellom-
bra per secoli circondata da oro e gioielli da comprare mezza
Venezia. Avevo sbagliato a partire dinverno. Oh, le male tra-
montane!
Nel Canale la mala tramontana, per dirla con Barbaro, era
diventata tempesta. Le voci sul ponte si facevano sempre pi
concitate. Uscii sulla coperta sferzata dalle onde. Il comandan-
te in persona era aggrappato al timone con altri due marinai,
tanto era lo sforzo per tenere la barra dritta.
De Marco, non riusciamo a vedere quel maledetto faro di
Otranto, eppure dovrebbe essere vicino, ma che dico, dovrem-
mo esserci quasi sopra. Sento le onde farsi pi alte.
Aguzzavo lo sguardo ma oltre la prua cera solo notte buia.
Ahaaaa, a sinistra, tutta a sinistra, viraaaa!
La voce della vedetta lacer laria mentre un lampo illumi-
n le scogliere a poche braccia dalla prua e sulle scogliere la
Torre e la finestra della lampada solo un quadrato nero.
Maledette le secare!
Mi ritorn in mente quella storia, sentita da giovane, delle
serpi che bevevano lolio della lampada sulla Torre. Mi ricordai
del vecchio guardiano, Stefano, che me laveva raccontata e
limmaginai addormentato per il vino e la fatica. Il faro era
spento e in quella notte di tregenda solo quelle maledette serpi
potevano avere avuto la malignit di spegnere il lume.
Sentivo il fragore della risacca farsi sempre pi vicino tra le
urla dei marinai che tentavano di governare per riguadagnare il
largo. Ma uno schianto, mentre eravamo nel cavo dellonda, ci
annunci che la chiglia aveva cozzato sugli scogli. La nave si
stava spezzando. Ero appena precipitato nellacqua gelida che
come una folgore le parole di Lei attraversarono la mia mente:
Io posso proteggere i tuoi sogni, non la tua vita!
I fulmini illuminarono ancora la scogliera. Riconobbi oltre
la spuma delle creste la Cala dellOrte. Ero a Otranto, a pochi
passi dalla mia citt, dai resti di Csole, dalle serre. Un altro
susseguirsi di lampi illumin le rocce ormai vicinissime e, drit-
ta sulla sommit della scogliera, vidi una donna con una lunga
:cc
tunica bianca stretta in vita da una pesante cintura dargento
che mi sembr pi adatta a sorreggere una spada che a posarsi
sui morbidi fianchi di una donna. Tentai di gridare il nome di
Alberada ma fu il mare di Otranto a bere il mio fiato.
Quando il mio corpo, spinto da unonda immensa, si in-
franse sugli scogli aguzzi non avvertii alcun dolore.
:c:
Il volume privo del simbolo
delleditore sullaletta da
ritenersi fuori commercio
Potrebbero piacerti anche
- Storie Minori della Divina Commedia: storie nel mezzo del cammin di nostra vitaDa EverandStorie Minori della Divina Commedia: storie nel mezzo del cammin di nostra vitaNessuna valutazione finora
- Scrittidicritica 00 TommuoftDocumento276 pagineScrittidicritica 00 TommuoftAndre CastroNessuna valutazione finora
- I Demagoghii Misteri Di Livorno by Monteverde, CesareDocumento241 pagineI Demagoghii Misteri Di Livorno by Monteverde, CesareGutenberg.orgNessuna valutazione finora
- Simulazione Prima Prova - 11 AprileDocumento8 pagineSimulazione Prima Prova - 11 AprileSconvolt GatesNessuna valutazione finora
- Nero Caravaggio - Rosso Barocco - Il giallo di Ponte SistoDa EverandNero Caravaggio - Rosso Barocco - Il giallo di Ponte SistoNessuna valutazione finora
- Storia Di Sebastianus Venetus Il PittoreDocumento79 pagineStoria Di Sebastianus Venetus Il PittoreMarco Lorenzo FaustiniNessuna valutazione finora
- Emanuele Maineri Baccio, LA LEGGENDA DEL BURANCODocumento139 pagineEmanuele Maineri Baccio, LA LEGGENDA DEL BURANCOmangiacarrubeNessuna valutazione finora
- Aleardi CantiDocumento338 pagineAleardi CantialdosciNessuna valutazione finora
- L'isola del tesoro: Ediz. integraleDa EverandL'isola del tesoro: Ediz. integraleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5520)
- "L'Adalgisa" Una Performance IntroduttivaDocumento9 pagine"L'Adalgisa" Una Performance IntroduttivaAntonio BaroneNessuna valutazione finora
- I ricordi del Capitano d'Arce. Con Introduzione e Note di Anna Morena MozzilloDa EverandI ricordi del Capitano d'Arce. Con Introduzione e Note di Anna Morena MozzilloNessuna valutazione finora
- "i diari della bicicletta-storie di salotto e di trincea"Da Everand"i diari della bicicletta-storie di salotto e di trincea"Nessuna valutazione finora
- Aleardi Aleardo - CantiDocumento238 pagineAleardi Aleardo - CantiElemireZollaNessuna valutazione finora
- Dario Fo - Contra JogulatoresDocumento8 pagineDario Fo - Contra JogulatoresmangiacarrubeNessuna valutazione finora
- Pariani Laura - Questo Viaggio Chiamavamo AmoreDocumento158 paginePariani Laura - Questo Viaggio Chiamavamo AmoreLilaNessuna valutazione finora