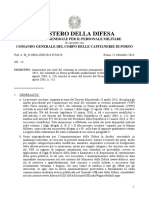Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Personalismo o Individualismo
Caricato da
Marialucia Bonofiglio0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
14 visualizzazioni2 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
14 visualizzazioni2 paginePersonalismo o Individualismo
Caricato da
Marialucia BonofiglioCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 2
Il dibattito recente confonde i diritti
dell’individuo e snatura il concetto di persona.
Ma così si stravolge la lezione di Mounier
Il personalismo? Non è individualismo
DI GIORGIO CAMPANINI
D a qualche tempo a questa parte è in atto un inquietante processo di trasformazione (o, piuttosto,
di deformazione) del concetto di persona.
Nato nei primi decenni del Novecento per reagire all’individualismo borghese (e a un’etica,
quella kantiana, incentrata esclusivamente sul soggetto) il personalismo si è sempre connotato, al
di là dell’estrema varietà dei suoi percorsi interni, per l’accentuazione della dimensione relazionale
dell’io: non a caso, del resto, una delle sue più importanti ed incisive espressioni storiche è stata
quella del personalismo comunitario (di Emmanuel Mounier, e non solo).
Ciò che ha sempre distinto il personalismo dall’individualismo (al di là delle formule e talora
dalla terminologia usata) è stato il rapporto con l’altro: occasionale e puramente esteriore per
l’individualismo, strutturale e determinante per il personalismo. L’individuo è un essere solitario e
autoreferenziale, la persona un essere sociale e radicato nella rete di relazioni.
Questa distinzione può apparire astratta e un poco scolastica, ma è ricca di conseguenze. Per
l’individualismo ciascuno è libero di disporre liberamente di se stesso e del proprio corpo, in nome
del principio di un’assoluta e insinda- cabile «autodeterminazione»; per il personalismo l’uomo è
un essere sociale inserito in una serie di relazioni e di correlativi obblighi.
Per l’individualismo l’uomo non deve «rispondere» di alcunché a chicchessia; per il personalismo
l’uomo è al centro di una rete di responsabilità. E così via.
Sono evidenti le implicazioni pratiche di questa distinzione. Abortire o non abortire è scelta
«individuale » della sola donna, e non un confronto con l’altro (il nascituro) e gli altri (il padre, la
società, la comunità che attende di essere arricchita da un figlio). Continuare a vivere o decidere di
morire, ricorrendo al suicidio, è una scelta sulla quale nessuno può interferire e che anzi, a giudizio
di taluni, la società dovrebbe non solo non impedire ma favorire attraverso il «suicidio assistito» e
così via.
È su questo sfondo che suscita non poche perplessità – almeno in chi si sente erede ed in qualche
modo interprete della tradizione personalista – sentire parlare di «riscoperta del personalismo» (se-
condo quanto recentemente affermato da Vannino Chiti su Europa)
a proposito di posizioni che appaiono di chiara marca individualistica, come individualistico è il
«principio di autodeterminazione » quando sia fondato sulla tesi secondo cui ciascuno è responsa-
bile soltanto di fronte a se stesso, e non anche di fronte agli altri ed alla società (e, per il credente,
anche a Dio).
La questione merita di essere sviluppata ed approfondita in sedi ben più qualificate di quanto non
siano le colonne di un giornale.
Ma chi si ispira al personalismo comunitario non può non provare un segreto brivido nel
constatare quanta parte della cultura «di sinistra » – un tempo fortemente legata ad una visione
solidaristica della vita e per questa ragione oggetto di penetrante attenzione da parte del
personalismo comunitario – si sia fatta invischiare nelle secche di quello che Mounier chiamava lo
«spirito borghese» (come borghese, appunto, è il principio dell’assoluta e indiscriminata
autoreferenzialità, sul piano degli affari come su quello della vita). Non è questo lo spirito della
Costituzione, fortemente impregnata della cultura del personalismo comunitario, quando tesse
attorno alla persona umana (pur se essa è espressamente invocata con sobrietà) una fitta rete di
relazioni che vanno dalle «formazioni sociali » (art. 3), alle autonomie locali (art. 5) alla famiglia
(art. 29). «Riscoprire il personalismo» non può significare accettare l’esclusiva autoreferenzialità
del singolo ma recuperare la relazionalità strutturale della persona, come un «io» che si rapporta
sempre, anche nelle situazioni più drammatiche della vita, a un «tu» che lo fronteggia e insieme lo
trascende.
Rompere l’estrema solitudine dell’io, anche alle frontiere della vita, non è un’invasione di campo
di un presunto «Stato etico» (impropriamente evocato da uno degli eredi di questa metafisica
scuola di pensiero) ma un riaffermare la dimensione comunitaria dell’esistenza. L’uomo non è mai
solo, anche nell’apparentemente solitudine della morte.
Avvenire, 16 aprile 2009, pag. 29
Potrebbero piacerti anche
- Invisible ChildrenDocumento38 pagineInvisible Childrenalessiomannucci100% (1)
- L12 - Cap. 10 - Contabilità Nelle IP - AGGDocumento39 pagineL12 - Cap. 10 - Contabilità Nelle IP - AGGMimi ZetaNessuna valutazione finora
- Alghe Curano Infertilita' Maschile - Corriere Della SeraDocumento2 pagineAlghe Curano Infertilita' Maschile - Corriere Della SeraTradamixNessuna valutazione finora
- Circolare VSP 2015Documento50 pagineCircolare VSP 2015Gabriella Miceli Max D'AurelioNessuna valutazione finora