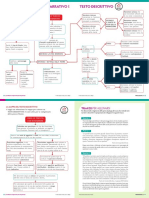Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Diritto Canonico
Diritto Canonico
Caricato da
Rebecca Gianforte0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2 visualizzazioni5 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2 visualizzazioni5 pagineDiritto Canonico
Diritto Canonico
Caricato da
Rebecca GianforteCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 5
La Marcia della Pace ed il dialogo
interreligioso.
VALENTINA JASMINE CHIAVAROLI MATR. 100129
LEONARDO DI BIASE MATR. 100245
MARGHERITA GIANCOLA MATR. 101291
REBECCA GIANFORTE MATR. 100100
CELESTE MONTENOVO MATR. 100264
NICCOLO’ LORENZO NIGRO MATR. 100274
LUCIA PISCIONE MATR. 100174
GIANLUIGI SARDELLA MATR. 100357
ILARIA TOMASI MATR. 100203
WALTER VERRIGNI MATR. 100007
La Marcia per la pace Perugi-Assisi è una manifestazione del movimento pacifista italiano nata il 24
settembre 1961 su invito di Aldo Capitini, iniziatore del movimento nonviolento in Italia e proponeva il
motto: “Per la pace e la fratellanza tra i popoli”. [1]
Si svolge solitamente tra fine settembre e inizio ottobre e si snoda per un percorso di circa 20 chilometri, da
Perugia fino ad Assisi.
Fino ad aggi ci sono state 24 Marce della pace, ognuna con un proprio tema collegato alle battaglie
economiche e politiche del tempo, ai valori sociali definiti dagli stessi fautori “più cari”. Dopo le edizioni del
1978 “Mille idee per la pace” e del 1985 “Svuotiamo gli arsenali, riempiamo i granai”, ai giorni nostri la
marcia ha assunto una cadenza biennale rappresentando l’appuntamento più importante per i movimenti pa-
cifisti italiani e internazionali; non a caso proprio in questa occasione venne per la prima volta utilizzata la
Bandiera della pace, simbolo dell'opposizione nonviolenta alle guerre e baluardo della difesa della pace, dei
diritti umani e della fratellanza. [2]
La marcia del 2021 nasce in risposta alla pandemia, alla crisi sociale ed economica. E’ intitolata I CARE:
questo tema esprime chiaramente la necessità di "prendersi cura" dei più poveri e più vulnerabili, del pianeta,
del bene comune, dei diritti umani e della democrazia. È tempo di ricominciare a lavorare per sconfiggere
l’indifferenza: I CARE è il nuovo nome della pace. [3]
La rilevanza del movimento è mondiale e attira l’attenzione e l’interesse dei maggiori personaggi politici e
sociali che si fanno suoi portavoce. David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, afferma come la
marcia della Pace rappresenti da sempre una straordinaria testimonianza di speranza, sottolineando la
necessità di rafforzare la coesione europea e investire nel valore della comunità per ridurre le disuguaglianze.
Non basta l’assenza di guerra: l’Europa deve dimostrarsi capace tramite iniziative concrete di diventare uno
strumento di pace, un progetto per il bene di tutti capace di proteggere le persone, sostenere le imprese ed
investire nell’uguaglianza, nel progresso sociale e nel benessere economico.
Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana, sostiene che i valori che ispirano la marcia Perugia-
Assisi e la partecipazione che continua a suscitare nonostante il passare degli anni sono risorse preziose e di
responsabilità. Avere a cuore il proprio destino come quello dell’altro che ci sta accanto è la scintilla della
cultura di pace che può sconfiggere l’egoismo, l’indifferenza e la violenza.
Quest’anno in occasione del sessantesimo anniversario i partecipanti sono stati più di trentamila. Il tema
della “cura come nuovo nome della pace” ha spinto Papa Francesco a sottolineare come la cura rappresenti il
contrario dell’indifferenza, di quell’anti-cultura che è alla base della violenza e della guerra. E’ perciò
necessario camminare sulla sua via ogni giorno, concretamente, con l’aiuto di Dio “che è padre di tutti e di
tutti si prende cura, perché impariamo a vivere insieme da fratelli e sorelle”. [4]
E’ proprio questa volontà di Dio di salvare ogni uomo e di promuovere l ’unità e la carità che si pone
all’origine del dialogo tra le religioni. L'espressione dialogo interreligioso si riferisce all'interazione positiva
e cooperativa fra differenti tradizioni che operano per la tolleranza e il rispetto reciproco.
Il dialogo della Chiesa Cattolica deve ad intra ridefinire la propria identità alla luce delle nuove istanze
sociali, storiche, politiche, culturali e mondiali; e ad extra confrontarsi con il mondo e le attese dell’Umanità
del terzo millennio. Si parla di vivere in uno spirito di apertura e di promozione dei valori comuni, non
soltanto in riferimento a persone radicate nel mondo religioso ma a tutti i cittadini. E’ dialogo di vita, di
opere, di scambi teologici e di esperienza religiosa. [5]
Per creare relazioni positive e costruttive tramite questo atteggiamento di apertura e di conoscenza è
necessario un solido contesto civile garantista rispetto alla libertà personale e comunitaria delle diverse fedi:
lo storico clima di opposizione tra civile e religioso lascia oggi spazio ad una laicità assertiva capace di
costituire uno spazio dialogico dove le diverse comunità di fede, tutelate nella propria differenza, possano
convergere nel reciproco riconoscimento.
Il caso italiano è unico per l’intreccio storico, geografico e politico con la Città del Vaticano, oltre che per la
presenza di una stragrande maggioranza della popolazione di professione cattolica: la libertà religiosa è
garantita costituzionalmente anche se la sua attuazione prevede la stipula di Intese tra comunit à e Stato.
Questo assume in materia il compito di garantire ad ogni credo ampia autonomia e tutela rispetto ad un
eccessivo ‘cattolicesimo diffuso’ nelle istituzioni pubbliche.
Il diritto alla libertà religiosa si colloca all’interno di quel nucleo di diritti fondamentali della persona che
concorrono a definire l’essenza della dignità umana. Non a caso nella Costituzione vengono riconosciuti i
diritti inviolabili, sia al singolo in quanto tale che nelle formazioni sociali (art. 2) e l ’uguaglianza dei cittadini
senza distinzione di religione (art. 3), dando alle Repubblica il compito di rimuovere ostacoli di ordine
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. In merito ai rapporti tra Stato e
Chiesa, l’art. 7 indica che questi sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine. Inoltre, tutte le
confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e quelle diverse dalla cattolica possono
organizzarsi secondo gli statuti. (art. 11)
Infine, all’articolo 19 si indica come tutti abbiano il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa,
in forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purch é
non si tratti di riti contrari al buon costume (tutela anche nell’art 18 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’uomo). [6]
Anche patti internazionali infatti vietano costrizioni sulla libertà di scegliere una religione o un credo.
Fondamentale è la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e di
discriminazione basata sulla religione o sulla fede per cui la violazione della libertà di religione sarebbe
matrice di guerre e sofferenze per l’umanità ed è compito dello Stato eliminarle (art.4). il dialogo
interreligioso unitamente al dialogo interculturale è considerato nei documenti dell’Unione Europea una
pratica fondamentale per “dare un contributo significativo allo sviluppo di una “società libera, ordinata e
coesa”, che sappia “superare l’estremismo filosofico e religioso, gli stereotipi e i pregiudizi, l’ignoranza e
l’indifferenza, l’intolleranza e l’ostilità, che anche nel passato recente sono stati causa di tragici conflitti e di
spargimento di sangue in Europa”. (Dichiarazione sul dialogo interreligioso e sulla coesione sociale,
adottata dai Ministri dell’Interno nella Conferenza di Roma di ottobre 2003 e fatta propria dal Consiglio
Europeo, doc. 5381/04).
Non solo nel diritto statale ma anche in ambito canonico il principio di libertà religiosa ha seguito un lungo
percorso evolutivo: dopo la condanna di Pio IX nel "Sillabo" (1864) questa ottenne pieno riconoscimento nel
1965 con la Dignitatis humanae. Parliamo di una risultanza fondamentale del Concilio Vaticano II: dopo
questo infatti il dialogo tra le religioni entra a far parte della missione di evangelizzazione della Chiesa
cattolica. È bene precisare che la questione viene affrontata prettamente dal punto di vista giuridico: la libertà
religiosa è considerata come un diritto naturale del quale sono titolari tutti gli uomini, compresi coloro che
non soddisfano l'obbligo morale di cercare e di seguire la verità e trovando limite solo nel rispetto del diritto
altrui. [7] [8] [9]
La dichiarazione conciliare Nostra Aetate è necessaria per la comprensione del dialogo della Chiesa cattolica
con le altre tradizioni religiose tramite la riflessione sulla fraternità universale: “Non possiamo invocare Dio
come Padre di tutti gli uomini se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono
creati ad immagine di Dio”. La Chiesa assume quindi il ruolo di guida nel dialogo perpetuo tra Dio e
l’umanità come sottolineato nell’enciclica Ecclesiam suam del 1964. [10]
La storia recente vive alcuni significativi momenti di dialogo, sebbene di frequente vengano dimenticati.
Eppure abbiamo negli occhi le immagini delle visite e delle preghiere degli ultimi Pontefici nelle moschee o
nelle sinagoghe. Con il pontificato di Giovanni Paolo II il magistero della libertà religiosa viene
approfondito: nella Lettera ai capi di stato sulla libertà religiosa e sul documento finale di Helsinki del
01/09/80 vengono individuati i singoli contenuti concreti del diritto di libertà religiosa sul piano personale e
comunitario, arrivando ad affermare che questa vada considerata in tutta la sua ampiezza come “assenza di
coercizioni esterne” fino a “responsabilità per il bene comune”. Nello stesso solco si inserisce la grande
preghiera per la pace ad Assisi nel 1986 con tutti i principali rappresentanti delle varie religioni. Tutti
impegnati per una preghiera di pace, ciascun gruppo pregò a suo modo e in luoghi vicini, ma diversi.
Il processo di condivisione e dialogo viene perseguito anche negli anni e dai successivi pontefici:
emblematica è la lettera del 13 ottobre 2007, firmata da 160 guide religiose musulmane ed indirizzata a
Papa Benedetto XVI e a numerosi patriarchi delle Chiese d’oriente. Il vero punto di incontro tra religioni
così lontane è l’amore verso Dio e questa vicinanza deve essere mantenuta con impegno
quotidiano e continuo negli anni come sottolineato in occasione dell’incontro del 20 aprile 2015 tra
Papa Francesco e la delegazione della conferenza dei rabbini europei.
Non sempre però le religioni sono state in grado di dialogare tra loro: la storia ci insegna che si sono
combattute non poche guerre e sacrificate non poche vite in nome di Dio, qualunque esso fosse. La religione
infatti è insieme strumento di integrazione, di trasformazione sociale ma anche generatore di conflittualità. I
flussi migratori tendono a far lievitare il numero di Paesi dove vi è una forte presenza di comunit à
appartenenti a diverse fedi. Si aprono questioni di convivenza quotidiana dovute, per esempio, ad usi
alimentari (il divieto di mangiare il maiale per i musulmani o la carne bovina per gli indù) o di costume (il
turbante dei sikh, il velo per alcune donne arabe), altre dovute alla possibilità di praticare il proprio culto in
luoghi idonei.
In generale, il fondamento e la finalità dell’etica di ogni religione sono differenti e spesso difficilmente
coniugabili. Eppure è possibile percorrere dei tratti di strada comuni che consentano di vivere in armonia
rispettando le differenze: ecco il patto sociale che permette la convivenza pacifica tra le persone singole e le
diverse culture.
E’ necessario allora conoscere la distanza tra le varie religioni studiando il loro credo e la loro cultura per
poter capire come si possa realizzare il dialogo interreligioso poiché “Parlare di dialogo richiama
necessariamente il tema dell’identità, considerato spesso in alternativa al dialogo, come realtà acquisita che
si vuole conservare ad oggi costo” (Canta, Pepe 2007). [11]
L’identità dal punto di vista sociologico è la concezione che una persona ha di se stesso anche in relazione
alla sua appartenenza a gruppi sociali. Da essa scaturiscono due problematiche: da una parte c’è la necessit à
di consolidarla e dall’altra di proteggerla da tutto ciò che viene considerato come diverso per non essere
contaminati. Eppure la persona costruisce la sua identità mettendosi in relazione con gli altri ed è per questo
che non è considerata statica ma aperta. [12]
I riti e le pratiche da cui nasce il senso di appartenenza dei fedeli al credo sono in realtà origine anche di
somiglianze. Un esempio lo troviamo nelle tre grandi religioni del Mediterraneo: si pensi al digiuno presente
nella Quaresima dei cattolici, nel Ramadan dei musulmani, nello Yom Kippur degli ebrei; si pensi ai
pellegrinaggi: la Mecca (Hajj) per i musulmani, Santiago de Compostela per i cristiani, la salita verso
Gerusalemme per gli ebrei. C’è poi il giorno di festa e di preghiera settimanale: sabato, venerdì e domenica.
[13]
Anche nella differenza si può arrivare ad un “noi”: l’uomo deve per realizzarsi e completarsi accettare l’altro
come fratello. Il dialogo è connaturato nella nostra stessa identità perchè bisogna percorrere la via
dell’accoglienza ed evitare la tentazione dell’intolleranza e dell’emarginazione. L’apertura dialogica alle
esperienze religiose altrui è l’occasione di approfondimento della propria fede: la sfida è rendere la propria
identità più chiara e più aperta senza andare a “snaturarla”. L’incontro infatti non trascura la propria fede ma
nemmeno il rispetto della sensibilità e libertà religiosa.
Fino ad alcuni decenni fa per conoscere l’islam, l’induismo o il Buddhismo bisognava affrontare un viaggio,
imparare lingue diverse e immergersi in una realtà molto lontana. Oggi possiamo dire che le religioni del
mondo sono venute ad abitare in casa nostra grazie allo sviluppo delle comunicazioni e della
globalizzazione. Spesso però queste diversità sono viste più come una minaccia che come risorsa a causa
della non conoscenza e dei pregiudizi. I tesi rapporti internazionali, il terrorismo, la superficialità dei mass
media fanno sorgere barriere di reciproche incomprensioni. Sono necessari allora nuovi strumenti di
comprensione: i rapporti tra religioni non vivono soltanto in una dimensione teoretica ma nella vita di tutti
giorni come straordinaria opportunità di arricchimento e cultura. [14]
È necessario abitare le frontiere per incontrare l’altro e per costruire insieme un mondo migliore. Occorre
anche riappropriarci della concezione dell’uomo come costruttore di pace capace di difendere i suoi diritti
ma anche quelli degli altri nell’osservanza dei suoi doveri. Una solida conoscenza della nostra cultura ci
rende pronti al rispetto della dignità di ognuno. I cambiamenti della nostra società avvengono attraverso la
formazione e l’educazione del singolo che agisce insieme per migliorare il suo contesto sociale. Esercitare il
dialogo e il confronto ci permette di scoprire e accettare i nostri limiti e quelli degli altri: Ritornare a noi
dopo essere passati attraverso una prospettiva estranea rappresenta un movimento che arricchisce e libera.
Bibliografia
[1] A sessant’anni dalla prima marcia della Pace, (ilmanifesto.it)
[2] Breve storia della marcia della Pace, (albiolotoday.altervista.org)
[3] Marcia per la pace, (www.perugiassisi.org)
[4] Messaggio del Santo Padre per la Marcia della Pace, (www.vatican.va)
[5] Il dialogo interreligioso, Angelo Vescovi
[6] Dialogo interreligioso e valori universali, Università degli studi di Padova
[7] Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, (www.vatican.va)
[8] Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica, (www.statoechiese.it), Antonino
Mantineo
[9] Lezioni di Diritto Canonico quinta edizione, Giuseppe Dalla Torre
[10] Il dialogo interreligioso, (www.centrostudifrancescani.it)
[11] Dialogo interreligioso e interculturale tra educazione e scuola, Gianni Vacchelli
[12] Esploratori dell’invisibile, Documento AGESCI sul dialogo interculturale ed interreligioso
[13] Cristiani nel mondo, anno XIX n.2 marzo/aprile/maggio 2004
[14] Incontri, dialogo interreligioso, Fondazione centro Astalli- ONLUS
Potrebbero piacerti anche
- Mappa Concettuale Storia Dell'arte ContemporaneaDocumento4 pagineMappa Concettuale Storia Dell'arte ContemporaneaAlessandro Luoni83% (6)
- Testo Narrativo E Testo Descrittivo: Tipologia ADocumento3 pagineTesto Narrativo E Testo Descrittivo: Tipologia AMaria StaibanoNessuna valutazione finora
- Su Georgij FilatovDocumento4 pagineSu Georgij FilatovLorenzo PubbliciNessuna valutazione finora
- FilettatureDocumento53 pagineFilettatureCosimo BruzzeseNessuna valutazione finora
- Giordano Bruno e GalileoDocumento3 pagineGiordano Bruno e Galileorimofabio_569973046Nessuna valutazione finora