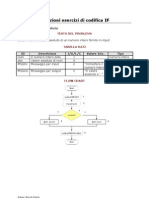Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Esame Economia Politicac
Esame Economia Politicac
Caricato da
Emanuele Di DioTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Esame Economia Politicac
Esame Economia Politicac
Caricato da
Emanuele Di DioCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|3969374
Esame Economia Politicac
Economia Politica (Università Cattolica del Sacro Cuore)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
ESAME ECONOMIA POLITICA
Cap. III
FORZE DI MERCATO: DOMANDA E OFFERTA
La domanda e l’offerta si riferiscono al comportamento degli individui all’interno del
mercato. MERCATO: insieme di venditori e compratori di un determinato bene o
servizio
Uno dei principi fondamentali del modello di mercato è che se le ipotesi sono
confermate, di conseguenza l’allocazione delle risorse che ne risulta sarà “efficiente”.
DOMANDA: determinata dall’insieme dei compratori
OFFERTA: determinata dall’insieme dei venditori
Il modello della domanda e dell’offerta che conduce a tale risultato efficiente si basa
sulle seguenti ipotesi:
- Nel mercato sono presenti molti compratori e venditori
- Ciascun compratore e venditore è perfettamente informato
- Nessun compratore o venditore ha dimensioni o potere sufficienti a
influenzare il prezzo
- Nel mercato c’è libertà di entrata e di uscita
- I beni prodotti sono omogenei
- Compratori e venditori agiscono indipendentemente, considerando solo
il proprio interesse
MERCATI CONCORRENZIALI
Si ha ‘concorrenza’ quando due o più imprese competono per attirare i consumatori.
In un mercato perfettamente concorrenziale operano molti compratori e molti
venditori, ciascuno di loro ha un impatto irrilevante sul prezzo e deve accettare il
prezzo determinato dal mercato: pertanto, i partecipanti a questo tipo di mercato
sono detti ‘price taker’. In un mercato perfettamente concorrenziale i prodotti sono
identici, pertanto il singolo venditore ha scarso interesse ad applicare un prezzo
inferiore a quello corrente, e se applica un prezzo superiore, i compratori faranno
acquisti altrove. Allo stesso modo, il compratore non può singolarmente influenzare
il prezzo, dal momento che acquista solo una piccola quantità del bene rispetto alla
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
domanda complessiva nel mercato: i compratori prendono le proprie decisioni sulla
base dell’utilità o soddisfazione che ottengono dal consumo, indipendentemente
dalle decisioni dei produttori.
Ci sono alcuni mercati ai quali si applica interamente l’ipotesi di ‘concorrenza
perfetta’. Ad esempio nel mercato dei prodotti agricoli della UE ci sono circa 14
milioni di agricoltori che vendono creali, frutta, latte ecc.; dal momento che nessun
singolo venditore è in grado di influenzare il prezzo dei prodotti agricoli, deve
prenderlo per dato e vendere tutta la produzione a prezzi di mercato. I prodotti nei
mercati agricoli sono tutti più o meno simili: il latte di un allevatore infatti non è poi
chissà quanto diverso da quello prodotto da un altro allevatore, sebbene occorra
ricordare che vi sono differenze tra qualità e utilizzo. In particolare l’esempio del latte
è bene da tenere in considerazione, in quanto il mercato del latte presenta molte
caratteristiche che contribuiscono a renderlo ‘mercato perfettamente
concorrenziale’.
LA DOMANDA
La domanda dei beni e servizi è costituita complessivamente dai compratori, o
consumatori.
Curva di domanda
La quantità domandata di un bene è la quantità di quel bene che i compratori
vogliono e possono acquistare ad ogni dato prezzo. E’ proprio il prezzo l’elemento
che gioca un ruolo fondamentale nel meccanismo di funzionamento del mercato. Se
il prezzo del latte aumentasse da 0,25 cent a 0,35 cent al litro, si acquisterebbe meno
latte; mentre se il prezzo del latte diminuisse a 0,20 cent al litro, se ne acquisterebbe
di più. La quantità domandata di latte aumenta pertanto se il prezzo diminuisce, e
viceversa, e questa affermazione ci porta a considerare che la quantità domandata è
inversamente correlata al prezzo. La relazione tra prezzo e quantità domandata è
rappresentabile con il seguente grafico:
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Il seguente grafico mostra la quantità domandata ad ogni livello di prezzo. Come si
può notare, una diminuzione di prezzo provoca un aumento della quantità
domandata, e vediamo che la curva di domanda ha pendenza negativa.
Domanda di mercato e domanda individuale
Per analizzare il funzionamento di un mercato, occorre determinare la domanda di
mercato, che corrisponde alla somma di tutte le domande individuali di un dato
bene o servizio.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
In accordo con la seguente tabella, possiamo stabilire la quantità di latte domandata
rispettivamente da Caterina e Nicola: la domanda di mercato a ciascun prezzo è la
somma delle due domande individuali. Per trovare la quantità domandata
complessivamente nel mercato a ogni livello di prezzo, occorrerà sommare i
corrispondenti valori riscontrati sull’asse delle ascisse delle curve di domanda
individuali. La curva di domanda di mercato mostra come varia la quantità
domandata totale di un bene al variare del prezzo del bene stesso, a parità di tutti gli
altri elementi che possono influenzare la quantità del bene che i consumatori
desiderano acquistare.
Spostamenti della curva di domanda e movimenti lungo la curva di domanda
Fino ad ora le curve di domanda individuale e di mercato sono state tracciate
ipotizzando la parità delle altre condizioni, ovvero che tutti li altri fattori che possono
influenzare la domanda rimangano fissi. Ma se il valore di uno dei fattori che
influenzano la domanda CAMBIA, la curva di domanda si sposta. Per esempio, se al
prezzo di 0,30 cent al litro un nucleo familiare acquista 5 litri di latte alla settimana,
se il suo reddito aumenta, può permettersi di acquistare più latte e potrebbe quindi
cominciare a comprarne 7 litri. Il prezzo del latte dunque non è cambiato: è sempre a
0,30 cent al litro ma la quantità di latte acquistata dal nucleo familiare è aumentata.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Così stabiliamo che al variare dei fattori, diversi dal prezzo, che influenzano la
domanda, cambia la quantità del bene che i consumatori desiderano acquistare a
ogni livello di prezzo.
Movimenti lungo la curva di domanda
La diminuzione del prezzo provoca un aumento della quantità domandata, per due
ragioni:
- L’effetto di reddito. Se ipotizziamo che i redditi rimangano invariati, la
diminuzione del prezzo del latte implicherebbe che i consumatori
possano permettersi di comprarne una quantità maggiore con il loro
reddito
- L’effetto di sostituzione. In seguito alla diminuzione del prezzo del latte
rispetto ad altri prodotti, alcuni consumatori decidono di sostituire le
bevande più costose con quella divenuta più conveniente
Spostamenti della curva di domanda
La curva di domanda si sposta se uno o più fattori che influenzano la domanda,
diversi dal prezzo, cambia. Ad esempio, poniamo il caso che le autorità sanitarie
comunichino che le persone che bevono latte regolarmente vivono più a lungo; ecco
che questo annuncio farebbe aumentare la domanda di latte, ovviamente a discapito
di altri prodotti.
Il seguente grafico mostra gli spostamenti della curva di domanda:
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Qualsiasi cambiamento che faccia aumentare la quantità che i compratori
desiderano acquistare a ogni livello di prezzo, provoca uno spostamento verso destra
della curva di domanda; viceversa qualsiasi cambiamento che faccia diminuire la
quantità che i compratori desiderano acquistare a qualsiasi livello di prezzo, provoca
uno spostamento verso sinistra della curva di domanda.
Ora, ipotizziamo che il prezzo del latte diminuisca: la legge della domanda afferma
che i consumatori acquisteranno più latte. Allo stesso tempo però acquisteranno
meno altri prodotti simili che potrebbero soddisfare gli stessi desideri del latte.
Quando la diminuzione del prezzo di un bene provoca la riduzione della domanda di
un altro bene, si dice che i beni siano sostituti. Più due beni sostituti sono correlati,
tanto maggiore è l’effetto sulla domanda se il prezzo dell’uno varia, mentre quello
dell’altro rimane inalterato. Quando invece la diminuzione del prezzo di un bene,
provoca un aumento della domanda di un altro bene, si dice che i due beni sono
complementari: i beni complementari sono spesso coppie di beni che vengono
utilizzati insieme, come benzina e automobili, latte e cereali.
Le variazioni di reddito incidono sulla domanda. Se il reddito diminuisce, gli individui
hanno meno capacità di spesa e quindi spendono meno per l’acquisto di alcuni beni.
Se la domanda di un bene diminuisce al diminuire del reddito, si diche che il bene in
questione è un bene normale. Se invece la domanda di un bene aumenta al
diminuire del reddito, si parla di bene inferiore.
Un importante determinante della domanda sono le preferenze: in quanto, se a un
individuo piace il latte, ne acquista in gran quantità.
Un altro fattore determinante della domanda è la popolazione: infatti, una
popolazione più numerosa comporta una maggiore domanda di beni e servizi.
L’OFFERTA
La seconda componente del mercato, dopo la domanda, è l’offerta, attraverso
l’analisi della quale esamineremo il comportamento dei venditori.
La curva di offerta
La quantità offerta di un bene o di un servizio è la quantità che i venditori vogliono e
possono vendere ad ogni livello di prezzo. Quando il prezzo del latte è più elevato, la
vendita del latte è più redditizia, quindi la quantità offerta è elevata: i venditori di
latte fanno acquistano più mucche e assumono lavoratori aggiuntivi per fare in modo
che l’offerta di mercato aumenti. Se invece il prezzo del latte è basso, vendere latte è
meno redditizio, e i venditori sono disposti a produrne meno. Se il prezzo del latte
scende al di sotto di un certo livello, alcuni venditori possono persino decidere di
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
cessare la produzione. Tale relazione tra il prezzo e la quantità offerta è detta legge
dell’offerta.
La seguente tabella mostra la quantità di latte che Pino è disposto a offrire a
differenti livelli di prezzo. Se il prezzo di 1 lt di latte è inferiore a 0,10 cent, Pino non
offre alcuna quantità di latte, ma a fronte di prezzi progressivamente più elevati,
Pino ne offre in quantità crescenti. Questa tabella pertanto illustra la relazione tra
prezzo e quantità offerta.
Offerta di mercato e offerta individuale
L’offerta di mercato è la somma delle offerte individuali di tutti i venditori. Per
trovare la quantità complessivamente offerta a ogni livello di prezzo si devono
sommare le relative quantità individuali misurate sull’asse delle ascisse nel grafico
dell’offerta individuale. La curva di offerta di mercato mostra come varia la quantità
offerta totale al variare del prezzo del bene.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Spostamenti della curva di offerta
Uno spostamento della curva di offerta piò essere causato da diversi fattori, diversi
dal prezzo, che influenzano l’offerta.
Ad esempio, i progressi della tecnologia accrescono la produttività, permettendo di
produrre una quantità maggiore utilizzando meno fattori di produzione, e di
conseguenza sia il costo totale sia quello unitario diminuiscono e l’offerta aumenta.
Spesso ci sono inoltre molti fattori naturali o sociali che influiscono sull’offerta, ad
esempio il clima, o i disastri naturali che influiscono sui raccolti, e tutti questi fattori
possono condizionare le decisioni di produzione.
Ancora, se nel mercato cresce il numero dei venditori, è logico aspettarsi che l’offerta
aumenti. Il numero di venditori in un mercato è determinato dalla redditività del
relativo prodotto e dalla facilità di entrata e uscita nel mercato.
L’EQUILIBRIO
L’equilibrio di mercato è una condizione di stabilità con cui non ci sono forze che
spingono a un cambiamento. In equilibrio, la domanda è uguale all’offerta.
MERCATO IN EQUILIBRIO: quando la quantità di bene che i compratori intendono
acquistare a un dato prezzo corrisponde alla quantità di bene che i venditori
vogliono vendere allo stesso prezzo. Il prezzo in questo caso viene detto prezzo di
equilibrio o prezzo di mercato e la quantità corrispondente è la quantità di equilibrio.
Se la curva si sposta dal prezzo di equilibrio si genera un’eccedenza o una penuria,
nonostante ciò le forze di mercato tendano a tornare in una posizione di equilibrio
ECCEDENZA: quando la quantità di beni offerta è maggiore rispetto alla domanda. I
venditori reagiscono diminuendo il prezzo, ciò attira più compratori. La diminuzione
di prezzo porta i venditori a diminuire la quantità prodotta.
PENURIA: quando la quantità domandata è maggiore della quantità di beni che i
venditori offrono al prezzo corrente. I venditori reagiscono aumentando il prezzo dei
beni, di conseguenza meno compratori acquistano il bene. Grazie all’aumento di
prezzi i venditori aumentano la quantità di beni prodotta
LEGGE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA: il prezzo di ogni dato bene tende
naturalmente ad aggiustarsi in modo da portare in equilibrio la quantità domandata
e la quantità offerta di quel bene
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Per i compratori il prezzo indica ciò a cui si deve rinunciare per acquistare il beneficio
che si ricava dal possesso di un bene o dalla fruizione di un servizio.
Utilità (soddisfazione): Questi benefici sono spesso detti utilità o soddisfazione.
Per i venditori il prezzo rappresenta un segnale della redditività della produzione. Un
aumento della produzione corrisponde a un aumento dei costi. Per far fronte a tale
aumento e per remunerare il venditore per il rischio che si assume le imprese
devono aumentare i prezzi, tale remunerazione è detta profitto.
Cap. IV
ELASTICITA
ELASTICITA: misura la reattività di compratori e venditori al cambiamento delle
condizioni di mercato
ELASTICITA DELLA DOMANDA AL PREZZO
Le imprese possono modificare il prezzo di un bene (tranne nei mercati
perfettamente concorrenziali). In questo modo influenzano il comportamento dei
consumatori. L’elasticità della domanda al prezzo misura la variazione della quantità
domandata al variare del prezzo.
Se la domanda di un bene aumenta considerevolmente allora si dice che la domanda
è elastica o sensibile al prezzo.
Se la domanda di un bene aumenta in modo modesto allora si dice che la domanda è
anelastica o insensibile al prezzo
- I beni che hanno stretti sostituti tendono ad avere una domanda più elastica
perché per i consumatori è facile sostituirli con beni da cui possono ricavare lo
stesso beneficio.
I beni necessari tendono ad avere una domanda anelastica mentre quelli di
lusso tendono ad avere una domanda elastica
- L’elasticità della domanda dipende anche dai confini del mercato. Se il
mercato ha confini ben definiti la domanda sarà piuttosto elastica. Se il
mercato avrà confini poco definiti la domanda sarà anelastica (è più facile
trovare sostituti).
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
- L’elasticità della domanda dipende anche dalla porzione di reddito destinata
all’acquisto di un bene. Maggiore è la porzione di reddito da destinare
all’acquisto del bene, maggiore sarà l’elasticità della domanda
- La domanda di un dato bene tende ad essere più elastica nel lungo periodo
che nel breve (es. benzina, energia elettrica)
GRAFICI ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
CALCOLO ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO
La formula comunemente utilizzata è la seguente:
VALUTAZIO PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DOMANDATA / VARIAZIONE
PERCENTUALE DEL PREZZO
Si supponga, ad esempio, che un aumento del 10% del prezzo dei cereali provochi
una diminuzione della quantità domandata del 20%. Le variazioni percentuali della
quantità domandata hanno sempre segno opposto a quelle del prezzo, pertanto
nell’esempio appena riportato, la variazione percentuale del prezzo è + 10% mentre
quella della uantità domandata è – 20%; generalmente la prassi comune vuole che
venga tralasciato il segno negativo e che venga attribuito segno positivo a tutti i
valori della elasticità. Sempre in accordo col nostro esempio, l’elasticità della
domanda al prezzo verrà calcolata con: 20% / 10% che è uguale a 2; pertanto riflette
il fatto che la variazione della quantità domandata è proporzionalmente doppia
rispetto a quella del prezzo. Se il valore della elasticità è compreso tra 0 e 1, la
domanda è anelastica, perché la variazione della quantità domandata è men che
proporzionale a quella del prezzo. Se il valore dell’elasticità è maggiore di 1 la
domanda è elastica, perché la variazione della quantità domandata è più che
proporzionale a quella del prezzo.
METODO DEL PUNTO MEDIO O ELASTICITA’ ARCUALE DELLA DOMANDA
Il metodo standard per calcolare una variazione percentuale consiste nel dividere la
variazione per il livello iniziale e moltiplicare il risultato per 100. Ora, se si considera
il seguente esempio:
Punto A: prezzo € 4 e quantità 120
Punto B: prezzo € 6 e quantità 80
Dal punto A al punto B, il prezzo aumenta del 50% e la quantità diminuisce del 33%;
pertanto il valore della elasticità della domanda al prezzo è di 33/50, ovvero 0,66.
Per contro, dal punto B al punto A, il prezzo diminuisce del 33% e la quantità
domandata aumenta del 50%, così il valore dell’elasticità della domanda al prezzo è
pari a 50/33, o 1,5.
In genere per evitare queste complicazioni, si ricorre al metodo del punto medio per
il calcolo della elasticità: così, invece di calcolare le variazioni percentuali con il
metodo tradizionale, il metodo del punto medio calcola ciascuna percentuale
dividendo la variazione per il punto medio tra il livello iniziale e quello finale. La
formula che viene utilizzata è la seguente:
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO = [(Q2 – Q1)] / [(Q2 + Q1) / 2] tutto
FRATTO / (P2 – P1) / [P2 + P1) / 2]
Il numeratore di questa espressione è la variazione percentuale della quantità
domandata, calcolata con il metodo del punto medio; mentre il denominatore è la
variazione percentuale del prezzo calcolata con la medesima formula.
Nel caso dell’esempio iniziale, il punto medio tra 4 e 6 euro è 5 euro: dunque, una
variazione da 4 a 6 euro è considerata un aumento del 40% perché (6 – 4) / 5 x 100 è
uguale a 40, e analogamente una variazione da 6 a 4 euro è considerata una
diminuzione del 40%.
METODO DELL’ELASTICITA’ PUNTUALE DELLA DOMANDA
L’elasticità puntuale della domanda calcola l’elasticità in un punto preciso sulla curva
di domanda.
Partendo dalla formula:
ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO = %ΔQd / %ΔP
La lettera greca Δ significa ‘variazione di’. Per calcolare le variazioni percentuali della
quantità domandata e del prezzo, si utilizza la seguente formula:
VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DOMANDATA = ΔQd / Qd tutto
moltiplicato x 100
VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO = ΔP / P tutto moltiplicato x 100
SPESA TOTALE, RICAVO TOTALE ED ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO
La spesa totale è data dalla quantità totale moltiplicata per il prezzo pagato.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Nella seguente tabella, viene raffigurata come la somma totale pagata dai
compratori e incassata come ricavo dai venditori sia pari all’area del rettangolo sotto
la curva di domanda, P X Q. Preso l’esempio per cui:
P = 4 euro
Q = 100
La spesa totale è pari a 4€ x 100, ovvero a 400 euro.
L’elasticità della domanda al prezzo è una variabile importante nel processo
decisionale delle imprese che non sono price-taker.
Se la domanda è anelastica, un aumento del prezzo causa un aumento della spesa
totale; e in accordo con l’esempio precedente un incremento del prezzo da 1 a 3
euro provoca una diminuzione della quantità da 100 a 80, ma al contempo un
aumento della spesa totale da 100 a 240 euro. L’aumento del prezzo accresce il
valore di P X Q perché la diminuzione di Q è proporzionalmente inferiore all’aumento
di P.
Se la domanda è elastica, si otterrà invece il risultato opposto, ovvero un aumento
del prezzo che provocherà una diminuzione della spesa totale.
Dunque:
- Se la domanda è anelastica, il prezzo e la spesa totale variano nella
stessa direzione
- Se la domanda è elastica, il prezzo e la spesa totale variano in direzioni
opposte
- Se la domanda ha elasticità unitaria, ovvero l’elasticità della domanda è
uguale a 1, qualsiasi variazione del prezzo lascia inalterata la spesa
totale
ELASTICITA’ E SPESA TOTALE LUNGO UNA CURVA DI DOMANDA LINEARE
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
L’elasticità in un dato punto della curva di domanda dipende dalla forma della curva
stessa. Una curva di domanda lineare ha una pendenza costante.
ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO
L’elasticità dell’offerta al prezzo misura la reattività della quantità offerta alle
variazioni del prezzo: l’offerta di un bene è detta ‘elastica’ se la quantità offerta varia
notevolmente a fronte di variazioni contenute del prezzo; mentre è ‘anelastica’ se le
variazioni della quantità offerta sono contenute a fronte di variazioni pronunciate del
prezzo.
ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO E LE SUE DETERMINANTI
L’elasticità dell’offerta al prezzo dipende dalla flessibilità dei venditori nel modificare
la quantità dei beni che producono. L’elasticità può assumere qualsiasi valore
maggiore o uguale a 0: quanto più si avvicina allo 0, tanto più l’offerta è anelastica;
quanto più tende all’infinito, tanto più l’offerta è elastica.
- L’orizzonte temporale. Nella maggior parte dei mercati una
determinante cruciale del valore dell’elasticità dell’offerta al prezzo è il
lasso di tempo preso in considerazione. Generalmente, l’offerta è più
elastica nel lungo periodo piuttosto che nel breve. Su un orizzonte
temporale estremamente ravvicinato per le imprese può essere
impossibile reagire a una variazione del prezzo modificando la quantità
offerta. Nel breve periodo, le imprese non possono adattare facilmente
le dimensioni degli impianti a livelli di produzione diversi da quelli
pianificati, ma godono comunque di una certa flessibilità: ad esempio,
per assumere nuova manodopera potrebbe essere necessario un mese
di tempo, trascorso il quale, si potrebbe espandere la produzione. Da
qui ne deriva che la quantità offerta non è molto sensibile alle variazioni
del prezzo. Nel lungo periodo invece, le imprese possono aprire nuovi
impianti o chiudere quelli esistenti; da qui ne deriva che la quantità
offerta può reagire in maniera più marcata alle variazioni del prezzo.
- La capacità produttiva. Nel breve periodo la maggior parte delle
imprese ha una capacità produttiva limitata: infatti, la quantità che la
singola impresa può produrre in ogni dato momento è determinata
dalla quantità di fattori di produzione della quale dispone. Nei periodi di
crescita economica sostenuta, le imprese potrebbero operare in
prossimità della piena capacità produttiva; se la domanda del loro
prodotto e i prezzi sono in aumento, per le imprese potrebbe essere
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
difficile espandere la produzione in tempi relativamente rapidi e quindi
l’offerta sarebbe più elastica.
- Le dimensioni dell’impresa e del settore. Nelle imprese e nei settori di
grandi dimensioni, la reazione dell’offerta a una uguale variazione del
prezzo potrebbe essere meno marcata rispetto a quella di imprese e
settori più piccoli: questa dinamica è collegata al numero di imprese nel
settore, a parità di altre condizioni, quanto più numerosi sono i
produttori nel settore, tanto più facile è espandere l’offerta.
- La mobilità dei fattori di produzione. C’è da tenere in considerazione
che spesso le imprese multinazionali costruiscono impianti identici fra
loro in diverse regioni del mondo: in questo modo, se il processo di
produzione in un impianto si arresta a causa di un guasto o di qualche
altro problema, l’impresa può facilmente trasferire le attività
dell’impianto in questione a un altro senza interrompere la produzione.
Ad esempio, diversi modelli di automobili sono dotati dello stesso
telaio, e grazie all’utilizzo dei medesimi componenti, l’offerta può
risultare più elastica.
CALCOLO DELL’ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO
Per calcolare l’elasticità dell’offerta al prezzo si segue un procedimento simile a
quello utilizzato per l’elasticità della domanda.
L’elasticità dell’offerta al prezzo è la variazione percentuale della quantità offerta
divisa per la variazione percentuale del prezzo, espressa con la seguente formula:
ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO = VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA
QUANTITA’ OFFERTA / VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO
METODO DEL PUNTO MEDIO PER IL CALCOLO DELL’ELASTICITA’
DELL’OFFERTA
Come per l’elasticità della domanda, anche in questo caso si può utilizzare la formula
seguente:
ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO = (Q2 – Q1) / [(Q2 + Q1) / 2] tutto fratto / (P2 –
P1) / [(P2 + P1) / 2]
TIPOLOGIE DI CURVE DI OFFERTA
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Nel primo grafico, l’elasticità ha valore 0, e l’offerta è perfettamente anelastica e la
curva di offerta è verticale: in tal caso, la quantità offerta è indipendente dal prezzo.
Nelle tre tabelle successive invece viene dimostrato come all’aumentare
dell’elasticità la pendenza della curva diminuisce, dimostrando che la quantità
offerta diventa più sensibile alle variazioni di prezzo. Infine, l’ultimo grafico, mostra
un caso di offerta perfettamente elastica, ovvero con valore dell’elasticità tendente
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
all’infinito. In tal caso la curva di offerta è orizzontale e riflette il fatto che variazioni
infinitesimali del prezzo provocano reazioni incommensurabili della quantità offerta.
RICAVO TOTALE ED ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO
In qualunque mercato il ricavo totale è uguale a P x Q, ovvero al prezzo di vendita di
un bene moltiplicato per la quantità venduta. Ora, se l’offerta è anelastica, un
incremento del prezzo è accompagnato da una variazione meno che proporzionale
della quantità offerta e da un aumento relativamente contenuto del ricavo totale. Se
invece l’offerta è elastica, un analogo incremento del prezzo provoca una variazione
più che proporzionale della quantità offerta e un aumento relativamente marcato
del ricavo totale.
CAP. VI
LE IMPRESE IN UN MERATO CONCORRENZIALE
I COSTI DI PRODUZIONE
Tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, devono sostenere dei costi per
produrre i beni e i servizi che offrono. Tali costi sono dovuti all’acquisto dei fattori
necessari alla produzione.
IL COSTO COME “COSTO-OPPORTUNITA’”
Il ‘costo-opportunità’ di un bene è ciò a cui si deve rinunciare per ottenerlo. Sono
cioè quei costi che l’impresa sostiene per realizzare la propria produzione di beni e
servizi, e sono talvolta evidenti, talvolta meno. Se X spende mille euro per acquistare
farina, non può usarli per acquistare qualcos’altro. E lo stesso vale per i salari che X
paga ai dipendenti. I costi che richiedono un esborso di denaro da parte dell’impresa
sono costi espliciti. Vi sono però anche costi impliciti, ai quali non corrisponde un
movimento di denaro: ad esempio X, molto esperto nella programmazione di
computer può guadagnare 100 euro all’ora lavorando come programmatore. X
rinuncia a quei 100 euro di reddito per ogni ora, che invece dedica alla produzione di
pizze: per un economista, anche questo reddito non guadagnato rientra tra i costi di
X.
IL COSTO DEL CAPITALE COME “COSTO-OPPORTUNITA’”
Si supponga che X abbia impiegato 300 mila euro dei suoi risparmi per acquistare la
fabbrica di pizza dal proprietario precedente. Se X avesse depositato quella somma
in banca, a un taso del 5%, avrebbe guadagnato 15 mila euro all’anno, quindi per
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
acquistare la sua fabbrica di pizza, X ha rinunciato a 15 mila euro all’anno di interessi,
che rappresentano un costo-opportunità implicito. Un economista considera quei 15
mila euro interessi non percepiti da X come un costo di impresa.
PRODUZIONE E COSTI
Le imprese sostengono costi per acquistare i fattori necessari alla produzione dei bei
e dei servizi che vendono. Se noi prendiamo come esempio la fabbrica di pizze di X,
vediamo che la dimensione della fabbrica di X è fissa, e X può modificare la quantità
offerta solo aumentando o riducendo il numero di addetti alla produzione. Tale
ipotesi è realistica nel breve periodo, ma non nel lungo periodo: X infatti non può
ingrandire il proprio stabilimento in una notte, ma può farlo se ha un anno di tempo.
FUNZIONE DI PRODUZIONE
La funzione di produzione può essere rappresentata mediante una funzione
matematica nella quale il livello di produzione Q è dipendente da due fattori di
produzione: capitale (K) e lavoro (L):
Q = f (K,L)
Occorre però considerare anche il cosiddetto ‘prodotto marginale’. Il prodotto
marginale di un fattore di produzione è l’aumento di produzione che si ottiene
impiegando una unità aggiuntiva del fattore stesso, e può essere rappresentato
come:
P1f = VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE / VARIAZIONE DELLA QUANTITA’ DEL
FATTORE DELLA PRODUZIONE
LE DIVERSE MISURE DI COSTO
Dai dati del costo totale di una impresa possiamo dedurre altre misure di costo che
ci possono essere utili nell’analisi delle decisioni di produzione e di prezzo.
Prendiamo ora in considerazione l’esempio del chiosco di limonate di Lia. Se
consideriamo un grafico ipotetico, diciamo che Lia può produrre un tot di limonate
da 0 a 10 all’ora.
COSTI FISSI E COSTI VARIABILI
Alcuni costi, detti ‘fissi’, sono indipendenti dalla quantità prodotta: possono variare,
ma non in funzione del livello della produzione, e permangono anche se la quantità
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
prodotta è pari a 0. Nell’esempio del chiosco delle limonate di Lia, i costi fissi sono
rappresentati dal canone di locazione e dallo stipendio di un barista, che devono
essere pagati a prescindere dalla quantità di limonata prodotta. Altri costi
dell’impresa, detti ‘variabili’, variano in funzione della quantità prodotta. Nel caso di
Lia, i costi variabili sono le spese sostenute per acquistare zucchero e limoni e la
retribuzione degli addetti alla produzione: quanta più limonata produce, tanto
maggiore è la quantità di zucchero e limoni che dovrà acquistare; allo stesso tempo,
se Lia fa lavorare i baristi un maggior numero di ore per produrre la limonata
aggiuntiva, i salari di questi lavoratori costituiscono un costo variabile. Il costo totale
di un’impresa è uguale alla somma di costi fissi e costi variabili.
COSTO MEDIO E COSTO MARGINALE
Sempre in accordo con l’esempio di Lia, in qualità di proprietaria dell’impresa, deve
decidere quanta limonata produrre. Un ruolo fondamentale in tale decisione è
giocato dal modo in cui i costi variano al variare del livello di produzione. Per
decidere, Lia potrebbe porsi due domande relative al costo di produzione della
limonata:
- Quanto costa in media un bicchiere di limonata?
- Quanto costa aumentare di un bicchiere la produzione di limonata?
Per trovare il costo medio dell’unità prodotta, si deve dividere il costo totale per la
quantità prodotta.
Se ad esempio l’impresa produce due bicchieri di limonata all’ora, il suo costo totale
è di 3,80€ e il costo medio di un bicchiere è pari a 3,80€ / 2 = 1,90€. Il costo totale
diviso per la quantità prodotta è detto ‘costo medio totale’:
CMT = CT / Q
Il costo medio totale non è altro che la somma di costi fissi e costi variabili, e può
essere espresso come la somma del costo medio fisso e del costo medio variabile. Il
costo medio fisso è pari al totale dei costi fissi divisi per la quantità prodotta.
Mentre, il costo medio variabile è pari al totale dei costi variabili per la quantità
prodotta.
COSTI NEL BREVE E NEL LUNGO PERIODO
Per molte imprese, la suddivisione dei costi tra fissi e variabili dipende dall’orizzonte
temporale di riferimento. Per esempio, in un arco temporale di alcuni mesi, X non
può modificare le dimensioni della propria struttura produttiva. Il solo modo che ha
per produrre di più o di meno è agire sulla manodopera impiegata. In un arco di
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
tempo più lungo invece, X può accrescere la propria capacità produttiva comprando
o costruendo nuovi stabilimenti, oppure ampliando quello esistente, e il costo degli
stabilimenti è quindi variabile nel lungo periodo.
Da questo grafico si evince la relazione tra le curve di costo di breve e di lungo
periodo: la curva di costo medio totale di lungo periodo ha infatti una forma più
appiattita della curva di costo medio totale di breve periodo. Inoltre, tutte le curve di
breve periodo giacciono al di sopra o sulla curva di lungo periodo. Tali proprietà
discendono dal fatto che le imprese godono di una maggiore flessibilità nel lungo
periodo. Nel lungo periodo, X può sia assumere un maggior numero di lavoratori, sia
espandere la propria capacità produttiva costruendo un terzo stabilimento, e il suo
costo medio totale rimarrebbe sempre lo stesso.
MERCATO CONCORRENZIALE
Un mercato rispondente alle caratteristiche tipiche di quello della concorrenza
perfetta è quello del latte. Nessun venditore è in grado di condizionare il prezzo di un
mercato con le proprie decisioni, perché offre un prodotto che è essenzialmente
omogeneo in una quantità relativamente piccola rispetto alle dimensioni del
mercato. Chiunque ha la possibilità di decidere di avviare un allevamento di bovini
da latte, e ogni allevatore in attività può decidere senza vincoli di abbandonare
l’attività. Ci sono molti singoli compratori di latte: i consumatori che lo acquistano
ogni giorno nei supermercati, cosiccome i supermercati stessi. Un’eccezione
all’ipotesi di mercato concorrenziale è che in molti paesi è presente un numero
relativamente basso di grandi imprese che acquistano latte e di conseguenza
esercitano un certo controllo sul prezzo di mercato.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
IL RICAVO DI UN’IMPRESA IN REGIME DI CONCORRENZA
Partiamo dall’esempio di una latteria X. La latteria X produce una quantità di latte Q
che vende a un prezzo di mercato unitario P. Il suo ricavo totale sarà quindi pari a P x
Q. Dato che è piccola rispetto alle dimensioni del mercato mondiale del latte, la
latteria subisce un prezzo determinato dalle condizioni del mercato. Questo significa
che il prezzo del latte è indipendente dalla quantità che produce e vende: se
raddoppiasse la produzione, il prezzo del latte rimarrebbe invariato e il ricavo totale
raddoppierebbe.
Il ricavo medio indica quanto incassa in media l’impresa dalla vendita di una unità di
prodotto.
RICAVO TOTALE, COSTO TOTALE E PROFITTO
Il profitto di un’impresa è la differenza tra il ricavo totale e il costo totale
dell’impresa.
MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO E CURVA DI OFFERTA DELL’IMPRESA IN
REGIME DI CONCORRENZA
Il profitto è pari al ricavo totale meno il costo totale, e il costo totale comprende il
costo-opportunità del tempo e del denaro che l’imprenditore conferisce
nell’impresa. Il ricavo dell’impresa deve compensare l’imprenditore del tempo e del
denaro che dedica all’attività aziendale. L’ammontare che va a remunerare i
proprietari dell’impresa è detto profitto normale, o equilibrio di profitto nullo. Ad
esempio, si supponga che per aprire una fattoria un agricoltore debba investire 1
milione di euro che, depositato in banca, gli renderebbe 50 mila euro di interessi
all’anno, e ancora che l’agricoltore sia costretto ad abbandonare un’altra
occupazione che gli offre un salario di 30 mila euro all’anno. Il costo-opportunità
dell’agricoltore include sia gli interessi che avrebbe potuto guadagnare, sia la
mancata retribuzione, per un totale di 80 mila euro. Questa somma è computata ne
costo totale dell’agricoltore, e gli economisti si riferiscono a una condizione di
profitto nullo come a una situazione nella quale l’impresa realizza un profitto
normale. Nel breve periodo il profitto può essere maggiore di 0, quindi maggiore del
profitto normale, ecco che in tal caso si parla di ‘extraprofitto’. Se le imprese di un
settore realizzano un extraprofitto, in assenza di barriere all’entrata altre imprese
hanno un incentivo a entrare nel mercato, innescando una dinamica che spinge il
mercato verso l’equilibrio di profitto nullo.
LA CURVA DI COSTO MARGINALE E LE DECISIONI DI OFFERTA DELLE IMPRESE
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
La figura in questione mostra una retta orizzontale in corrispondenza del livello del
prezzo P. la retta del prezzo è orizzontale perché l’impresa è price-taker, ovvero il
prezzo non dipende dalla quantità del bene che l’impresa decide di produrre.
Ora, dato che un’impresa subisce il prezzo, il suo ricavo marginale è uguale al prezzo
di mercato; a ogni dato prezzo di mercato, la quantità che massimizza il profitto
dell’impresa in regime di concorrenza può essere individuata dall’intersezione del
livello del prezzo con la curva di costo marginale.
CAP. VII
CONSUMATORI, PRODUTTORI ED EFFICIENZA DEI MERCATI
Il benessere soggettivo si riferisce al modo in cui i singoli individui valutano la propria
felicità: questo include la soddisfazione che traggono dal lavoro e dal tempo libero, e
la reazione che hanno agli eventi che caratterizzano la propria vita. Il benessere
oggettivo si riferisce a una misura della qualità della vita che fa ricorso a indicatori
quali il livello di istruzione, le misure del tenore di vita, l’attesa di vita e così via.
L’economia del benessere utilizza alcune tecniche per stimare l’efficienza allocativa:
una misura dell’utilità, la soddisfazione, derivante dall’allocazione delle risorse.
IL SURPLUS DEL CONSUMATORE
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Il prezzo massimo di ciascun potenziale acquirente è la sua disponibilità a pagare,
ovvero il valore che egli attribuisce al bene. Il surplus del consumatore è la differenza
tra il prezzo che un compratore è disposto a pagare per l’acquisto di un bene e il
prezzo che paga effettivamente. In gergo, banalmente lo diremmo per ciò che si dice
‘fare un affare’. In economia, l’affare si fa quando il prezzo pagato è
considerevolmente inferiore alla disponibilità a pagare e di conseguenza il
compratore ottiene un surplus del consumatore più elevato di quello atteso. Il
surplus del consumatore misura il beneficio che i compratori traggono dal
partecipare a un mercato. Ad esempio, X ottiene un beneficio di 199 euro dalla
partecipazione ad un’asta, poiché paga solo 801 euro per un bene che valuta 1000
euro. Y, Z e T non traggono alcun surplus del consumatore dall’aver partecipato
all’asta, poiché l’hanno abbandonata senza acquistare il bene e senza pagare alcun
prezzo. Prendiamo ora un esempio parzialmente differente: si supponga di avere due
chitarre identiche da vendere e di metterle nuovamente all’asta tra i quattro possibili
acquirenti: X, Y, Z e T. Si ipotizzi ancora che le due chitarre siano vendute insieme e
allo stesso prezzo e che nessuno dei potenziali acquirenti sia interessato a comprarle
entrambe. Perciò il prezzo salirà fino a quando non rimarranno due potenziali
acquirenti. In tal caso la gara si conclude quando X e Y offriranno 701 euro a
ciascuno: a questo prezzo infatti Z e T sono entrambi ben felici di acquistare le
chitarre. X e Y beneficiano entrambi di un surplus del consumatore, misurato dalla
differenza tra le rispettive disponibilità a pagare e il prezzo pagato.
Il concetto di surplus del consumatore ci permette di formulare un giudizio
normativo sulla desiderabilità dei risultati del mercato. La curva di domanda
rappresenta il valore del beneficio economico che i consumatori traggono dal
consumo del bene, misurato dal prezzo che devono pagare per ottenerlo,
ipotizzando he siano in grado di valutare accuratamente le proprie preferenze, i
costi-opportunità del prezzo pagato e la variazione del benessere derivante dal
consumo. I consumatori valutano il valore che attribuiscono all’acquisto di un bene.
L’interazione tra compratori e venditori viene generalmente percepita come un
processo di negoziazione in cui due agenti economici interessati e in competizione
tra loro raggiungono un risultato condiviso.
IL SURPLUS DEL PRODUTTORE
Si pensi che X sia il proprietario di un appartamento che ha bisogno di essere
tinteggiato e che si rivolga a quattro tinteggiatori: Y, Z, T e M. Ciascuno di loro è
disposto a eseguire il lavoro ad un prezzo che ritiene idoneo. X decide di organizzare
un’asta e di affidare il lavoro a chi avrà presentato l’offerta più bassa. Ogni
tinteggiatore è disposto a eseguire il lavoro solo se il compenso che riceve è
superiore al costo che sostiene per eseguirlo. Qui il termine costo deve essere
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
interpretato come il costo-opportunità per il tinteggiatore: deve dunque includere
sia i costi diretti (pennelli, vernici ecc.), sia il valore che il tinteggiatore stesso
attribuisce al proprio tempo. Nel bandire l’asta, X potrebbe partire da un prezzo
elevato, che rapidamente diminuirà grazie alla concorrenza tra i tinteggiatori per
ottenere la commessa. Non appena Y offre poco meno di un dato tot., rimane l’unica
venditrice sul mercato. Il surplus del produttore è la differenza tra il prezzo incassato
dal venditore e il suo costo di produzione; tale differenza misura il beneficio di cui il
venditore gode in virtù della sua partecipazione al mercato.
L’EFFICIENZA DEL MERCATO
Nelle economie di tutto il mondo, ogni giorno vengono effettuate milioni di
transazioni. Il surplus del consumatore e il surplus del produttore forniscono uno
strumento per misurare i benefici dello scambio per consumatori e produttori.
Questa analisi è alla base di quello che viene definito ‘equilibrio generale’, ovvero
l’idea secondo la quale le decisioni e le scelte degli agenti economici sono coordinate
in tutti i mercati. L’equilibrio generale esprime l’idea che i meccanismi del mercato
conducono a risultati efficienti. I consumatori massimizzano l’utilità, i produttori
massimizzano il profitto e producono in corrispondenza del costo medio minimo.
Se si considera l’efficienza come concetto generale, occorre introdurre la nozione di
‘spreco’ che è strettamente connessa a quella di inefficienza. Dal punto di vista di un
consumatore, spendere denaro per un bene che non offre valore può essere
considerato uno spreco. Allo stesso modo, per un produttore spendere denaro nella
produzione di un vene che i consumatori non desiderano acquistare rappresenta uno
spreco. Verrebbe quindi da asserire che il libero mercato conduca a uno spreco di
risorse. Se così fosse però, le risorse potrebbero essere riallocate in modo da ridurre
lo spreco: i consumatori modificherebbero le proprie abitudini d’acquisto e i
produttori i propri metodi produttivi. Il surplus del consumatore e il surplus del
produttore rappresentano rispettivamente i benefici che i compratori e i venditori
traggono dal partecipare a un determinato mercato. In ogni punto della curva di
domanda, il prezzo rappresenta il valore attribuito dai consumatori, all’unità
aggiuntiva per il produttore. Se un’allocazione non è efficiente, alcuni dei benefici
dello scambio tra compratori e venditori non si realizzano.
Occorre ora introdurre il discorso sulla ‘efficienza paretiana’: si ha efficienza
paretiana quando non è possibile riallocare le risorse in modo tale da migliorare le
condizioni di un individuo senza peggiorare quelle di un altro. I mercati si fondano
sullo scambio e la curva di domanda fornisce informazioni riguardo ai benefici che i
consumatori traggono dallo spendere il proprio reddito in un determinato modo,
mentre la curva di offerta indica i benefici che i produttori ottengono dalla vendita di
un bene. Lo scambio apporta benefici sia al consumatore sia al produttore e dunque
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
rappresenta un ‘miglioramento paretiano’, ossia un’azione che migliora le condizioni
di almeno un agente economico senza peggiorare quelle di un altro.
CAP. VIII
DOMANDA, OFFERTA E POLITICHE ECONOMICHE
I CONTROLLI DEI PREZZI
Vi sono due misure di controllo dei prezzi: i livelli massimi e i livelli minimi di prezzo.
Questi provvedimenti vengono generalmente introdotti dal governo o da un’autorità
di regolamentazione. Un livello massimo di prezzo è il prezzo più alto al quale un
bene può essere legalmente venduto. Un livello minimo di prezzo è l’esatto opposto,
ovvero il prezzo più basso al quale un bene può essere venduto. Per verificare come i
controlli dei prezzi condizionino il risultato di un mercato, si consideri come esempio
il controllo dei canoni di locazione. Se lo spazio in affitto a fini residenziali è
scambiato in un mercato concorrenziale non regolamentato, si suppone che i canoni
di affitto varino fino a portare in equilibrio la domanda e l’offerta: al prezzo di
equilibrio la quantità di immobili in locazione che i compratori vogliono affittare è
pari a quella che i venditori desiderano dare in affitto.
GLI EFFETTI IN UN LIVELLO MASSIMO DI PREZZO
Se il governo impone un livello massimo di prezzo, possono verificarsi 2 risultati:
- Se il governo fissa ad esempio un livello massimo di prezzo a 40 euro al
metro quadrato, poiché il prezzo di equilibrio (ovvero 30 euro) è
inferiore al livello massimo del prezzo, quest’ultimo è non vincolante. Le
forze del mercato spingono automaticamente il prezzo verso il livello di
equilibrio e il provvedimento non ha alcun effetto sul prezzo o sulla
quantità venduta.
- Se il governo fissa un massimo di prezzo a 20 euro al metro quadrato, il
prezzo di equilibrio del mercato è comunque di 30 euro e il livello
massimo di prezzo costituisce un vincolo al mercato: le forze della
domanda e dell’offerta tenderebbero a spingere il prezzo verso il livello
di equilibrio, ma dal momento che il prezzo non può superare il prezzo
di 20 euro, il prezzo limite diventa il prezzo di mercato. Dato questo
limite vincolante al prezzo, gli incentivi cambiano: alcuni proprietari non
troveranno redditizio dare in locazione il proprio immobile a quel prezzo
e lo toglieranno dal mercato. Gli incentivi per gli affittuari sono diversi: a
fronte di un prezzo più basso, il sacrificio associato alla locazione di un
immobile, cioè le scelte alternative a cui devono rinunciare, è minore,
per cui in corrispondenza del livello massimo di prezzo sono disposti ad
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
affittare una casa più grande. Il livello massimo di prezzo ha effetto
anche sui venditori: alcuni potrebbero convincersi che non convenga più
continuare a dare immobili in locazione e decidere di abbandonare il
mercato, deprimendo di conseguenza l’offerta. a causa del canone più
basso, per risparmiare i proprietari potrebbero ridurre la quantità di
manutenzioni e riparazioni che effettuano sulle loro proprietà,
deprimendo la qualità degli alloggi in affitto. Di conseguenza, i
lavoratori del settore delle riparazioni, così come gli agenti immobiliari,
potrebbero restare disoccupati perché i loro servizi non sono più
richiesti e alcuni esercizi finirebbero per uscire dal mercato.
GLI EFFETTI DI UN LIVELLO MINIMO DI PREZZO
Se il governo impone un livello minimo di prezzo, ad esempio, nel mercato degli
alcolici, si possono produrre due risultati:
- Se il livello minimo di prezzo è pari a 0,25 cent all’unità e il prezzo di
equilibrio è 0,35 cent, in questo caso dato che il prezzo di equilibrio è
maggiore del livello minimo, quest’ultimo non è vincolante perché le
forze del mercato riescono comunque a portare naturalmente il prezzo
al livello di equilibrio.
- Se invece, per esempio, il prezzo di equilibrio è pari a 0,35 cent all’unità,
mentre quello minimo legale è di 0,45 cent, le forze del mercato non
sono più in grado di riportare il mercato in equilibrio, perché il prezzo
non può diminuire nella misura necessaria. Al livello minimo di prezzo,
la quantità di alcolici offerta è maggiore di quella domandata: a quel
prezzo alcuni venditori non riescono a vendere alcolici e si genera una
eccedenza.
LE IMPOSTE
Tutte le amministrazioni pubbliche ricorrono alla tassazione per raccogliere risorse e
influenzare il comportamento degli agenti economici. Esistono molti tipi differenti di
imposte, che si possono suddividere in 2 categorie principali:
- Le imposte sul reddito
- Le imposte sulla spesa
Le imposte sul reddito sono dette ‘imposte dirette’, in quanto gli individui sono
responsabili del corretto pagamento dell’imposta dovuta. Le imposte sulla spesa
sono invece dette ‘imposte indirette’, e gravano generalmente sulle imprese, che
possono decidere di trasferire parte dell’onere sui consumatori sotto forma di prezzo
più elevato. Di conseguenza, i consumatori condividono con l’impresa l’onere
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
dell’imposta, di cui diventano responsabili in modo indiretto. Possiamo identificare 2
tipi di imposta di spesa:
- L’imposta specifica
- L’imposta ‘ad valorem’
L’imposta specifica è pari a un ammontare fisso per ogni unità di spesa: per esempio
a 0,75 cent al litro di benzina. Una imposta ad valorem è invece espressa in
percentuale del prezzo, per esempio con un’aliquota del 10 o del 20%. Questi due
tipi di imposta influenzano i risultati di mercato in modo diverso.
GLI EFFETTI DI UN’IMPOSTA SULLE VENDITE
Imposta specifica. Si ipotizzi che l’amministrazione locale imponga alle stazioni di
servizio di corrispondere un’imposta di 0,50 cent per ogni litro di benzina venduto.
L’effetto iniziale si avrà sui venditori di benzina. La quantità domandata a ogni dato
prezzo rimane invariata e la curva di domanda non si sposta. Per contro, l’imposta
sulle vendite rendi il commercio di benzina meno redditizio a ogni singolo dato
prezzo: qualunque sia la cifra che incassa, il venditore dovrà versare allo stato 0,50
cent al litro. Il venditore si confronta di fatto con un aumento del costo di produzione
pari a 0,50 cent al litro. Dato che accresce il costo di produrre e vendere benzina,
l’imposta sulle vendite provoca una diminuzione della quantità offerta a ogni dato
prezzi; di conseguenza la curva di offerta si sposta verso sinistra. Tale spostamento è
parallelo alla curva di offerta originale, perché, quale che sia la quantità offerta, il
venditore deve pagare lo stesso importo al litro e, a ogni dato prezzo, la distanza tra
la curva di offerta originale e la nuova curva di offerta è sempre pari all’ammontare
dell’imposta, ovvero 0,50 cent. A ogni dato prezzo di mercato, il prezzo effettivo per
il venditore è di 0,50 cent più basso: ad esempio, se il prezzo di mercato della
benzina fosse di 2 euro al litro, il prezzo effettivo incassato dal venditore sarebbe di
1,50 euro.
L’imposta crea un divario tra il prezzo pagato dai compratori e quello incassato dai
venditori. Tale divario è identico, indipendentemente dal fatto che l’imposta gravi sui
compratori o sui venditori.
Imposta ad valorem. L’effetto iniziale dell’imposta si esercita di nuovo sui venditori.
La quantità domandata, ad esempio, di scarpe da ginnastica a ogni dato prezzo è la
stessa: di conseguenza, la curva di domanda non cambia. Il venditore si confronta
nuovamente con un aumento del costo di produzione, ma questa volta l’incremento
del costo varia n funzione del prezzo. Se l’imposta è pari al 20% e il costo di
produzione delle scarpe è pari a 20 euro, il venditore deve versare allo stato 4 euro
sotto forma di imposte, ovvero il 20% di 20 euro. Se il costo di produzione delle
scarpe è 50 euro, il venditore deve corrispondere allo stato 10 euro. La curva di
offerta si sposta verso sinistra ma non parallelamente alla curva originaria.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
L’imposta sulle vendite accresce il costo di produrre e vendere scarpe da ginnastica,
cos come accade con imposta specifica, ma in questo caso l’ammontare dovuto dai
venditori si riduce al diminuire del prezzo, essendo calcolato in percentuale. La curva
di offerta si sposta verso sinistra e ruota nel punto di origine: a prezzi più bassi il
venditore corrisponde un ammontare minore di quello dovuto a prezzi più elevati. A
ogni prezzo di mercato, il prezzo effettivo incassato dai venditori è del 20% più basso.
Il prezzo di equilibrio delle scarpe da ginnastica aumenta e la quantità di equilibrio
diminuisce. L’imposta riduce la dimensione del mercato delle scarpe da ginnastica e
compratori e venditori condividono l’onere dell’imposta. Dato che il prezzo di
mercato aumenta, i compratori pagano le scarpe tot euro in più rispetto a prima, e i
venditori dal canto loro ricevono un prezzo più alto, ma la somma effettiva che
incassano diminuisce.
CAP. X
BENI PUBBLICI, RISORSE COLLLETTIVE E BENI MERITORI
DIVERSI TIPI DI BENE
Possiamo suddividere i beni in 4 tipi:
- Beni privati. Sono esclusivi e rivali nel consumo. La maggior parte dei
beni presenti in economia sono privati, come ad esempio le barrette di
cioccolato: per ottenerli e godere dei relativi benefici bisogna pagare.
- Beni pubblici. Non sono né esclusivi, ne rivali nel consumo; questo
significa che non si può impedire a qualcuno di fruire di questi beni, e
che il fatto che un individuo ne fruisca non impedisce ad altri di fare
altrettanto.
- Risorse collettive. Sono rivali nel consumo, ma non sono esclusive. Ad
esempio, i pesci del mare sono rivali nel consumo: se un individuo
pesca, resta un minor numero di pesci a disposizione di altri pescatori.
Ma i pesci non sono esclusivi.
- Beni di club. Sono esclusivi ma non rivali nel consumo. Ad esempio, il
servizio di vigilanza antincendio in una piccola città.
I BENI PUBBLICI
Trattasi di beni non esclusivi, poiché è impossibile impedire a chicchessia di
assistervi, e non rivale nel consumo, dal momento che se un individuo assiste allo
spettacolo non impedisce ad altri di fare altrettanto. Ad esempio, gli abitanti di
Moena, nelle Dolomiti, amano gli spettacoli pirotecnici del 31 dicembre. Ciascuno
dei 500 abitanti del paese attribuisce allo spettacolo un valore di 10 euro, e dato che
lo spettacolo costa 1000 euro, per gli abitanti di Moena è economicamente efficiente
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
organizzare uno spettacolo di fuochi pirotecnici per la vigilia di Capodanno.
Probabilmente, il libero mercato non perverrebbe a questo equilibrio efficiente.
Questo esempio è pregnante, perché molte amministrazioni locali in Italia finanziano
i festeggiamenti per il capodanno, così come fanno le municipalità britanniche con i
festeggiamenti del 5 novembre ecc. questo esempio permette di trarre una
conclusione di carattere generale sui beni pubblici: dato che i beni pubblici non sono
esclusivi, il problema del free rider impedisce al mercato privato di fornirli. Lo stato,
tuttavia, può potenzialmente rimediare al problema. Se lo stato stabilisce che i costi
di un bene pubblico sono minori dei benefici, può fornire il bene, finanziarlo con le
entrate fiscali e accrescere il benessere economico.
Alcuni esempi di beni pubblici importanti sono:
- La difesa nazionale. La difesa del paese da possibili aggressioni straniere
è un classico esempio di bene pubblico.
- La ricerca di base. La creazione di conoscenza è un bene pubblico.
- La lotta alla povertà. Molti provvedimenti statali hanno l’obiettivo di
aiutare i poveri e tali provvedimenti vengono finanziati attraverso la
tassazione dei nuclei familiari che hanno maggiori disponibilità
economiche.
LE RISORSE COLLETTIVE
Le risorse collettive come i beni pubblici sono non esclusive: infatti sono disponibili
gratuitamente per chiunque le voglia sfruttare. Ma, diversamente dai beni pubblici,
le risorse collettive sono rivali nel consumo: l’uso di una risorsa collettiva da parte di
un individuo impedisce ad altri individui di goderne. Dunque, lo stato si deve
preoccupare di quanto e come viene usato il bene. Tra i vari esempi di risorsa
collettiva annoveriamo:
- Aria e acqua pulita. I mercati non riescono a proteggere adeguatamente
l’ambiente. L’inquinamento è una esternalità negativa alla quale si può
porre rimedio con la regolamentazione diretta o imposte correttive.
- Strade congestionate. Le strade possono essere beni pubblici o risorse
collettive. Se una strada non è congestionata dal traffico, l’uso da parte
di un individuo non influisce su nessun altro. Ma se la strada è molto
trafficata, l’uso da parte di ciascun individuo comporta una esternalità
negativa, perché il traffico aumenta e gli altri automobilisti devono
guidare più lentamente, e in tal caso la strada è una risorsa collettiva.
I BENI MERITORI
Vi sono beni che possono essere prodotti dal settore privato ma che potrebbero non
essere consumati in quantità sufficiente se la loro fornitura fosse demandata
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
esclusivamente al mercato: questi sono i cosiddetti ‘beni meritori’. Tali beni devono
la loro esistenza al fatto che i consumatori potrebbero avere una conoscenza
imperfetta dei relativi benefici e di conseguenza non essere in grado di attribuire loro
il giusto valore. I beni meritori sono soggetti a un problema di scelta intertemporale,
che sorge quando le decisioni prese oggi influenzano le scelte future. Esempi di beni
meritori includono l’istruzione, i servizi sanitari, le pensioni e le assicurazioni. Pochi
individui sono in grado di giudicare se e quando avranno bisogno di servizi sanitari e
assicurativi. Molti giovani non sentono la necessità di risparmiare oggi per finanziare
la propria pensione tra 30 o 40 anni, perché si tratta i una prospettiva per loro
lontana: i benefici sono troppo distanti nel futuro per essere significativi nel
presente. Se le persone dovessero pagare direttamente per fruire dei servizi sanitari,
assicurativi e pensionistici, avrebbero un incentivo a consumare una quantità
insufficiente.
Vi sono poi anche i beni cosiddetti ‘demeritori’, che hanno la caratteristica di essere
consumati in quantità eccessiva se lasciati interamente al mercato. Ciò avviene
perché il consumo di tali beni impone costi privati e sociali e, nel prendere una
decisione di consumo, l’individuo non dispone delle informazioni necessarie a
comprendere appieno tali costi.
CAP. XI
ESTERNALITA’ E FALLIMENTO DEL MERCATO
ESTERNALITA’
Una esternalità è l’effetto dell’azione di un soggetto economico sul benessere di altri
soggetti terzi, non direttamente coinvolti, che non pagano né ricevono un compenso
per l’azione: se tale effetto è dannoso, avremo una esternalità negativa; se è
beneficio una esternalità positiva. Le esternalità negative e positive sono connesse ai
costi e ai benefici sociali associati alle decisioni. In genere, gli individui e le imprese
agiscono sulla base di costi e benefici privati, ma non sempre prendono in
considerazione i costi e i benefici sociali delle proprie scelte; di conseguenza il prezzo
non riflette il costo e il beneficio reali di un’azione o di una decisione e la quantità
prodotta potrebbe essere efficiente dal punto di vista privato, ma non dal punto di
vista sociale, ossia troppo alta o troppo bassa rispetto al livello ottimo.
I COSTI SOCIALI E I BENEFICI SOCIALI DELLE DECISIONI
L’attività dei mercati si fonda su milioni di decisioni prese da individui e gruppi. Nel
formulare tali decisioni, vengono presi in considerazione solo i costi privati e i
benefici privati: ad esempio, nel fare un viaggio in automobile, una persona sostiene
vari costi privati, come l’usura e il consumo del carburante. Nell’utilizzare
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
l’automobile inoltre, questa stessa persona gode di alcuni benefici privati quali la
comodità, il calore e la possibilità di raggiungere la destinazione rapidamente. Ma
nel decidere se intraprendere un viaggio in automobile gli individui potrebbero non
prendere in considerazione anche i costi e i benefici sociali della decisione stessa:
un’automobile contribuisce alla congestione del traffico, all’usura delle strade,
all’inquinamento atmosferico e acustico; sul fronte dei benefici, un viaggio in
automobile significa invece ad esempio un posto in più disponibile nei servizi di
trasporto pubblico.
VARI TIPI DI ESTERNALITA’
Le esternalità assumono forme diverse:
- I gas di scarico delle automobili, ad esempio, sono una esternalità
negativa poiché producono smog che viene respirato anche da hi non
usa l’auto, e di conseguenza gli automobilisti tendono a inquinare
eccessivamente.
- Il restauro degli edifici storici apporta una esternalità positiva, in quanto
anche i passanti e i turisti godono della bellezza e del senso della storia
offerti da un palazzo restaurato.
- Un cane che abbaia crea una esternalità negativa, poiché i vicini di casa
del proprietario del cane vengono disturbati dal rumore.
ESTERNALITA’ E INEFFICIENZA DEL MERCATO
Occorre ora valutare come le esternalità influenzano il benessere
CAP. XIV
IL MONOPOLIO
LA CONCORRENZA IMPERFETTA
Una impresa in concorrenza imperfetta. È in grado di differenziare in qualche modo il
proprio prodotto e quindi di influenzare il prezzo al quale lo vende. Esistono diversi
gradi di concorrenza imperfetta, e il primo che andremo ad analizzare è quello del
monopolio. A rigore, un monopolio è una struttura di mercato caratterizzata dalla
presenza di un’unica impresa; tuttavia per esercitare un potere monopolistico è
sufficiente avere una posizione dominante nel mercato. Una impresa può esercitare
potere di mercato quando è in grado di aumentare il prezzo del proprio prodotto
senza vederne azzerare le vendite. Quindi, contrariamente alle imprese price-taker,
quelle dotate di potere di mercato sono in grado di influire sul prezzo, e vengono
dette ‘price-maker’.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
PERCHE’ ESISTONO I MONOPOLI
Un’impresa è un monopolio se è l’unico venditore di un bene per il quale non
esistono buoni sostituti. Questa è la definizione più ristretta del termine, ma in realtà
si dice che le imprese godono di un potere monopolistico se sono il venditore
dominante in un mercato e sono in grado di esercitare un controllo sul mercato
stesso. La causa fondamentale del monopolio sono le barriere all’entrata, ostacoli
all’entrata di altre imprese nel mercato. Quanto più le barriere all’entrata sono forti,
tanto più è difficile per un’impresa entrare nel mercato e tanto maggiore è il potere
che il monopolista è in grado di esercitare. E’ possibile che un monopolista sia l’unico
venditore nel mercato perché le altre imprese non riescono a entrarvi. Le barriere
all’entrata, per parte loro, vengono generate da 4 principali ordini di cause:
- Una risorsa chiave è detenuta da una unica impresa
- Lo stato concede a un’unica impresa il diritto esclusivo di produrre un
bene o fornire un servizio
- La struttura dei costi di produzione rende la singola impresa più
efficiente di una molteplicità di produttori
- Un’impresa è in grafo fi acquisire il controllo delle altre imprese che
agiscono nel medesimo mercato, crescendo in dimensioni
IL MONOPOLIO DELLE RISORSE
Il modo più semplice per creare un monopolio è fare in modo che una sola impresa
detenga una risorsa chiave. Ad esempio, si consideri il mercato dell’acqua potabile in
una piccola città su un’isola sperduta che non riceve acqua dalla terraferma. Se in
città vi fosse un solo pozzo e non vi fosse altro modo per procurarsi acqua, il suo
proprietario avrebbe il monopolio della vendita. Ovviamente, il monopolista ha un
potere di mercato ben più grande di quello della singola impresa operante in un
mercato concorrenziale. La proprietà esclusiva di una risorsa chiave è causa
potenziale di monopolio, ma nella pratica sono pochi i monopoli che nascono per
questa ragione.
I MONOPOLI DI STATO
In molti casi il monopolio si crea perché lo stato conferisce a un solo operatore il
diritto esclusivo di vendere un determinato bene o servizio. A volte questo accade
per l’influenza politica dell’aspirante monopolista.
IL MONOPOLIO NATURALE
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
I beni di club sono un tipo di monopolio naturale: un settore è un monopolio
naturale se una singola impresa può fornire il bene o il servizio all’intero mercato a
costi inferiori rispetto a quelli sostenuti da una molteplicità di imprese. Un esempio
di monopolio naturale è la distribuzione dell’acqua potabile. Per fornire l’acqua agli
abitanti di una città, un’impresa deve costruire una rete di condutture, se due o più
imprese devono competere per la fornitura del servizio, le spese di impianto
raddoppiano, quindi il costo medio totale dell’acqua è più basso se il servizio viene
fornito da un’unica impresa che serve l’intero mercato. Quando gode di un
monopolio naturale, l’impresa non teme che nuovi concorrenti possano entrare nel
mercato ed erodere il suo potere monopolistici.
MONOPOLIO E CONCORRENZA
La differenza fondamentale tra l’impresa concorrenziale e quella monopolistica è la
capacità di quest’ultima di influenzare il prezzo del proprio prodotto. Un’impresa
concorrenziale ha dimensioni modeste rispetto al mercato in cui opera e perciò
subisce il prezzo determinato dalle condizioni del mercato; l’impresa monopolistica
invece è l’unico produttore del mercato e può far variare il prezzo di ciò che produce
adeguando la quantità che offre sul mercato. Un modo per evidenziare questa
differenza tra i due diversi tipi di imprese è considerare la curva di domanda con la
quale esse interagiscono: dato che l’impresa concorrenziale può vendere a qualsiasi
quantità a quel prezzo, la sua curva di domanda è orizzontale:
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Se l’impresa applicasse un prezzo appena superiore, perderebbe tutte le proprie
vendite a favore dei concorrenti: in effetti, dato che l’impresa concorrenziale vende
un bene perfettamente sostituibile con quello di tutte le altre imprese attive nello
stesso mercato, la sua curva di domanda è perfettamente elastica.
L’impresa monopolistica invece, essendo l’unico produttore, ha una curva di
domanda che corrisponde alla domanda di mercato. Il monopolista interagisce
quindi con una normale curva di domanda con pendenza negativa.
Se il monopolista aumenta il prezzo del bene, i consumatori ne acquistano in
quantità inferiore; analogamente, se riduce la quantità offerta, il prezzo tende a
salire. La curva di domanda di mercato limita la capacità del monopolista di sfruttare
il proprio potere di mercato.
IL RICAVO DI UN MONOPOLISTA
Si consideri una città con un solo fornitore di acqua potabile.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Le prime due colonne mostrano la scheda di domanda con la quale interagisce il
monopolista. Se produce 1 lt d’acqua, può venderlo a 1 euro, se ne produce 2 deve
abbassare il prezzo a 0,90 cent, se ne produce 3 deve scendere ancora a 0,80 cent.
La terza colonna della tabella mostra il ricavo totale del monopolista, ottenuto
moltiplicando la quantità prodotta per il prezzo. La quarta colonna computa il ricavo
medio, ovvero quanto l’impresa ricava per l’unità venduta, che è uguale al prezzo.
L’ultima colonna invece riporta il ricavo marginale dell’impresa, ovvero il ricavo
generato dalla vendita di ciascuna unità aggiuntiva di prodotto. Il ricavo marginale di
un’impresa è sempre minore del prezzo.
Quando il monopolista aumenta la quantità venduta, sortisce 2 effetti sul ricavo
totale:
- L’effetto quantità: la quantità venduta aumenta, quindi Q è maggiore, e
ciò tende ad accrescere il ricavo totale
- L’effetto prezzo: il prezzo diminuisce, quindi P è minore e ciò tende a
ridurre il ricavo totale
L’impresa concorrenziale, invece, potendo vendere a qualsiasi quantità al prezzo di
mercato, non subisce l’effetto prezzo. Se espande la propria offerta di 1 unità, incassa
il prezzo di mercato anche per quella, come per le altre unità già vendute. Dunque,
dal momento che in regime di concorrenza la singola impresa subisce il prezzo, il
ricavo marginale è uguale al prezzo; in regime di monopolio invece se l’impresa
aumenta la produzione di 1unità deve ridurre il prezzo di tutte le unità vendute.
IL COSTO DEL MONOPOLIO IN TERMINI DI BENESSERE
Un monopolio, diversamente da un’impresa concorrenziale, può vendere il proprio
prodotto a un prezzo superiore al costo marginale. Dal punto di vista del
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
consumatore il prezzo di monopolio, più elevato, non è desiderabile. Allo stesso
tempo, tuttavia, il monopolista realizza un profitto proprio grazie alla possibilità di
praticare prezzi più elevati; quindi dal punto di vista dell’impresa monopolistica, il
monopolio è una condizione estremamente desiderabile.
LA PERDITA SECCA DI BENESSERE
Il risultato di mercato in regime di monopolio è diverso da quello che si produce in
condizioni di concorrenza perfetta; di conseguenza al monopolio è associata una
perdita secca di benessere. Il surplus totale è pari al valore del bene per i
consumatori meno il costo di produzione sostenuto dal monopolista. La perdita
secca di benessere causata da un monopolio è analoga a quella provocata da una
imposta, e il monopolista in effetti, se vogliamo, può considerarsi un esattore di
imposte privato. Un’imposta su un bene crea un divario tra la disponibilità a pagare
del consumatore e il costo medio del produttore. Esercitando il proprio potere di
mercato e praticando un prezzo superiore al costo marginale, il monopolista provoca
il medesimo effetto: in entrambi i casi, tale divario provoca una diminuzione della
quantità prodotta al di sotto del livello socialmente ottimo. La differenza tra i due
casi è che le imposte generano un’entrata per lo stato, mentre il monopolio crea
profitto per l’impresa.
LA DISCRIMINAZIONE DI PREZZO
In alcuni casi le imprese tentano di vendere lo stesso prodotto a consumatori diversi
con prezzi differenti. Tale pratica viene detta ‘discriminazione di prezzo’. Un’impresa
può praticare prezzi differenziati solo se gode di potere di mercato.
Per capire la ragione per la quale il monopolista dovrebbe differenziare i prezzi,
occorre fare un esempio. Si immagini di essere il presidente di società editrice X, e
che l’autore più popolare abbia appena ultimato un nuovo romanzo. Si immagini
ancora di dover versare a tale autore 2 milioni di euro per il diritto esclusivo alla
pubblicazione del libro e che il costo di produzione sia così irrisorio da poter essere
considerato nullo. Il profitto della società è pari alla differenza tra quanto incassa
dalla vendita del libro e i 2 milioni di euro pagati all’autore. Il primo passo per la
determinazione del prezzo è sicuramente la stima della domanda: si ponga che il
caso che l’ufficio marketing informi la società che il libro è gradito a due categorie di
lettori: i 100.000 fanatici entusiasti dell’autore, disponibili a pagare anche 30 euro
per una copia, e altri 400.000 lettori meno entusiasti che sarebbero disposti a pagare
5 euro per una copia del libro. I prezzi da prendere in considerazione sono due: 30
euro, che è il prezzo più elevato che la società editrice può applicare per avere quei
100.000 lettori, e 5 euro il prezzo più elevato che può applicare per sfruttare un
mercato di 500.000 potenziali lettori. La soluzione del problema è di natura
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
prevalentemente aritmetica: a 30 euro, vendendo 100.000 copie, il ricavo totale è di
3 milioni di euro, e il profitto è di 1 milione di euro; a 5 euro, vendendo 500.000
copie, il ricavo totale è di 2,5 milioni di euro e il profitto è di 500.000 euro. Quindi, la
società massimizza il profitto applicando un prezzo di 30 euro e rinunciando a un
mercato potenziale di 400 mila lettori. Questa decisione genera una perdita secca di
benessere: ci sono infatti 400 mila lettori disposti a pagare 5 euro per un libro il cui
costo marginale di produzione è virtualmente nullo; il surplus totale che viene perso
a causa della decisione di prezzo dell’editore è quindi di 2 milioni di euro. La perdita
secca di benessere è la tipica inefficienza che insorge in tutti i casi nei quali il
monopolista fissa un prezzo superiore al costo marginale.
Si considerino ora più formalmente le conseguenze della discriminazione di prezzo
sul benessere economico. Si ipotizzi che il monopolista possa praticare una
discriminazione di prezzo perfetta: questo significa che il monopolista conosce
esattamente la disponibilità a pagare di ogni singolo consumatore ed è in grado di
applicare a ciascuno un prezzo diverso. In questo caso il monopolista fa pagare a
ciascun consumatore esattamente il prezzo che è disposto a pagare, appropriandosi
così dell’intero surplus generato da ogni transazione. Nella realtà naturalmente la
discriminazione di prezzo non è perfetta: i consumatori non entrano nei negozi
mostrando su apposite targhette la propria disponibilità a pagare. Ciò che accade è
che le imprese tendono a dividere i consumatori in gruppi: giovani e anziani, clienti
del weekend e dei giorni feriali ecc.
CAP. XV
LA CONCORRENZA MONOPOLISTICA
LA CONCORRENZA CON PRODOTTI DIFFERENZIATI
Per comprendere i meccanismi che regolano un mercato in concorrenza
monopolistica, occorre esaminare dapprima il processo decisionale della singola
impresa. Dopodiché occorrerà capire ciò che accade nel lungo periodo, quando le
imprese possono entrare nel mercato, e infine vi sarà una analisi volta a stabilire se il
risultato di un mercato in concorrenza monopolistica sia o meno desiderabile dal
punto di vista della società nel suo complesso.
L’IMPRESA IN CONCORRENZA MONOPOLISTICA NEL BREVE PERIODO
Ogni impresa in un mercato in concorrenza monopolistica è in qualche modo un
monopolista: il suo prodotto è diverso da quello delle altre imprese attive nel
medesimo mercato, quindi la sua curva di domanda ha pendenza negativa. Dunque,
per massimizzare il profitto l’impresa in concorrenza monopolista determina la
quantità da produrre in modo che il costo marginale sia uguale al ricavo marginale e
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
definisce il prezzo sulla base della domanda, in modo che sia coerente con quella
quantità.
Questa tabella mostra le curve di costo, di domanda e di ricavo marginale di due
imprese tipo, ciascuna attiva su un diverso mercato in concorrenza monopolistica.
L’EQUILIBRIO DI LUNGO PERIODO
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Quando le imprese realizzano profitti, nuove imprese sono incentivate a centrare nel
mercato. L’ingresso di nuove imprese determina un aumento del numero di prodotti
in vendita nel settore. L’aumento dell’offerta provoca una diminuzione del prezzo
incassato da ogni impresa per unità di prodotto. Se un’impresa esistente desidera
vendere di più, è costretta a ridurre il prezzo. Poiché il numero di sostituti disponibili
nel mercato è aumentato, l’effetto per la singola impresa è uno spostamento verso
sinistra della curva di domanda. Di conseguenza, il numero dei prodotti tra i quali il
consumatore può scegliere, aumenta, quindi la domanda con la quale si confrontano
le imprese già presenti nel mercato diminuisce. In altre parole, il profitto stimola
l’ingresso di nuovi concorrenti, e ciò provoca uno spostamento verso sinistra della
curva di domanda rilevante per ciascuna impresa. Le imprese del settore che prima
dell’entrata di nuovi concorrenti riuscivano a malapena a sopravvivere, potrebbero
trovarsi ora a realizzare profitti insufficienti, e di conseguenza potrebbero decidere di
abbandonare il mercato. Quando le imprese subiscono delle perdite, le imprese
presenti nel mercato sono incentivate a uscirne. Con la progressiva uscita delle
imprese, l’offerta diminuisce e il prezzo tende ad aumentare. Il numero di beni
sostituti disponibili nel mercato diminuisce, e dunque diminuisce anche il numero
dei prodotti tra i quali i consumatori possono scegliere. Di conseguenza, la domanda
con cui si confrontano le singole imprese rimaste nel mercato, si espande. Il processo
di entrata e di uscita continua fintanto che le imprese attive nel mercato non
realizzano un profitto economico nullo.
In sintesi, son 2 le caratteristiche che descrivono l’equilibrio di lungo periodo in un
mercato in concorrenza monopolistica:
- Come in un mercato monopolistico, il prezzo è maggiore del costo
marginale. Infatti, la massimizzazione del profitto impone l’uguaglianza
di costo marginale e ricavo marginale e, data una curva di domanda con
pendenza negativa, il ricavo marginale è sempre inferiore al prezzo
- Come in un mercato concorrenziale, il prezzo è uguale al costo medio
totale. Infatti, la libertà di entrata e di uscita dal mercato porta
all’azzeramento del profitto
CONCORRENZA MONOPOLISTICA E CONCORRENZA PERFETTA
La presenza di libertà di entrata e di uscita porta tutte le imprese attive in un
mercato in concorrenza monopolistica a collocarsi sul punto di tangenza tra la curva
di domanda e la curva di costo medio tale. Nel lungo periodo, le imprese in
concorrenza perfetta producono quantità corrispondenti alla rispettiva dimensione
efficiente, mentre quelle in concorrenza monopolistica producono quantità minori e
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
quindi hanno capacità produttiva in eccesso. In altre parole, l’impresa in concorrenza
monopolistica, diversamente dall’impresa perfettamente concorrenziale, potrebbe
ridurre il proprio costo medio totale aumentando la produzione.
CAP. XVI
L’OLIGOPOLIO
LE CARATTERISTICHE DELL’OLIGOPOLIO
La caratteristica principale dei mercati oligopolistici è la presenza di un numero
relativamente ridotto di imprese dominanti, ognuna delle quali può offrire un
prodotto identico o simile a quello degli altri produttori.
Nei mercati oligopolistici le imprese offrono prodotti simili, ma potrebbero tentare di
differenziarsi in qualche modo. Ad esempio, una birra chiara è spesso indistinguibile
da molte altre, ma ciononostante le imprese produttrici di birra tentano di
convincere i consumatori che la propria birra è diversa dalle altre.
I mercati oligopolistici sono dominati da poche grandi imprese legate da un rapporto
di interdipendenza: ogni impresa influisce su tutte le altre attraverso le proprie azioni
e può reagire alle decisioni prese dalle altre. Ciascuna impresa nel mercato compie le
proprie scelte, ma nel farlo deve tener conto delle possibili reazioni dei concorrenti.
Questa interdipendenza può creare un conflitto tra cooperazione e interesse privato.
Un gruppo di oligopolisti ha tutto l’interesse a cooperare e ad agire come un
monopolista, producendo basse quantità e applicando un prezzo maggiore del costo
marginale. Tuttavia, dato che l’obiettivo di ogni oligopolista è massimizzare il profitto,
vi sono incentivi poderosi che impediscono agli oligopolisti di mantenere nel tempo
il risultato di monopolio.
CONCORRENZA, MONOPOLIO E CARTELLO
Un accordo tra imprese sulla quantità da produrre e il prezzo da applicare
vene detto ‘collusione’ e il gruppo di imprese che agisce in maniera
coordinata viene detto ‘cartello’. In presenza di un cartello è come se il
mercato fosse servito da un monopolista, pertanto è possibile applicare
l’ipotesi di monopolio. Un cartello deve accordarsi non soltanto sulla
quantità totale da produrre, ma anche sulla quantità prodotta da ciascun
membro. Ciascun membro del cartello desidera per sé una grossa quota di
mercato, poiché a una quota di mercato maggiore corrisponde un profitto
maggiore.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
L’EQUILIBRIO IN REGIME DI OLIGOPOLIO
Gli oligopolisti, pur desiderando formare cartelli per godere di profitti
monopolistici, non sempre ci riescono. Le norme sulla concorrenza
proibiscono accordi espliciti tra oligopolisti, e inoltre il disaccordo tra i
membri dell’oligopolio sulla spartizione delle quote di mercato spesso
rende la collusione impraticabile.
GLI EFFETTI DELLE DIMENSIONI DELL’OLIGOPOLIO SUL RISULTATO
DEL MERCATO
Se possono formare un cartello, gli oligopolisti cercheranno di
massimizzare il profitto totale producendo la quantità di monopolio e
applicando il prezzo di monopolio. Esattamente come se ci fossero due
soli venditori, i membri del cartello dovrebbero accordarsi sulle rispettive
quote di produzione e trovare un modo per far rispettare l’accordo. Con
l’aumento dei partecipanti al mercato, tuttavia, la possibilità di costituire
un cartello stabile è sempre più labile. All’aumentare delle dimensioni del
gruppo, diventa sempre più difficile raggiungere un accordo e farlo
rispettare. Se non formano un cartello, gli oligopolisti decidono
autonomamente la quantità da produrre. Per stabilire come il numero dei
venditori condiziona il risultato del mercato, si consideri la decisione che
ogni venditore deve affrontare, soppesando due effetti:
- L’effetto quantità. Dato che il prezzo è maggiore del costo
marginale, vendere un tot in più accresce il profitto
- L’effetto prezzo. All’aumentare della produzione aumenta la
quantità totale venduta e accresce quindi il prezzo di quel
prodotto, riducendo il profitto anche su tutti gli altri tot. Di
quel prodotto venduti
IL DILEMMA DEL PRIGIONIERO
LE BARRIERE ALL’ENTRATA NELL’OLIGOPOLIO
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Le imprese oligopolistiche agiscono strategicamente. Le imprese possono
trarre vantaggio anche dalla presenza di barriere all’entrata nel settore,
che ostacolano l’ingresso di nuovi concorrenti nel mercato. Quando in un
oligopolio le imprese sono di grandi dimensioni, possono beneficiare di
economie di scala e operare quindi in un punto più basso lungo la curva di
costo medio di lungo periodo. Le imprese che aspirano a entrare nel
mercato potrebbero essere ostacolate dal fatto di non presentare le
stesse economie di scala e di conseguenza avrebbero costi unitari
superiori, che le costringerebbero a praticare costi più elevati. Oltre a
questo, è probabile che i nuovi entranti si confrontino con altri costi di
avviamento per fare il proprio ingresso in un settore dominato da un
numero relativamente ristretto di imprese. La presenza di costi di
avviamento elevati implica che dovranno passare alcuni anni prima che un
nuovo entrato cominci a realizzare profitti. Le imprese esistenti inoltre
potrebbero disporre di un budget dedicato alla pubblicità non solamente
per informare i consumatori, ma anche come mezzo per erigere barriere
all’entrata: se un nuovo entrante vuol competere nel mercato,
probabilmente dovrà anch’esso ricorrere pesantemente alla pubblicità,
per farsi conoscere dai consumatori e sottrarre così clienti alle imprese già
affermate. L’elevato costo della pubblicità fa aumentare tuttavia i costi di
avviamento e agisce da ulteriore deterrente all’entrata.
CAP. XVII
L’ECONOMIA DEI MERCATI DEL LAVORO
LA DOMANDA DI LAVORO
La domanda di lavoro è determinata dai datori di lavoro. Il lavoro non è
richiesto di per se stesso, ma pe il contributo che apporta alla produzione.
La domanda dei fattori di produzione è una ‘domanda derivata’. Questo
significa che la domanda di un fattore di produzione da parte di
un’impresa dipende dalle sue decisioni di offerta in un altro mercato.
Quindi le imprese impiegano lavoratori affinché contribuiscano alla
produzione, e il pagamento che corrispondono loro è il prezzo che devono
pagare per ottenere i servizi del lavoro.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
L’IMPRESA CONCORRENZIALE CHE MASSIMIZZA IL PROFITTO
Si consideri l’esempio di un produttore di mele. L’impresa è proprietaria di
un meleto e deve decidere quanti raccoglitori assumere per la raccolta
delle mele mature: presa la decisione, i lavoratori raccolgono quante più
mele possono e l’impresa le vende, paga i lavoratori e trattiene la
differenza fra ricavi e costi come profitto. Si ipotizzi che questa impresa sia
concorrenziale, sia nel mercato delle mele, sia nel mercato dei raccoglitori
di mele. Dato che ci sono molte altre imprese che vendono mele e che
impiegano raccoglitori, la singola impresa ha una influenza nulla, o quasi,
sul prezzo che riesce a spuntare per le proprie mele e su quello che deve
pagare ai lavoratori. L’impresa deve limitarsi a decidere quanti lavoratori
impiegare e quante mele vendere.
LA FUNZIONE DI PRODUZIONE E IL PRODOTTO MARGINALE DEL
LAVORO
Per decidere quanti lavoratori assumere, un’impresa deve stabilire come il
numero di questi condizioni la quantità che può essere venduta.
IL VALORE DEL PRODOTTO MARGINALE E LA DOMANDA DI
LAVORO
Il valore del prodotto marginale di un fattore di produzione è pari al
prodotto marginale del fattore moltiplicato per il prezzo di mercato del
prodotto. Se il prezzo di mercato per l’impresa concorrenziale è costante,
il valore del prodotto marginale diminuisce all’aumentare del numero dei
lavoratori.
SPOSTAMENTI DELLA CURVA DI DOMANDA DEL LAVORO
La curva di domanda di lavoro riflette il valore del prodotto marginale del
lavoro. Si consideri quali sono gli eventi che possono provocare uno
spostamento della curva di domanda di lavoro:
- IL PREZZO DEL PRODOTTO. Se il prezzo del prodotto cambia,
cambia il valore del prodotto marginale e la curva di domanda
di lavoro si sposta.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
- IL PROGRESSO TECNOLOGICO. Il progresso tecnologico fa
aumentare la produttività e quindi il prodotto marginale del
lavoro.
- L’OFFERTA DI ALTRI FATTORI. La quantità disponibile di un
fattore di produzione può condizionare il prodotto marginale di
altri fattori.
OFFERTA DI LAVORO
Per determinare la propria offerta di lavoro si ipotizza che gli individui si
confrontino con un trade-off tra lavoro e tempo libero: più ore si
trascorrono a lavorare, meno se ne hanno a disposizione per guardare la
tv, socializzare ecc. nel valutare questo trade-off, gli individui devono
prendere in considerazione il costo-opportunità del tempo libero. La curva
di offerta di lavoro riflette il mood in cui le decisioni dei singoli lavoratori
relative al trade-off tra lavoro e tempo libero rispondono a variazioni del
costo-opportunità- una curva di offerta di lavoro con pendenza positiva
indica che all’aumentare del salario i lavoratori sono disposti a lavorare di
più.
L’INFLUENZA DEL SALARIO SULL’OFFERTA DI LAVORO
Per analizzare come un individuo alloca il proprio tempo tra lavoro e
tempo libero si può ricorrere ai concetti di effetto di reddito ed effetto di
sostituzione. Si consideri l’esempio di Sara, una web designer. Sara è
sveglia per 100 ore alla settimana e dedica part del proprio tempo ad
attività di svago e parte alla creazione di siti web. Per ogni ora che dedica
alla sua attività lavorativa guadagna 50 euro, che spende in beni di
consumo. Quindi il salario orario riflette il trade-off tra tempo libero e
consumo. Per ogni ora di tempo libero cui rinuncia, Sara guadagna 50
euro in più che può destinare al consumo. Se Sara dedica tutte le sue 100
ore ad attività di svago, non potrà permettersi di consumare nulla; mentre
se le dedica al lavoro, può consumare beni e servizi per un valore di 5 mila
euro, ma non dispone di tempo libero. Se lavora le canoniche 40 ore
settimanali, dispone di 60 ore di tempo libero e può consumare beni per 2
mila euro.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Se il salario di Sara aumenta, il tempo libero diventa relativamente più
costoso del consumo: ciò induce Sara a sostituire tempo libero con
consumo e quindi a lavorare un maggior numero di ore: questo è l’effetto
sostituzione. Tuttavia, all’aumentare del salario, Sara si sposta su una
curva di indifferenza più elevata, che le garantisce un maggior livello di
soddisfazione. Dato che tempo libero e consumo sono entrambi beni
normali, Sara tende a sfruttare il suo maggior potere d’acquisto
procurandosi una quantità maggiore di entrambi i beni. Con un salario più
elevato, Sara può decidere di lavorare meno e allo stesso tempo ottenere
un maggior livello di soddisfazione, generando una curva di offerta di
lavoro con pendenza negativa; e questo risultato è dovuto all’effetto di
reddito. Se l’effetto di sostituzione prevale su quello di reddito, Sara lavora
di più; se l’effetto di reddito prevale su quello di sostituzione, Sara lavora
meno. La curva di offerta di lavoro, di conseguenza, può avere pendenza
positiva o negativa.
SPOSTAMENTI DELLA CURVA DI OFFERTA DI LAVORO
La curva di offerta di lavoro si sposta se cambia la quantità di lavoro che gli
individui intendono offrire a ogni dato livello di salario.
EQUILIBRIO NEL MERCATO DEL LAVORO
E’ possibile stabilire 2 fatti circa la determinazione dei salari nei mercati di
lavoro concorrenziali:
- Il salario varia in modo da eguagliare la domanda e offerta di
lavoro
- Il salario è uguale al valore del prodotto marginale del lavoro
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Questo grafico indica il mercato del lavoro in equilibrio: salario e quantità
di lavoro sono tali da bilanciare domanda e offerta di lavoro.
TEORIA MARXISTA DEL LAVORO
Marx ha preso in esame la teoria del valore-lavoro e in particolare l’idea di
‘plusvalore’. Secondo Marx i beni hanno un valore d’uso derivato dl fatto
che la maggior parte di essi è destinato al consumo e viene acquistata
perché ha un valore per il consumatore. I beni hanno anche un valore di
scambio, che corrisponde al valore di scambio tra beni diversi. Il valore
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
totale di un bene è determinato dal lavoro che viene impiegato nella sua
produzione, detto tempo socialmente necessario. Il tempo socialmente
necessario corrisponde al contributo medio del lavoro alla produzione. Il
valore di un bene è ciò che Marx chiama ‘lavoro morto’ e ‘lavoro vivo’. Il
lavoro morto è costituito da tutto il lavoro che è stato impiegato per
produrre i beni capitali e le materie prime usate nella produzione di un
bene; il lavoro vivo è il lavoro impiegato nella produzione del bene stesso.
Il valore di un bene è dato dal lavoro, sia vivo sia morto, speso nella sua
produzione.
I DIFFERENZIALI SALARIALI
Nella maggior parte dei sistemi economici i lavoratori percepiscono livelli
di salario molto diversi fra loro.
Quando un lavoratore deve decidere se accettare una proposta di lavoro,
la retribuzione è solo una delle variabili che prende in considerazione: gli
individui non sono motivati solamente dall’interesse personale e dalla
razionalità, ma anche da altruismo, compassione ecc.
Gli economisti usano il termine ‘differenziale di compensazione’ per
indicare le differenze di salario giustificate da differenze nelle
caratteristiche non monetarie delle diverse mansioni. I differenziali di
compensazione sono presenti in tutto il sistema economico. Ad esempio:
- Gli addetti alla manutenzione delle autostrade sono pagati
meglio di altri lavoratori pubblici addetti alla manutenzione
delle vie cittadine o delle strade comunali. La maggior
retribuzione compensa il pericolo connesso con l’occupazione
che svolgono.
- I lavoratori che fanno turni di notte in fabbrica o in altre forme
di occupazione notturna, quali gli impiegati dei negozi aperti
24 ore su 24, sono pagati meglio di quelli che fanno il turno di
giorno. E la maggiore retribuzione compensa uno stile di vita
che la maggior parte degli individui considera poco attraente.
Il ‘capitale umano’ è l’accumulazione delle conoscenze e delle competenze
maturate dagli individui. La forma più importante di capitale umano è
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
l’istruzione. Come tutte le forme di capitale, l’istruzione comporta una
spesa di risorse in un determinato momento finalizzata ad accrescere la
produttività futura; ma diversamente dagli investimenti in altre forme di
capitale, l’investimento nell’istruzione p legato al singolo individuo; e
questo è il fattore che caratterizza il capitale umano. Chi dispone di molto
capitale umano guadagna, nella media, di più di chi ne h poco. La teoria
del capitale umano indica che le imprese sono disposte a pagare di più i
lavoratori con elevata scolarizzazione perché questi hanno una
produttività marginale più alta; i lavoratori sono disposti a sostenere i
costi dell’istruzione superiore solo se riescono a trare un beneficio. In
sostanza, la differenza tra i salari dei lavoratori a scolarizzazione elevata e
quelli a bassa scolarità può essere considerata una differenza di
compensazione per i costi dell’istruzione.
LE LEGGI SUL SALARIO MINIMO
Le leggi sul salario minimo sono un esempio di livello minimo di prezzo e
stabiliscono il prezzo più basso legalmente ammesso dalla manodopera.
Per comprendere al meglio gli effetti del salario minimo, è importante
ricordare che in un sistema economico non esiste un solo mercato del
lavoro, ma tanti mercati quante sono le diverse figure professionali.
L’impatto del salario minimo dipende in parte dalle competenze e
dall’esperienza dei lavoratori. I lavoratori più qualificati ed esperti non
sono influenzati dalla normativa sul salario minimo, perché le loro
retribuzioni di equilibrio sono assai più elevate del livello minimo.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
una misura alternativa al salario minimo è il salario di sussistenza. Questo
viene calcolato sulla base di stime sui bisogni minimi delle famiglie che
devono essere soddisfatti per garantire un tenore di vita accettabile. I
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
risultati mostrano invariabilmente che il salario di sussistenza è superiore
al salario minimo stabilito per legge.
ANALISI ECONOMICA DELLA DISCRIMINAZIONE
Si ha discriminazione quando il mercato offre opportunità differenti a
individui con attitudini simili ma che sono diversi per razza, gruppo etnico
o altre caratteristiche personali. La discriminazione è l’effetto dei
pregiudizi di alcuni individui nei riguardi di alcuni gruppi sociali.
Se un particolare gruppo sociodemografico riceve un salario inferiore
rispetto a quello di altri gruppi, non è scontato stabilire chi sia
responsabile di tale differenziale. Potrebbe sembrare naturale attribuire la
responsabilità di tale discriminazione ai datori di lavoro: dopotutto, sono
loro che decidono chi assumere, determinando la domanda di lavoro e il
salario. Se alcuni gruppi di lavoratori sono retribuiti meno del dovuto, la
responsabilità potrebbe essere fatta ricadere sui datori di lavoro. Eppure,
molti economisti sono scettici a tal riguardo e stabiliscono quanto segue.
Le imprese che hanno come unico obiettivo la massimizzazione del
profitto possono avvantaggiarsi rispetto a imprese concorrenti che
abbiano anche obiettivi di discriminazione. Perciò le imprese che non
discriminano tendono a sostituire quelle che discriminano e, per questa
via, i mercati concorrenziali offrono un antidoto alla discriminazione da
parte dei datori di lavoro.
CAP XVIII
LA DISUGUAGLIANZA DEL REDDITO E POVERTA’
MISURARE LA DISUGUAGLIANZA
Occorre anzitutto partire dalla distribuzione del reddito, cercando di
rispondere ai 4 quesiti cardine di questo discorso:
- Quanta disuguaglianza c’è nella nostra società?
- Quante persone vivono in povertà?
- Quali problemi insorgono nel misurare la disuguaglianza?
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
- Con quale frequenza gli individui si muovono tra diverse classi
sociali?
I due metodi di misurazione della disuguaglianza del reddito più
comunemente usati sono la curva di Lorenz e il coefficiente di Gini.
LA CURVA DI LORENZ
La curva di Lorenz rappresenta la relazione tra la percentuale cumulata
dei nuclei familiari e la percentuale cumulata del reddito. Se il reddito è
distribuito in maniera uniforme, ogni nucleo familiare riceve la stessa
percentuale di reddito totale: e in tal caso la curva di Lorenz sarebbe una
retta a 45 gradi uscente dall’origine. Se il reddito totale di un paese fosse
di 100 milioni di euro, il 10% più povero della popolazione ne riceverebbe
10 milioni, così come il 10% successivo, e così via. Tuttavia, va da se che la
perfetta uguaglianza del reddito non trova pieno riscontro nel mondo
reale. Il confronto tra la curva di Lorenz e la distribuzione perfettamente
ugualitaria descrive il grado di disuguaglianza all’interno di un paese.
IL COEFFICIENTE DI GINI
Il coefficiente di Gini misura il rapporto tra l’area compresa tra la retta a
45 gradi di perfetta uguaglianza del reddito e la curva di Lorenz, e l’area
totale sottostante la retta di uguaglianza assoluta del reddito.
Confrontando il coefficiente di Gini di un campione di paesi possiamo
osservare le diverse distribuzioni del reddito. Il coefficiente di Gini non
offre indicazioni sul modo in cui il reddito è distribuito all’interno di un
dato paese, ma permette solo di stabilire se un paese sia caratterizzato da
una maggiore disuguaglianza del reddito rispetto ad un altro. Può
assumere un valore compreso tra 0 e 1:
- Se è pari a 0, il reddito è distribuito in maniera perfettamente
uniforme, e la curva di Lorenz corrisponde alla retta di perfetta
uguaglianza;
- Se invece tutto il reddito fosse nelle mani di un solo soggetto,
l’area tra la semiretta a 45 gradi uscente dall’origine e la curva
di Lorenz sarebbe pari a 1; e ne consegue che, quanto più il
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
valore del coefficiente Gini si avvicina a 1, tanto maggiore è il
grado di disuguaglianza del reddito.
I PROBLEMI DI MISURAZIONE DELLA DISUGUAGLIANZA
I dati sulla distribuzione del reddito e sul tasso di povertà aiutano a
formarsi un’idea del grado di disuguaglianza della società in cui viviamo,
ma la loro interpretazione non sempre è immediata. Andiamo ad
analizzare vari fattori:
Il reddito nel ciclo di vita. Nel corso della vita di un individuo, il reddito
segue un andamento in genere prevedibile: un giovane, soprattutto se
studente, ha un reddito molto basso; con il raggiungimento della maturità
e il crescere dell’esperienza, il reddito aumenterà e raggiungerà il suo
massimo attorno ai 50 anni, per poi crollare con il pensionamento. Per
ammortizzare l’andamento altalenante del reddito durante il ciclo di vita e
mantenere un livello soddisfacente di consumo, gli individui possono
risparmiare o indebitarsi; per questa ragione il tenore di vita in ogni dato
anno dipende più dal reddito guadagnato complessivamente nell’intero
ciclo di vita che dal reddito annuale. Il normale andamento del ciclo di vita
si caratterizza per variazioni di reddito annuo che non rappresentano
necessariamente vere disuguaglianze del tenore di vita. Per valutare la
disuguaglianza del tenore di vita nella nostra società, la distribuzione del
reddito complessivo nel ciclo di vita è più rilevante della distribuzione dei
redditi annui.
Reddito transitorio e reddito permanente. Il reddito individuale è soggetto
anche a eventi casuali o transitori. Gli individui possono risparmiare o
indebitarsi non solo per ammortizzare le variazioni cicliche del reddito, ma
anche le variazioni transitorie. Quando hanno un’occupazione, gli
individui possono decidere di risparmiare una parte del reddito per i
momenti difficili; analogamente, un lavoratore che si trovi senza lavoro
attinge ai risparmi precedentemente accumulati oppure si indebita, al fine
di mantenere costante il proprio tenore di vita. La capacità di una famiglia
di procurarsi beni e servizi dipende in larga misura dal suo reddito
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
permanente, cioè dal reddito che considera normale o medio. Per
valutare la disuguaglianza del tenore di vita, la distribuzione del reddito
permanente è più rilevante di quella del reddito annuo.
Il tasso di povertà. Per valutare la disuguaglianza del reddito si ricorre
spesso al tasso di povertà, ovvero la percentuale di popolazione che
dispone di un reddito inferiore a un determinato valore, detto soglia di
povertà. Si ha povertà assoluta quando l’individuo non è in grado di
soddisfare bisogni fondamentali della vita. Si ha povertà relativa quando
l’individuo è escluso dalla funzione di un tenore di vita considerato
normale e accettabile a livello sociale.
CAP.XIX
INTERDIPENDENZA E BENEFICI DELLO SCAMBIO
MACROECONOMIA
CAP. XX
PIL
Per stabilire se un sistema economico vada bene o no è necessario
prendere in considerazione la somma dei redditi guadagnati da tutti i
componenti della società, cioè il PIL (Prodotto Interno Lordo). Il PIL misura
sia il reddito totale dei componenti della società, sia la spesa totale per
l’acquisto di ciò che viene prodotto nella stessa società. Il fatto che il PIL
riesca a misurare due cose è dovuto al fatto che le due variabili sono
identiche: il reddito deve essere uguale alla spesa perché ogni transazione
coinvolge un compratore e un venditore, e ogni euro speso da un
compratore è un euro incassato da un venditore. (Tizio dice a Caio di fare
X per 20 euro, Caio vende un servizio X che Tizio acquista; così Caio
guadagna i 20 euro che Tizio spende) – in tal senso, il PIL aumenta di 20
euro. L’eguaglianza tra reddito e spesa si può dimostrare con un
diagramma di flusso circolare, per cui:
-gli individui acquistano beni e servizi dalle imprese
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
-le imprese usano il ricavo delle vendite per pagare i salari ai
lavoratori, le spese ecc.
Il PIL altro non è che la somma delle spese degli individui nel
mercato e la somma di salari, rendite e profitti pagati dalle imprese
nei mercati di produzione.
-le fuoriuscite dal diagramma di flusso riguardano le imposte, il
risparmio e la spesa per le importazioni
-gli apporti al flusso riguardano la spesa pubblica, l’investimento e il
reddito generato dalle esportazioni.
Quando gli individui acquistano beni e servizi dalle imprese, il
denaro transita e le imprese a loro volta utilizzano il denaro ricevuto
per corrispondere i salari ai lavoratori ecc. Così il denaro continua a
fluire dagli individui alle imprese e dalle imprese agli individui. C’è da
aggiungere che una parte del reddito ricevuto dagli individui è
soggetto a tassazione: alcuni non spendono tutto il reddito che
guadagnano, ma ne risparmiano una parte che si riversa nelle
istituzioni finanziarie sotto forma di risparmio previdenziale,
assicurazioni e depositi bancari. Una parte del reddito che gli
individui spendono per l’acquisto di beni e servizi esce dal sistema
economico sotto forma di spesa per le importazioni, e allo stesso
nodo una parte del reddito delle imprese viene versato allo stato
sotto forma di imposte sulla società.
MISURAZIONE DEL PIL
Il PIL è il valore di mercato di tutti i beni e i servizi finali prodotti in un
paese in un dato periodo di tempo. Fondamentalmente il PIL somma
diversi generi di prodotti in un unico indicatore del valore dell’attività
economica, e per poterlo fare ricorre ai ‘prezzi di mercato’. Tali prezzi di
mercato riflettono il valore monetario attribuito a quei determinati beni. Il
PIL deve inoltre essere ‘onnicomprensivo’, deve cioè includere tutti i beni
prodotti e venduti legalmente: comprende anche il valore dei servizi
forniti dal patrimonio immobiliare dell’economia (per questi ultimi il
valore è facile da calcolare per gli immobili in affitto, poiché corrisponde al
canone di locazione; per le abitazioni di proprietà invece il caso si fa più
complesso e il PIL a tal proposito deve includere anche i servizi abitativi di
cui usufruisce il proprietario della casa). Alcuni prodotti vengono
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
comunque esclusi dal computo del PIL, poiché è difficile misurarne il
valore: trattasi di tutti quei beni e servizi prodotti illegalmente. Il PIL
comprende dunque sia beni tangibili (cibo, abiti ecc.), sia servizi intangibili
(pulizie domestiche, visite mediche ecc.), con l’aggiunta che nel computo
del PIL rientrano i soli ‘beni finali’ (trattasi del prodotto ‘finito’, quindi se
una cartiera vende ad una casa editrice la carta per fare un libro, la carta
verrà considerata ‘bene intermedio’ non incluso nel calcolo del PIL,
mentre il libro verrà considerato ‘bene finale’). Un’eccezione a questo
principio sussiste nel caso in cui un bene intermedio non viene
immediatamente utilizzato per la produzione di un altro bene, ma viene
messo da parte per essere poi venduto in un secondo momento: in tal
caso il suo valore costituisce un investimento e viene computato nel
calcolo del PIL. Ancora, il PIL comprende beni e servizi prodotti nel
periodo corrente e non quelli prodotti nel passato, e misura il valore della
produzione nell’ambito dei confini geografici di un paese; per cui se un
cittadino svizzero lavora in Italia, ciò che produce viene incluso nel PIL
italiano. Infine, il PIL misura il valore della produzione in uno specifico
intervallo temporale, che corrisponde generalmente all’anno solare o al
trimestre. Misura i flussi di reddito e spesa che hanno luogo in quel dato
periodo. Per le rilevazioni trimestrali si parla anche di
‘destagionalizzazione’, ossia di quella procedura statistica che ne compie
una manipolazione, per cui i dati non destagionalizzati mostrano che
l’economia produce una maggiore quantità di beni in determinati periodi
dell’anno.
COMPONENTI DEL PIL
Il PIL comprende tutta una serie di forme di spesa per beni e servizi
prodotti internamente, e allo stesso modo ogni paese europeo rileva tutte
le forme di spesa e di reddito per giungere a una stima del PIL della
propria economia. A tal fine, gli economisti ripartiscono il PIL tra le diverse
voci di spesa, per giungere poi alla conclusione che il PIL si componga di
quattro elementi:
-consumo ( C)
-investimento (I)
-spesa pubblica (G)
-esportazioni nette (NX)
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Y = C + I + G + NX (questa espressione algebrica è “un’identità”, per
cui è necessariamente vera data la definizione delle variabili che la
compongono). E in tal caso, dato che ogni euro di spesa incluso nel
PIL appartiene per definizione a una delle quattro categorie, la
somma di queste non può che essere uguale al PIL.
-CONSUMO: Il consumo è la spesa degli individui per l’acquisto di
beni e servizi.
-INVESTIMENTO: L’investimento è la spesa per l’acquisto di beni che
saranno utilizzati in futuro per produrre altri beni e servizi. Trattasi
della somma degli acquisti di beni capitali, attrezzatture, scorte e
strutture. Circa il trattamento riservato alle scorte è necessario fare
un piccolo approfondimento: se ad esempio la Ferrari produce
un’automobile e, piuttosto che venderla, la aggiunge al proprio
inventario di magazzino, nel calcolo del PIL ci si comporta come se la
Ferrari avesse acquistato l’automobile da se stessa.
-SPESA PUBBLICA: La spesa pubblica comprende gli acquisti di beni e
servizi da parte dell’amministrazione statale e delle amministrazioni
locali. Sono inclusi nella spesa pubblica i salari dei dipendenti
pubblici e la spesa per le opere pubbliche. La spesa pensionistica
rientra invece nella categoria dei ‘trasferimenti’: i trasferimenti
equivalgono a un’imposta negativa, dunque ad un pagamento della
pubblica amministrazione che non viene effettuato in contropartita
della cessione di un bene o di un servizio.
-ESPORTAZIONI NETTE: Le esportazioni nette sono pari alla
differenza tra valore dei beni di produzione interna acquistati da
soggetti esteri (esportazioni) e quello dei beni di produzione estera
acquistati dall’interno (importazioni). L’aggettivo ‘nette’ si associa al
valore delle importazioni che viene sottratto a quello delle
esportazioni. Questa sottrazione deve essere effettuata perché beni
e servizi importati vengono automaticamente inclusi nelle altre tre
componenti del PIL.
Una volta calcolato il PIL, esso può essere comunicato in diversi
modi, una delle più comuni è il PIL Pro Capite. Per determinare il PIL
Pro Capite si divide il numero del PIL per il numero dei suoi abitanti,
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
e il risultato esprime il reddito nazionale per ogni individuo nel
sistema economico.
Ora, dato che il PIL misura la spesa totale per l’acquisto di beni e
servizi in tutti i mercati di un sistema economico, se da un anno
all’altro la spesa aumenta sono da valutare diverse questioni: è
altrettanto aumentata la produzione di beni e servizi, o sono
aumentati i prezzi. Per misurare la quantità totale di beni e servizi
prodotti dall’economia è necessario depurare i dati dagli effetti
dell’aumento dei prezzi tramite un indicatore denominato ‘PIL reale’.
Il PIL reale mostra come varia effettivamente nel tempo la
produzione totale di beni e servizi del sistema economico. Il PIL
calcolato con questo metodo prende il nome di ‘PIL a prezzi
costanti’. Il PIL calcolato senza invece prendere in considerazione la
variazione dei prezzi nel tempo prende il nome di ‘PIL a prezzi
correnti’ (o ‘PIL a prezzi di mercato) e si calcola moltiplicando la
quantità prodotta di beni e servizi per il prezzo di quei beni e servizi
nell’anno considerato.
ESEMPI CALCOLO PIL REALE: una tabella X riporta alcuni dati di un
sistema economico che produce due beni (pere e mele). Per
calcolare la spesa totale nel sistema si deve moltiplicare la quantità
di mele e di pere per i rispettivi prezzi. Nell’anno 2013 si vendono
100 kg di mele a 1 euro al kg, per una spesa di 100 euro. In quello
stesso anno si vendono 50 kg di pere a 2 euro al kg, per una spesa di
100 euro. Questo valore che corrisponde alla produzione di beni e
servizi valutata a prezzi correnti prende il nome di ‘PIL nominale’. Per
calcolare il PIL reale è necessario scegliere un anno base e utilizzare i
prezzi delle mele e delle pere in quell’anno per valutare la
produzione dei due beni in tutti gli anni.
Il PIL nominale invece utilizza i prezzi correnti per attribuire un
valore ai beni e servizi prodotti dall’economia, il PIL reale valorizza la
produzione ai prezzi rilevati in un anno base. Il valore del PIL reale è
indipendente dalla dinamica dei prezzi e le sue variazioni riflettono
le sole variazioni della produzione.
DEFLATORE DEL PIL
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Si può parlare di ‘deflatore del PIL’ come di un indicatore del livello dei
prezzi, calcolato come rapporto percentuale tra PIL nominale e PIL reale. Il
deflatore del PIL si calcola dunque con questa operazione: PIL nominale /
PIL reale X 100. C’è da dire che PIL reale e PIL nominale sono identici
nell’anno base, e in quell’anno il deflatore del PIL è sempre uguale a 100.
PIL E BENESSERE ECONOMICO
Il PIL pro capite sembra essere un indicatore naturale del benessere
economico individuale. La validità del PIL come indicatore del benessere
viene però spesso contestata per motivi più legati alla sfera morale,
perché sicuramente si dovrebbe attribuire maggiore importanza a cose
come la salute, l’istruzione, piuttosto che pensare al mero benessere
economico. Però c’è anche da dire che un PIL elevato aiuta effettivamente
a innalzare la qualità della vita. In breve si può dire che il PIL non è un
indicatore diretto di ciò che contribuisce alla qualità della vita, ma misura
la possibilità di ottenere mezzi per vivere una vita dignitosa. Ciò non
significa nemmeno che il PIL sia da considerare come un indicatore
perfetto del benessere economico, in quanto non comprende alcune delle
cose che contribuiscono alla qualità della vita, come ad esempio il tempo
libero: se infatti tutti i membri di un sistema economico iniziassero a
lavorare ininterrottamente sette giorni su sette, sicuramente
aumenterebbe la produzione di beni e di servizi e di conseguenza anche il
PIL, ma l’aumento del PIL non sarebbe proporzionale al benessere
collettivo. Ancora, il PIL non tiene conto dei beni e servizi prodotti per
l’autoconsumo, e ancora non prende in considerazione la qualità
dell’ambiente, o la distribuzione del reddito. In sostanza, se ne può
dedurre che il PIL sia sicuramente un buon indicatore del benessere
economico per certi aspetti, ma non per tutti. Un modo per valutare
l’utilità del PIL come indicatore del benessere economico è esaminare i
dati internazionali: in quanto, chiaramente, i paesi ricchi hanno livelli di
PIL pro capite sostanzialmente differenti rispetto ai paesi poveri. Nei paesi
più ricchi come Regno Unito e Giappone, Usa e Germania, gli individui
hanno un’attesa di vita superiore ai 70 anni e quasi la totalità della
popolazione è alfabetizzata; nei paesi più poveri invece, come Nigeria,
Pakistan e Bangladesh, le persone hanno un’aspettativa di vita più bassa,
tassi più elevati di mortalità infantile ecc.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
CAP. XXI
MISURARE IL COSTO DELLA VITA
Per misurare il costo della vita, gli economisti spiegano che è necessario
trasformare i valori espressi in moneta corrente in una misura significativa
del potere d’acquisto, tale misura statistica prende il nome di ‘indice dei
prezzi al consumo’. L’indice dei prezzi al consumo permette di stabilire
come varia il costo della vita nel tempo: se aumenta, la famiglia deve
spendere una somma maggiore per acquistare la stessa quantità di beni e
servizi. Si parla in tal senso di ‘inflazione’ per descrivere una situazione
nella quale il livello generale dei prezzi tende ad aumentare. L’indice dei
prezzi al consumo è dunque un indicatore del costo complessivo di beni e
servizi acquistati dal consumatore; per calcolare l’indice dei prezzi al
consumo e il tasso di inflazione si rilevano i prezzi di mercato di migliaia di
beni e servizi.
CALCOLO INDICE DEI PREZZI A CONSUMO
Partiamo da un’economia in cui esistono soltanto due beni, pizzette e
panini.
- Il primo passo da compiere per calcolare un indice di prezzi al
consumo è stabilire quali siano i prezzi importanti per il
consumatore, per cui se questi acquistano più pizzette che
panini, il prezzo delle pizzette avrà sicuramente un’importanza
maggiore del prezzo dei panini e avrà di conseguenza anche un
peso maggiore nella determinazione del costo della vita. Si
parla di ‘paniere’ dicendo che il consumatore medio
dell’esempio acquista un paniere di 4 pizzette e 2 panini.
- La seconda fase richiede di rilevare il prezzo di vendita di ogni
bene o servizio del paniere nei diversi momenti in cui viene
venduto.
- Nella terza fase si utilizzano i dati rilevati per calcolare il prezzo
del paniere dei beni e servizi in ciascuno dei tre anni. Tenendo
costante il paniere (sempre composto da 4 pizzette e 2 panini),
vengono isolati gli effetti della variazione dei prezzi da quelli
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
del cambiamento delle preferenze del consumatore che si
possono verificare in quello stesso intervallo di tempo.
- Nella quarta fase si individua un anno da utilizzare come base
del calcolo. Per calcolare l’indice, il prezzo del paniere di beni e
servizi rilevato in ogni anno viene diviso per il prezzo ricavato
nell’anno base e moltiplicato X 100; il risultato di questa
operazione sarà uguale all’indice dei prezzi al consumo. Se nel
2014 il costo del paniere di 4 pizzette e 2 panini è di 8 euro, il
prezzo del paniere in ciascun anno deve essere diviso X 8 e
moltiplicato X 100. L’indice dei prezzi al consumo nel 2014 è
100, nel 2015 è 175, e ciò significa che il costo del paniere nel
2015 è pari al 175% di quello rilevato nell’anno base.
- La quinta ed ultima fase consiste nel calcolo del tasso di
inflazione, cioè la variazione di percentuale dell’indice dei
prezzi al consumo da un periodo all’altro. Il tasso di inflazione
tra due anni consecutivi è calcolato con la seguente formula:
INDICATORE DEI PREZZI AL CONSUMO (IPC) NELL’ANNO 2 –
INDICATORE DEI PREZZI AL CONSUMO (IPC) NELL’ANNO 1 / IPC
NELL’ANNO 1 X 100.
Viene inoltre calcolato anche un indice dei prezzi alla produzione, che
misura i prezzi di un paniere di beni e servizi acquistati dalle imprese,
invece che dai consumatori.
PROBLEMI DI MISURAZIONE DEL COSTO DELLA VITA
L’indice dei prezzi al consumo cerca di stabilire di quanto dovrebbero
aumentare o diminuire i redditi per poter mantenere inalterato il tenore
di vita. Se nel 2014 un individuo ha un reddito di 100 euro alla settimana,
con il quale acquista solo panini a 2 euro l’uno, allora il suo tenore di vita è
pari a 50 panini alla settimana. Nel 2015 il prezzo di un panino aumenta a
3 euro, e ora il tenore di vita del consumatore, ponendo il caso che il suo
reddito sia rimasto invariato, è di solamente 33,3 panini alla settimana. Il
suo tenore di vita è così diminuito, perché ora può permettersi di
consumare meno panini, e per mantenere il suo tenore di vita costante è
necessario che il suo reddito aumenti da 100 a 150 euro alla settimana.
L’IPC non è comunque una misura perfetta del costo della vita, essendo
inficiato da 3 problemi fondamentali:
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
1) DISTORSIONE DA SOSTITUZIONE: I prezzi di alcuni beni possono
aumentare più di quelli di altri, mentre altri possono addirittura
diminuire. Il consumatore reagisce a queste continue variazioni
acquistando quantità sempre minori di beni i cui prezzi sono
aumentati e viceversa acquistando quantità sempre maggiori i cui
prezzi sono rimasti invariati o sono addirittura diminuiti, in quanto il
consumatore tende a sostituire i beni relativamente più costosi con
quelli relativamente più a buon mercato. Supponiamo che nell’anno
base le mele siano meno costose delle pere e che i consumatori
acquistino più mele che pere, il paniere per il calcolo dell’IPC
contiene più mele che pere. Ora, supponiamo che nell’anno
successivo le pere diventino meno costose delle mele: il
consumatore medio reagisce acquistando più pere e meno mele. Ma
nel calcolare l’IPC viene utilizzato un paniere fisso, ipotizzando che il
consumatore non adegui il proprio comportamento alle variazioni di
prezzo e acquisti le stesse quantità dell’anno precedente. Per
questo, l’indice sovrastima l’aumento del costo della vita rispetto
all’esperienza effettiva del consumatore.
2) INTRODUZIONE DI NUOVI BENI: Quando viene introdotto un
nuovo bene sul mercato, il consumatore si trova per forze di cose
davanti ad una gamma di scelta più ampia e per questa ragione il
consumatore ha bisogno di meno moneta per mantenere inalterato
il suo tenore di vita. Tuttavia, l’indice dei prezzi al consumo (l’IPC)
non subisce alcuna variazione.
3) IMPOSSIBILITA’ DI MISURARE VARIAZIONI QUALITATIVE: Se la
qualità di una categoria di beni diminuisce da un anno all’altro,
diminuisce anche il valore della moneta nonostante i prezzi
rimangano inalterati. Ora, se la qualità di un bene compreso nel
paniere aumenta, si cerca di aggiustare il prezzo del bene in funzione
della differenza qualitativa, cercando di calcolare il costo di un
paniere di beni in condizioni di qualità costante.
4) RILEVANZA DELL’IPC: Un ultimo problema legato all’indice sta nel
fatto che gli individui singolarmente potrebbero non considerare
l’IPC come un’inflazione rilevante per la loro particolare situazione. E
a causa delle diverse percezioni individuali, viene pubblicato un
calcolatore dell’inflazione personale (PIC), che consente agli utenti di
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
inserire i propri dati personali, relativi alla spesa mensile
complessiva e a diverse categorie di spesa.
C’è da aggiungere che, prima del 2004, nel Regno Unito il livello dei
prezzi veniva misurato con l’RPI (indice dei prezzi al dettaglio). L’RPI
è un indice di prezzi che differisce dall’IPC per beni e servizi inclusi
nel paniere e per la copertura delle famiglie. Nello specifico, l’IPC
esclude alcuni articoli che invece sono inclusi nell’RPI, come imposte
sugli immobili e pagamenti di interessi di mutui ipotecari. Questi
articoli sono esclusi nell’IPC perché ad esempio le imposte possono
variare per ragioni politiche, da qui ne deriva che il tasso di
inflazione misurato dall’RPI può aumentare anche in assenza di
pressioni inflazionistiche nell’economia. L’RPI esclude invece il 4%
delle famiglie con il reddito più elevato e le famiglie di pensionati
che traggono almeno ¾ del proprio reddito da trasferimenti statali.
Ma quando si parla di IPC e ci si domanda il perché sia di fatto stato
introdotto, la risposta non è mai concreta. Da una parte si dice che
esso sia una misura più precisa del concetto di livello generale dei
prezzi utilizzato nell’analisi della macroeconomia; la tesi opposta
sostiene invece che questa definizione sia in realtà fuorviante in
quanto sottostima i costi dell’abitazione, escludendo pagamenti di
interessi sui mutui e imposte locali sugli immobili. Ma poi di fatto la
ragione principale dell’adozione dell’IPC nel Regno Unito è la
necessità di uniformare il proprio indice del livello dei prezzi a quelli
calcolati in altri paesi membri dell’Unione Europea. Questi indici
vengono chiamati nello specifico IAPC (indici armonizzati dei prezzi
al consumo). Questi indici consentono un confronto diretto tra tassi
di inflazione degli stati membri dell’UE.
Tornando ora al discorso circa il deflatore del PIL : dato che il PIL
nominale è la produzione corrente valutata a prezzi costanti riferiti a
un anno base, il deflatore del PIL descrive i livello corrente dei prezzi
rispetto a quello rilevato nell’anno base. Per valutare il tasso di
crescita dei prezzi si prende in considerazione sia il deflatore del PIL,
sia l’indice dei prezzi al consumo. Generalmente questi due hanno
valori analoghi, ma non si esclude che possano emergere anche due
importanti differenze: 1) Il fatto che il deflatore del PIL rifletta i prezzi
di tutti i beni e i servizi prodotti internamente, mentre l’indice dei
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
prezzi al consumo riflette i prezzi di tutti i beni e servizi acquistati da
consumatori. ESEMPIO 1: se il prezzo di un aeromobile prodotto da
impresa X francese e venduto all’aeronautica francese aumenta,
anche se la transazione contribuisce alla crescita del PIL della
Francia, l’aeromobile non fa comunque parte del paniere di beni e
servizi acquistati dal consumatore tipo e di conseguenza l’aumento
del prezzo viene computato dal deflatore de PIL, ma non dall’IPC
della Francia. ESEMPIO 2: supponiamo ora che la casa
automobilistica X tedesca aumenti i prezzi delle proprie automobili,
dato che le auto sono prodotte in Germania, non contribuiscono alla
formazione del PIL francese, nonostante gli automobilisti francesi
acquistino quelle auto, che quindi entrano a far parte di beni e
servizi acquistati dal consumatore tipo. Così, l’aumento del prezzo di
un bene al consumo importato viene rilevato dall’IPC francese, ma
non dal deflatore del PIL. Questa differenza tra deflatore del PIL e
IPC si fa sempre più evidente nel caso di un aumento del prezzo del
petrolio, in quanto il Regno Unito si pone come produttore di
petrolio, ma di fatto gran parte del suo fabbisogno è soddisfatto
attraverso l’importazione di greggio dal Medio Oriente, di
conseguenza petrolio e suoi derivati (quali benzina e gasolio)
rappresentano una quota di spesa per il consumatore assai più
rilevante di quella corrispondente al contributo dato poi
effettivamente dal petrolio alla formazione del PIL.
2)Mentre l’IPC si fonda su un paniere costante di beni e servizi, il
deflatore del PIL mette a confronto il prezzo di beni e servizi di
produzione corrente con quello che questi stessi beni avrebbero
avuto nell’anno base. Questa differenza non è particolarmente
rilevante se i prezzi cambiano in maniera proporzionale, ma se i
prezzi di beni diversi variano a velocità diversa, le modalità di
‘pesatura’ dei vari prezzi acquisiscono grande importanza.
DEPURARE VALORI DELLE VARIABILI ECONOMICHE DAGLI EFFETTI
DELL’INFLAZIONE: Il livello generale dei prezzi generalmente viene
misurato per permettere il confronto tra dati monetari rilevati in
tempi diversi. CONFRONTARE VALORI MONETARI PRESENTIE
PASSATI TRAMITE CALCOLO DEGLI INDICI DI PREZZI: è necessario
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
conoscere il livello dei prezzi corrente e quelli di allora. ESEMPIO:
per confrontare gli stipendi del 1911 è necessario esprimere il valore
delle sterline di allora nel valore delle sterline attuali. Per
trasformare i valori monetari la formula utilizzata è VALORE
MONETARIO CORRENTE = VALORE MONETARIO NELL’ANNO T X
LIVELLO DEI PREZZI CORRENTE / LIVELLO DEI PREZZI NELL’ANNO T
INDICIZZAZIONE: Quando un valore monetario viene automaticamente
corretto per l’inflazione si dice che è ‘indicizzato’. Molti contratti collettivi
di lavoro prevedono ad esempio l’indicizzazione totale o parziale del
salario e fanno riferimento all’IPC, e si parla in tal caso di ‘scala mobile’ e
fa variare automaticamente le retribuzioni in funzione del costo della vita.
La correzione delle variabili economiche per gli effetti dell’inflazione è
particolarmente importante quando si considerano i tassi di interesse, che
implica necessariamente il confronto di somme di denaro in diversi
momenti nel tempo. ESEMPIO: se tizio corrisponde i propri risparmi in un
deposito bancario, li consegna alla banca che glieli restituirà in futuro
maggiorati dagli interessi e se tizio si indebiterà, la banca gli darà del
denaro ‘oggi’ e Tizio dovrà corrisponderglielo in futuro con gli interessi. E
in entrambi i casi è necessario comprendere che il ‘denaro futuro’ ha un
valore diverso da quello attuale: in pratica si devono eliminare gli effetti
dell’inflazione. Se infatti nel frattempo i prezzi aumentano, con 1 € si
acquista oggi una quantità di beni minore rispetto a un anno fa. Il tasso di
interesse corrisposto dalla banca è detto ‘tasso di interesse nominale’,
mentre il tasso di interesse corretto per l’inflazione è chiamato ‘tasso di
interesse reale’. La relazione tra i due è espressa dalla formula: TASSO DI
INTERESSE REALE = TASSO DI INTERESSE NOMINALE – TASSO DI
INFLAZIONE. Il tasso di interesse reale dunque è la differenza tra tasso di
interesse nominale e tasso di inflazione. Il tasso di interesse nominale
stabilisce di quanto aumenta nel tempo l’ammontare di denaro depositato
in banca, il tasso di interesse reale stabilisce di quanto aumenta nel tempo
il potere d’acquisto di una somma depositata.
CAP. XXII
PRODUZIONE E CRESCITA
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
PRODUZIONE E CRESCITA
Per analizzare la crescita dei sistemi economici nel lungo periodo è
anzitutto necessario osservare quanto è accaduto ad alcune economie
mondiali. I dati del PIL reale pro capite dimostrano che il tenore di vita
varia notevolmente da paese a paese. Il reddito medio individuale negli
USA ad esempio è circa di 32 volte quello dell’India, nonostante questo
paese sia notevolmente aumentato dal 1961. Ovviamente, i paesi più
poveri hanno un livello di reddito medio pro capite inferiore. Il Giappone è
uno dei paesi il cui reddito pro capite è aumentato maggiormente,
crescendo di oltre l’8000% dal 1961: nel 1961 il Giappone non era un
paese ricco, il suo reddito pro capite era minore di quello della Grecia,
oggi invece grazie alla sua forte crescita è una superpotenza economica,
con un reddito quasi simile a quello di Francia e Germania.
TEORIA DELLA CRESCITA
Il tasso di crescita economica di un paese varia nel tempo. I sistemi
economici attraversano periodi di crescita sostenuti e altri di
rallentamento, e altri ancora di contrazione. La crescita tendenziale viene
così calcolata: CRESCITA TENDENZIALE = PIL T2 – PIL T1 / PIL T1 X 1000
Questa formula indica che per calcolare la crescita tendenziale è
necessario considerare il PIL di un determinato periodo e sottrarvi il PIL
del periodo iniziale, dividere il risultato per il valore del PIL nel periodo
iniziale ed esprimere la cifra risultante in termini percentuali. Per spiegare
la crescita economica sono state proposte numerose teorie: una delle più
celebri fu quella di Solow e Swan che identificarono nei tassi di crescita
del capitale umano fisico e della popolazione le determinanti
fondamentali della crescita economica. Altri fattori che potrebbero
influenzare la crescita economica di un paese sono sicuramente il livello di
stabilità macroeconomica, il regime degli scambi commerciali, natura e
qualità delle istituzioni e ancora fattori interni come quantità di terra
coltivabile ecc.
LA PRODUTTIVITA’
Con il termine ‘produttività’ si indica la quantità di beni e servizi che un
lavoratore può produrre nell’unità di tempo. Solow e Swan hanno
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
individuato alcune determinanti della crescita economica: si può
interpretare il PIL di un paese come un’estensione della funzione di
produzione di un’impresa, in cui il livello di produzione dipende da fattori
di produzione impiegati. ESEMPIO: se nella produzione vengono impiegati
due soli fattori, si intende il capitale K e il lavoro L, per cui il PIL di un
paese (Y) è una funzione dello stock di capitale K e dell’offerta di capitale
umano L: Y = f(K,L) Il prodotto marginale del lavoro (PL) è la variazione
della produzione PIL che risulta da una variazione della quantità di lavoro
impiegata: P’L = DELTA Y / DELTA L
Da qui se ne deduce che non è solo la quantità di lavoro ad essere
importante ma anche la sua produttività, determinata da svariati fattori.
Per calcolare la produttività media del lavoro, partendo dalla funzione
Y=f(K,L) dividiamo entrambi i termini per L e otteniamo Y/L = f(K/L, 1) in
cui Y/L è la produttività media del lavoro, ossia la quantità di lavoro di
prodotto per occupato. La produttività media del lavoro dipende dal
rapporto tra capitale e lavoro K/L. La produttività del lavoro e lo stock di
capitale sono positivamente correlati, ma all’aumentare dello stock di
capitale, la produttività del lavoro aumenta a un tasso decrescente, di
conseguenza la crescita economica dipende dallo stock di capitale per
occupato e dalla produttività media del lavoro.
CRESCITA DELLO STOCK DI CAPITALE FISICO: Generalmente, gli individui
che percepiscono un reddito non lo spendono completamente, ma ne
risparmiano una parte, tale percentuale di reddito risparmiata è
denominata ‘saggio di risparmio’. L’importanza del saggio di risparmio è
stata evidenziata da Solow e Swan in particolar modo nella
determinazione dell’investimento. In un sistema economico
l’investimento è la spesa per il capitale fisico, ossia per la capacità
produttiva. L’investimento è finanziato tramite il risparmio. La spesa per
investimento può essere classificata in due modi: investimento lordo o
investimento netto. L’investimento lordo è la spesa totale in stock di
capitale in un dato periodo; l’investimento netto è la spesa in stock di
capitale al netto della spesa per sostituire lo stock di capitale esistente.
Tasso di ammortamento e tasso di crescita della popolazione sono fattori
chiave per la determinazione dell’investimento richiesto al fine di
mantenere costante il rapporto capitale/lavoro.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
DETERMINANTI DELLA PRODUTTIVITA’
-CAPITALE FISICO: I lavoratori sono più produttivi se dispongono di
strumenti con i quali lavorare, dunque la dotazione di utensili e strutture
da utilizzare per la produzione di beni è detta ‘capitale fisico’. Uno degli
aspetti peculiari del capitale fisico è che si tratta di un fattore di
produzione che è a sua volta un prodotto: il capitale cioè è un fattore di
produzione che nel passato è stato il prodotto di un processo esecutivo.
-CAPITALE UMANO: Il capitale umano è qualificabile come le conoscenze e
le capacità accumulate dai lavoratori attraverso l’istruzione, formazione e
l’esperienza, e comprende le conoscenze e le competenze maturate
durante gli studi e l’esperienza acquisita direttamente sul lavoro. Anche il
capitale umano come quello fisico accresce la capacità di una azione di
produrre beni e servizi ed è anch’esso un fattore di produzione che è a sua
volta prodotto.
-RISORSE NATURALI: Sono fattori di produzione forniti dalla natura e
possono assumere due forme, rinnovabili e non rinnovabili. La diversa
disponibilità di risorse naturali è una delle cause della diversità del tenore
di vita tra i paesi del mondo. Il successo economico degli USA ad esempio
è dovuto in gran parte anche alla disponibilità di terreni adatti alla
coltivazione; altri paesi invece come Arabia Saudita e Kuwait sono ricchi
semplicemente perché nel loro sottosuolo si trovano i più grandi
giacimenti di petrolio del mondo.
-CONOSCENZE TECNOLOGICHE: Trattasi della conoscenza dei modi più
efficaci di produrre beni e servizi e può assumere molte forme. Le
conoscenze tecnologiche si riferiscono per lo più alle conoscenze diffuse
nella società sul funzionamento del mondo.
Per ottenere una crescita economica non basta comunque tutto ciò, ma
richiede anche un progresso tecnologico, ossia un miglioramento della
qualità del capitale fisico e umano.
Il tenore di vita di un sistema economico dipende dalla sua capacità di
produrre beni e servizi e la produttività dipende dal capitale fisico, umano,
dalle risorse naturali e dalle conoscenze tecnologiche.
CAP. XXIII
LA DISOCCUPAZIONE
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Un indicatore di estrema importanza circa il tenore di vita di un paese è la
quantità di persone che sono disoccupate: cioè individui che vorrebbero
lavorare ma non riescono a trovare un lavoro. Il problema della
disoccupazione può essere diviso in due parti: il problema di lungo
periodo e quello di breve periodo. Soffermandosi sul problema di lungo
periodo è necessario avere ben chiari tutti i concetti relativi al tasso
naturale di disoccupazione di un sistema economico. I disoccupati sono
coloro che, in età lavorativa, pur essendo abili e disponibili a lavorare al
salario corrente, non hanno un impiego. Ci si occupa in economia del
tasso di disoccupazione, cioè del numero di disoccupati espresso in
percentuale della forza lavoro, a sua volta definita come il numero totale
di persone che potrebbero essere occupate nel sistema economico in un
dato periodo di tempo. La disoccupazione si può misurare o tramite il
conteggio dei richiedenti sussidio, o tramite le indagini sulla forza lavoro.
CONTEGGIO DEI RICHIEDENTI SUSSIDIO
Consiste nel contare il numero di persone che, in un dato giorno,
richiedono alla pubblica amministrazione di accedere alle indennità di
disoccupazione, il cosiddetto ‘conteggio dei richiedenti’. Tali prestazioni
vengono normalmente erogate da un ente pubblico, e questo facilità
un’agenzia governativa nell’ottenere i dati sul numero dei richiedenti.
Tuttavia questo metodo presenta una serie di problemi: anzitutto, risente
dei cambiamenti della normativa che stabilisce chi ha diritto a percepire
l’indennità di disoccupazione. Perciò, se ad esempio il governo decidesse
di inasprire le regole, tanto da ridurre il numero di persone che possono
richiedere l’indennità, il numero di disoccupati diminuisce e diminuisce
anche il tasso di disoccupazione, anche se il numero di persone occupate
o no è rimasto invariato. Accadrebbe l’opposto se il governo diventasse
più permissivo e allentasse le regole, in modo da incrementare il numero
di soggetti idonei.
INDAGINI SULLA FORZA LAVORO
Metodo sicuramente più attendibile, consiste in un sondaggio condotto
attraverso interviste a un campione di persone sulla base di una
definizione accettata di disoccupazione. Nel Regno Unito e in molti altri
paesi questa indagine viene svolta dall’ILO, l’Organizzazione
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Internazionale del Lavoro. Un disoccupato è un individuo senza lavoro,
disposto a iniziare a lavorare nelle due settimane successive all’indagine e
che ha cercato lavoro nelle quattro settimane precedenti o è in attesa di
iniziare a lavorare. Nel Regno Unito l’indagine è basata su un campione di
circa 60.000 famiglie e in Europa il campione totale è basato su circa 1,5
milioni di famiglie. Sulla base delle risposte date alle domande, il governo
colloca ciascun adulto, maggiore i 16 anni, in una delle seguenti categorie:
occupato, disoccupato, non appartenente alla forza lavoro. Una persona è
considerata occupata se ha trascorso almeno una parte della settimana
precedente impiegata in un’occupazione retribuita, ed è considerata
invece disoccupata se risponde alla definizione dell’ILO. Un individuo che
invece non ricade in nessuna di queste categorie, come uno studente a
tempo pieno, una casalinga o un pensionato, non appartengono alla forza
lavoro e sono considerati ‘economicamente inattivi’. FORZA LAVORO =
NUMERO DEGLI OCCUPATI + NUMERO DEI DISOCCUPATI. Il tasso di
disoccupazione può essere misurato come la percentuale della forza
lavoro che è disoccupata, perciò TASSO DI DISOCCUPAZIONE = NUMERO
DEI DISOCCUPATI/FORZA LAVORO X 100 e il governo ricorre ai risultati del
medesimo sondaggio per produrre anche stime sul tasso di
partecipazione alla forza lavoro, cioè la percentuale della popolazione
adulta che fa parte della forza lavoro, perciò TASSO DI PARTECIPAZIONE
ALLA FORZA LAVORO = FORZA LAVORO/POPOLAZIONE ADULTA X 100
TASSO NATURALE DI DISOCCUPAZIONE: Trattasi del tasso medio di
disoccupazione intorno al quale oscillano le osservazioni annue. La
deviazione della disoccupazione rilevata annualmente dal livello naturale
è detta ‘disoccupazione ciclica’.
Per giudicare poi quanto sia grave il problema della disoccupazione, si
deve stabilire se si tratta di una condizione di breve periodo o di lungo
periodo. Se la disoccupazione fosse di breve durata, si potrebbe
concludere che il problema non sia poi così grave dal punto di vista
sociale, mentre se la disoccupazione si manifestasse in maniera
persistente, i connotati del problema sarebbero ben più gravi. La durata
media del periodo di disoccupazione può perciò condizionare la
valutazione del fenomeno e gli economisti sono giunti ad una soluzione di
per sé contradditoria: “la durata dei periodi di disoccupazione è
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
generalmente breve, ma la maggior parte della maggior parte della
disoccupazione rilevata in ogni dato momento è di lunga durata.
ESEMPIO: se tizio va all’ufficio di collocamento ogni settimana per un
anno ai fini si rilevare e analizzare i dati sulla disoccupazione, ogni
settimana noterà la presenza di 4 disoccupati, di cui 3 sempre gli stessi per
l’intero anno, mentre il quarto cambia ogni settimana. Sulla base di questa
rilevazione, è necessario capire se la disoccupazione si tratti di un
fenomeno di breve o di lunga durata. Considerando il livello complessivo
della disoccupazione, 3 persone disoccupate per un anno equivalgono a
156 settimane di disoccupazione. Si può quindi parlare di disoccupazione
di lunga durata.
In un mercato del lavoro ideale inoltre, i salari dovrebbero aggiustarsi in
modo che la quantità di lavoro domandata sia uguale a quella offerta, e
tale aggiustamento del salario garantirebbe sempre la piena occupazione.
La realtà tuttavia è ben diversa: ci sono infatti sempre alcuni lavori
disoccupati, anche quando l’economia va bene. 4 spiegazioni del perché
persiste il fenomeno della disoccupazione:
1)I lavoratori impiegano tempo per trovare un lavoro adeguato alle loro
aspettative. Si parla di ‘disoccupazione frizionale’, ossia della
disoccupazione causata dal tempo necessario a un lavoratore per trovare
una nuova occupazione adatta alle proprie capacità e aspirazioni.
2/3/4) Le altre tre spiegazioni fanno supporre che il numero di posti di
lavoro disponibile non sia sufficiente per dare un’occupazione a chiunque
la richieda. Questo accade se la quantità di offerta di lavoro supera la
quantità domandata. Si parla a tal proposito di ‘disoccupazione
strutturale’. Questo genere di occupazioni insorgono quando i salari sono
maggiori di quelli che garantirebbero l’equilibrio tra domanda e offerta.
COLLOCAMENTO DEL LAVORO
Trattasi del processo attraverso il quale i lavoratori trovano
un’occupazione rispondente alle proprie capacità e aspirazioni. Se tutti i
lavoratori e tutti i posti di lavoro fossero uguali, ogni lavoratore sarebbe
adatto a ogni posto di lavoro e il collocamento non rappresenterebbe un
problema. Ma, nella realtà i lavoratori sono diversi per capacità e
preferenze e i posti di lavoro si differenziano per caratteristiche ecc.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
La disoccupazione frizionale è spesso il risultato di variazioni della
domanda di lavoro tra diverse imprese: se i consumatori decidono di
preferire il bene X al bene Y, l’impresa che produce il bene X deve
aumentare il numero dei propri occupati, mentre l’altra deve ridurlo. Così,
gli ex dipendenti dell’impresa Y devono trovare un nuovo posto di lavoro e
il produttore del bene X deve decidere quali nuovi lavoratori assumere. Il
risultato di questa transizione è un periodo di disoccupazione. La
disoccupazione frizionale è inevitabile perché l’economia è in continua
evoluzione. Un provvedimento che contribuisce ad aumentare la
disoccupazione frizionale è l’indennità di disoccupazione, ossia un
provvedimento statale pensato per offrire ai lavoratori una parziale
protezione in caso di perdita del posto di lavoro. I lavoratori dimissionari,
quelli licenziati per giusta causa o quelli che sono appena entrati nella
forza lavoro non possono beneficiarne, in quanto l’indennità viene
corrisposta solo a coloro che sono stati licenziati perché le loro
competenze non erano più necessarie. L’effetto dell’indennità di
disoccupazione dipende dal modo in cui il provvedimento è formulato e
interpretato.
CAUSE DELLA DISOCCUPAZIONE
- LEGGI SUL SALARIO MINIMO: Il salario minimo ha un effetto
rilevante su determinati gruppi sociali, già gravati da un forte
tasso di disoccupazione. Una legge che impone un salario
minimo più elevato rispetto all’equilibrio del mercato fa
aumentare la quantità di lavoro offerta e diminuire la quantità
domandata rispetto al valore di equilibrio, creando
un’eccedenza di lavoro. Le leggi sul salario minimo sono
vincolanti per i lavoratori meno qualificati e per i membri più
giovani della forza lavoro meno esperti. (GRAFICO 462 –
disoccupazione provocata da retribuzioni superiori al livello di
equilibrio) Se il salario viene mantenuto al di sopra del livello di
equilibrio, il risultato è la disoccupazione. E’ comunque
necessario sottolineare come la disoccupazione strutturale che
deriva da salari superiori al livello di equilibrio sia diversa dalla
disoccupazione frizionale che discende invece dal processo di
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
collocamento. Nei casi in cui la disoccupazione può essere fatta
risalire al collocamento, i lavoratori sono alla ricerca di
un’occupazione che soddisfi le loro aspettative; quando invece
i salari sono al di sopra del livello di equilibrio, la quantità di
lavoro offerta è maggiore della quantità domandata e i
lavoratori sono disoccupati in attesa che si liberino posti di
lavoro.
- SINDACATI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: Un sindacato è
un’associazione di lavoratori che contratta collettivamente con
i datori di lavoro salari e condizioni lavorative. Un sindacato è
una sorta di cartello che rappresenta un gruppo di venditori
che agiscono nella speranza di esercitare un potere di mercato
congiunto. Il processo attraverso il quale sindacati e imprese
raggiungono un accordo sulle condizioni di occupazione viene
detto ‘contrattazione collettiva’. Nel contrattare con
un’impresa, il sindacato chiede salari più elevati e migliori
condizioni di lavoro di quanto l’impresa stessa sarebbe
disposta a offrire in assenza del sindacato. Se l’azione del
sindacato spinge le retribuzioni al di sopra del livello di
equilibrio, la quantità di lavoro offerta aumenta e quella
domandata diminuisce, producendo disoccupazione: così i
lavoratori che riescono a mantenere l’impiego ne traggono
beneficio, ma quelli che perdono il posto ne vengono
danneggiati. Il ruolo dei sindacati dipende dalle leggi che
regolano l’attività sindacale e la contrattazione collettiva. Il
sindacato è criticato soprattutto perché costituisce una forma
di ‘cartello’, e quando spinge le retribuzioni al di sopra del
livello, riduce la quantità di domanda del lavoro e provoca
disoccupazione, così l’allocazione del lavoro risulta inefficiente
e iniqua. Tesi opposta viene sostenuta da coloro che invece
sostengono che i sindacati siano un bene per l’economia, che
vuole che l’opera del sindacato sia vista come antidoto al
potere di mercato delle imprese che assumono lavoratori.
- TEORIA DEL SALARIO DI EFFICIENZA: Secondo tale teoria le
imprese operano con maggiore efficienza se le retribuzioni
sono maggiori del livello di equilibrio. La novità introdotta dal
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
salario di efficienza è che corrispondere retribuzioni più
elevate potrebbe essere redditizio per l’impresa stessa, dal
momento che potrebbe aumentare la produttività del lavoro.
Sono prevalentemente 4 le ragioni per cui le imprese possano
avvantaggiarsi pagando salari superiori al livello di equilibrio:
1)La salute dei lavoratori; i lavoratori meglio pagati hanno un regime
alimentare migliore e chi mangia meglio è più sano e produttivo.
2)Il turnover dei lavoratori; i lavoratori lasciano il posto per qualsiasi
ragione e la frequenza delle dimissioni dipende dall’intero sistema
cui i lavoratori stessi sono esposti, perciò quanto più un’impresa
paga i lavoratori, tanto meno essi decidono di lasciare il lavoro.
3)L’impegno dei lavoratori; tendenzialmente i lavoratori possono
decidere quanto impegnarsi per svolgere la mansione loro
assegnata. Di conseguenza l’impresa verifica l’impegno dei lavoratori
e quelli che si sottraggono alle proprie responsabilità possono essere
puniti o licenziati. E un’impresa può tentare di risolvere questo
problema pagando salari più elevati, in modo tale che i lavoratori
abbiano un incentivo più forte a conservare la propria occupazione e
impegnarsi perciò al meglio delle proprie capacità.
4)La qualità dei lavoratori; pagando un salario elevato le imprese
attraggono un miglior bacino di potenziali dipendenti.
COSTO DELLA DISOCCUPAZIONE
La disoccupazione impone costi che gravano sugli individui e sulle loro
famiglie, così come sul governo, sui contribuenti ecc.
Uno dei costi più ovvi associati alla disoccupazione è la perdita di reddito:
l’individuo tendenzialmente si trova a dover ridurre le spese in beni
voluttuari e questo ha chiaramente un effetto anche sulla società. La
disoccupazione può inoltre comportare gravi problemi psicologici per
l’individuo e una conseguente perdita di autostima che non in rari casi lo
conducono a fare sempre maggior abuso di alcolici e sostanze
stupefacenti per evadere dalla propria condizione. Tra l’altro, c’è anche da
aggiungere che le famiglie con membri disoccupati si disgregano con più
facilità.
Il costo-opportunità di un disoccupato è il valore di beni e servizi che
avrebbe potuto produrre. Questa ‘produzione mancata’ riduce anche il
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
tenore di vita della società nel suo complesso. I disoccupati hanno un
reddito basso, limitato spesso alla sola indennità corrisposta dallo stato, di
conseguenza l’ammontare delle imposte versate allo stato da questi
individui si riduce. Dunque, tanto più il tasso di disoccupazione è elevato,
tanto più ingente è l’effetto negativo sul gettito fiscale.
CAP. XXIV
RISPARMIO, INVESTIMENTO E SISTEMA FINANZIARIO
Il sistema finanziario si configura come un gruppo di istituzioni che
operano nell’economia al fine di incanalare il risparmio di un soggetto
verso l’investimento di un altro. Risparmio e investimento sono due
concetti fondamentali della crescita economica, infatti risparmiando una
quota rilevante del PIL, un paese rende disponibili più risorse per
l’investimento in beni capitali, l’aumento del capitale fa a sua volta
aumentare la produttività e il tenore di vita. Di base, il sistema finanziario
trasferisce le risorse scarse dell’economia dai risparmiatori, cioè da coloro
che spendono meno di quanto guadagnano, ai prenditori, cioè a coloro
che spendono più di quanto guadagnano. I risparmiatori offrono denaro al
sistema finanziario, aspettandosi di vederselo restituire con gli interessi; i
prenditori invece domandano denaro al sistema finanziario sapendo che
saranno tenuti a restituirlo con gli interessi in una data futura. Le
istituzioni finanziarie possono essere raggruppate in due categorie:
mercati finanziari e intermediari finanziari.
MERCATI FINANZIARI
Sono le istituzioni attraverso le quali un soggetto che risparmia può
finanziare direttamente un soggetto che si vuole indebitare. I due mercati
finanziari più importanti sono:
1)mercato obbligazionario
2)mercato azionario
MERCATO OBBLIGAZIONARIO
Partendo dall’esposizione del concetto di obbligazione, un’obbligazione è
un titolo di debito contratto dall’emittente che specifica gli obblighi del
debitore verso il creditore e stabilisce il momento nel quale il prestito
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
verrà rimborsato e il tasso di interesse che verrà periodicamente
corrisposto prima della scadenza. Nel sistema finanziario circolano milioni
di obbligazioni differenti, ma nonostante ciò i titoli obbligazionari
presentano tutti 3 caratteristiche fondamentali:
1)la durata; ovvero il tempo che intercorre tra l’emissione e la scadenza
del titolo. Molte obbligazioni hanno una durata breve, mentre altre più
lunga. Il tasso di interesse corrisposto da un’obbligazione dipende in parte
dalla durata, le obbligazioni a lungo termine sono più rischiose di quelle a
breve scadenza perché i sottoscrittori delle prime devono attendere più a
lungo per vedersi restituire il capitale, e se il titolare di un’obbligazione a
lungo termine si trova nella necessità di rientrare in possesso del proprio
denaro in anticipo, non ha altra scelta che venderlo, rischiando anche di
vedersi corrispondere una cifra inferiore a quella prevista.
2)il rischio di credito; ovvero la probabilità che il debitore non onori gli
impegni presi. Tale insolvenza, in economia prende il nome di ‘default’. Un
punto importante da prendere in considerazione è la relazione tra prezzo
di un’obbligazione e il suo rendimento. ESEMPIO: se un’impresa emette
un’obbligazione da 1000 euro con durata di 10 anni e una cedola del 3,5%
e l’impresa paga nel corso dei 10 anni all’acquirente dell’obbligazione un
interesse di 35 euro all’anno e alla data di scadenza dei 10 anni gli
restituisce i 1000 euro; in qualunque momento durante il periodo dei 10
anni l’acquirente può vendere l’obbligazione sul mercato e il prezzo che
ottiene dipende dalla domanda e dall’offerta di quelle obbligazioni nel
mercato. Il rendimento di un’obbligazione è dato da CEDOLA/PREZZO X
100, in cui il prezzo è riportato in percentuale del principale. I prezzi delle
obbligazioni sono influenzati dalle obbligazioni già presenti nel mercato,
dall’emissione di nuove obbligazioni, dal rischio di default associato
all’emittente ecc.
MERCATO AZIONARIO
Anche qui diamo una prima esposizione generale del significato di
‘azione’. Per azione si intende un titolo di proprietà dell’impresa che
costituisce un diritto sui profitti che questa stessa realizza. La vendita di
azioni per raccogliere fondi è denominata ‘finanziamento con capitale di
rischio’, mentre l’emissione di obbligazioni viene detta ‘finanziamento con
capitale di debito’. Le azioni emesse e vendute da una società possono
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
essere liberamente scambiate in un mercato organizzato, ma la società
emittente non trae alcun beneficio diretto dalla compravendita dei propri
titoli. I prezzi ai quali le azioni vengono scambiate nel mercato sono
determinate dall’interazione di domanda e offerta. Per tenere sotto
controllo l’andamento dei mercati azionari, i risparmiatori hanno a
disposizione i cosiddetti ‘indici azionari’. Un indice azionario viene
calcolato come valore medio delle quotazioni di un gruppo di titoli. Tale
indice è attualmente basato sui corsi azionari delle 30 maggiori società
statunitensi.
INTERMEDIARI FINANZIARI
Sono istituzioni finanziarie attraverso cui i risparmiatori possono fornire
fondi ai prenditori indirettamente. Il termine ‘intermediario’ indica per
l’appunto il ruolo di tali istituzioni che si collocano tra il risparmio e
l’investimento.
- BANCHE: Le banche sono l’intermediario finanziario con il
quale gli individui hanno maggior famigliarità. Una delle
funzioni primarie della banca è raccogliere il risparmio di chi
spende meno di quanto guadagna e impiegarlo per fare prestiti
a chi ha la necessità di indebitarsi. Le banche hanno inoltre la
funzione di facilitare lo scambio di beni e servizi, permettendo
agli individui di emettere assegni a fronte dei propri depositi, o
di usare una carta di debito per trasferire denaro dal proprio
conto a quello della persona da cui acquista beni o servizi.
- FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO: Anche questi sono
intermediari finanziari che stanno col tempo acquistando
un’importanza sempre maggiore. Trattasi di istituzioni che
vendono proprie quote di partecipazione al pubblico e con il
ricavato acquistano una selezione di titoli azionari,
obbligazionari. Il sottoscrittore della quota di fondo comune di
investimento accetta implicitamente il rischio e il rendimento
associati al portafoglio scelto. Il rischio si fa meno importante
se un portafoglio contiene azioni o obbligazioni di diversi
emittenti, perché le sorti di una singola impresa possono
influire solo limitatamente sul suo valore complessivo. I fondi
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
comuni di investimento possono essere di due tipi: chiusi o
aperti. La differenza fondamentale sta nel fatto che
l’investimento in un fondo aperto dà luogo all’emissione di
nuove quote o azioni del fondo, mentre l’unico modo di
investire in un fondo chiuso è quello di acquistare quote o
azioni esistenti.
- CREDIT DI DEFAULT SWAP (CDS): I CDS sono uno strumento a
disposizione dei detentori di obbligazioni per assicurarsi contro
il rischio di insolvenza di un emittente. Ogni obbligazione
emessa contiene un rischio implicito: nel caso delle
obbligazioni garantite da portafogli di mutui ipotecari, il rischio
è che il sottoscrittore di un mutuo possa risultare
inadempiente. ESEMPIO: se una banca ha acquistato
un’obbligazione garantita da attività finanziarie per un valore di
5 milioni di euro, l’obbligazione avrà di conseguenza un
capitale di 5 milioni di euro. La cedola, cioè l’interesse sulle
obbligazioni, è pari al 10%. Se tutti i mutuatari onorano i propri
impegni e rimborsano l’intero prestito, la banca guadagna un
interesse per tutto il periodo in cui rimane in possesso
dell’obbligazione (nel caso di un’obbligazione decennale con
una cedola del 10%, l’obbligazionista ottiene un rendimento
del 10% all’anno per 10 anni). L’obbligazionista può rivolgersi a
una società di assicurazione e stipulare una polizza contro il
rischio di insolvenza, e la banca che desidera assicurare il
rischio è detta ‘acquirente di protezione’, mentre la
controparte ‘venditore di protezione’. La polizza prevede che in
caso di inadempienza dell’emittente dell’obbligazione,
l’obbligazionista rientri in possesso della somma
originariamente investita. Se l’emittente dell’obbligazione si
rende inadempiente, si ha un CREDIT EVENT che innesca un
pagamento. Quando si verifica questo evento di credito, il
contratto di assicurazione può essere onorato in due modi: il
primo è quello in cui l’acquirente di protezione cede
l’obbligazione al venditore, che gli corrisponde il valore facciale
del titolo. Il mercato dei CDS è poi cresciuto e i CDS sono stati
utilizzati con fini speculativi. Col crescere del mercato dei CDS,
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
il numero dei contratti di assicurazione ha finito per superare il
numero di obbligazioni su cui erano basati. Questo significava
che qualcuno poteva essere acquirente di protezione per un
titolo che non possedeva materialmente e i venditori di
protezione di conseguenza hanno iniziato a liquidare il dovuto
agli acquirenti mediante il regolamento per contanti. Il
contratto di CDS stabilisce anche che il venditore di protezione
debba fornire una qualche forma di garanzia collaterale a
copertura dell’esposizione al rischio di inadempienza. E
l’importo della garanzia collaterale dipende dal valore di
mercato dell’obbligazione e del rating del venditore di
protezione.
- CDO – COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION: Sono titoli
garantiti da attività il cui valore dipende da quello delle attività
sottostanti e dal flusso di reddito che esse generano.
FUNZIONAMENTO DELLE CDO: un gestore che vuole creare
una CDO incoraggia gli investitori ad acquistare le obbligazioni
e i fondi così raccolti vengono impiegati per comprare un
portafoglio di crediti. Tale portafoglio di crediti viene suddiviso
in tranche, delle quali viene valutato il grado di rischio. Le
tranche a basso rischio corrispondono un tasso di interesse più
contenuto, quelle ad alto rischio un tasso di interesse più
elevato. In caso di inadempienza, le tranche più rischiose
potrebbero non essere pagate e questo è il rischio che si
assumono gli acquirenti di tali tranche. I problemi veri e propri
per le CDO però sorgono quando si è registrato un aumento
dei casi di inadempienza sui mutui ‘subprime’. Il MERCATO
SUBPRIME offriva l’opportunità di accedere a un mutuo
ipotecario a soggetti che non tradizionalmente non erano presi
in considerazione dagli intermediari finanziari a causa del forte
rischio di credito. I soggetti considerati a basso rischio di
credito per l’erogazione di mutui ipotecari costituivano il
PRIME MARKET, o mercato dei mutuatari di prim’ordine. Ne
consegue che esisteva un mercato subprime, formato da
soggetti che avevano maggiori difficoltà ad accedere a un
mutuo ipotecario.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
RISPARMIO E INVESTIMENTO NELLA CONTABILITA’ NAZIONALE
Le istituzioni che compongono il sistema hanno la funzione di coordinare
il risparmio e l’investimento del sistema economico. Ora, le regole su cui si
fonda la contabilità nazionale includono importanti identità: l’identità è
un’espressione algebrica necessariamente vera. Le identità sono utili
perché consentono di chiarire come le diverse variabili sono in relazione
le une con le altre. Una tra le identità più importanti è sicuramente: Y = C
+ I + G + NX ogni euro di spesa, computato nella parte sinistra
dell’equazione, è sicuramente incluso anche in una delle quattro
componenti della parte destra. Ancora Y = C + I + G è un’affermazione
necessariamente vera in quanto in un’economia chiusa il PIL è uguale alla
somma di consumo, investimento e spesa pubblica. Ma questa equazione
ci rivela anche qualcosa in più circa i mercati finanziari. Infatti sottraendo
da entrambi i membri C e G si ottiene che Y – C – G = (C – G) + I + (G – G)
Y- C – G = I in cui il membro sinistro dell’identità (Y – C – G) è il reddito
totale dell’economia che rimane dopo aver sottratto consumo e spesa
pubblica. Questo ammontare corrisponde al risparmio (S). Per cui, con
una semplice sostituzione, si può scrivere: S = I e questa espressione
stabilisce che il risparmio è necessariamente uguale all’investimento.
Possiamo comunque adottare due definizioni del risparmio:
1)S = Y – C – G
2)S = (Y – T – C) + (T - G)
Le due equazioni sono esattamente identiche, ma la seconda permette di
scindere in particolare il risparmio in due componenti: risparmio privato
(Y – T – C) e risparmio pubblico (T – G). Il risparmio privato è il reddito
degli individui che rimane una volta pagate i consumi e le imposte. Il
risparmio pubblico è la differenza tra le entrate tributarie e la spesa
pubblica.
MERCATO DEI FONDI MUTUABILI
E’ un mercato al quale partecipano tutti i risparmiatori per impiegare i
propri risparmi, e tutti i prenditori per ottenere prestiti. Il termine ‘fondi
mutuabili’ si riferisce alla parte di reddito che gli individui scelgono di
risparmiare e offrire in prestito invece di utilizzarla per il consumo. Il
mercato dei fondi mutuabili è governato dalla domanda e dall’offerta.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
L’offerta di fondi mutuabili proviene da chi ha un reddito eccedente le
proprie necessità di consumo. I prestiti possono essere diretti o indiretti.
La domanda di fondi mutuabili proviene da imprese e individui che
desiderano farsi finanziare un investimento e comprende gli individui che
accendono un mutuo ipotecario per l’acquisto di un’abitazione e le
imprese che finanziano l’acquisto di nuove attrezzature o strutture
produttive indebitandosi. Il tasso di interesse è il prezzo dei prestiti.
(GRAFICO 485) – Tasso di interesse per il quale la quantità domandata e la
quantità offerta di fondi mutuabili coincidono. L’offerta di fondi mutuabili
dipende dal risparmio nazionale, la domanda proviene invece dalle
imprese e dagli individui che vogliono indebitarsi per finanziare i propri
investimenti. E’ inoltre possibile ricorrere ad un’analisi dei fondi mutuabili
per stabilire l’effetto di diversi provvedimenti di politica economica su
risparmio e investimento.
- INCENTIVI AL RISPARMIO: Molti economisti utilizzano il
principio secondo cui gli individui rispondono agli incentivi per
ipotizzare che il saggio di risparmio in alcuni paesi sia molto
basso perché la normativa tributaria scoraggia i risparmiatori. I
governi raccolgono entrate tassando il reddito, incluso quello
da interessi da dividendi, e per stabilire quale sia l’effetto di
tale sistema impositivo si può ad esempio considerare un
25enne che con 1000 euro di risparmi acquisti un’obbligazione
30ennale al 9%. In assenza di imposte, al compimento di 55
anni, i suoi 1000 euro diventerebbero 13mila e268, ma con
un’imposta del 33%, il tasso di interesse ammonterebbe solo al
6% e i 1000 euro dopo 30 anni sarebbero poco più di 5 mila.
Per risolvere questo problema molti economisti hanno valutato
l’idea di sostituire l’attuale imposta sui redditi con un’imposta
sui consumi. Così, il reddito risparmiato non viene tassato se
non nel momento in cui viene speso e questo tipo di tributo è
molto simile all’IVA, che grava su molti beni nei paesi europei.
Tuttavia, l’IVA è un’imposta indiretta prelevata su un bene al
momento dell’acquisto da parte di un consumatore finale,
mentre un’imposta sui consumi potrebbe anche essere
un’imposta diretta prelevata direttamente sull’individuo.
Un’altra proposta è quella di favorire l’accesso ai piani di
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
risparmio a regime fiscale agevolato, che permettono agli
individui di proteggere una parte del proprio risparmio
dall’imposizione fiscale.
- INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO: Ora, se il parlamento concede
sgravi fiscali a tutte le imprese che costituiscono un nuovo
impianto produttivo, consideriamo l’effetto di tale
provvedimento sul mercato dei fondi mutuabili (GRAFICO 487):
se l’approvazione di un credito di imposta sull’investimento
stimola le imprese a investire di più, la domanda di fondi
mutuabili aumenta; perciò il tasso di interesse di equilibrio
aumenta, incentivando il risparmio.
- AVANZI E DISAVANZI DEL BILANCIO PUBBLICO: Se la spesa
pubblica supera le entrate tributarie, si genere un disavanzo di
bilancio e l’accumulazione di deficit nel tempo va ad
aumentare il debito pubblico. Quando spesa pubblica ed
entrate tributarie sono identiche si ha un bilancio in pareggio.
Ora, se un governo si trova nella necessità di gestire un
disavanzo. Un disavanzo di bilancio rappresenta una variazione
del risparmio pubblico e perciò dell’offerta di fondi mutuabili.
Ma, nel momento in cui il disavanzo di bilancio non condiziona
direttamente la quantità di fondi mutuabili che gli individui
domandano per finanziare i propri investimenti, la curva di
domanda non subisce alcuna variazione. Se il bilancio è in
disavanzo, il risparmio pubblico è negativo e il risparmio
nazionale diminuisce di conseguenza.
CAP. XXVII
IL SISTEMA MONETARIO
Nell’ambito del sistema economico la moneta ha 3 funzioni:
1)mezzo di scambio
2)unità di conto
3)riserva di valore
MEZZO DI SCAMBIO: E’ ciò che i venditori sono disposti ad accettare
in cambio di un bene o servizio, e il trasferimento di denaro è ciò che
rende possibile lo scambio.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
UNITA’ DI CONTO: E’ un parametro rispetto al quale si determinano i
prezzi e si valutano i debiti.
RISERVA DI VALORE: E’ ciò che gli individui possono utilizzare per
trasferire potere d’acquisto dal presente al futuro.
Si parla inoltre di LIQUIDITA’ per indicare la facilità con la quale un valore
patrimoniale può essere convertito nel mezzo di scambio dell’economia.
La moneta è il valore patrimoniale più liquido, ma se i prezzi aumentano, il
potere di acquisto della moneta diminuisce. La moneta può assumere la
forma di valore intrinseco, e in tal caso si parla di MONETA-MERCE. Il
valore intrinseco è il valore del bene in sé, a prescindere dal fatto che
venga utilizzato come moneta. Un esempio di moneta-merce è l’oro.
Quando un sistema economico utilizza l’oro come moneta si dice che
operi in ‘regime aureo’, o GOLD STANDARD. La moneta priva di valore
intrinseco è invece detta MONETA A CORSO LEGALE, o MONETA-FIAT. La
quantità di moneta che circola in un sistema economico è invece detta
STOCK DI MONETA e ha una forte influenza su molte variabili economiche.
Ora per stabilire cosa si intenda esattamente per moneta dobbiamo
valutare alcuni dettagli: la prima cosa da prendere in considerazione è il
CIRCOLANTE, le banconote e le monete metalliche nelle mani del
pubblico. Il circolante è il mezzo di scambio più diffusamente accettato
nell’economia e senza alcun dubbio entra a far parte dello stock di
moneta. Ma il denaro contante non è l’unico strumento che si può
utilizzare per acquistare beni o servizi. Sono infatti accettati anche
pagamenti con carte di debito, che consentono il trasferimento
elettronico di somme di denaro dal conto corrente di chi acquista a quello
di chi vende. Non si può tuttavia affermare che una carta di debito o un
assegno costituiscano di per sé moneta. Infatti è il conto corrente a cui
attingono la carta di debito o l’assegno che contiene la moneta; la carta di
debito o l’assegno sono solo mezzi per trasferire denaro da un conto
bancario ad un altro. Nel caso di carta di debito o assegno il denaro viene
trasferito dal conto dell’avventore a quello del ristoratore più o meno
immediatamente o con un breve ritardo. Nel caso della carta di credito, il
ristoratore si vede accreditare quasi immediatamente la somma sul conto
e l’avventore deve poi regolare la transazione con la banca che emette la
carta di credito, attingendo al proprio conto corrente. Una misura dello
stock di moneta deve inoltre comprendere i DEPOSITI A VISTA, ovvero i
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
saldi dei depositi bancari liberamente e immediatamente disponibili
usando una carta di debito o compilando un assegno.
RUOLO BANCHE CENTRALI
Quando un sistema economico adotta un sistema di moneta a corso legale
deve esistere anche un’istituzione incaricata di regolamentare il sistema.
Questo ruolo viene normalmente svolto dalla BANCA CENTRALE,
un’istituzione pensata per vigilare sul sistema bancario e regolamentare la
quantità di moneta nell’economia. La banca centrale ha il potere di
incrementare o ridurre la quantità di moneta nell’economia. L’insieme di
azioni intraprese dalla banca centrale per influenzare l’offerta di moneta è
detta POLITICA MONETARIA. La banca centrale ha a sua disposizione un
importante strumento, le operazioni di mercato aperto, ossia la
compravendita di attività finanziarie non monetarie con il settore
bancario. Ad esempio, la banca centrale può incrementare l’offerta
creando circolante e utilizzandolo per acquistare obbligazioni dal pubblico
nel mercato obbligazionario e a seguito dell’acquisto, il circolante rimane
nelle mani del pubblico. Viceversa, se vuole ridurre l’offerta di moneta, la
banca centrale può vendere al pubblico obbligazioni che detiene in
portafoglio. Dopo la vendita, il circolante ricevuto in contropartita dalle
obbligazioni non è più nelle mani del pubblico.
BANCHE E OFFERTA DI MONETA
Di seguito la prassi di come le banche influenzano l’offerta di moneta e di
come rendano più complicato per la banca centrale espletare la propria
funzione di controllo dell’offerta di moneta.
Per stabilire come le banche influenzino l’offerta di moneta si immagini un
mondo senza banche, nel quale il circolante è l’unica forma di moneta. Si
ipotizzi che la quantità totale di circolante sia 100 euro e che perciò
l’offerta di moneta sia di 100 euro. Si supponga ora che qualcuno apra una
banca dedita esclusivamente alla raccolta e al deposito, cioè che accetti
depositi ma non conceda prestiti. Ora, se qualcuno deposita denaro, la
banca lo chiude in una cassaforte e lo custodisce finché il depositante si
presenta a reclamarlo. I depositi che le banche raccolgono e non
impiegano sono detti RISERVE. In un’economia come quella appena
descritta, tutti i depositi vanno a riserva e tale sistema bancario è detto A
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
RISERVA TOTALE. Si prenda ora in considerazione l’offerta di moneta in
questa economia fittizia. Prima dell’apertura dell’unica banca l’offerta di
moneta è di 100 euro contanti, dopo l’apertura della banca, l’offerta di
moneta è costituita da 100 euro di depositi a vista detenuti dalla banca.
Ogni euro depositato in banca riduce la quantità di circolante e aumenta
quella dei depositi a vista, lasciando immutata l’offerta di moneta. Ora, se
il flusso di nuovi eventuali depositi è uguale a quello dei prelievi, quella
banca può trattenere a riserva solo una piccola frazione della raccolta e
adotta un sistema bancario A RISERVA FRAZIONARIA. La quota del totale
di depositi che la banca trattiene come riserve è detta TASSO DI RISERVA,
ed è determinato dalla regolamentazione bancaria e dalla strategia della
banca stessa. La BCE stabilisce il livello minimo di riserve che la banca
deve detenere, ossia le riserve obbligatorie. Ora, si supponga ancora che
quella unica banca abbia un tasso di riserva al 10%, questo significa che
trattiene a riserva il 10% di tutti i depositi e impiega la parte rimanente. La
banca ha ora due tipi di attività: 10 euro conservati in cassaforte e 90 euro
di crediti che le verranno restituiti nel futuro, e il passivo continua a
restare di 100 euro per cui attività e passività continuano ad eguagliarsi.
STRUMENTI DI CONTROLLO MONETARIO DELLA BANCA CENTRALE
La banca centrale dispone di 3 strumenti per gestire la moneta:
1)operazioni di mercato aperto
2)tasso di rifinanziamento
3)riserva obbligatoria
OPERAZIONI DI MERCATO APERTO
Se desidera aumentare l’offerta di moneta, la banca centrale crea
circolante e lo utilizza per acquistare titoli di stato dal pubblico nel
mercato obbligazionario. Dopo l’acquisto, il nuovo circolante è nelle mani
del pubblico, e l’acquisto di titoli di stato mediante un’operazione di
mercato aperto accresce l’offerta di moneta. Se invece desidera diminuire
l’offerta di moneta, la banca centrale può vendere al pubblico i titoli di
stato che detiene in portafoglio. Tali operazioni di mercato prendono il
nome di operazioni di mercato aperto definitive, perché ciascuna
comporta l’acquisto o la vendita definitive di attività non monetarie dal o
al settore bancario.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
TASSO DI RIFINANZIAMENTO
La banca centrale fissa un tasso di interesse al quale è disposta a erogare
prestiti a breve termine alle banche. Per erogare prestiti al settore
bancario, la banca centrale si avvale di una speciale forma di operazione
di mercato aperto. Così la banca centrale eroga un prestito e acquisisce
titoli di stato o altre attività come garanzia collaterale sul finanziamento.
La banca centrale stila un elenco delle attività che è disposta ad accettare
come collaterale; generalmente si tratta di attività sicure , come titoli di
stato o obbligazioni emesse da grandi imprese per le quali il rischio di
insolvenza dell’emittente è tendenzialmente trascurabile. Il tasso di
interesse applicato dalla banca centrale è detto TASSO DI
RIFINANZIAMENTO. E dato che la banca centrale acquista le attività a
condizione che chi le vende accetti di riacquistarle successivamente ad un
prezzo stabilito, questo tipo di operazione di mercato aperto prende il
nome di PRONTI CONTRO TERMINE, o REPO: trattasi di contratti con i
quali una banca vende alla banca centrale un’attività non monetaria
impegnandosi contestualmente a riacquistarla a un prezzo prestabilito e a
una data futura specificata.
CAP. XVIII
CRESCITA DELLA MONETA E INFLAZIONE
LA TEORIA CLASSICA DELL’INFLAZIONE
Per spiegare le determinanti di lungo periodo del livello dei prezzi e del
tasso di inflazione gli economisti ricorrono alla cosiddetta TEORIA
CLASSICA DELL’INFLAZIONE, elaborata nel XVIII secolo. Si supponga di
osservare un aumento del prezzo dei gelati da 0,10 cent a 1 euro: da una
parte è possibile che le persone gradiscano il gelato in maniera sempre
maggiore, dall’altra è possibile che l’aumento del prezzo sia il risultato di
una progressiva perdita di valore della moneta con la quale vengono
pagati i gelati. E proprio quest’ultima considerazione suggerisce una
direzione per formulare una teoria dell’inflazione. L’inflazione è un
fenomeno di portata sistematica che riguarda il valore del mezzo di
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
scambio in uso nell’economia. Il valore della moneta è determinato da
domanda e offerta.
OFFERTA DI MONETA E DOMANDA DI MONETA
Si consideri anzitutto l’OFFERTA DI MONETA: ora, se la banca centrale
vende titoli di stato con operazioni di mercato aperto provoca una
contrazione dell’offerta di moneta; se li acquista provoca un’espansione
dell’offerta di moneta. Il moltiplicatore monetario amplifica poi l’effetto
delle operazioni di mercato aperto sull’offerta di moneta. Parlando invece
della DOMANDA DI MONETA, la quantità domandata di moneta è
determinata da molte variabili. La quantità di moneta che gli individui
decidono di detenere dipende ad esempio dalla diffusione di carte di
credito o dal tasso di interesse che si può ottenere utilizzando fondi
disponibili per acquistare obbligazioni, anziché lasciarli depositati su un
conto corrente infruttifero ecc. Tra le variabili che determinano la
domanda di moneta ce n’è una che assume una posizione rilevante: il
livello medio dei prezzi nell’economia. Ora la quantità di moneta che gli
individui decidono di detenere per effettuare transazioni dipende dal
prezzo dei beni e dei servizi che decidono di acquistare: tanto più sono alti
i prezzi, tanto maggiore è la quantità di moneta che gli individui
detengono in forma di circolante. Perciò se il livello dei prezzi è elevato, la
quantità domandata di moneta è maggiore. Ciò che garantisce che la
quantità di moneta offerta dalla banca centrale sia uguale alla quantità
domandata dal pubblico dipende dall’orizzonte temporale considerato.
Nel lungo periodo invece la risposta è diversa, in quanto il livello generale
dei prezzi si aggiusta in modo da garantire l’uguaglianza tra quantità
domandata e quantità offerta di moneta.
EFFETTI DI INIEZIONE DA LIQUIDITA’
Si considerino ora gli effetti di un cambiamento della politica monetaria.
ESEMPIO: Si immagini che l’economia sia in equilibrio e che
improvvisamente la banca centrale decida di raddoppiare l’offerta di
moneta stampando una gran quantità di banconote e spargendole a caso.
Cosa accade a seguito di questa iniezione di liquidità? L’iniezione di
liquidità fa spostare verso destra la curva di offerta di moneta da OM1 a
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
OM2 (grafico 534) e l’equilibrio passa dal punto A al punto B. Di
conseguenza, il valore della moneta diminuisce da ½ a ¼ e il livello dei
prezzi di equilibrio aumenta da 2 a 4. Perciò se un aumento dell’offerta di
moneta ne rende disponibile una maggiore quantità, il livello generale dei
prezzi aumenta e il valore della moneta diminuisce. N accordo con la
TEORIA QUANTITATIVA DELLA MONETA, la quantità di moneta disponibile
nell’economia determina il livello dei prezzi e il tasso di crescita della
quantità di moneta disponibile determina il tasso di inflazione.
DICOTOMIA CLASSICA E LA NEUTRALITA’ DELLA MONETA
Rimane ora da capire come i cambiamenti monetari influenzano altre
variabili come produzione, occupazione, salari reali ecc. Hume e i suoi
contemporanei ipotizzano che tutte le variabili economiche possano
essere divise in due classi:
-variabili nominali
-variabili reali
Le prime sono misurate in unità monetaria, le seconde misurate in unità
fisiche. La suddivisione delle variabili economiche nelle due classi è detta
DICOTOMIA CLASSICA. L’applicazione della dicotomia classica è
particolarmente complessa quando si parla di prezzi. Tendenzialmente i
prezzi sono espressi in termini monetari e sono perciò variabili nominali.
La situazione si complica in presenza di prezzi relativi, ossia di prezzi di
qualcosa in termini di un’altra. Quando si confrontano i prezzi di due beni,
il numero risultante viene espresso in unità fisiche.
SALARIO REALE: se prezzo delle banane è 2 euro e salario è 10 euro
all’ora. 10 euro è il salario nominale espresso in termini monetari. Il
salario REALE è dato dal rapporto tra il salario nominale e il prezzo delle
banane. Cioè 10/2, dunque per poter acquistare 5 banane il consumatore
deve lavorare un’ora. Se il salario aumenta a 12 euro all’ora e il prezzo
delle banane aumenta a 3 euro, il consumatore è avvantaggiato o no? Il
salario reale sarebbe ora di 12/3, cioè 4 banane all’ora, dunque questa
nuova situazione danneggia il consumatore che ora può permettersi di
acquistare solo 4 banane. C’è da dire che le variazioni dell’offerta di
moneta condizionano le variabili nominali e non quelle reali. E questa
irrilevanza dei cambiamenti monetari per la determinazione delle variabili
reali è detta IPOTESI DI NEUTRALITA’ DELLA MONETA.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
VELOCITA’ MONETA E EQUAZIONE DI SCAMBIO
Si parla di velocità di circolazione della moneta in relazione al ritmo al
quale la moneta cambia di mano. Per calcolare la velocità della moneta si
divide il valore nominale del prodotto per la quantità di moneta. V = (P X
Y)/ M dove P è il livello dei prezzi, Y la quantità di prodotto e M la quantità
di moneta. L’equazione può anche essere scritta come M X V = P X Y per
cui la quantità di moneta moltiplicata per la sua velocità di circolazione è
uguale al livello dei prezzi per la quantità del prodotto. Si parla di
EQUAZIONE DI SCAMBIO perché mette in relazione la quantità di moneta
con il valore nominale del prodotto con il quale viene scambiata. Dunque
si può asserire che l’essenza della teoria quantitativa della moneta sia
rappresentata dai seguenti 5 passaggi:
1)velocità di circolazione della moneta relativamente costante nel
tempo
2)essendo la velocità stabile, quando la banca centrale modifica la
quantità di moneta provoca una variazione proporzionale del valore
nominale della produzione
3)quantità di beni e servizi prodotta nell’economia è determinata
dall’offerta di fattori di produzione e dalla tecnologia disponibile
4)se la produzione viene determinata dall’offerta dei fattori di
produzione le variazioni sono provocate da cambiamenti del livello
dei prezzi
5)quando la anca centrale aumenta l’offerta di moneta in maniera
rapida, la conseguenza è un elevato tasso di inflazione
IMPOSTA DI INFLAZIONE
Trattasi di entrate che lo stato ricava attraverso la creazione di moneta.
L’importanza dell’imposta di inflazione varia da paese a paese. L’inflazione
si placa quando il governo introduce una riforma fiscale che elimina la
necessità dell’imposta da inflazione. Inoltre, secondo il principio di
neutralità della moneta, un aumento del tasso di crescita della quantità di
moneta provoca un’accelerazione dell’inflazione ma non influenza le
variabili reali. Tale principio riguarda l’effetto della moneta sul tasso di
interesse. I tassi di interesse sono variabili importanti che creano un
collegamento tra economia attuale e quella futura. Si deve però prima
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
fare una precisazione: il tasso di interesse nominale è quello al quale ci si
riferisce normalmente nella maggior parte delle transazioni finanziarie. Il
tasso di interesse reale corregge invece quello nominale, depurandolo
dagli effetti dell’inflazione e rivela di quanto aumenta il potere d’acquisto
della moneta. Il tasso di interesse reale è uguale alla differenza tasso di
interesse nominale e tasso di inflazione. L’adattamento del tasso di
interesse nominale al tasso di inflazione è detto effetto FLASHER, e si
definisce appunto come relazione diretta e unitaria tra tasso di inflazione
e tasso di interesse nominale. (GRAFICO 539)
Si parla inoltre di COSTO DELLE SUOLE in relazione alle risorse sprecate
quando l’inflazione incentiva gli individui a ridurre la quantità di moneta
detenuta in forma direttamente liquida. Trattasi di un costo di transazione,
cioè un costo-opportunità di recarsi in banca più spesso di quanto sarebbe
desiderabile. La maggior parte delle imprese aggiorna inoltre
quotidianamente il costo dei suoi prodotti. Questo accade perché
cambiare i prezzi comporta un cost, e il costo di modificare i prezzi è detto
COSTO DI LISTINO. Il costo dei listini comprende i costi sostenuti per
determinare il nuovo livello dei prezzi, per stampare nuovi listini e nuovi
cataloghi ecc. L’inflazione accresce il costo dei listini sopportato dalle
imprese. Ora, supponiamo che a gennaio una trattoria stampi un nuovo
menu con nuovi prezzi e che lasci tali prezzi inalterati per tutto l’anno. In
assenza di inflazione i prezzi rimarrebbero costanti per tutto l’anno, ma se
l’inflazione fosse del 12% all’anno, i prezzi relativi della trattoria
diminuirebbero automaticamente dell’1% al mese, e quanto è maggiore il
tasso di inflazione, tanto è maggiore questa variazione automatica. E
quando l’inflazione distorce i prezzi relativi, le decisioni dei consumatori
ne vengono influenzate e i mercati non sono più in grado di allocare le
risorse in maniera efficiente.
Molte imposte diventano inoltre ancora più problematiche in presenza di
inflazione, dato che l’inflazione tende ad aggravare l’onere fiscale sui
redditi derivanti dal risparmio. Un esempio di come l’inflazione scoraggia
il risparmio è l’imposta sulle plusvalenze, cioè sul profitto che il
risparmiatore realizza vendendo un’attività patrimoniale a un prezzo
maggiore di quello di acquisto.
CAP. XXXII
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
L’ECONOMIA KEYNESIANA E IL MODELLO IS-LM
LA CROCE KEYNESIANA
Una prima definizione da dare è quella di ‘piena occupazione’ con la quale
si intende una condizione in cui tutti gli individui che desiderano lavorare
al salario di mercato corrente sono in grado di trovare un impiego. Un
elemento fondamentale dell’analisi keynesiana è la distinzione tra
DECISIONI PROGRAMMATE e DECISIONI EFFETTIVE di famiglie e imprese.
Per SPESA, RISPARMIO O INVESTIMENTO PROGRAMMATI si intendono le
azioni che le famiglie e le imprese desiderano o intendono intraprendere.
Per SPESA, RISPARMIO O INVESTIMENTO EFFETTIVI si intendono gli esiti
realizzati. Ora, secondo Keynes non vi era motivo per cui il reddito
nazionale di equilibrio dovesse coincidere necessariamente con il
prodotto della piena occupazione. I prezzi e i salari potrebbero non
aggiustarsi nel breve periodo e quindi l’economia potrebbe trovarsi in una
congiuntura in cui il livello della domanda non è sufficiente a garantire la
piena occupazione.
EQULIBRIO DI UN SISTEMA ECONOMICO
Il prodotto interno lordo di un paese è suddiviso in SPESA PER CONSUMO,
SPESA PER INVESTIMENTO, SPESA PUBBLICA ED ESPORTAZIONI NETTE.
Ora si ipotizzi che in un sistema economico la spesa totale, data da C + I +
G + NX, sia pari al reddito nazionale GRAFICO 595 La retta C + I + G +
NX è una funzione di reddito, per cui la spesa dipende dal reddito. Se il
reddito aumenta, anche la spesa aumenta e la retta ha pendenza positiva.
La spesa autonoma è rappresentata graficamente dall’intercetta verticale
E0 ed è la parte di spesa che non dipende dal reddito/prodotto.
Nell’equilibrio di breve periodo, la spesa effettiva è uguale alla spesa
programmata. L’economia è in equilibrio nel punto in cui la retta C + I + G
+ NX interseca la semiretta a 45 ° e le due rette intersecate formano la
croce keynesiana. Si parla inoltre di GAP RECESSIVO per la differenza che
intercorre tra il prodotto di pieno impiego e la spesa necessaria per
conseguirlo. Si parla invece di GAP INFLAZIONISTICO per spiegare la
differenza che intercorre tra il prodotto di pieno impiego e la spesa
effettiva quando quest’ultima è maggiore del prodotto di pieno impiego.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
EFFETTO MOLTIPLICATORE
La retta C + I + G + NX è denominata FUNZIONE DI SPESA. La spesa
programmata E dipende dalla somma di consumo, investimento, spesa
pubblica ed esportazioni nette, per cui E = C + I + G + NX La pendenza
positiva della funzione di spesa è dovuta al fatto che la spesa
programmata aumenta all’aumentare del reddito. Si parla di EFFETTI
MOLTIPLICATORE per l’amplificazione degli effetti di una politica fiscale
espansiva sulla domanda aggregata, attraverso il successivo aumento del
reddito e della spesa per consumo. Questo effetto moltiplicatore si
manifesta in più fasi: se la spesa per consumo aumenta, le imprese che
producono beni di consumo utilizzano più manodopera e godono di
profitti più elevati.
LE CURVE IS E LM
La croce keynesiana delinea un quadro dell’economia nel breve periodo.
In equilibrio la spesa programmata è pari al reddito effettivo, ovvero E =. Y.
Questo equilibrio riguarda il mercato dei beni e dei servizi. Il mercato dei
beni e dei servizi e quello della moneta sono interconnessi e l’elemento di
giunzione è il tasso di interesse. Seguendo l’analisi keynesiana del mercato
dei beni e dei servizi e del mercato monetario, sorge una teoria che
descrive il collegamento tra i due mercati e mostra come analizzare la
politica sia fiscale che monetario, e questo apparato è noto come
‘modello IS-LM’. Le curve IS-LM descrivono l’equilibrio in due mercati e
insieme determinano l’equilibrio generale del sistema economico: si ha un
equilibrio economico generale nel punto in cui il mercato dei beni e dei
servizi e quello della moneta sono entrambi in equilibrio per un dato
livello del tasso di interesse e del reddito.
LA CURVA IS
La curva IS mostra la relazione tra il tasso di interesse e il livello di reddito
nel mercato dei beni.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
La curva IS esprime una relazione inversa tra tasso di interesse e reddito
nazionale: se il tasso di interesse diminuisce, il reddito nazionale
aumenta, e viceversa. L’aumento del reddito dipende dall’ampiezza della
variazione del tasso di interesse dall’entità del moltiplicatore. La pendenza
della curva IS è determinata dalla reattività del consumo e
dell’investimento a variazioni del tasso di interesse. Gli spostamenti della
curva IS sono provocati da variazioni della spesa autonoma. Ad esempio,
un aumento della spesa pubblica è indipendente da eventuali variazioni
del tasso di interesse. Un aumento della spesa autonoma si traduce in uno
spostamento verso destra della curva IS, per cui il taso di interesse
corrente è associato a un più elevato livello di reddito.
LA CURVA LM
La curva LM raccoglie i punti in cui il mercato della moneta è in equilibrio
data la combinazione di valori del tasso di interesse e del reddito
nazionale.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
La curva LM ha pendenza positiva: un aumento del reddito è associato a
un aumento del tasso di interesse. La curva LM può spostarsi se la banca
centrale espande o contrae l’offerta di moneta. Ipotizzando che il reddito
sia costante, un aumento dell’offerta di moneta provoca una flessione del
tasso di interesse e il raggiungimento di un nuovo equilibrio per un dato
livello di reddito. Ciò è associato ad uno spostamento della curva LM
verso il basso e a destra, a individuare una nuova combinazione di reddito
e tasso di interesse e in corrispondenza della quale il mercato monetario è
in equilibrio.
DOMANDA AGGREGATA E OFFERTA AGGREGATA
La curva di domanda aggregata indica la quantità totale di beni e servizi
domandati nell’economia a ogni dato livello generale di prezzi, e ha
pendenza negativa, questo può dipendere da tre fattori: una diminuzione
del livello generale dei prezzi provocherebbe un aumento della quantità
domandata di beni e servizi, per cui i consumatori si sentono più ricchi e
questo stimola la domanda di beni e servizi per il consumo, ancora la
diminuzione del tasso di interesse stimola la domanda di beni di
investimento e infine, il deprezzamento del tasso di interesse stimola la
domanda di esportazioni nette. E per tutte queste ragioni la curva di
domanda aggregata ha pendenza negativa.
SPOSTAMENTI DELLA CURVA DI DOMANDA AGGREGATA
1)SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DEL CONSUMO: Qualsiasi
evento che modifichi la quantità consumata ad ogni dato livello dei prezzi
provoca uno spostamento della curva di domanda aggregata. Una delle
variabili che produce questo effetto è il livello della tassazione.
2) SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DELL’INVESTIMENTO:
Qualunque evento che faccia variare la quantità di investimenti che le
imprese desiderano effettuare a ogni dato livello dei prezzi, provoca uno
spostamento della curva di domanda aggregata. Una variabile che può
condizionare l’investimento e anche la domanda aggregata è l’offerta di
moneta. Nel breve periodo un aumento dell’offerta di moneta fa
diminuire il tasso di interesse reale e la curva LM sposta verso destra. Il
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
costo dell’indebitamento diminuisce, stimolando la spesa per
investimento e provocando uno spostamento verso destra della curva di
domanda aggregata a ogni dato livello dei prezzi.
3)SPPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DELLA SPESA PUBBLICA:
Modificando la spesa pubblica, i responsabili delle politiche economiche
influenzano direttamente la posizione della curva di domanda aggregata.
4)SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DELLE ESPORTAZIONI NETTE:
Qualsiasi evento che faccia variare il volume delle esportazioni nette ad
ogni dato livello di prezzi provoca uno spostamento della curva di
domanda aggregata. Le esportazioni nette a volte variano perché la
speculazione internazionale provoca fluttuazioni del tasso di cambio.
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
CAP. XXXIII
DOMANDA AGGREGATA E OFFERTA AGGREGATA
LA CURVA DI DOMANDA AGGREGATA
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
La curva di domanda aggregata indica la quantità totale di beni e servizi
domandati nell’economia a ogni dato livello generale di prezzi, e ha
pendenza negativa, questo può dipendere da tre fattori: una diminuzione
del livello generale dei prezzi provocherebbe un aumento della quantità
domandata di beni e servizi, per cui i consumatori si sentono più ricchi e
questo stimola la domanda di beni e servizi per il consumo, ancora la
diminuzione del tasso di interesse stimola la domanda di beni di
investimento e infine, il deprezzamento del tasso di interesse stimola la
domanda di esportazioni nette. E per tutte queste ragioni la curva di
domanda aggregata ha pendenza negativa.
SPOSTAMENTI DELLA CURVA DI DOMANDA AGGREGATA
1)SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DEL CONSUMO: Qualsiasi
evento che modifichi la quantità consumata ad ogni dato livello dei prezzi
provoca uno spostamento della curva di domanda aggregata. Una delle
variabili che produce questo effetto è il livello della tassazione.
2) SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DELL’INVESTIMENTO:
Qualunque evento che faccia variare la quantità di investimenti che le
imprese desiderano effettuare a ogni dato livello dei prezzi, provoca uno
spostamento della curva di domanda aggregata. Una variabile che può
condizionare l’investimento e anche la domanda aggregata è l’offerta di
moneta. Nel breve periodo un aumento dell’offerta di moneta fa
diminuire il tasso di interesse reale e la curva LM sposta verso destra. Il
costo dell’indebitamento diminuisce, stimolando la spesa per
investimento e provocando uno spostamento verso destra della curva di
domanda aggregata a ogni dato livello dei prezzi.
3)SPPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DELLA SPESA PUBBLICA:
Modificando la spesa pubblica, i responsabili delle politiche economiche
influenzano direttamente la posizione della curva di domanda aggregata.
4)SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DELLE ESPORTAZIONI NETTE:
Qualsiasi evento che faccia variare il volume delle esportazioni nette ad
ogni dato livello di prezzi provoca uno spostamento della curva di
domanda aggregata. Le esportazioni nette a volte variano perché la
speculazione internazionale provoca fluttuazioni del tasso di cambio.
CURVA DI OFFERTA AGGREGATA
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Indica la quantità di beni e servizi che le imprese desiderano produrre e
vendere a ogni dato livello di prezzi. Diversamente dalla curva di domanda
aggregata che ha sempre pendenza negativa, la curva di offerta aggregata
dipende dall’orizzonte temporale considerato. Nel lungo periodo la curva
di offerta aggregata è verticale, cioè ha pendenza negativa, mentre nel
breve periodo ha pendenza positiva.
SPOSTAMENTI CURVA DI OFFERTA AGGREGATA
1)SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAIZONI DELLA FORZA LAVORO: Se
aumenta il flusso di immigrati verso un paese, dal momento che ci sono
più lavoratori disponibili, la quantità offerta di beni e servizi aumenta e di
conseguenza la curva di offerta aggregata di lungo periodo si sposta verso
destra; invece se molti lavoratori si spostano verso un altro paese, la curva
di offerta aggregata si sposta verso sinistra.
2)SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DELLO STOCK DI CAPITALE: Un
aumento dello stock di capitale di un sistema economico accresce la
produttività e perciò la quantità di beni e servizi offerta ad ogni dato
livello di prezzi. Di conseguenza la curva di offerta aggregata di lungo
periodo si sposta verso destra. Invece una diminuzione dello stock di
capitale riduce la produttività e la quantità offerta di beni e servizi,
provocando uno spostamento verso sinistra della curva di offerta
aggregata di lungo periodo.
3)SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DELLE RISORSE NATURALI: La
produzione di un sistema economico dipende dalle risorse naturali di cui
dispone, e in molti paesi alcune risorse naturali sono importate dall’estero
e una variazione della disponibilità di queste risorse può provocare
spostamenti della curva di offerta aggregata di lungo periodo.
4)SPOSTAMENTI CAUSATI DA VARIAZIONI DELLE CONOSCENZE
TECNOLOGICHE: Una delle ragioni principali dell’aumento della
produzione aggregata dei sistemi economici rispetto a una generazione
precedente è l’avanzamento delle conoscenze tecnologiche, compresi
anche tutti quegli eventi che non si verificano in ambito strettamente
tecnologico, ma hanno degli effetti analoghi a quelli di un avanzamento
della tecnologia.
PENDENZA CURVA DI OFFERTA AGGREGATA BREVE PERIODO
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Il fatto che nel breve periodo la curva di offerta aggregata abbia sempre
pendenza positiva è spiegabile tramite 3 teorie alternative:
1) VISCHIOSITA’ DEI SALARI: secondo questa teoria la curva di offerta
aggregata di breve periodo ha pendenza positiva perché i salari
nominali non si adeguano istantaneamente alle mutate condizioni
economiche, e sono cioè ‘vischiosi’.
2) VISCHIOSITA’ DEI PREZZI: questa teoria pone l’accento sulla
lentezza con cui i prezzi dei beni si aggiustano in reazione ai
cambiamenti della congiuntura economica. Questa lentezza in
parte si deve al fatto che per aggiustare i prezzi si sostiene un
costo, detto COSTO DEI LISTINI, e in conseguenza a tale costo, i
prezzi, come i salari, possono essere vischiosi nel breve periodo.
3) ERRORE DI PERCEZIONE: secondo questa teoria i produttori
possono essere temporaneamente fuorviati da variazioni del
livello generale dei prezzi, che li inducono a interpretare in
maniera scorretta quanto avviene nei mercati in cui operano. In
conseguenza all’errore di percezione nel breve periodo, i
produttori reagiscono a una variazione del livello generale dei
prezzi in modo da conferire alla curva di offerta aggregata una
pendenza positiva.
Tutte e tre le teorie giungono alla conclusione che la produzione devia dal
suo livello naturale quando il livello dei prezzi si discosta da quello atteso.
Questo concetto viene espresso con la seguente formula QUANTITA’ DI
PRODOTTO OFFERTA = TASSO NATURALE DI PRODUZIONE + a(LIVELLO DEI
PREZZI EFFETTIVO – LIVELLO DEI PREZZI ATTESO) in cui ‘a’ è una costante
che determina la reattività della produzione aggregata a variazioni
inattese del livello dei prezzi.
CAP. XXXIV
L’INFLUENZA DELLA POLITICA MONETARIA E FISCALE SULLA DOMANDA
AGGREGATA
TEORIA DELLA PREFERENZA PER LA LIQUIDITA’
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
Nella teoria generale Keynes ha sviluppato la teoria della preferenza per
la liquidità per spiegare quali fattori determinano il tasso di interesse
dell’economia. Questa teoria altro non è che l’applicazione del modello di
domanda e offerta: il tasso di interesse si aggiusta, in accorda con Keynes,
in modo da equilibrare l’offerta w la domanda di moneta.
OFFERTA DI MONETA
Il primo pilastro della teoria menzionata sopra è l’offerta di moneta.
L’offerta di moneta è controllata dalla banca centrale, che può alterare
l’offerta di moneta agendo sulla quantità di riserve detenute dal sistema
bancario attraverso la compravendita di titoli di stato in operazioni di
mercato aperto. Ora, se la banca centrale acquista titoli di stato, il denaro
speso per l’acquisto in genere entra nelle casse delle banche e incrementa
le riserve bancarie, se invece la banca centrale vende titoli di stato, il
denaro che incassa proviene spesso da depositi bancari e riduce le riserve
bancarie. Tali variazioni delle riserve bancarie modificano a loro volta la
capacità del sistema bancario di erogare prestiti, portando alla creazione o
distruzione della moneta.
DOMANDA DI MONETA
Il secondo pilastro della teoria menzionata sopra è la domanda di
moneta. Le determinanti della domanda di moneta sono svariate, ma
l’accento viene messo in particolar modo sul tasso di interesse, che è
considerato la variabile più importante in quanto rappresenta il costo –
opportunità del possesso di moneta. Un aumento del tasso di interesse fa
aumentare anche il costo – opportunità del possesso di denaro contante.
Gli individui hanno dunque un incentivo a ridurre i propri saldi monetari,
conferendo il denaro in depositi fruttiferi e facendo diminuire di
conseguenza la quantità di moneta domandata.
PENDENZA NEGATIVA DELLA CURVA DI DOMANDA AGGREGATA
Se il livello generale dei prezzi aumenta, in ogni transazione viene
scambiata una maggiore quantità di moneta e di conseguenza gli individui
decidono di detenere una porzione maggiore della propria ricchezza in
forma liquida. Ciò significa che un aumento del livello generale dei prezzi
provoca un aumento della quantità domandata di moneta ad ogni dato
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
lOMoARcPSD|3969374
livello del tasso di interesse. L’aumento della domanda di moneta
influenza l’equilibrio nel mercato della moneta: il tasso di interesse deve
aumentare in modo da riportare in equilibrio domanda e offerta di
moneta. L’aumento del tasso di interesse ha conseguenze anche sulla
quantità di beni e servizi complessivamente domandata. L’effetto del tasso
di interesse può essere riassunto in 3 passaggi:
1) Un aumento del livello generale dei prezzi fa aumentare la
domanda di moneta
2) L’accresciuta domanda di moneta fa aumentare il tasso di
interesse
3) L’aumento del tasso di interesse riduce la quantità domandata di
beni e servizi
Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- 5 ConectoresDocumento4 pagine5 ConectoresGiankrlo Cabrera CervantesNessuna valutazione finora
- Arsenale LibreDocumento66 pagineArsenale LibreMiguel TrindadeNessuna valutazione finora
- CWKWeb Cormach150000EDocumento729 pagineCWKWeb Cormach150000EWilliam da Silva MarquesNessuna valutazione finora
- Soluzioni Esercizi Codifica IfDocumento4 pagineSoluzioni Esercizi Codifica IfCinzia BocchiNessuna valutazione finora
- Catalogo AUTENTICO 2010Documento24 pagineCatalogo AUTENTICO 2010ABC CREAR ARQUITECTURANessuna valutazione finora
- Visual Basic Express 2010Documento43 pagineVisual Basic Express 2010nuvapatagoniaNessuna valutazione finora
- La Trincea Avanzata, Antonio SacconeDocumento14 pagineLa Trincea Avanzata, Antonio SacconeElvira PaganoNessuna valutazione finora