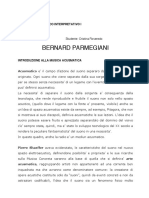Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Teoria Musicale - Andrea Cappellari 1
Teoria Musicale - Andrea Cappellari 1
Caricato da
Rufus Loacker100%(1)Il 100% ha trovato utile questo documento (1 voto)
557 visualizzazioni74 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
100%(1)Il 100% ha trovato utile questo documento (1 voto)
557 visualizzazioni74 pagineTeoria Musicale - Andrea Cappellari 1
Teoria Musicale - Andrea Cappellari 1
Caricato da
Rufus LoackerCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 74
Andrea Cappellari
Per i Licei musicali, per i corsi Pre-Accademici e le classi oll
BEM Recs RU Conservatori
CARISCH
Andrea Cappellari
-Teorio
musicole
Per i Licei musicali, per i corsi Pre-Accademici e le classi di
Teoria, ritmica e percezione musicale dei Conservatori
©
Carisch
perso Tne Mute Ses Group
London Now ork Pus! yng / Copengen Bein Mri / Hong Kon eyo
bblicato da
isch
15 Borers Street,
adon, WIT 3LJ, UK,
trbutori esclusiv:
Isic Sales Limited
aribution Centre, Newmarket Road,
ty St Edmunds, Suffolk IP33 3VB, UK.
sie Sales Corporation
3 Madison Avenue, 24th Floor,
w York NY 10016, USA,
Isic Sales Pty Limited
floor, Lisgar House, 80-92 Carrington Steet,
stney, NSW 2000, Australia
der No, MK19171
3N 9788850730508
tiproduzione non autorizzata di qualsiasi parte di questa
dblicazione con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia
tna violazione del dirito d'autore.
tura di Germano Dantone.
afica di Copertina: Promograph - Milano
impato in EU.
vvostra garanzia di qualita:
ime editor, ci sforziamo di produrre ogni libro con i pid elevati
Indard commercial
‘esto libro & stato accuratamente progettato per ridurre al minimo
mode vottate di pagina e far si che la lettura sia un vero piacere,
Ticolare cura é stata data alla carta che @ esente da acidi ed éa base
nescole che non sono state sbiancate col clo,
‘esta mescola viene ricavata da foreste sostenibili ed & pradotta con
‘ticolare riguardo por ambiente.
stampa e la filegatura sono eseguite accuratamente al fine di
‘antico un libro robusto, accativante e atraente che dara anni di
Adisfazioni.
la copia non soddista i nostri standard elevati, vi preghiamo di
marci e saremo liti di sostituiria,
‘sw.musicsales.com
‘wcarisch.com
dedicato al carissimo
Sig. CARLO TORRETTA
Prefazione
II presente volume offre un agile e facile percorso per apprendere i rudimenti della Teoria e per fornire
in modo semplice ma esauriente tutte le conoscenze teoriche necessarie a completare la formazione
musicale di chi intende avicinarsi alla pratica dell'arte della musica
Tutte le nozioni teoriche nella Musica vanno prima di tutto vissute nella pratica e poi apprese nella
teoria.
Solo sperimentando con gli allievi il trasporto allo strumento di una sempiice melodia in tutte le varie
possibili tonalita si potra far loro apprendere per esempio il Circolo delle Quinte.
Nel panorama editoriale questa materia & spesso trattata con una serie di informazioni storiografiche
@ musicologiche che possono allontanare \'allievo dal far musica e scoraggiarlo. Tutte queste nozioni
hanno una grande importanza ma possono essere apprese in un secondo momento, quando
\'attivita strumentale e musicale nel suo complesso sara gia sviluppata ed awiata,
Purtroppo molti autori non riescono ad esimersi dal desiderio di dar sfoggio della loro conoscenza
teorica della Musica, perdendo di vista il ioro compito di formare prima di tutto un Musicista e non un.
futuro Musicologo 0 uno Storico della Musica
Non @ incorso in questo pericolo l'autore di questo volume che ha deciso di affrontare tutti gli
elementi della teoria musicale in modo completo, con precisione e chiarezza ricorrendo anche
allutilizzo di tabelle e schemi riassuntivi presentati in modo semplice ma dettagliato ed esauriente
per favorire la rapida comprensione e memorizzazione da parte degli studenti
Per questi motivi questo nuovo trattato di teoria musicale é a mio avviso adatto a tutti gli allievi che si
awicinano alla musica, di qualunque tipologia esso sia, e pud validamente servire a formare i
musicisti del futuro: il bambino che sta imparando a suonare uno strumento, 'adolescente che ha
scoperto la sua passione, gli studenti dei Licei Musicali, gli allievi del Conservatorio, I'adulto che
vuole ritagliarsi uno spazio nella sua vita lavorativa e familiare da dedicare a questa disciplina cosi
affascinante, e persino coloro che, finita la loro attivita lavorativa, con i figli gia grandi e magari gid
sposati e a loro volta padri e madri, potranno riscoprire e alimentare la loro passione per la musica
Questa nuova pubblicazibne di Andrea Cappellari si aggiunge alla ampia raccolta di manuali di
"Teoria, Ritmica e Percazione Musicale” che da tempo utilizzo al Conservatorio di Milano con i miei
alunni dei corsi di Teoria, ritmica e percezione musicale perché scritti nel caratteristico stile
dell’autore, improntato con naturalezza e semplicita per awicinare piuttosto che per allontanare al
meraviglioso mondo musicale coloro che vogtiono intraprendere la nobile Arte della Musica.
Fabio Moretti
Coordinatore Disciplinare di Teoria, ritmica e percezione musicale
del Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi” di Milano
Istituto di Alta Cultura Musicale
Indice
Prefazione
Capitolo I
Pentagramma
Doppio pentagramma ..
Note musicali
Chiave
Tagli addizionali
Do centrale (Dos)
Sistema delle Ottave
Trasposizione di ottava
Setticlavio
Capitolo II
Note
Simboli di durata
Punto di valore ... muses
Doppio punto di valore .
Legatura di valore
Corona :
Grafia delle figure ..
Capitolo III
Battute .
Accent principal
Indicazione di tempo (retro)
Tempi semplici e tempi composti
Misure fondamentali
Misure per aumentazione
Misure per diminuzione ......
Indicazioni di tempo ..
Unité metriche
Pausa di intero ...
Accenti secondari
SIMCOE so ssseeeeeee
Contrattempo
Ritmi inizial
Rit finali
Misure miste
Accenti delle misure miste ;
Indicazione di tempo doppia e multipla
Multimettia . vs
Emiolia
Capitolo IV
Scala ; Meer
Intervalli
Intervalli giusti
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag
pag.
pag.
pag,
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag
pag
pag
pag.
pag
pag
pag
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
12
12
13
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
16
7
18
18
19
19
20
20
20
2
2
22
22
22
23
24
26
_ TEORIA MUSICALE
Aterazioni semplici (accident) pag. 26
Alterazioni isse, transitorie, precauzionali... pag. 26
Intervalli eccedenti e diminuiti pag. 26
Intervalli consonanti e dissonant... as sees Pag. 27
Intervalli melodici e armonici : : a pag. 27
Doppie alterazioni ........... : oe : pag. 27
Intervall pid. che eccedentie pid che diminuit : pag. 27
Intervalli compost ......... : seoeeiees os , pag. 27
Tavola riassuntiva degli intervalli pag. 27
Rivolto degli intervalli... pag. 28
Capitolo V
Sistemi di formazione delle scale Maggiori . pag. 29
Scale Maggiori ....... eheeeeeeny : : pag. 30
Ordine dei diesis ¢ dei bemoll pag. 31
Soale MINOT ....seccvsssseeeeesseesenie os cesceeeeeenennee pag. 32
Circolo delle quinte ... vocseeenees een pag. 34
Tonalita omologhe ...... ves ee pag. 34
Criteri per determinare la tonalita ........ pnenes . pag. 34
Tonalita vicine : pag. 35
Modulazione : ceseeeeeeenee PQQ. 36
Scala cromatica ...... : sess pag. 36
‘Suoni omologhi pag. 36
Scala di Bach =— (itstessbaesreasssisneeiesisisineersisnn POG. OF
Scala napoletana Siaceetors . pag. 37
Scala tzigana ee fect pag. 37
Scala enigmatica : pag. 37
Scala Maggiore naturale, armonica e melodica . pag. 38
Scala di Scriabin : pag. 38
Scala orientale ........0.0- pag. 38
Scala alternata (0 Octofonica) . ve ‘ pag. 39
Scala blues . pag. 39
Scala araba . soso cesttttttiisenimnn pag. 39
Soale Modal ............... f pag. 40
Scala pentatonica peo . pag. 41
Scala esatonale cess fi ae pag. 41
Capitolo VI
Trasporto . pag. 42
Come praticare il trasporto ... pease soon pag. 43
Trasporto un tono sopra ar pag. 44
Trasporto un tono sotto .........-- : So pag. 44
Strumenti traspositori . 7 . pag. 45
Tabella dei principali strumenti traspositori pag. 45
Capitolo VIL
Gruppi irregolari en costettittttisttninee .. pag. 48
Duina pag. 47
Terzina pag. 48
Quartina Pag. 49
Quintina ....
Sestina
Settimina ..
Gruppo di otto
Gruppo di nove .
Gruppo di undici e tredici
Gruppi irregolari in posizione asimmetrica ...
Gruppi irregolari in figurazioni complesse
Tavola riassuntiva del gruppi itregolari
Capitolo VII
Abbellimenti,
Acciaccatura:
Appoggiatura
Gruppetto
Trllo
Tremolo
Arpeggio
Mordente
Fioritura
Glissando ..
Capitolo IX
Abbreviazioni e segni convenzionali
Indicazioni dinamiche ...
Indicazioni di agogica
Indicazioni di articolazione .
Capitolo X
Triadi vs
Rivatto delle triad
Accordi di settima
Settima di dominante
Accordo di settima diminuita
Tavola riassuntiva delle specie di settima
Accordi di nona
Accordi di undicesima e tredicesima
Capitolo XT
Suono
Altezza
Intensita .......
Timbro
Suoni armonici
Battimenti
Vibrazione simpatica
Suono risultante
Risonanza (rimbombo)
Diapason .
Indice analitico ..
pag
pag
pag.
pag
pag
pag
pag.
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag.
pag
pag.
pag.
pag.
pag.
pag
Pag.
pag
pag
pag
pag
pag
pag,
pag
pag
pag
pag
pag,
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag
pag.
pag.
pag.
pag.
49
50
50
51
51
51
52
52
54
54
54
55
56
56
57
S7
57
58
59
59
59
66
TEORIA
MUSICALE
[EORIA MUSICALE
Capitolo I
PENTAGRAMMA
li Pentagramma™ (0 rigo musicale) & formato da 5 linee e 4 spazi.
Linee e spazi sono numerati dal basso verso lalto.
|I Doppio Pentagramma @ formato da due pentagrammi uniti tra loro da una parentesi gratfa e da una
linea verticale che li congiunge.
NOTE MUSICALI
Le note musicali sono sette: |Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si
3
Le note possono stare:
—
———
cule nee ig 8 See ere nsglspa Se a
See
La serie ascendente e discendente delle note si ottiene scrivendole in successione alternando
nelfordine nota sulla linea, nota nello spazio, nota sulla linea, nota nello spazio ecc.
p00: 3
wo ee 2 © SS
La posizione delle note sul pentagramma ne indica la diversa altezza.
11) Dal greco pente = cinque e gramma = Tinea
(2) sistema di notazione SILLABICO che identifica le note con luso di sillabe (do, re, mi, fa, sol, I) verne ideato da Guido Arezzo.
Guide a’arezzo (098-1050) utiizzb le prime sillabe dei sel verseti del! Inno a S. Giovanni ottenendo cos! Tesacorco ut, re, fa, SOI, fa
Ilsi venne introdotto successivamente (probabiimente ricavato dalle letiee inizial dele parole “Sancte loannes* che conciudono
inno).
£ = =
PSs =
[Gilqie-an ta as [Ref so-na-re f-brs
SS eS
Sol ve pol-w- 8 ubo-i ‘San
(racaione:Afinch fel possano cena a pina voce le te gests meravigloss, lima, 0 San Govan, og impure fv abba)
Noi 1600 la nota ut viene modticata in do (soo in Francia la nota do conserva il nome criginale ut)
Nei paesi ai lingua inglese © tedesca si utiiza i sistema ALFABETICO (0 “etlerale’) ne! quale le note vengono Indicate con letere
dolrafabeto: 2.6. d.e,f.g (a= La)
Nei paesi dl ingua tedesca:h = Sib mente b = Sik
a ‘TEORIA MUSICALE
MI CHIAVE
La Chiave ¢ il segno grafico utilizzato per fissare la posizione delle note sul pentagramma'”
@ @
CHIAVE di SOL 6 CHIAVE di FA CHIAVE di DO B
Chevedi SOL Chiave di VIOLINO. Indica che la nota posta sulla
seconda linea del pentagramma é il sol.
Chiave oi FA =E=S—— Chive aii BASSO. Indica che la nota posta sulla
quarta linea del pentagramma é il fa
Una volta fissata la posizione di una nota grazie alla chiave, considerato che le altre procedono per
“gradi congiunti" (cioé senza salti), sara possibile dare il nome alle altre note.
™ TAGLI ADDIZIONALI
Per poter scrivere la nota do si utiliza il "taglio addizionale”.
Bisogna immaginare che sotto la prima linea in chiave di violino e sopra la quinta in chiave di basso ce
ne sia un‘altra (appunto una “linea immaginaria’) a
Della linea immaginaria si utlizza solo un frammento (taglio addizionale) per scrivere il do
linea immaginaria
lined immaginaria
tagio addizionale
JH
— taglio addizionale
o 7 fa
do re mi fa sol ee
(GAnlicamente tre letiare alfabetiche erano usaie come chiavi: G, Ce F. La chiave disol deriva dalla lettera G, la chiave dido dalla
lettera Ce la chiave di fa dalla ltteraF.
(@) La Chiave ai FA pud anche trovarsi sulla Ga linea del Pentagrarnma tc pag 7,
@)La Chiave di DO pus trovarsi sulla ta linea, sulla 2a linea, sulla 3a linea, sulla 4a linea oppure sulla Sa linea dol Pentagrarna (oan *1)
() Questo di @ i cosiddetto do centrale (dos). La cia 3 posta al pedice del nome della nota & legata al crerio di numerazione dele
Ottave wedi 10,
Gs dog
<> <
dog ap
N1Do centrale @ la nota comune alle chiavi dl Vioino e di Basso.
TEORAMUSICALE
1 DO CENTRALE (D03)
lI dos (cosiddetto "do centrale’) & la nota comune alle chiavi di violino e di basso.
II do centrale @ preceduto verso il grave dal do, e seguito verso lacuto dal do
dos ottava do,
4 attava
do bs
Per poter scrivere il do; @il dos. si utilizzano due "tagli addizionali
Bisogna immaginare che sopra la prima linea immaginaria in chiave di violino e sotto la prima linea
immaginaria in chiave di basso ce ne sia un’alira
s-seeeee--~ nga immaginaria
linea immagnaria
inea immaginaria
tinea inmaginana
— taglio addizionale
= tagho addizionale
taglio addzionale
tagilo addzionale
do,
0s
| SISTEMA DELLE OTTAVE
La diversa altezza (registro) dei sette suoni genera il sistema delle ottave:
© —
| SE purse = =
oS ——S —
eof
$B, er ty 201 wy sh dagregmig aps ayy dorm ig fy 8 cyte ma Sag lal is egg ly oy ls
dio centile
| TRASPOSIZIONE DI OTTAVA
Per trasportare una ottava sopra 0 una ottava sotto si utilizzano queste indicazioni
Be-- > ottava alta gw. - ~~~ ottava bassa
gratia effetto
‘TEORIA MUSICALE,
MSETTICLAVIO
Nella notazione modema si utilizzano tre tipi di chiavi musical
- chiave di Sol (chiave di violino),
~ chiave di Fa (chiave di basso)
- chiave di Do.
La chiave di Sol @ posizionata esclusivamente sulla 2° linea de! pentagramma.
La chiave di Fa pud essere posizionata sulla 4° linea (rigo per la voce di basso) 0 sulla 3° (rigo per la
voce di baritono)
La chiave di Do pud trovarsi sulla 1° linea (rigo per la voce di soprano), sulla 2#linea (rigo per la voce
di mezzosoprano), sulla 3° linea (rigo per la voce di contralto), € sulla 4° linea (rigo per la voce di
tenore).
Le sette posizioni danno origine al SETTICLAVIO.
Rigo per la voce La chiave di Sol indica che la nota posta sulla
di CANTO seconda linea de! pentagramma é il Sol!”
v
Rigo per la voce La chiave di Fa indica che la nota posta sulla
di BASSO jee quarta linea del pentagramma é il Fa.
Rigo per la voce = —=—= La chiave di Fa indica che la nota posta sulla
di BARITONO ES terza linea del pentagramma é il Fa.
Rigo per la voce —————= _Lacchiave di Do indica che la nota posta sulla
di SOPRANO Be prima linea del pentagrarnma @ il Do.
Rigo per la voce La chiave di Do indica che Ia nota posta sulla
di MEZZO SOPRANO po seconda linea del pentagramma é il Do.
Rigo per la voce La chiave di Do indica che la nota posta sulla
di CONTRALTO. terza linea del pentagramma é il Do.
Rigo per la voce == La chiave di Do indica che la nota posta sulla
di TENORE quarta linea del pentagramma é il Do
La posizione del do, nelle diverse chiavi risulta essere:
2
ip oF SS
(Nei brani scriti per coro si pud incontrare la chiave di Sol tenorizato:
| suoni vanno esegut una ottava sotto la normale chiave di Sol
i
| NOTE
Per indicare altezza e durata dei suoni si utilizzano le note.
La diversa forma delle note (colore della testa, presenza o assenza del gambo, numero di codette)
indica la loro diferente durata, a diversa posizione sul Pentagramma indica laitezza.
I SIMBOLI DI DURATA
Per indicare la durata di note e pause vengono utilizzate le seguenti figure:
NOTE PAUSE
INTERO (0 semibreve) © —
META’ (0 minima)
QUARTO (0 semiminima)
OTTAVO (0 croma)
SEDICESIMO (0 semicroma)
y
q
j
La semibreve (del valore di un intero) rappresenta, nel nostro sistema notazionale, la nota della durata
pid lunga"
Le altre figure sono parti della semibreve che viene progressivamente suddivisa per due: ciascuna
delle altre figure vale la meta della figura precedente e, di conseguenza, il doppio di quella seguente.
TRENTADUESIMO (0 biseroma)
“a “a7 Sar WD A
te
SESSANTAQUATTRESIMO (0 semibiscroma)
1 intero °
2meta d d
sqav J J
om J « J 2 J”
1Geedoosin ol 7. UU 7 rer eee ae
64 sessantag. da, le joes OCC:
(@Esiste anche la nota de valore cl un centoventotesimo (costa Yui) uttzatararamente@ slo in andamenti rt
___TEORIA MUSICALE_
M PUNTO DI VALORE
\I punto aggiunge alla nota stessa (0 alla pausa) meta del suo valore, cio® ne prolunga i! suono (0 il
silenzio) di meta della sua durata,
Jesh d= Dt SB cc.
mmieded ok
Re hey eco
@ DOPPIO PUNTO DI VALORE"’
il secondo punto aumenta la durata della nota (0 della pausa) della meta della durata del primo punto,
cioé aumenta della meta il valore del primo punto.
Maededed Lededed
a
@ LEGATURA DI VALORE
La legatura di valore @ una linea curva che unisce due note alla stessa altezza e ne somma i valori di
Lpeded a deerd
La legatura si utiliza solo tra note (e mai tra pause)”
CORONA
La corona @ viene posta su note (oppure su pause) con l'effetto di prolungare la durata a discrezione
dellesecutore. f
1 GRAFIA delle FIGURE”
Per convenzione le figure musicali al di sopra della terza linea del pentagramma si scrivono con il
gambo in gid (tracciato a sinistra della testa della nota)
Le figure al di sotto della terza linea del pentagramma si serivono con i! gambo in su (tracciato a
destra della testa della nota)
testa dolla nota sopra la terza linea + gambo in git == 4 = =
ies sal i Dio fae
testa della nola sotto la terza linea > gambo in su =
) Sipossone Incontrare (raramente) figure con i trplo panto,
(2) Mentre i punto di valore si collaca solo alfinterno della battuta, la lagatura pud trovarsi ta figure musical a cavalo di battuta.
{@) Elementi delia nota musicale: testa + gambo + codetta (0 uncino}
fa
sae cata
‘Quandio si succedono pili note con la cadetta, si possono ragaruppare con i tratlo dunione a seconda del vaiore delturité i tempo
(eictanea wciens 1) 9 Le 600 0-CLES
TEORIA MUSICALE
Capitolo IIT
ME BATTUTE
Le note vengono raggruppate nelle "battute" (o misure)
Le Battute sono delimitate da linee verticali chiamate ‘stanghette*
La Battuta & fo spazio compreso tra due stanghette.
La doppia stanghetta indica che il brano é terminato!”)
2
7 stanghetta| stanghetta ‘stanghetta doppia
stanghetta
La suddivisione in battute é strettamente legata alla percezione.
Lorecchio tende a percepire gli eventi musicalistrutturandoli in gruppi: il “fenomeno del
raggruppamento' é cos} importante che anche la dove si hanno eventi sonori identici, lorecchio fi
raggruppa sentendo (anche se in realta non cé) una pulsazione nella quale si alternano battiti
accentuati e battiti non accentuati
Ogni "unit& di tempo" (0 "pulsazione") pud contenere al suo interno una suddivisione binaria o temaria.
Per convenzione si utiizzano le seguenti unita di tempo: ®)
unitaaitempo ¢ unita ditempo #-
suddivisione binaria ] suddivisione ternaria J J
§ ACCENTI PRINCIPALI
Gli accenti ritmici principal si identificano nelle unita di temipo (cioé nella pulsazione)*
Nella misura a 2 tempi ci sono due accent principali: Forte/Debole
Nella misura a 3 tempi ci sono tre accenti principal: Forte/Debole/Debole
Nella misura a 4 tempi ci sono quattro accenti principali: Forte/Debole/MezzoForte/Debole
In base al numero dei tempi contenuti nella battuta si hanno:
iliac ~
Misure BINARIE (2 pulsazioni per battuta) | | dd.
FD FD
Misure TERNARIE (3 pulsazioni per battuta) J J d
-————_—
Misure QUATERNARIE (4 pulsazioni per battuta) d J J | : d.
FD MF OD FD
{Ta doppia sanghatiathals'6 composta Ga una thea Sole 6 da una a graseat. La doppia slanghela ven anche aizata pa
del cambio delarmatura di clave 0 pa di un cambo dl tempo ma in questo caso la seconda stangheta€ pl sole aa pag. 23
{Nal pentagramma sempice alo del ga on si tova alcuna siangheta cl alu
(3) Qualsias simclo ci durata pud essere usato come unita di tempo, Per canvenzione il segno pill usato @ la semiminima (¢)
(# Esistono anche lazcento metic (cade sul pe movimento d ogni misuta)e Tacceno dnanico:= (accent infenst).
id.
MF OD
- _— ‘TEORIA MUSICALE
MINDICAZIONE DI TEMPO (o METRO)
Lindicazione di tempo (o metro)" é segnalata allinizio del rigo da due numeri sovrapposti posizionati
subito dopo la chiave musicale.
Serve ad indicare il valore complessivo della durata delle note contenute in ogni battuta,
Inisoe
® TEMPO \Lvan Beethoven
Inca a
TEMPO Lvan Beethoven,
@ TEMPI SEMPLICI e TEMPI COMPOSTI”
I Tempo é SEMPLICE quando la SUDDIVISIONE dellunita di tempo" BINARIA.
li Tempo @ COMPOSTO quando la SUDDIVISIONE del'unité di tempo & TERNARIA.
Tempo Semplice Tempo Composto
I
unita di tempo | unita di tempo a
| suddivisione binaria d ) suddivisione temavia J J 7
Nei tempi semplici lunita di tempo 6 sempre rappresentata da una figura musicale singola. Es: 4 4
Nei tempi composti [unita di tempo 8 sempre rappresentata da una figura col punto, Es:d. J.
‘Ad ogni tempo semplice corrisponde un tempo composto con lo stesso numero di tempi (cioé di
pulsazioni) ma differente nella suddivisione. Ogni movimento del tempo semplice viene prolungato,
nel corrispondente tempo composto, aggiungendo un punto di valore.®)
* alleged gi dd-gddd
(7 METRO = aliemanza peiodioa di pulsazioni accentate e non accentate.
IV metro binario ha un accento ogni due pulsazioni, i metro ternario un acento ogni tre pu'sazioni, il metro misto combina i metri
binario e temario.
(2) TEMPO = termine utiizzato con una molteplicité di significa
con Findicazione i tempo" ci si ferisce at due numeri sovrappost incicatialnizio del rigo subito cope la chiave musicale
~ con "unita di terpot viene indicata la pulsazione
“con “tempo sempiice' cis rifersce alla sucdvisione binaria delfunita i tempo (0 pulsazione),
(an “tempo composto’ ci si frisce alla suddivisione ternaria delfunta ci tempo.
= i termine “terrpo" pud anche essare utlizzato rferendosi alla velocita ci esecuzione di un brano. in questo caso si pud pariare oi
tempo moderato, tempo lento ecc.
(@)Esistono anche i TEMP! MISTI nel quali si alternano suddivisione binaria e sudlivisione ternaria (ws poa 21)
(4) Perla scansione dalfunita di tempo (pulsazione) si utlizza il METRONOMO,
metronome fu breveltato da Maézel nel 1816,
LLindicazione de! metronorno stabilsce il numero di pulsazioni al minuto. Esempio:
= 20 significa 80 pulsazioni regotar in un minuto, con und per ogni batt.
(6) Dato un tempo semplice si pud trovare il temipo composto carrispondente mottipicando il numeratore per 3 ell denominatore per 2
Esembo:2 $= 8
6.322
Dato un tempo composto si trova il cortispondente semplice dvidendo I numeratore per 3. il denominatore per 2.68, 8°2~ 4
1S
‘TEORIAMUSICALE _
@ MISURE FONDAMENTALI
Per convenzione si considerano misure fondamentali quelle che hanno come unita di tempod opp
TEMP! SEMPLICI (suddivisione binaria) TEMP! COMPOST (suddivisione ternaria)
j =
mem ltdete tterte
we teed Nrberbe
vv A Ue be | Rr fer ere
Ml MISURE PER AUMENTAZIONE J cood
Si considerano misure per aumentazione quelle che hanno come unita di tempo ¢ opp d+
TEMPI SEMPLICI (suddvisione binaria) TEMP! COMPOST (suaiivisione temeia)
Misure a 2 tempi 3 : r ‘ f | § bre bre
|
Merecsore” Bd oo 1 OWsderterter
Misureadiempi | fr ‘ . ; . ; oR ee rp bee tee
lM MISURE PER DIMINUZIONE Dood)
Si considerano misure per diminuzione quelle che hanno come unita di tempo ¢) opp «?.
TEMPI SEMPLICI (sucdivsione binaria) TEMP! COMPOSTI (suddivisione temaria)
~ Wea 2iome | § e Ds lg bor bey
|
woth Dd aR
wo REE R Ba Bbke
iT emi Ia, I, SB possone cosesienalmente considera tempi Compoal quando Gono Seagal a uno", ccd moto vod un
sola movimento.
_— a ‘TEORIA MUSIOALE
INDICAZIONI DI TEMPO
Nei tempi semplici l'indicazione numerica (tempo o metro) posta dopo la chiave indica al numeratore il
numero di pulsazioni per ogni battuta, al denominatore il valore di ogni pulsazione
Es:
4 7insca il numero delle pulsazioni per ogni battuta (in questo caso 4)
AN indica il valore di ‘ogni pulsazione (in questo caso } dioted ae
3g 71 Indica il numero delle pulsazioni per ogni battuta (in questo caso 8)
2. indica it valore di ogni pulsazione (in questo caso , coke}
Liindicazione di tempo nelle misure semplici pud essere espressa nei seguenti modi:
2.2 2.2 2_2
Avr 2° f 8~ 6 foe
@
Nei tempi compost lindicazione numerica posta dopo la chiave indica al numeratore il numero di
suddivisioni per ogni battuta, al denominatore il valore di ogni suddivisione.
Es
‘A indica il numero delle suddivisioni per ogni battuta (in questo caso 6)
8\ indica il valore ai ogni suddivisione (in questo caso }, cicé: d
7 indica il numero delle suddivisioni per ogni battuta (in questo caso 9)
16y inai¢a it valore di ogni suddivisione (in questo caso 45 cicé: 4)
Lindicazione di tempo nelle misure composte pud essere espressa nei seguenti modi
6_6 6_6 66 ox
Sap Af BSE
NB. Tutte le indicazioni di tempo che al numeratore hanno 2, 3, 4, si riferiscono a tempi semplici.
Tutte le indicazioni ai tempo che al numeratore hanno 6, 9, 12, identificano tempi compost.
( iltempo 4 viene definite "tempo ordinario’ € pud essere anche indicato cosi: @
4
1 tempo 3 & detto “tempo taglato' 0 "tempo a cappella in tilerimento alla musica aseguita ‘a cappolat (c:08 senza stument) in
cons
Pu anes arora cee ont
(natura pd rove
Pl
8 r
in questo caso numerator indica i numer dl temp denominator a due ogi emgo
17
‘TEORIA MUSICALE
@ UNITA' METRICHE
Le principali unita metriche sono:
- UNITA' DI TEMPO (pulsazione): é la figura che rappresenta il valore di ogni movimento
- UNITA’ DI SUDDIVISIONE: é la figura che rappresenta il valore di ogni suddivisione
- UNITA’ DI MISURA: @ la figura che rappresenta il valore complessivo contenuto nella misura.
unita ot
MIURA,
unita di
TEMPO
unita di
‘SUDDIMSIONE
unita di
MISURA
rita di
TEMPO
unita gi
SUDDIVISIONE
re
qe
fo
J
J
J
d
d
d
ge
Bo
ged
J
J
1
d
)
d
unita gi
MISURA
uunita ot
TEMPO
unit di
SUDDIVISIONE,
unit di
MISURA
wna a
TEMPO
unita dt
SUDDIVISIONE
re
re
J
J
J
J
J
J
go
Qe
1.
L
1.
|
Be
J.
J.
J.
4
Be
d.
go B tor
igus, Teveo__suoovsione BURA EEO ___suboMsone
3) >) OS} Ogee
ae Dd od fgen dn 8
4
™@ PAUSA DI INTERO
La pausa di un intero vale come pausa per l'ntera battuta in qualsiasi tipo di misura.
a: 1
e
‘TEORIA MUSICALE
1 ACCENTI SECONDARI
Gili accenti secondari cadono sulle suddivisioni.
Tempi semplici
accenti principal F
Shh bth Lthd
accentisecondarif d f d fdfdid fdfdfdftd
Tempi composti
accenti principali F F DOD FMD)
ten J. 4, ! :
| suddivision’ 8" re (dele fer f fer
|accenti secondari fd d dfdd |
™ SINCOPE
La sincope é uno spostamento di acento dalla pulsazione forte a quella debole precedente, Quindi
un suono emesso su un tempo debole (o sulla parte debole di un tempo) si prolunga sul tempo forte
successivo (0 sulla parte forte di eso)
Es: ower
oe Fee DS
am d
eer caa eho et sincope relativa agli accenti second
Quando la nota non inizia su un tempo pid debole di quello sul quale si prolunga NON c® sincope.
Es ; :
ll
La sincope é:
= regolare: quando si trova le due note hanno |o stesso valore"”
- imegolare: se posta tra due note con valori diversi.
sincope regolare sincope irregolare
Quando la sincope si prolunga per diverse battute si ha il cosiddetto andamento sincopato.
Es:
get dbl ppb Jd.
oy <>
‘Nei tempi compost a sincope & considarala regolare quando Il rapport Gi duraia tra la nola daliacco @ i suo prolungamento 8 1:2.
Mgidsd
19
TEORIA MUSICALE
MCONTRATTEMPO
\I contrattempo inizia su un tempo debole (0 su una parte debole de! tempo) come la sincope, ma
invece di prolungarsi sul tempo forte, viene seguito da una pausa.
|I contrattempo @ regolare quando il valore delle pause e dei suoni é lo stesso, irregolare se pause €
suoni hanno durate differenti
coptatengo, $4. By dye Ba Bey de gd yg dig dig gy
@ RITMI INIZIALI
Un brano pud iniziare:
- sulla prima pulsazione (cioé "in battere" sul primo tempo forte) > attacco TETICO!
~ su un tempo debole (cioé "in levare') > altacco ANACRUSICO™
- con una pausa sul primo tempo forte -> attacco ACEFALO®
eco g J J FI 1,
d Quando lattacco & anacrusico, spesso i
‘Anacrusico sey —H] valor delle note assenti nella prima
tattuta sono compensati nelfutima
Acefalo yell C1 y
o
GPh, Telemann - Suite A minor
In questo esempio la nota iniziale si trova entro la prima meta della battuta, lattacco 6 acefalo (la nota
Ginizio é pit vicina all'accento forte precedente che al seguente)
@ RITMI FINALI
Ilritmo finale di un brano pué essere:
- TRONCO (0 "maschile’) quando I'ultima nota cade su! tempo forte della battuta (cioé ‘in battere")
- PIANO (0 "femminile’) quando la nota conclusiva @ su tempo debole.
finale tronco finale piano
o
{Termine tetco deriva dal greco ‘tesis™= movimento in battere. (esi = battere, asi = levare)
{21 termine anacrusi deriva dal greco ‘anacrousis" che significa ‘preludere’. n presenza di pid note in anacrusi, la diferenza tra ritmo
‘acalalo e anacrusica é determinata dalla posizione meltica delfaccento forte della prima nota. Se la nota di inizio @ pill vicina
alfaccento forte precedente che al seguente Fattacco @ acofalo, se la nota dinizio @ pil vicina allaccento forte sequente che a quello
precedente (oppure é equidistante trai due) lattacca @ anacrusico.
ill termine acefalo deriva dal greco "achelalos’ = senza testa.
TEORIA MUSICALE,
Ml MISURE MISTE
Le misure miste (0 ‘asimmetriche") combinano metri binari e metri ternari
Sono caratterizzate dalla suddivisione mista (suddivisione binaria + suddivisione ternaria)
+3)
Misure a
2 tempi
Altre combinazioni: 2+3+2 oppure 3+2+2
Misure a
3 te
SMP! | gsae9)
ya
° Goo nm
Misure a
4 tempi |
Ave combinazioni: 3+2+2+3 oppure 3+2+3+2 ec
| exes
| Sys 2 sy = bh,
|_ERSPSF PrP Tr err tEresrerer tpererrenrey”
Altre combinazioni: 34+3+-2+3 oppure 3+2+3+3 oppure 2+3+3+-3 ec.
@ ACCENTI DELLE MISURE MISTE
Gli accenti principali e quelli secondari seguono la regola generale vista a pag. 19. Es:
|
g d a
eo
C6er
accent principal F D
accentisecondari f od f d d
21
TEORIAMUSICALE
MINDICAZIONE DI TEMPO DOPPIA E MULTIPLA
Quando nel metro si alternano due (0 pili) indicazioni di tempo diverse, @ necessario mettere una
indicazione ai tempo doppia (0 muttipla) per indicare laltemnanza permanente dei tempi indicati.
Indicazione d Inccazone oi
TEMPO DOPPIA TEMPO MULTPLA
eo, ap flop,
Pott {
@ MULTIMETRIA
Con il termine rmultimetria si intende lalternanza di misure con metro diverso.
Esempio:
iio ey
Liindicazione posta nella seconda battuta indica che il quarto (J) del nuovo tempo (2/4) corrisponde
alla meta (4) del tempo precedente (3/2).
|
Lindicazione = #- viene utiizzata quando nel passaggio da tempo semplice a tempo composio (e
viceversa) la durata dellunita ol tempo non cambia: Unita di tempo ¢ = unita dl tempo viceversa
Es: JoJ, all TD,
Ss
Liindicazione viene utilizzata quando nel passaggio da tempo semplice a uno composto (¢
viceversa) la velocité della sudivisione non camibia: suddlvisione g = suddivsione p
b
Es: be)
git) Fly DOO
SEMIOLIA
II termine emiolia si utilizza per indicare il contrasto metrico che si crea quando nelle misure a
suddivisione temaria si utilizzano 3 note al posto di 2 note puntate (cioé quando si passa da 2
pulsazioni con suddivisione ternaria a 3 pulsazioni con suddivisione binaria).
= hd
TW Alcuni autor invertono Tordine delle indicazioni
.
Capitolo IV
SCALA F
La scala é formata da QR note (chiamate anche gradi).
I gradi vengono seritti ih cifre romane: I, II, II, IV, V, VI, VIL, VU.
Risulta quindi evidente che il primo grado indica anche la prima nota della scala.
‘TEOFIA MUSICALE
———
Grad dela scala] mom Ww ovoow ove vm
Denominazione dei gradi della scala:
TONICA = I grado (@ la nota fondamentale che da il nome alla tonalita)
SOPRATONICA = II grado
MEDIANTE (0 caratteristica) = Ill grado (8 a meta strada tra tonica e dominante)
SOTTODOMINANTE = IV grado
DOMINANTE = V grado
SOPRADOMINANTE = VI grado
SENSIBILE = VII grado (tende a risolvere melodicamente sulla tonica)
La scala procede per “gradi congiunti (cio8 senza salt
Tra un grado e laltro pud esserci la distanza (intervallo) di TONO (formato da due semitoni) oppure di
SEMITONO (cio’ mezzo tono).®
La scala di Do Maggiore @ la SCALA MODELLO di tutte le scale Maggiori®ed ha il semitono tra il terzo
e il quarto grado e tra il settimo @ lottavo grado.
no _tono tone
i ‘semitono
semitono.
La scala di Do Maggiore & costituita dalla successione di due tetracordi (cio due gruppi di quattro
note ciascuno).
| due tetracordi sono Maggiori e sono separati da un ton,
Ii tetracorcio Maggiore
I* totracorde Maggiore
oe
dominante
tonica
La prima nota del I tetracordo (che é poi il I grado della scala) @ la tonica,
la prima nota del II’ tetracordo (che é anche il V grado della scala) é la dominante.
THVIT grado = ripetizione dela Tonica una ottava sopra
®)Le stale Maggiore minor appartengana al'genere ciatonco’, i suoni sono depos provalentoments per toi (epg 26)
@)Ogni grado pud essere linizio di una nuova scala Maggiore (nella quale toni ¢ semitoni devono essere disposti come nella scala
‘modelio di Do Maggiore).
3
TEORIA MUSICALE _ _ ee
INTERVALLI
Tntervallo 6 Ta distanza in altezza tra due suoni.
Liintervallo si misura contando i gradi congiunti compresi tra la nota base e quella superiore.
In questo modo viene definita a QUANTITA’ deltintervallo.
oe o “S, eo
PRIMA 'SECONDA TERZA © quanta
eusanoy
oe
© Quinta SESTA © seTTIMA © omava
Dal punto di vista della QUALITA’, cicé della "specie" (che dipende dal computo dei toni e dei
semitoni) si hanno: interval giust, interval "Maggior'e "minor, interval ‘eccedent¢ "dininui
— geste ul
UNISONO (PRIMA)"”?
Lunisono comprende due suoni avent la stessa altezza.
Dal punto di vista qualitativo nella scala di Do Maggiore lunisono @ un rienai GUSTO)
e ©
Unisono
SECONDA
Lintervallo di seconda comprende due suoni consecutivi.”
Dal punto di vista qualitativo nella scala di Do Maggiore la seconda pud essere:
- MAGGIORE (formata da un tono)
- MINORE (formata da un semitono)
4
vo o e
3S:
2a Maggiore “Pa 2a minore Pe, tA
TERZA 3 3
Lintervallo di terza comprende tre suoni consecutiv.
Dal punto di vista qualitativo nella scala ci Do Maggiore la terza pud essere:
= MAGGIORE (formata da due toni)
- MINORE (formata da un tono e un sernitono).
a ee
2 6 A
‘3a Maggiore “ 3a minore—!
W Teoricamente Tunisono non viene classificato fra gi intervalli essendo formato da due suoni della slessa allezza.
@Gii interval ai seconda sono INTERVALL! CONGIUNTI (cic@ intervali tra note che si susseguono senza salt). Tutti gl alt interval
‘sona INTERVALL! DISGIUNT), cic@ interval tra due suoni separa tra loro da uno o pit gradi della scala
24
Potrebbero piacerti anche
- Adès - Arcadiana Op.12Documento28 pagineAdès - Arcadiana Op.12Rufus Loacker100% (1)
- Analisi Di Cristina Roveredo - ParmegianiDocumento14 pagineAnalisi Di Cristina Roveredo - ParmegianiRufus Loacker100% (1)
- Mr. Banks VerificaDocumento2 pagineMr. Banks VerificaRufus LoackerNessuna valutazione finora
- Codifica e Compressione Dell'Audio DigitaleDocumento7 pagineCodifica e Compressione Dell'Audio DigitaleRufus LoackerNessuna valutazione finora
- Le Montagne Della FolliaDocumento17 pagineLe Montagne Della FolliaRufus LoackerNessuna valutazione finora
- Prova Generale CanzoniereDocumento1 paginaProva Generale CanzoniereRufus LoackerNessuna valutazione finora
- Tesina - Codifica e Compressione Dell'Audio DigitaleDocumento7 pagineTesina - Codifica e Compressione Dell'Audio DigitaleRufus LoackerNessuna valutazione finora
- Bennato - Sono Solo CanzonetteDocumento1 paginaBennato - Sono Solo CanzonetteRufus LoackerNessuna valutazione finora
- Arie Antiche Italiane (La Flora 01)Documento149 pagineArie Antiche Italiane (La Flora 01)Fernando Esteban100% (3)
- Lettera Ai CoristiDocumento1 paginaLettera Ai CoristiRufus LoackerNessuna valutazione finora
- Chiara Galiazzo - Il Futuro Che SaràDocumento1 paginaChiara Galiazzo - Il Futuro Che SaràRufus LoackerNessuna valutazione finora