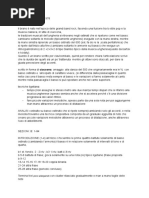0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti) 222 visualizzazioni19 pagineFabio Cifariello Ciardi PDF
Copyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo,
rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Fabio Cifariello Ciardi
APPUNTI PER UN MODELLO GENERALE
DI SEGMENTAZIONE MELODICA'
1, La segmentazione del continuum acustico: principi ¢ limiti generali
[Nala maggor parte dei ala musica & un art che nate dllinterarione i te
nti: compoitor, eseestore,Fssoletore. Di consepuenca lanl musicale
dowrebbe porre atenzione non solo al lavoro del compositor alla parttira dali
realists, ma anche al'spporeo creative dellinerpreteche(c)aduce i sgn in
Sono e delltcoatore che, a sua vol, (atsegna al suono un senso. A questo
proporto Bene arma come “rt gl sip clan musicale intra cone t-
Givi ottointendono quel ondamentale punt di conato tal mentee i suono
tausicale che & la pererione muscle” [Bent-Drabkin 1990, 1-2], Ma a quae
Nelfanalizare Fambiente acutico che lo ctconda Nascotatore uiliza diverse
snp cognitive: lene dipendono ds regle vin comuni ad og eee wna
10 gi level a pried primi mes di it, ale si sviuppano lange Taco del-
Inviad un qual! oggete, ale ancora soo legate pecifchecomptenge ©
abilitsvlupputespeno atuaverio una suffciente espodzione ad un petcolare
idioma, proprio neo sido di quest aratege cognitive che Vaal masiae
ba pricologia dell msica poxiono trovare un campo d'indagine condi,
Canali nscale pod rrarve vncaggjo da ie perimene git acquis dalla
puicologia dell rmsiea per verificne se e fino a che pane> le peopicinmisiont
dtalkiche possin trovare un fondamento oggetive nelle rpone di wn gruppo
Saticamentesignicativo ci [Link] alla pscoogia della musics pud
cere ule una competenzaspecieatamente musicale vice perinenaa
de pang! perimental con freaks muscle "fur! dl aboratorio"
‘Una dalle suatogieuelizare dllascoltatore sla quale converge a Tinterese
dela pelcologis della musica sia quello delfsnalsiriguada la segmentatione del
si riferisce Bent?
* Lebprablemascheslfonma dl prsece lavoro non sebbero wate ma font dlastore n=
za lestmalan lection’ di Mara Oltets Beerinei che gui caloroumente ringrana, Un
dboverso ingraamento va anche ad Egido Porn © Roberts Gottd pt Tatenta seve del�Faso Ciranuetio Can
continuum acustco, Per Vanalisi musicale la segmentazione & uno strumento uate
Per comprendere sia la strutcura del materiale musicale, sia le ragioni di un deter-
‘minato fraseggic realizzato dall'interprete o suggerito dal compositore. Perla px
cologia della mnusia, invece, la segmentazione é una strategia cognitive per lo pill
inconsapevole, in parte indipendente dalla competenza musicale [Drake 1998] ¢
aller, utilizzata per ricordare, conftontare, giudicare cid che ascoltiamo, I risul-
‘ati sperimentali disponibili rendono legittime alcune domande, Le variabili che
determinano ta divisione di un lusso sonore mantengono una loro rilevanza per
ertiva indipendentemente dal contesto acustco in cui vengone percepite? In ale
parole, segmentiamo un canto gregoriano, un tema di Guerre stellar, uno studio
Per pianoforte di Ligeti oil suono i un treno utilizzando le steste categorie 0 ap-
Plicando ‘regole’ simili e dungue generalizzabil? Quest interrogativi rimandano
alla possibilits di definire un modello generale di segmentazione, ovvero una for-
rmulizzazione dei processi cognitivi utilizaati dallascoltatore per raggruppare le
Porzioni di wn qualsisi Qusso sonoro, indipendentemente dalla sa durata, natura
(concreta sintetica) e origine (strumenti musicali, fenomeni naturali, forme vi-
venti, macchine).
Se ipotizgiamo che un simile modello possa essere effettivamente formalizzato,
‘come prima cosa occorzera domandarci se esistano dei principi di base che sotto-
‘anno alla segmentazione di un qualsiasisegnale sonoro, Una risposta parcialmen-
te positiva emerge dai molti studi (riassunti in Dowling-Jay-Harwood 1986 ¢
Deutsch 1982] che hanno dimostrato come V'organizzazione di alcani attributi del
suono sia generalmente basata sui principi di prossimita, similariti e buona conti-
‘nuazione (vedi esempio 1) gid formalizzati nella percezione visiva dalla psicologia
ells Gestl (51 veda ad esempio Kane 1948]
Es. t. Ekemplifcazione dei principi dela Getl prow 2), simian () e buona
continuasone(¢).
Nell'ambito acustco i princpi sembrano interagite fia di loro ed essere applica
bili @ qualsiasi dimensione dellevento sonoro. Il principio di prossimita afferma
che gl element vicini tenderanno ad essere percepiti come un gruppo unitario e
separato dagii clementi lontani; viste le evidenti analogie spazialiutilizaate nella
notazione musicale tadizionale il principio di prossimiti & stato soprattutto asso-
APrUTI FER Unt MODELLO GENERALE DI SEGMENTAZIONE MELODICA »
ciato alla duratae alla altezza (esempio 22). II principio di similarita afferma invece
cche elementi percepiti come similformeranno un gruppo separato rispetto agli
cclementi percepiti come divers; la simiaritA in un contesto acustico pud riferirsi
ancora alla durata 0 all'altezza ma anche ad esempio alle caratteristche di una figu-
ra melodica (esempio 2b). I principio di buona continuazione, infne, afferma che
ali elementi che sisusseguono in una medesima direzione saranno percepiti come
appartenenti ad uno stesso gruppo; nell’ambito sonoro la dimensione su cui rile
vare la buona continuazione’ pud essere ancora 'atezza ~ pid precisamente il pro-
filo melodico ~ 0 il imbro (esempio 2¢).*
Es, 2, Exemphiicaione musicale de princi dlls Gea: 2) poss (elatvamente 3
‘iagco« dere), b) sia (urate « Bgur), e) buona contiaussione(proSla
pen
‘melodica e timbe)
‘Tali principi s sono rivelatiestremamente utili per comprendere le primissime
fas della codifica ci un evento sonoro e percid sono stati spesso utilizzati come re-
gole di base in diversi studi sulla segmentazione musicale [Tenney-Polansk 1980;
Lerdahl-Jackendof 1983; Narmour 1990]. Le ricerche effectuate in questo ambito
hhanno fornito allimalsi musicale tradizionale una chiave nuova e, in parte, scien-
tificamente fondata per la comprensione della musica tonale {Cross 1998}.
assando dai semplici esempi musicali utilizzati dai ricercatori alla complessti
del paesaggio sonoro che ci circonda, i principi della Gestal, pur mantenendo una
loro validta, non sono sufficienti per costrure il modello generale di segmentazi
Nel scone cao cafes ac principio dl "buona continuazione” epplist al bro ate per
Supe Tambigan che pouetbeemnegere dalincrocio dele due ine melodie del faut =�fe Fasio ClraRIELLO CiAnoy
ne che abbiamo precedentemente ipotizzato, Almeno due sono le questioni che
‘meritano qui d'essere approfondite. La prima riguarda le dimensioni del fenome-
no sonore sulle quali applicare i principi della Gert; la seconda rimanda al rap
porto fia le strategie cognitive attivate dall'acoltatore nella regmentazione ¢ le sue
conoscenze € competenze specifiche.
La psicologia cognitivista della musica parte dal principio che la codifica di
tun'evento sonoro debba presupporre una rappresentazione mentale dello stimolo
steso. Tanto la rappresentazione quanto le sue succestve elaborazioni dipendono
all capaciti del soggetto di estrarze dal evento delle specitiche categorie percettive
in qualche modo correlate con dei parametri Sisici misurabili. Nel define talicate-
sgorie gi pricologi sono sti inluenzasi non gia dal complesso delia nostra esperienza
Acustica quotidiana, ma quasi esclusivamente da un particolare insieme di suoni —
‘quell ad altezza determinasa,diffusamente utilizzati dalla culeara musicale occiden-
tale — e dal sistema simbolico di notazione urilizzato per la loro tracrizione, Cost
facendo sono state sottovalutate le conseguenze di uno dei presupposti storici dela,
scrittura musicale: la notazione musicale occidentale non é nata per trascrivere cut
cid che l'uomo era in grado di sentire, ma soprattucto per favorie la conservazione
e la trsmissione dei prodotti della propria cultura musicale. In quest ottica un artico—
Jaco insieme i sti, convenzioni ¢ valutazioni estetiche ha fatto si che la serttura
‘musicale occidentale abba finito con il rendete pitt facile e precisa la definizione di
Patametti come le altezzee le durate, e decisamente pili complesa € approssimativa
|a descrizione ai altri atributi sonori quali Ie inflessioni il vibrato o le variazioni
timbriche, Tal limiti delle categorie tradizionali sono emersi con incontrovertbile
evidenza negli ulin cinquant‘anni con Vallargamento delle rsorse sonore — libe-
ramente costruite © derivate dalla nostra quotidiana scena uditiva — che la tecnolo
gia ha messo a disposizione dei compositori [Windsor 1995)
Calero aspetto che rende improbable la realizzazione di un modello utile alla
segmentazione di un qualsiasi continuum acustco riguarda 'induenza di speciéi-
che conoscenze acquisite [Tan-Aiello-Bever 1981; Imberty 1986]. In aleuni casi
influenza della memoria a lungo termine, quella che conserva la nostra cono-
scenza del mondo, varia con il variare dell'ambivo temporale considerato dal sog-
‘Beto, Presupponendo sempre un alto livello d’attenzione, determinate elaborazio-
ni cognitive — come ad esempio organizzazione getarchica dei gruppi melodici
«delle strutture metriche — riwsltana fortemente dpendenti dalle competence &
alle preference individuali non appena Yambito temporale viene ampliato [Drake
998). Dalfalero lto & anche possibile che la memoria a lungo termine venga at
tivata da eventi sonori di brevissima durata. Una ricerca di Perrott e Gjerdigen
[199s] ha evidenziato, ad esempio, come gli studenti di un college americano ab-
biano mostrato una buon: capacici di individuare il genere musicale di un brano
sscoltando frammenti di sppena 250 millisecondi. II risultato non deve stupire. Se
le ricerche di laboratorio hanno dimosteato come la codifica di un evento sonora
-APTUNTI FER UN MODBLLO GINERALE DI SEOMENTAZIONE MELODICA a
proceda spesso per fai successive, atraverso process sempre pid compless, & anche
evidente come il nostro quotidiano rapporto con V'ambiente acustico ci obblighi
spesso a tovare risposce in tempi molto ristretti o sulla base di un numero limitato
@informazioni. In questi casi esperienca passata & utilizzata dal soggetto per pro-
darre aspertative activate con Vobiettvo di abbreviare il tempo necessaio per portare
4 termine I'elaborazione dello timolo percepito, sia esso visivo [Lamberts 1995) che
acustico [Dowling-Harwood 1986]. D'altronde lz narura stesa dellascolto implica
un fusso d'informazioni pressoché continuo che tende improbabile un'articolazione
dei processi cognitivi struttarata e ondinata, Spesso non attendiamo il risultato di
tun'chborazione per avviarne una nuova, ma tendiamo ad anticiparne Vesito con
delle ipotesi basate sulla nostra precedente conoscenza del mondo.?
2, Peculiarta, limiti e seruttura del modelo
Questioni come quelle citate hanno portato spessa le ricerche sulla segmenta-
zione a concentrarsi nom tanto su una modellizeazione valida per un qualsiasi con.
‘inuum acustico, quanto piuttosto su formalizzszioni applicabili solo a specifiche
categorie di eventi sonori. In generale, per la psicologica cognitivists, la delimita-
ione del campo d'indagine é utile per diversi motivi. Circoscrivendo con preci-
sione Yambito della ricerca 8 possibile migliorare il control delle variabili che in-
Suenzano la risposta dei soggeti impiegati negli esperiment,failitae il confronto
dei risultati sperimentali ottenuti e soprattutto permettere di trarte conclusion
ggettive o quanto meno statisticamente fondate, L'smbito della ricerca viene s0-
litamente limitato in due modi: da wn lao si cerca di controllare V'influenza delle
competenze specifiche utilizzando soggerti omogenei per formazione e/0 etd;
dall'aluo, per poter meglio controllare Vinfluenza di ciascun parametro, gli stimol
‘sati negli esperimenti presentano delle versioni molto semplificae rispetto a ci3
che aceade nella reals,
In questo contesto una delle semplifcazioni pid fequenti nelle ricerche della,
psicologia cognitivista della musica riguarda idioma musicale a cui lo stimolo ri-
2 Gl ei di ali ancipazioni oscilano tm duc exten. Nel cas d un brane conor cone
iver rapidement del precise wacce dela props nemaria esac di comepents 3 pods
Acie poten anendbusché gu cosenusanno'une amon det femp neces pode na
‘pasa copniva utle Pe un evento sonoro non conor, inves del remorasranno
Ete con minore precsione Isinema copii dovr und: dcider 6 tent compngue Una
“Seoretie™producendo dl pots sla based un numero inficente dr clement se sen
dere Ursula proces cog legs eens ale informazions cate dag crt so
hod immediatamene precedent Nel primo cao le apetaite prodote al weolotore, quar
fr oem Sichsao & sre hu ic copa elena co dno
{caus compleureleaborsie pot comporare ls pera parle tole dela avs lor
atone che el fetempo¢ acetal sve oecchie I eaivoperdrare dr spent cognitive 900
‘oddsacees pou atunmente see delle comepuenze negrove sol lvelo datennionedescal-�2 Fasio CvaRsetto Canoe
‘manda, La gran parte degli studi sulla segmentazione e, in generale, sulle modalta,
i organizzaaione delle struteure musicali stata condotta con frammenti musical
riconducibii prevalentemente alla grammaticatonale. Le ragioni della scelta sono
di certo comprensibili: la grammatica tonale, in quanto ampiamente formalizzata
dalla cultura musicale occidentale e uniformemente condivsa, rende pi agevoe il
controle ¢ il confionto di diversi paradigms sperimentai e permetze di ottenere
risultativalidi per numerose categorie di soggetti. D'atro canto perd il pacsaggio
sonoto e musicale che si ascolta fuori dai aboratori di ricerca ® decisamente diver-
so, Le musiche “colte” degli ultima cento anni e, a ben vedere, anche la musica ap~
plicata¢ di consumo che quotidianamente ascoltiamo sono soggette ad un intrec~
cio complesso di influenze multiculeurali ¢ multietniche non sempre facilmente
circoserivibili entro rstretti ambit stilistici e certamente non riconduciili alla sola
grammatica tonale. Di conseguenza, anche se un modello generale di segmenta-
Zione di un qualsasi continuum acustico ¢ ancora lontano ed una delimitezione
del campo d'indagine appare comunque necesaria, pud essere certamente utile
domandarsi in che modo circoserivere Pambito degli eventi tonori da considerare
alfinché sia posibile define un modello di segmentazione in grado di produrre
"sult pertinenti indipendentemente da variabilistilistiche e grammatical.
{La prima considerazione é di carattere metodologico ed ha un'inevitabile rica
data sulla tipologia degli eventi sonori che sari possibile analizzae, Nell ipotizeare
tuna formalizzazione dei processi cognitivi attivati dall'ascolratore, un modello di
segmentazione dovrebbe fare riferimento 2 specific riultat sperimentali. Un si-
‘ile approccio non ha la pretesa di assegnare al modello una valenza oggettiva
sma che sia stata portata a termine una sua directa verifica sperimentale, ia bia Jo
scopo di limitar, git nella formulazione delle ipotesi, il ricorso ad arbitraie valu
tazioni empiriche ‘ed evidenziare, nel contempo, le question alle quali la ricerca
attuale ancora non & riuscica a dare delle risposte soddisicenti A partite da questo
vincolo, visto che la gran parte dei dat sperimentali sulla segmentazione e sullin~
‘uenze dei principi della Gestlrriguaeda prevalentemente eventi monofonici ba-
satis suomi ad altezza determinata, le questioni qui delineate riguarderanno
senzialmente la definizione di un modello generale di segmentazione melodica.’
Una seconda necessaria considerazione riguarda le dimensioni percettive consi-
derabli. Dallanalisi dei limiti dele categorie tradizionalmente utiizate nella de-
Tints gee papal hme oly ode Lp te
pic negara Tope hy (ot tte a Lge
eee ieee
ee ——r————
ie apenas ces ome gre
Sr ene ech rea ah ie eh
send emit romney momen pyre ae te
fr aca treme eee eee ogee eres
eget ame pal pe hc op mer cp le
Arron! FER UN MODELLO GENERALE Di SEOMENTAZIONE MELODICA 8
scrizione del suono & emerso come la generalzzabilith dei risultati sia proporzio-
rale ala generalzzabilita delle categorie uilizate; cid significa che tanto pit le ca-
tegoric utlizate dal modello rimarranno pertinent: in contest acustici divers, pith
‘generalizzabili potranno essere i risutati prodotti dal modello stesso. Considerando
il ruolo delle nostre rappresentazioni nel quadro delle nostre strategie di adatta-
‘mento [Millikan 1984) potremmo ipotizzare che, nella segmentazione di un qual-
siasi fusso sonoto, i parametri maggiormente induenti per V'ascoltatore saranno
uel che nella sua pastata esperienza gli hanno consentito di elaborate e ricordare
‘il numero maggiore possibile di informazioni. In quest’ottica per le line melodi-
che, cosi come per una gran parte degli eventi sonori che ci circondano, molte
Gelle informazioni per noi significative risultano essere spesto correlate non con
dei parametrifisici, ma con la connotazione dell'evento acustico e rimandano alla
cavsa che determina il suono, alla funzione del suono nel contesto in cui & ascol-
tato e al signicato che l'ascoltatore gli assegna sulla base delle proprie conoscenze
id 0 meno condivise [Cifsriello Ciardi 1996]. Purtroppo la connotazione del
suone, anche quando é largamente condivisa, presenta delle diffcolti di rilevazio~
ze e misurazione tali da rendere complesa una valutazione oggettiva del suo ruclo
nella segmentazione. Escludendo tai influenze, le categorie maggiormente rile-
‘vanti nella codifica di una qualsiasi linea melodica sono Valtezza, la durata, la dina~
mica e il timbro, Fra queste, come vedremo, non tutte sono facilmente integrabil
in un modello di segmentarione melodica
Il parametro forse pit significativo e rilevante in una grande varieta di contest
acustici la dinamica che influenza fortemente la nostra capaciti di localizzazione
del suono nelle spaciv [Scheiver 2000]. La sua urlitd in un modelio di segmenta
zione & perd limitata dl fatto che la nostra sensibilic alle variazioni dinamiche &
decisamente inferioze rispetto alla sensbilit che dimostriamo nella percezione
dell'altezza ¢ della durata [Patterson 1974].* Un altro paramerro tanto importante
{quanto complesso da utilizzare @ il timbro. Come é noto il termine timbro sinte=
tizza in modo vago quella grande quantith di informazioni correlate con I'nvilup-
po spetiale e d’ampiezza che non sono considerate dagl altri atributi del suono.
Se la requenza ha per lo pit il suo correlato percettivo nell'altezza, ¢ !'ampiezza &
in gran parte correlta con Tintensiti dinzmica, i diversi parametrifisici che deter
‘inano il timbro, pur essendo associabili a categorie come chiaro/scuro [Wessel
1979], non presentano dei correlati percettivi precisi ¢ condivisi analoghi all'aktez~
za, alla duratae al'intensti dinamica. Queste diffcolti hanno fatto si che il rualo
7 Taridoua capac 6 dinguere divers live ingens dipende, meno in pare, dla
EuSpewe igboncolabe ils nae: n tuo l perco Gal yorgente savor facotatore
ample del tepuleafensata dalle condiioni sence (presen oxacob terre).
{alt poncione desolation [ut Plomp 198], dale sve prefrenae[Puce#lsers-Pewoano-
Bart on] cance lieve el et om ga pret del sono [Rae 974�we Fasto CiraRiet10 CaKot
timbro nella segmentazione melodica sia stato fino ad oggi ancora non suf
cientemente approfendito [Deutsch 1982; Iverson 1995] ¢ dungue un so wtlizo
nel modéllo proposteappare, purroppo, ancora decisamente problematic,
Tenendo conto di questo ipo di problemi le etegorie legate alla duraae all'l-
tezza del sono sembrano quelle che meglio si prestano ad essere utilizate per pri=
me da un modello generale di segmentazione melodica. Anaitutto entrambe con-
teibuiscono in maniers determinante all analist di quabsiasi linea melodica; in se-
condo hiogo ls nostasensibilit sensoriale alle variaioni di duratae altezza&, in
determinate condizioni, decisamente pit alta che per alte categorie; infine, una
notevole mole di dat sperimentalirende possibile ua valutazione piutosto preci
$2 de loro ruolo nella segmentazione melodica, Per quanto riguarda la durta, sia
ca asoluta o reatva 2d un'unita di misura vaiabile, occorve distinguere «ra la
dunt di un suono e Vintevallo temporal fa due suoni, osi il tempo miscrato
tea loro punt datiacco (intron time). Secondo Drake ¢ Palmer (1993) la vatia~
Zione che maggiormente influenza le segmentazione melodica quella che riguar-
4a la dstanaa fia i punci Zatacco dei suoni Irene Delidge [1987], oltre a confer-
‘are i ruolo primario del punto d'atacco, ha evidensiato come le variazion! di
altezza (cegistto)¢ di timbeo abbiano un ruolo determinante in particolar modo
peri non musics. In base ai suo rsulai il profilo melodico, da solo, non sembra
essere in grado di determinare chiaramente i conSini di un gruppo. Il profilo, tut-
‘ava, ha un ruoto centrale in contest lontan da quello ronale a causa della capita
della sua rilevazione: Tandamento della linea melodies wn'informazione imme-
diaamente disponibile prima dell afermazione dela tonaliti [Edworthy 1985] €
<8 potrebbe spiegare il motivo per cui nel riconoscimento di melodie i non ma
siciti sembrano basarsi pit sul profilo che non suglintervali (Baver-Chiarello
1974), Nella segmentazione ¢ probabile che Vimporsanca delle variazioni di prof-
lo emergano in modo tanto pi rilevante, quanto pid sulin contestualmente
evidensivarizioni su aire dimensioni. Tenendo coato di questi dati, le regole
proposte per una prima versione del modello prenderanno in considerazione
cselosvamente le categorie della durata,dell'ltezzae del profilo melodico.
Una tea consderazione riguarda la durata wotle dei fammento melodico da
analiezare e pud essere utile per tentare di minimizzare lineviabile ruolo gioeato
dalle competenze specifche del'sscolatore. Poiché l'nfluenza dells memoria 2
Jungo termine nella segmentazione di un evento sonoro pub essere messa in rla-
zone sia con lambito temporale considera, sia con le varabili che impongono
al soggeto una maggiore 0 minore rapiditd nell risposta cognitva, & plausible
supporte che la generalzeabilitd dei risulaiforniti dal modelo sari tanto minore
«quanto maggiore sari lo durata dllevento da segmentae. Con Vaumentare della
durats del evento acolatore & portato a riunire in modo ricorsivo gruppi di due
© tre segment in alti sempre pit ampi e gerarchicsmente organizzati per
4i seategie di claborazione sempre ni complesse e probabilmente sero vit le
APPUNETI FER UN MODILLO GENERALE D!SEGMENTAZIONE MELODICA 85
gate alla sua specifica competenza. Inoltre, maggiore sari la durata dellevento,
‘maggiore sari la quantiti la complessiti dell'informazione che lascoltatore si tto-
veri a dover organizzare © dunque maggiore sari la possibilita che le aspettative,
baste sulla passat esperienza, vengano utlizzate per accelerate i tempi e migliora-
te la performance delle sue risposte cognitive” In alte parole, maggiore sari il nu-
‘mero dei liveli gerarchici utilizzati dall’acoleatore per raggruppare i segmen:
nore sar la posibilit di generalizzare i risultaci della sua segmentazione. Sulla base
di questa considerazione la presente versione del modelo si limitera a prendere in
considerazione solo i primi due o tre livelli di segmentazione. Per determinare la
ddurata assoluta di un segmento considerable dal modello sé tenuto conto dei ri-
sulati di Frasse (1974) secondo il quale la durata massima di un segmenco che
ppossa contenere al suo interno una singola suddivisione binaria 0 ternaria é di «~5
second. Di conseguenza la duratz ottimale del fammento melodico considerato
dal modello dovra avere una durata massima di circa 4~§ X 3 = 15 secondi
ultima considerazione utile riguarda la dinamica delle strategie cognitive uti-
lizzate dall'ascoltatore. I process attvati nella segmentazione possono essere arti~
colati in tre fasi successive: la rilevazione di variazioni su diverse dimensioni
dell'evento; la definizione di gruppi separati sulla base delle variazioni precedente
‘mente percepite; 'organizzazione dei gruppi individuati in stratture temporal pid
ampie. La reali della nostra percezione non é cosichiaramente organiezatae le re
fasiagiscono probabilmente non serialmente e in modo lineare, ma in parallelo ©
jn modo non del tutto lineare. Come abbiamo visto, infat, nel processo di seg
mentazione di un evento sonoro la pressione imposta dallo scorrere dellinforma-
ione spinge Fascoltatore a genetare diverse aspetative sia per “ssltare” asi
delf'elaborazione ritenute ridondanti, sia per massimizzare la rapidita delle sue ri-
sposte cognitive. Ciononostante un’organizzazione lineare, pur non rappresentan—
do del tuto la realtd dei nostri procesii cognitivi, @ indispensabile ad una chiara
formalizzazione. Per descrivere il modello proposte, quindi, ci proponiamo di de-
finite: 1) le categorie percettive di base utilizate nella rilevazione delle variazioni;
2) criteri utilizzati per definire dei grappi a partite dalla vaviazioni dal!'altezza, di
durata e di profilo della linea melodica; 3) i crteri utilieati per organizzate gerar~
camente i gruppi precedentemente defini,
7G quesione poueble exer verifatasperimentalmente nel modo segunt: sea eodiea di
Seen mi a ap comport n nuggae iliy dle memoria +ngo cree
uid dle speitche comprense deUucoletore, sor la segmenaone l fxninen Bib
ap dveebbe fori det ito pi vara peta a anunens pa bev el vr do
$e i aca a aap dlr con aa dena competes eno nas
Potrebbero piacerti anche
LIGETI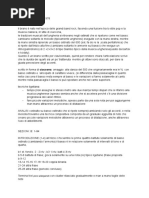
Nessuna valutazione finora
LIGETI
2 pagine
Debussy
Nessuna valutazione finora
Debussy
10 pagine
Semio
Nessuna valutazione finora
Semio
11 pagine