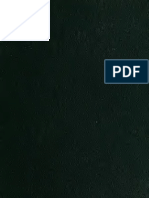Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Significato Del Sillabo
Il Significato Del Sillabo
Caricato da
palpitum0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
18 visualizzazioni4 pagineCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
PDF o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
18 visualizzazioni4 pagineIl Significato Del Sillabo
Il Significato Del Sillabo
Caricato da
palpitumCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 4
La separazione tra Chiesa e Stato
Una posizione simile assume la Chiesa di fronte alla
fra Chiesa ¢ Stato, che essa respinge in linea
ipio, ma ammette in date circostanze com’ un
male minore, come la soluzione che pud offrire i mag-
giori vantaggi. La Chiesa non pud ammettere di essere
me una associazione privata, che
Pambito del diritto comune: questo significherebbe ne-
garle il carattere di societh sovrana, perfetta, che ha rice-
vuto direttamente da Dio i suoi diritti e i suoi poteri,
ificherebbe permettere allo Stato di determinare i
limiti della sua azione. Né risponde a verith In teoria
delle due paral yuale Stato © Chiesa, avendo
diverse compet se sfere di azione, non si
incontrano mai, possono ignorarsi. Stato e Chiesa si
incontrano nella realta concreta del soggetto umano: uno
€ identico
Il soggetto attorno al quale essi operano.
so ¢ 'uomo Iaico non sono due persone
che vivono uno accanto alPaltra, ignorandosi, ma una
sola e identica persona. Ora, dovunque, vi ‘un unico
i esiste un solo fine ultimo da raggiungere,
perfezione fondamentale, un solo bene sostan-
che convergono a questo fine unico
arallele, Stato e Chiesa si incontrano
poi nella realta concreta della vita, dove entrambi giudi-
ano ¢ influiscono sulle stesse azioni, sia pure da punti
i vista di lo Stato, dal punto
tico-temporale, la Chiesa dal punto di vista
religioso-soprannaturale: 10 Stato, per giudicare se un
dato mezzo pud raggiungere o no un dato fine immediato;
la Chiesa, per giudicare se il fine proposto ¢ i mezzi pre=
scelti siano in armonia col fine ultimo dell'uomo e con
Ja sua natura razionale, Ancora una volta, attivitt che
confiuiscono nell'approvare 0 condannare la stessa azione
non possono dirsi parallele.
dove i cattolici sono una minoranza. Dove que-
sta separazione & applicata lealmente, la Chiesa Paccetta
come una situazione di fatto inevitabile, come ipotesi,
purché le sia concessa piena elluso de
teri, dei suoi diritti sercizio
nell’educazione, purche
di proprieta ed i cittadi
zrione al sacerdozio o al
‘cati inconvenienti in questa soluzione: ma essa ha of-
ferto spesso dei reali vantaggi. Meglio, in molti casi,
questa reale liberti, della larvata oppressione del giu-
nisdizionalismo. In Cile, osservava Mons, Larrain, ‘ve-
scovo di Talca, si sono fatti progressi_ sostanzi
ri di seguire la voca-
ioso. Non sono man-
Il significato del Sillabo
E dunque ora possil ire le nostre conelusioni, €
ribadire, se ve ne fosse ancora bisogno, il significato del
Sillabo.
TI documento pontificio condanna recisamente la pre-
tesa di costruire la societi senza tenere conto dei diritti
di Dio, di quella legge morale, universalmente valida,
che non fa che sancire antecedentemente alla proibizione
cid che & gid per 'uomo ¢ per la societi un bene o un male.
Se vogliamo cogliere i punti chiave del Sillabo, essi pos
sono ridursi a tre: la proposizione 39, che condanna la
e Ia fonte di
tutti i diritt, che gode di un certo suo diritto illimitato »
ra
(la concezione cattolica @ su questo punto completata
dalla dottrina contenuta nella proposizione 29, che riven-
ddica alla Chiesa i caratteri di societd perfetta); la pro-
posizione 64, che condanna il falso nazionalismo, che
Titeneva lecito ogni mezzo per la grandezza della nazione:
‘qualsivoglia azione scellerata & da lodarsi, quando si
‘commetta per amore della patria» ¢ la proposizione 58,
che respinge Padorazione della rice propria del
regime capitalists, per cui «ogni disciplina ed onesta
i costumi riposta nellaccumulare ed accrescere per
qualsivoglia modo la ricchezza ¢ nel soddisfare le proprie
passioni s. B forse esagerato vedere in queste tre frasi
11 quadro di tanta parte del secolo x
erale, uscito dalla rivoluzione, erede dei
principi dell’89 ¢ della dottrina della sovranita popolare
di Rousseau, «non pud assolutamente ammettere fuori
di s@ altra fonte di diritto », «non pud e non deve rico-
noscere altre proteste che quelle che dal suo seno innal-
zano le varie forze spiritual, fra le quali anche la Chiesa,
‘ma non come forza eteronoma, C’é una spiritualith che
viene dallo Stato... ». Esso si arroga una missione educa-
tiva, ¢e riconosce Ia piena liberta dell'insegnamento, ma
sottraendola ad ogni autoritA estranea allo Stato stesso »,
42 creazione utilitaria, giuridica, e come tale persegue
fini e metodi che non debbono essere giudicati etica-
tale regime non riconosce altre forze
le che da Tui stesso emanano, proclama
suo valore religioso, si arfoge una
missione educativa di fronte al cittadino, svincola il
suo operato da ogni norma morale, separando morale &
politica e dichiarandosi implicitamente pronto, al bisogno,
ad ogni arbitrio, ad ogni violenza. Si proclama liberale,
ma per una intrinseca dialettica tende necessariamente
a trasformarsi in totalitario, e intanto non riconosce al
(57) Pere, op. cit. p. 31 68 e passim.
Ey
cittadino diritti ¢ valori indipendenti dallo Stato, non
tollera accanto a sé altre istituzioni sovrane, non si preoc-
cupa di imporre obblighi in contrasto con la coscienza
“Tale era lo stato uscito dal nostro Risorgi-
‘mento: si presentava in teoria come V'emanazione della
volonti popolare, ma rappresentava I'l % della popola-
zione. Minoranza esigua che imponeva alla maggioranza
Ja sua volontA senza possibilita di appello. Bsso rappre-
sentava in realtA una sola classe, la borghesia, ignorando
per lunghi anni le sofferenze ed i bisogni della nascente
Classe operaia e del Mezzogiomno, demolendo ogni autono-
mia locale in ossequio alla assoluta sovranita dello Stato,
che non ammetteva davanti a sé altro che inc
E questo Stato si presentava come una creazione nuova
ben diversa dalla semplice « cucitura » dei vari staterelli
preesistenti, come un organismo dotato di una missione
ftica € religiosa nei confronti dei cittadini, che preten-
deva di educare secondo i suoi criteri, imponendo loro
una data concezione di vita.
Ancor oggi, questo 2 lo stato sognato ¢ difeso da molti
scrittori liberali, eredi diretti dello spirito risorgimentale.
‘Molte, espressic desunte alla let-
tera dai loro scritti ‘chi pretende di
Il secolo xix @ anche il secolo del nazionalismo esa
vede nelPunita nazionale non solo un bene,
fo ed auspicabile raggiungere entro le norme
lore assoluto, fonte di diritto.
ogni mezzo diveniva lecito, La
dimostra ad ogni pagina.
la nazione, il Papa ricordava
storia del. Kisorgimento
Contro questa idotatria
ancora una volta: non &
raggiungere il bene, e imy
dalle conseguenze ‘di quellesagerato_nazior
all'inizio del secolo seguente, si sarebbe logicamente
trasformato in imperialismo ed avrebbe scatenato im-
mani conflitti.
labo, pur non considerando esplicitamente gli
aspetti economico-sociali del liberalismo, li stronca alla
radice condannando anche la concezione mat i
nomiche, che sempre esisteranno, ma anche
Ja miseria pit squallida del proletariato. L’egoi
come un castigo pet Ia loro cattiva condotta, non sapeva
suggerire altro rimedio che la rinunzia all'uso del ma-
io, € in nome di una uguaglianza ¢ libert’ illu-
soria imponeva la sua dittatura agli operai. La morale
del capitalismo era una «morale di concorrenza ¢ di
lotta, che permette di verificare la potenza ¢ la grandezza
deli’tomo sul solo piano dell’azione economica, condi-
zione per il riscatto e la vittoria sul male », frase brillante
per una verith sordida, il c 10 permetteva ai pith
forti di schiacciare i pit deboli, esaltava anzi_ questa
i cose. Dalla Francia del ’48 all'Italia della
fine del secolo, il malessere conseguente questa situazione
continuava a ‘serpeggiare.
Il Papa si sollevava infine ai principi supremi da cui
i derivavano. A coloro che volevano esal-
erarlo da ogni vincolo, ricordava il valore
rivelarione, i limiti della ragione umana,
i dovere di accettare Ia voce divina ¢ di sottomett
essa. Contro il criticismo che negava la post i
‘conoscere la verit’, contro Pindifferentismo per cui ogni
religione ¢ buona, il Papa aveva il coraggio di dichiarare
cche solo la Chiesa cattolica segue la vera religione, ¢ chi
& fuori di essa scientemente € consapevolmente, per un
Bs
deliberato rifiuto, non pud essere salvo. Mentre V'idolatria
i tanza della veriti,
Quanto vi era di buono nelle idee liberali @ conservato.
Il Sillabo non @ il rifiuto totale del mondo moderno.
Liindipendenza ¢ a so dello Stato nel suo campo,
il valore intrinseco delPattivita temporale ¢ politica (che
tutti gli individui di fronte alla ione
il controllo al governo, la liberta di parola ¢ di opinione
che rispetti i diritti della verith ¢ della giustizi
tutto cid @ condannato, La Chiesa non rispolvera le
dottrine teocratiche che vari teologi e canonisti
‘cento avevano difeso con calore, secondo le quali auto-
rita civile deriva il potere da quella ecclesiastica, & la
esccutrice delle sue dir ;eorie che trovarono anche
allora tra gli stessi catt
tori, mai fu
€ furono in ogni caso
ito sono nel loro ordine
non pud mai viol
i cittadini contro gl del potere
Nonostante tutte le imperferioni della redazione, la
unione e la frapposizione di polemiche contingenti ¢ di
Potrebbero piacerti anche
- Anonymous La Grande TruffaDocumento21 pagineAnonymous La Grande TruffapalpitumNessuna valutazione finora
- Dizionariodellom 00 GiuluoftDocumento532 pagineDizionariodellom 00 GiuluoftpalpitumNessuna valutazione finora
- I Fanatici Dell' ApocalisseDocumento3 pagineI Fanatici Dell' ApocalissepalpitumNessuna valutazione finora
- Futuro Del Tradizionalismo 6 MarzoDocumento107 pagineFuturo Del Tradizionalismo 6 MarzopalpitumNessuna valutazione finora
- La Chiesa Le Chiese Ildebrando A SantangeloDocumento37 pagineLa Chiesa Le Chiese Ildebrando A Santangelopalpitum100% (1)
- Giovanni CaprileDocumento27 pagineGiovanni Caprilepalpitum100% (2)